I SUONI DEL MARE
Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.
I SUONI DEL MARE
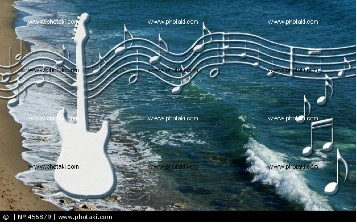




Anche le aragoste emettono suoni che nel loro complesso si uniscono in una singolare sinfonia. O meglio producono segnali acustici sonici e ultrasonici in particolari condizioni di stress. Questa scoperta, fatta dal Gruppo di Bioacustica dell’Istituto per l’ambiente marino costiero (Iamc) del Cnr di Capo Granitola, conferma che, se l’orecchio umano potesse captare anche lunghezze d’onda superiori ai 15-20 Kherz, percepiremmo il mare in modo del tutto diverso. Da muta distesa d’acqua diventerebbe un mezzo capace di diffondere un chiacchierio di note usate dagli animali marini per comunicare tra loro. Immaginare dunque il mare come un insieme di ecosistemi caratterizzati da una propria firma acustica è possibile, tanto più che attraverso di esso i suoni si propagano con una velocità di circa 1.500 metri al secondo e possono coprire distanze di migliaia di chilometri. Senza neppure vederlo, ma solo sentendolo, potremmo riconoscere per esempio un posidonieto proprio là in prossimità di una spiaggia o un mare più profondo o una barriera corallina. Suoni dai toni e frequenze diversi si alternerebbero a seconda dei paesaggi marini che incontreremmo. Potrebbero essere anche così rumorosi da farci tappare le orecchie.
Legittima difesa
Ma ritorniamo alla ricerca. <<Dalla letteratura si sapeva che le aragoste, come del resto altre specie di crostacei, generavano suoni che tuttavia per la prima volta sono stati caratterizzati e associati a precisi comportamenti>>, spiega Giuseppa Buscaino, ricercatore dell’Iamc. Venti esemplari della specie Palinurus elephas, vivi e mantenuti in vasca salata, sono stati monitorati per mezzo di due telecamere, una subacquea e l’altra posta al di sopra di essa, quando erano attaccate singolarmente o in gruppo da due loro acerrimi nemici: il grongo e il polpo. Il risultato? Emettevano suoni brevi, quasi metallici, uniti tra loro, come si può ascoltare dall’audio allegato. Registrati con un idro microfono reso impermeabile, collegato a un pre-amplificatore e acquisito con una scheda di conversione analogica-digitale, sono stati attentamente studiati.
Comportamenti a “rischio”

I ricercatori hanno così notato che correlavano con alcune posizioni di questi animali marini, per esempio con il cosidetto “tail flip (rapida flessione dell’addome che fa spostare l’aragosta a reazione da un punto all’altro) o con lo stato di ”alert” (animale sta dritto sulle zampe posteriori). <<Si è pertanto capito che i suoni emessi erano veri e propri segnali prodotti per avvertire gli altri di un imminente pericolo e per attuare una strategia collettiva di difesa>>, dice Giuseppa Buscaino. <<Al loro suono le aragoste si avvicinavano le une alle altre e puntavano all’esterno le loro antenne ricche di spine capaci di formare una barriera fisica molto efficace contro i predatori>>.
Il canto dei cetacei

Molti animali acquatici hanno evoluto sistemi complessi per ricevere ed emettere suoni. <<I delfini sono alcuni di questi. Emettono fischi udibili ma anche i cosidetti click, impulsi ad ampia banda di frequenza, udibili e non udibili, per avvicinarsi alle barche dei pescatori, sfruttare i loro attrezzi di pesca e ridurre gli sforzi della pesca>>, ci dice Giuseppa Buscaino, riferendosi ai risultati di una ricerca in corso nel Mar Ionio. In realtà questi click sono parte di un sonar: generati da sacche aeree in comunicazione con lo sfiatatoio, incontrano l’oggetto (in questo caso l’attrezzo luminoso a intermittenza che attira i pesci) e parte della loro energia tornando indietro viene captata dalla mandibola (hanno perso il padiglione esterno!) dotata di un grasso a bassa impedenza acustica che la trasferisce direttamente all’orecchio medio. Analizzando il ritardo, calcolano la dimensione e la distanza dalla preda. I furbetti pare abbiano imparato a immergersi solo quando quest’ultima si avvicina molto alla superficie.
Manuela Campanelli
Rapallo, 28 luglio 2018
I PALOMBARI - COSTA CONCORDIA
I PALOMBARI
Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.
PALOMBARI: I silenziosi protagonisti del recupero dei superstiti Caso Concordia




Vestono una tuta di gomma, calzano scarponi di piombo e portano pesi e un caratteristico elmo di rame che ha affibbiato loro il bonario nomignolo di “teste di rame”. Sono i Palombari delle Forze Specialistiche Subacque della Marina Militare. Sono loro che continuano con perseveranza ad aprire con microcariche varchi di dimensioni prestabilite nella struttura sommersa al fine di trovare superstiti e tracciare vie di fuga per il personale stesso che entra nella nave. <<Siamo giunti sul posto in 12, divisi in due squadre, il giorno dopo l’incidente con l’elicottero. Successivamente ci ha fatto d’appoggio la nave Pedretti che, imbarcando una camera iperbarica mobile e un infermiere specializzato in fisiopatologia subacquea, ha fornito a noi e agli altri soccorritori la copertura sanitaria contro i barotraumi>>, ci aggiorna il primo maresciallo palombaro Fabio Masuzzo, da oltre 15 anni nel Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.). Lui e i suoi compagni hanno effettuato immersioni sino alla profondità di 36 metri ad aria di profondità per eseguire ispezioni sotto lo scafo e valutare i danni e la stabilità dell’imbarcazione. I loro orecchi, sempre tesi a cogliere il minimo rumore proveniente dal relitto, e i loro occhi sono i più affidabili testimoni di un disastro che a detta loro, che sul posto ci sono stati, si può definire “impressionante” sia per la mole della nave e sia per il numero di passeggeri coinvolti che non ha uguali nella nostra storia civile.
In soccorso ai sommergibili
E’ infatti la prima volta che il G.O.S. è stato impegnato con un’unità passeggeri di simile portata. <<Venti anni fa è stato attivato per soccorrere il personale intrappolato nell’Espresso Trapani, il traghetto che nel 1990 affondò tra l’isola di Levanzo e lo scoglio dei Porcellini a poche miglia di distanza dal porto della città siciliana. Allora persero la vita 13 persone>>, ricorda Riccardo Fantini, capitano di Corvetta della Marina Militare Italiana. Di solito questi intrepidi subacquei si occupano di altro, in particolare del soccorso ai sommergibili sinistrati. <<Per i nostri sei sommergibili, tra cui si annoverano il Todaro e lo Scirea noti per la loro innovativa tecnica di propulsione, non c’è stato fortunatamente mai bisogno del loro intervento>>, spiega Riccardo Fantini. <<Si sono però proposti per soccorrere il sommergibile Kursk in cui morirono oltre cento uomini della Marina russa: l’Unione Sovietica all’epoca non accolse il loro intervento, come del resto quello degli altri paesi NATO>>. Con questo compito il G.O.S. fa parte di ISMERLO (International Submarine Escape and Rescue Liaison Office), un servizio internazionale che coordina tutte le marine che vi partecipano sulle stesse coordinate di fuga e di salvataggio dai sommergibili.
I mezzi speciali

Il palombari del G.O.S, elite della nostra Marina, hanno aperto sette varchi per raggiungere parti sommerse dello scafo della Costa Concordia.
Giusto l’anno scorso il G.O.S. ha partecipato all’esercitazione Bold Monarch, tenutasi a Cartagena in Spagna, volta a migliorare la cooperazione per il recupero di vite umane dai sommergibili danneggiati. Per svolgere questa attività utilizza il mini sommergibile SRV 300, un veicolo subacqueo capace di raggiungere una profondità di 300 m e di trasferire sul sommergibile sinistrato 12 operatori a ogni viaggio, e la campana McCann, collegata con la superficie e in grado di arrivare a 120 m di profondità e di trasferire 6 persone per ogni viaggio. Molto utile nei soccorsi si è dimostrato l’A.D.S. (Atmospheric Diving Suit), una tuta in metallo collegata alla superficie da un cavo ombelicale che crea al suo interno una pressione ambientale e permette quindi agli operatori di immergersi fino a 300 m di profondità senza dover eseguire pressurizzazioni e depressurizzazioni. Grazie a essa i subacquei possono svolgere interventi in tempo reale e rimanere sottacqua il tempo che vogliono in base alla loro resistenza fisica.
Le bonifiche di ordigni
I palombari del G.O.S. sono inoltre chiamati a disinnescare piccoli e grandi ordigni esplosivi, appartenenti al II conflitto mondiale e rinvenuti a tutt’oggi nei mari, nei fiumi o nei litorali: un’attività che li impegna con più di 4.400 interventi all’anno. Chi sono dunque questi arditi operatori? <<Sono persone altamente addestrate, già in servizio presso la Marina, che hanno superato un’accurata selezione>>, spiega Riccardo Fantini. <<Prima di essere ammessi al corso che dura 10 mesi e prevede 300 immersioni tra diurne e notturne, si sottopongono a prove di idoneità fisica che valutano per esempio la capacità respiratoria, cardiaca e cerebrale. Una volta superate possono accedere alla selezione in vasca per testare la loro acquaticità>>. Il loro brevetto è davvero sudato ed ha un rateo di successo del 15 per cento circa: su 20 candidati solo 5 o 6 lo ottengono.
Manuela Campanelli
Rapallo, 28 luglio 2018
L'OCEANOGRAFIA: fotografa e preserva i noistri mari
Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.
L’OCEANOGRAFIA: fotografa e preserva i nostri Mari
Copernicus, la tecno-sentinella dei mari

Il 4 Aprile 2014 L’Europa ha lanciato il primo satellite ambientale del programma COPERNICUS. Il satellite, del peso di 2,3 tonnellate, è decollato ieri sera a bordo del lanciatore Soyuz dallo spazio porto europeo di Kourou, nella Guyana francese, alle 23:02 (21:02 GMT). La separazione del primo stadio è avvenuta 118 secondi più tardi, seguito dalla separazione del fairing (a 209 secondi), del secondo stadio (287 secondi) e del gruppo superiore (526 secondi). Dopo 617 secondi di spinta, lo stadio superiore Fregat ha messo il satellite Sentinel nell'orbita eliosincrona ad un'altitudine di 693 km. Il satellite si è separato dallo stadio superiore dopo 23 minuti e 24 secondi dal lancio. "Il Sentinel-1A apre una nuova pagina nell'implementazione di Copernicus, la seconda iniziativa spaziale dell'Unione Europea, dopo il sistema di posizionamento Galileo" ha detto il Direttore Generale dell'ESA, Jean-Jacques Dordain.

Nave Magnaghi (A 5303) è la prima nave idro-oceanografica progettata e costruita in Italia. Prende il nome dall'ammiraglio Giovan Battista Magnaghi, per ...

Dal prossimo anno prima di uscire in barca, di prendere un traghetto o di fare una regata si potrà conoscere lo stato attuale e prossimo del mare consultando il servizio d’informazione COPERNICUS. Finanziato dall’Unione Europea dal 2014 al 2020, eseguirà un monitoraggio accurato della terra in tutti i suoi cinque domini, mari compresi: di questi ultimi l’Italia, attraverso il Gruppo nazionale di oceanografia operativa (Gnoo) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), gestirà il Mare Mediterraneo per l’Europa. <<Si tratterà di un servizio regolare e sistematico, accessibile gratuitamente a tutti, che consentirà di stimare le condizioni del mare al meglio delle tecnologie attuali (satelliti e misure in situ) e di fare la migliore previsione di tutte le sue componenti, dalle correnti alla biochimica marina, dal moto delle onde alla salinità e alle temperature dell’intera colonna d’acqua>>, ci spiega Nadia Pinardi, docente di Oceanografia all’Università di Bologna, direttrice dello (Gnoo) e autrice del libro “Misurare il mare” edito da Bonomia University Press.
I servizi già esistenti
Se si è potuto mettere a punto uno strumento così completo, il merito va all’oceanografia operativa, la disciplina che si avvale di tecnologie avanzate che raccolgono dati in tempo reale, li fanno arrivare sul deskop dei computer di un centro di calcolo per essere elaborati e li immettono in un modello di monitoraggio globale ad alta risoluzione che li controlla e li confronta con modelli numerici che fanno previsioni. Chi è però appassionato di navigazione, o chi per professione se ne deve interessare, può obiettare che a tutt’oggi esistono già il bollettino delle previsioni dei Mari dello Gnoo consultabile sul sito dell’INGV all’indirizzo http://gnoo.bo.ingv.it/mfs/web_ita/contents.htm e il servizio del progetto di tecnologie avanzate visionabile su www.see.conditions.it.
Un confronto costruttivo
Quali differenze hanno i servizi d’informazione marina attuali con il futuro servizio COPERNICUS? <<Innanzitutto non garantiscono una consegna tempestiva dei dati e delle previsioni e pur essendo di dominio pubblico da essi non si possono prendere le informazioni e farle proprie per scopi economici. Tra l’altro elaborano previsioni solo di alcune componenti del mare e dell’atmosfera>>, ci aggiorna Nadia Pinardi. In particolare il servizio see-conditions diventerà privato. Il suo sistema di erogazione delle previsioni sul web è già realizzato dall’azienda Links S.p.a., mentre l’attività di ricerca e la rielaborazione dei modelli oceanografici sono svolte dal centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC) e dall’Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero (IAMC) del Cnr. COPERNICUS sarà invece un servizio pubblico e darà molte informazioni in più. Permetterà pure di far crescere la cosidetta economia “blu” e di creare occupazione: le aziende potranno infatti prendere i dati oceanografici e metereologici da COPERNICUS e fare loro le previsioni.
I vantaggi di COPERNICUS
Oltre ad aggiornarci su “che mare sarà”, COPERNICUS permetterà di avere rotte più sicure in mare e di gestire al meglio le emergenze che avvengono nelle nostre acque. <<Già il servizio di previsioni dello Gnoo aveva supportato l’azione delle guardie costiere della protezione Civile Italiana per l’incidente della Concordia sia nel 2012 per un eventuale sversamento del carburante e sia quest’anno per la rimozione della nave>>, ci ricorda Nadia Pinardi. Le informazioni sui componenti chimici e biogeochimici marini ottenuti con COPERNICUS saranno inoltre utili per il monitoraggio della qualità dell’acqua e per il controllo degli inquinanti; quelle relative al livello del mare aiuteranno a valutare l’erosione costale; e quelle sulla temperatura superficiale dell’acqua marina, uno dei primi parametri che fa la spia dell’impatto fisico del cambiamento climatico, renderanno conto della diretta conseguenza sugli ecosistemi marini.
A supporto di molte applicazioni marine
COPERNICUS contribuirà anche a migliorare la sicurezza marina, la difesa del territorio per uno sviluppo sostenibile e la protezione delle coste da eventi estremi, a esercitare un controllo sulla pesca e sul pescato per salvaguardare questa risorsa alimentare e a facilitare il lavoro di scienziati e di ricercatori che avranno a disposizione una rappresentazione dello stato del mare su cui studiare la dinamica marina. Molti dei dati distribuiti dal servizio, quali temperatura, salinità, livello del mare, correnti, venti e ghiacci in mare, giocheranno un ruolo cruciale nel dominio del meteo, del clima e delle previsioni delle stagioni. La meteorologia non è infatti disgiunta dall’oceanografia: c’è infatti uno scambio di informazioni tra le previsioni atmosferiche e le previsioni del mare. Al momento COPERNICUS è disponibile in modalità pre-operativa e consultabile dagli utenti registrati su www.marine.copernicus.eu o www.MyOcean2.
Manuela Campanelli
Rapallo, 28 Luglio 2018
DARWIN DAY
Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.
DARWIN DAY: l’evoluzione a dimensione dei giovani
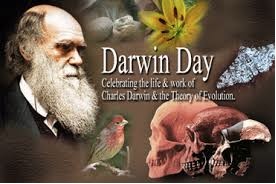
Avete mai chiesto a un ragazzino di farvi qualche esempio di evoluzione? Alcuni esperti intervenuti all’Undicesimo Darwin Day di Milano 2014 ci hanno provato e uno di loro si è sentito rispondere con queste parole: <<Durante la crescita è possibile che un Pokémon evolva in un Pokémon differente>>. Siete rimasti spiazzati? Probabilmente sì. Gli stessi studiosi che hanno fatto la domanda consigliano però di non demonizzare le risposte dei più giovani ma di usare i loro linguaggi e la loro immaginazione per avvicinarli a concetti scientifici corretti. Quindi ripartiamo dai Pokémon. Se è vero che queste creature immaginarie possono cambiare e salire di livello in base a qualcosa che succede nel loro ambiente, per esempio per numero di combattimenti vinti, per felicità, per conoscenza di una “mossa” o per saper tenere in mano uno strumento, è anche vero che le loro trasformazioni sono più una metamorfosi che un’evoluzione. <<La prima presuppone infatti un cambiamento che avviene nel corso della vita di un organismo secondo un percorso ben preciso dettato dai geni (come quello dal girino alla rana), mentre la seconda, cioè l’evoluzione, riguarda un cambiamento che coinvolge almeno un’intera popolazione e non un singolo individuo e avviene in tempi lunghissimi dell’ordine di milioni e milioni di anni tanto da rendere le generazioni successive diverse da quelle precedenti>>, spiega Emanuele Serrelli, ricercatore all’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Spunti di riflessione
Vi sembra di aver dato una definizione giusta di che cos’è l’evoluzione partendo tra l’altro dalle vicende dei “mostri tascabili”, i Pokémon appunto, i cartoni conosciuti da tutta la nostra gioventù e vi sentite in pace con voi stessi. Ma c’è sempre un “sì però” e a sollevarlo è stato un altro ragazzino: <<Sì però anche tra i Pokémon ci sono specie uniche, altre più rare e altre ancora più numerose>>. Come fargli capire che l’evoluzione è la storia che lega tra loro le varie specie le quali non spuntano fuori dal nulla? <<L’evoluzione, contrariamente alla metamorfosi, non è lineare, procede per ramificazioni, come nel caso cosiddetto passaggio degli organismi dall’acqua alla terra>>, suggerisce Emanuele Serrelli. <<In alcuni grandi gruppi di pesci attraverso le ere si sono infatti accumulate modificazioni che li hanno resi animali terrestri, dando origine dapprima ai rettili e poi agli anfibi: della vita di allora conservano tutt’oggi ancora dei segni>>, sottolinea Emanuele Serrelli. Portarsi “addosso” il proprio passato è comune a tutti gli esseri viventi. Come è stato ben illustrato nella sezione “Conchiglia addio …voglio nuotare” tenutasi durante il Darwin Day i polpi portano ancora le vestigia della conchiglia, persa per conquistare un habitat marino più profondo e con un minor grado di competizione, sotto forma di due piccole cartilagini presenti nella parte posteriore del loro corpo. Allo stesso modo la seppia ricorda il suo passato con l’osso di seppia, che altro non è che la vecchia conchiglia i cui setti si sono riempiti di carbonato di calcio. Noi esseri umani non siamo da meno: i nostri polmoni sono le vestigia della vescica natatoria dei pesci primordiali.
Una questione di tempi
I fumetti e i cartoni spesso sviano i loro lettori dalla scienza “vera”, ma anche i film non sono da meno. Che dire per esempio di “L’era glaciale 2: il disgelo” in cui davanti allo scioglimento di tutti i ghiacci del mondo Sid, l’antenato del bradipo, dice: <<Non possiamo fare altro che trasformarci in animali acquatici>>. Un attimo. Ma per farlo occorrono migliaia di anni, centinaia di generazioni. Più appropriata è senz’altro l’esclamazione di compatimento della tigre che scotendo la testa gli dice di rimando: <<Geniale Bradipo>. <<Il fumetto “X Men” con il suo gruppo di super-eroi mutati perché portatori del gene-X, risultato di un’alterazione del DNA che li dota di facoltà straordinarie, si avvicina un po’ di più al concetto di evoluzione biologica, cioè al concetto che la specie umana sta cambiando grazie alla diffusione di alcune caratteristiche piuttosto che di altre>>, sostiene Emanuele Serrelli.
Termini appropriati
Le animazioni, i fumetti e i corto o lunghi metraggi sono tuttavia entrati a pieno titolo tra i linguaggi riconosciuti dalla letteratura ufficiale (quest’anno al prestigioso Premio Strega sarà candidato per la prima volta un fumetto dal titolo “Una storia”, quello di Gianni Pacinotti, in arte Gipi). <<Quanto meno possono dare spunti di riflessione in materia di evoluzione che è un termine spesso usato per dare un’idea di progresso e di cambiamento, scegliendo soltanto le parti della Teoria dell’Evoluzione che interessano per ciò che si vuole dire. In questo modo ci si dimentica che la stessa teoria spiega anche i meccanismi della stasi evolutiva per la quale famiglie intere non cambiano per lunghissimi periodi di tempo>>, dice Emanuele Serrelli.
L’evoluzione “visibile”
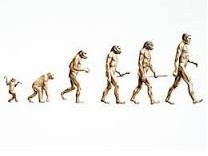
L’evoluzione si può dunque approcciare da punti di vista diversi: partire dai singoli esempi per poi sommarli insieme o cominciare da un concetto unitario per poi dividerlo nelle sue parti. Oppure avvicinarla dal “piccolo”, cioè dalla genetica per spiegare fenomeni di ampie dimensioni o iniziare a spiegarla dal “grande”, cioè da fattori macroscopici come per esempio la deriva dei continenti, la frammentazione degli habitat, il cambiamento dei climi. Da qualunque angolazione la si avvicini, non si può prescindere dal fatto che l’evoluzione sia ovunque, che riguardi la vita di tutti i giorni e che coinvolga tutti gli esseri viventi. Già, ma come possiamo cogliere e percepire quest’”alito evolutivo” che pervade ogni oggetto animato che ci circonda? In altre parole come possiamo accorgercene oggi, qui e ora? <<Sebbene dei suoi effetti non ci possiamo rendere conto perché richiedono il passaggio di ere geologiche, in pochissime occasioni possiamo tuttavia tastare con mano l’evoluzione anche nell’arco della nostra vita. La resistenza agli antibiotici è una di queste: possiamo vedere manifestarsi gli effetti delle mutazioni comparse nel DNA dei batteri che si riproducono velocemente perché hanno un ciclo vitale molto breve.

Un’immagine del fringuello Geospiza fuligginosa, fa parte di 13 specie che si conoscono attualmente.
Oppure possiamo osservare la selezione dei fringuelli delle Galapagos a opera dei cambiamenti climatici avvenuta in un lasso di tempo di qualche decina di anni>>, dice Emanuele Serrelli.
Un fenomeno complesso
Scindere l’evoluzione biologica da quella culturale non è inoltre sempre semplice. Sul ruolo della tecnologia ci sono due correnti di pensiero: c’è chi la considera parte dell’ambiente e chi la ingloba invece nell’evoluzione grazie agli strumenti che ci fornisce per migliorare la qualità di vita, dagli occhiali alle protesi e ai pacemaker per il cuore per esempio. Una domanda è lecita: per quanto tempo potremo sostenere lo stile di vita attuale? Ripassando mentalmente la nostra storia evolutiva, ci accorgiamo che per diventare i bipedi che siamo ci sono voluti 7 milioni di anni, la specie Homo sapiens esiste da meno di 200 mila anni, e l’agricoltura da circa 11 mila anni. Non c’è che dire: l’evoluzione è imprevedibile nei suoi tempi e nei suoi modi. Con questa premessa anche chiedersi per esempio per quanto tempo lo stare seduti davanti al computer dovrà durare perché abbia un effetto tangibile sulla nostra genetica e perché possa quindi diventare un carattere ereditabile, non può avere una risposta precisa.
Manuela Campanelli
28 Luglio 2018
CORALLI
Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.
CORALLI

Nel Queensland (Australia) esiste la Grande Barriera Corallina, iscritta nella lista del Patrimonio dell'Umanità nel 1981, è la più grande del pianeta (si estende per 2300 km), gode di una grandissima biodiversità ed è formata da miliardi di piccolissimi organismi, "i polipi del corallo" che incessantemente, modificano con il loro lavoro la morfologia del pianeta. Non a caso per la sua ampiezza è l’unico organismo vivente della Terra visibile dallo spazio!

Immergersi con le bombole nelle profondità delle acque e nello stesso tempo contribuire alla salvaguardia dei coralli. A consentire questa doppia attività è il progetto STE (Scuba Tourism for the Environment – Red Sea Biodiversity Monitoring Program) appena ripartito dopo lo stop dettato dal Ministero degli Esteri per le mete turistiche egiziane: esso si propone infatti di monitorare la biodiversità delle scogliere coralline del Mar Rosso con l’aiuto di turisti volontari che trascorrono le vacanze nelle località di Sharm el-Sheikh, Marsa Alam, ma anche in luoghi meno noti ma ricchi di coralli quali Berenice, l’Egitto Meridionale, il Sudan, fino a Yanbù Al-Bahr e Rabigh sulla costa araba. Un vero e proprio esempio di citizien science , cioè d’impiego dei cittadini per indagare la scienza che in questo caso coinvolge subacquei ricreativi e snorkelisti che usando maschere e pinne potranno osservare solo la parte più superficiale della barriera corallina: entrambi raccolgono osservazioni che si trasformano poi in dati e quindi in un quadro completo del benessere di ciò che hanno visto.
Comportamenti sostenibili innanzitutto
Venirne a conoscenza è semplice. Basta consultare il sito www.steproject.org o bussare direttamente alla porta dei centri di diving aperti nelle rinomate mete egiziane. <<A impartire ai turisti volontari lezioni di biologia marina ci pensa il Marine Science Interdisciplinary Research GROUP (MSG - www.marinesciencegroup.org ), un gruppo di ricercatori, studenti universitari e personale formato che sul posto organizzano dei seminari volti ad affinare l’osservazione, a illustrare le problematiche di conservazione delle specie e a insegnare come approcciare la barriera corallina nella maniera meno impattante possibile, sia fuori dall’acqua con comportamenti sostenibili (limitare l’uso di detergenti, non comprare souvenir fatti di corallo…) e sia dentro il mare: imparare a valutare il giusto assetto d’immersione, per esempio la quantità di chili necessari per contrastare il galleggiamento, è estremamente importante per rimanere a mezz’acqua senza cadere sul fondo e andare addosso alla barriera>>, dice Stefano Goffredo, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna.
Un specifico monitoraggio
A ogni partecipante verrà consegnata una scheda di monitoraggio che dà notizie su 65 parametri sulla quale riportare le specie di interesse (circa una sessantina) e la loro frequenza di distribuzione rispetto all’atteso. In altre parole si chiede a ciascuno di essi di riportare quali organismi sono stati avvistati e in questo caso qual è la loro abbondanza: indicazioni valide sono anche quelle relative al ritrovamento di coralli morti, sbiancati, rotti o di rifiuti. Dalla somma delle osservazioni si ricava un quadro completo degli organismi che popolano l’area monitorata e cosa vi sta succedendo. Come si fa a sapere se i dettagli riportati dai volontari sono affidabili? <<La validazione dei dati raccolti viene eseguita da alcuni nostri studenti o ricercatori che, immergendosi a loro volta con i turisti, ma senza interferire con l’attività di questi ultimi, raccolgono a loro volta dettagli e osservazioni. Alla fine si confrontano le schede, quelle dei ricercatori ritenute corrette con quelle dei volontari: di solito si trova un’affidabilità del 60 per cento, del tutto paragonabile a quella riscontrata in altri progetti>>, spiega Stefano Goffredo. E’ un valore troppo basso, dite voi?
I risultati ottenuti
In realtà sapere quasi in tempo reale ciò che succede su vaste aeree geografiche ha costi enormi. L’approccio citizien science (uso di volontari per indagare la scienza) si è pertanto dimostrato un giusto compromesso per seguire i veloci cambiamenti degli ecosistemi, causati da modificazioni del clima e influenzati anche dall’uomo, senza commettere grosse imprecisioni. Non a caso Horizon 2020, il principale strumento di finanziamento dell’Unione Europea volto a sovvenzionare progetti di ricerca , ha previsto lo sviluppo di un sistema di monitoraggio di città e campagne impiegando i cittadini chiamati a segnalare precisi parametri per esempio tramite smart phone. MSG è tuttavia pioniere del metodo citizien science dato che ha iniziato a utilizzarlo dal 1999. E i risultati sono stati numerosi. A oggi sono state raccolte 30 mila schede che hanno dato indicazioni importanti sullo stato di biodiversità marina di 114 siti di rilevamento del Mar Rosso.
Dalla teoria alla realtà

Il monitoraggio effettuato dai volontari ha consentito d’individuare differenze tra aree di uno stesso territorio marino e di osservare disuguaglianze significative nella qualità delle barriere coralline tra le zone meridionali di Hurghada e quelle settentrionali di Sharm. <<Queste ultime sono infatti meglio conservate in quanto da sempre nei parchi protetti che le costituiscono è vietato l’ancoraggio libero delle barche che avviene su boe fisse>>, dice Stefano Goffredo. Le autorità locali sono tuttavia consapevoli dell’importanza di salvaguardare la biodiversità anche di questi luoghi turistici perché fanno da serbatoio alla capacità riproduttiva delle larve degli organismi che formano le barriere coralline. Il Ministero e l’Ente del Turismo Egiziano oltre a finanziare il progetto STE organizzano ogni anno un incontro in cui valutano i risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato dai nostri ricercatori e ascoltano i consigli che vengono loro dati affinché possano trasformarsi in provvedimenti pratici. Un esempio? Da qualche anno hanno messo le boe fisse per l’ormeggio delle barche anche a Hurghada e mantenuto le zone parco a Sharm.
I nostri coralli



Livorno, Calafuria, profondità 30 metri. Corallium rubrum dimensioni 7-8 cm
Si parla tanto dei coralli che popolano il Mar Rosso o tanti altri luoghi del mondo e mai di quelli che vivono nelle nostre aree marine. <<Ben quaranta sono le specie che si trovano nel Mare Mediterraneo e quindi anche in acque italiane>>, dice Stefano Goffredo. <<Abitano ambienti sia illuminati e sia bui e riescono a raggiungere densità di popolazioni elevate o dominanti. Sebbene non formino scogliere coralline come nei Tropici, costituiscono tuttavia un elemento costruttivo dell’ambiente>>. Un esempio noto a tutti è il corallo rosso, assai diffuso oltre i 40 metri di profondità: lo stesso corallo è tuttavia molto abbondante a basse profondità in prossimità di Livorno ed è dominante nelle grotte buie a fianco del quale si sviluppano altre specie di coralli. Una specie di corallo bianco di profondità, la Lophelia pertusa, forma invece dei veri e propri banchi nei Mari Ionio e Tirreno.
Scenari possibili
Perché ci si preoccupa tanto della sopravvivenza dei coralli? In altre parole, se periscono, quale scenario si configurerebbe? L’economia dei Paesi emergenti di sicuro ne risentirebbe: il loro Pil è infatti basato sul turismo richiamato dalle barriere coralline e sulla pesca che questi stessi coralli consentono essendo l’inizio di una catena alimentare soprattutto in acque oceaniche. Verrebbe inoltre meno la protezione delle coste: le scogliere coralline fanno in un certo senso da scudo alle erosioni e agli tsunami. Negli anni ’80 nei Caraibi una malattia ha attaccato le scogliere coralline della Giamaica colpendo dapprima i ricci, organismi erbivori che controllano le alghe verdi, e successivamente l’intero ecosistema che si è trasformato in una distesa di coralli morti con sopra le alghe. I pesci che depongono le uova e trovano rifugio nella tridimensionalità della struttura della scogliera corallina potrebbero nel tempo addirittura estinguersi.
Manuela Campanelli
Rapallo, 28 Luglio 2018
TEMPO DI GUERRA... amarcord 5
TEMPO DI GUERRA
AMARCORD...5
Ho incontrato ……Eichmann

Sul finire del 1944, io, Lucio, Franco, Gianni, Aldo e altri, ci incontravamo sempre nel Convento dei Francescani di Pegli, dedicato a Sant’Antonio Abate, quello con il maialino. Non eravamo una vera associazione, per altro proibita dal Regime Fascista, in quell’epoca dominante. Si giocava a Biliardo, a carte e quant’altro con il beneplacito dei rispettivi genitori che, sapendoci in convento, ritenevano quello essere uno dei posti più sicuri in un momento di caos inimmaginabile. Ci eravamo organizzati una specie di bar, nei limiti del tempo di guerra, per dare parvenza di “adulti” ai nostri incontri. All’imbrunire però si doveva per forza rientrare a casa per non incorrere nel “coprifuoco” che, all’epoca, scattava abbastanza presto ed era fatto rispettare con rigore dai militi delle Brigate Nere. Facevano parte del nostro gruppo anche i giovani frati, da poco nominati Sacerdoti e che da lì iniziavano la loro missione. Insomma eravamo tutti giovani e in Convento c’era uno dei pochi telefoni funzionanti; nelle case era oggetto raro. Noi poi non eravamo ancora in età da essere arruolati nei Bersaglieri, il corpo raccogliticcio messo insieme, per volere dei Tedeschi, dal governo fantoccio, grondante sangue, della Repubblica di Salò. Tutti i giovani in età di leva, quell’età, in guerra, continuava ad abbassarsi mano a mano che gli uomini al fronte morivano, finivano d’ufficio nei “Bersaglieri. Và detto che quel Corpo raggruppava tutti quelli che non si volevano unire volontariamente alle varie Brigate Repubblichine operative, vere e proprie bande di assassini. Insomma vi finivano i “lavativi”. Appena finita la guerra, dopo pochissimi mesi, ci raggiunse con gioia, anche Enzo, il fratello di Gianni, appena tornato a casa dopo aver risalito l’Italia combattendo come soldato del ricostruito Esercito Italiano, equipaggiato dagli Inglesi. Dopo neppure un anno, iniziarono ad arrivare degli individui che cercavano di Padre Dömotor ( che noi pronunciavamo Demeter)un frate ungherese che, da poco arrivato, si era inserito bene nel nostro gruppo. Era un formidabile giocatore di biliardo. Parlava uno strano italiano, oggi diremmo alla Zeman, ed era molto gioviale, anche se un po’ misterioso. Ogni tanto spariva per poi ricomparire senza dare spiegazioni. Poco dopo la sua comparsa cominciarono ad arrivare degli individui, tutti dall’atteggiamento dignitoso e taciturno; restavano alcuni giorni in convento, uscendo solo la sera e mai allontanandosi dal sito. Il Convento è in zona defilata e dominante, fuori dalla viabilità usuale che invece passa poco sotto, al fianco della ferrovia. Era quello che si potrebbe definire “un posto discreto e tranquillo”.


In generale, appena arrivati, vestivano lunghi inquietanti cappotti di pelle nera, che richiamavano alla mente, uniti ai cappelli a larga tesa, l’abbigliamento classico della Gestapo, la terribile polizia Segreta hitleriana. Poi rimediavano abiti civili. A noi dicevano che erano intellettuali o attori Ungheresi, fuggiti perché ricercati come anticomunisti dagli occupanti russi e vestivano abiti raffazzonati, dati loro dalla Croce Rossa Internazionale. La Chiesa, materna, li aiutava per quello. Quindi veri e propri profughi perseguitati che noi, ormai liberi, guardavamo con simpatia anche se facevano gruppo a sé. Non parlavano con alcuno se non con Padre Demeter e riservatamente. Ogni tanto però qualcuno spariva e subito ne arrivavano altri. Di solito li vedevamo, uscendo alla sera, che facevano crocchio fuori dalla porta del convento ma mai in Chiesa, che noi invece frequentavamo. Mi ricordo che una volta, e vi rimase per alcuni giorni, arrivò un mingherlino piccoletto, dal fisico da ragazzino asciutto pur essendo adulto, ma con degli occhi che mi rimasero impressi. Erano di cristallo quasi trasparenti; oggi li definirei di ghiaccio.

Anche lui, il ragazzino, come gli altri dopo un po’ scomparve e sapemmo che pressoché tutti andavano a trovare pace in Sud America, in particolare in Argentina, all’epoca governata dal Generale Peron, utilizzando molto spesso navi della Costa, molto legata alla Curia genovese, all’epoca retta dal Cardinal Siri. Le navi spesso tornavano poi con carichi di carne congelata o altre derrate; credo rientrassero negli aiuti del dopoguerra, gestiti anche dal Vaticano.
Dopo qualche tempo cessò l’arrivo dei profughi e, con la partenza dell’ultimo di loro, anche Padre Demeter scomparve, insalutato ospite. Di queste presenze i frati non desideravano parlare e, se ben ricordo, di padre Demeter non avevano grande stima: la consegna era il silenzio. Non predicava ne confessava ma, visto lo strano italiano che parlava, la cosa era, per noi ragazzotti, comprensibile. E pensare che alcuni di noi, come chi scrive, affiancavano già i partigiani.

Adolf Eichmann

Simon Wiesenthal
Dopo qualche anno, tutto quell’andare e venire, venne smascherato dal gruppo di Simon Wiesenthal, l’ebreo scampato ai campi di sterminio che si era ripromesso di rintracciare quelle “pantegane”, in qualunque parte del mondo si fossero infognati. Scovarono anche “il ragazzino”; era Eichemann che avevo visto e memorizzato a Pegli. Si seppe che molti di quei “pegliesi” erano <ustascia>, cioè boia di destra croati, di etnia cristiana che si erano messi al servizio dei nazisti per massacrare i loro compatrioti, con la scusa della diversa fede. Una considerazione và fatta: la gerarchia Ecclesiastica non poteva non sapere chi erano quelli che aiutava a scappare se addirittura l’ufficio per salvarli era gestito, in Vaticano, da due Cardinali. Alla domanda legittima: <<perché lo avete fatto?>>, la solita farisaica risposta: << erano anticomunisti >>. E i cinque milioni di ebrei da quei maledetti inceneriti come fossero denaro falso, cosa erano? E i massacri degli ustascia erano giustificati solo perché contro i “comunisti”? Non mi si dica che la Curia non lo sapeva; proprio loro che sanno tutto e che confessano i fedeli. Quando, anni dopo e per lavoro, andai in Venezuela, scoprii che Padre Dömoter, morto da poco, nel frattempo era diventato niente meno che Ordinario Militare della Polizia Venezuelana. L’allora dittatore, Perez Jemenez, affidò a militari nazisti e a membri della Ghestapo transfughi, l’incarico di ristrutturare tutte le sue Forze Armate e la Polizia. Guarda caso, Padre Dömoter c’era un’altra volta di mezzo.
Enzo BAGNASCO
Rapallo, 17 Aprile 2014
TEMPO DI GUERRA... amarcord 4
TEMPO DI GUERRA
AMARCORD... 4
La guerra degli ….altri genovesi
Dal libro < Liguria amore mio> di Renzo Bagnasco-Mursia Editore. Capitolo Y

Senza che nessuno lo potesse sapere, stava per finire quella che, poi, si ricorderà come l’ultima estate di guerra; gli anglo-americani erano ormai padroni assoluti del campo e, in mare, da tempo, non c’era un’imbarcazione italiana e neppure più quelle poche della marina tedesca. Un’ordinanza nazi-fascista vietava infatti l’uso di barche a chicchessia per paura che, fra queste, potesse esserci chi l’avrebbe utilizzata per tenere contatti con sommergibili nemici.
Correva voce che al largo incrociassero navi alleate con tanto di portaerei, indispensabili basi agli aeroplani per continuare a bombardare il Nord-Italia; dopo si seppe che quegli sciami di bombardieri che vedevamo passare, partivano dagli aeroporti del Centro e del Sud-Italia, già in mano loro. Anche in cielo non volavano né aerei tedeschi e, meno che meno, italiani.

I cannoni delle nostre antiquate batterie contraeree, mai ammodernati, avevano gittata utile solo per tentare di colpire i vecchi aerei ma non per arrivare alla quota cui volavano le nuove fortezze volanti che quindi, in pieno giorno e con visibilità ottima, scorgevamo arrivare dall’orizzonte, passarci sopra le teste e andare a portare devastanti distruzioni, nell’entroterra.
Viste così, geometriche formazioni compatte, sembravano fazzoletti di coriandoli d’alluminio luccicanti al sole; l’uno a seguire l’altro, distanziati da un brevissimo intervallo, questi rettangoli rombanti, avanzavano indisturbati. Sotto di loro, nel tentativo di salvaguardare l’onore nazionale, si perdevano i colpi sparati vanamente dai nostri asfittici cannoni; riuscivano solo a disegnare un disordinato tappeto di bianchi batuffoli di cotone, oltre i quali s’intravedeva il greve, indisturbato avanzare degli aerei. Solo dopo aver capito che per noi non c’era più gioco o, semplicemente, perché non avevamo più munizioni, si decisero a far tacere quegli inutili rumorosi ferri vecchi, risparmiandoci le pericolose piogge di schegge che ricadevano, sparpagliate, ad ogni deflagrazione.
Nei primi anni di guerra i bombardamenti avvenivano di notte perché, con il buio, aerei che ancora non volavano molto alti potevano contare sul fatto di non essere individuati. Il nostro sistema d’allarme, leggermente antiquato, era basato sull’intercettazione fonica del rombo dei motori; dei non vedenti erano appollaiati alla base di aerofoni posti in altura per poter spaziare e, grazie alla loro acuta percezione, avvertivano i rumori degli aerei in avvicinamento. A questo punto partiva l’allarme che veniva diffuso alla popolazione attraverso l’urlo di apposite sirene. Quando il rombo era percepibile anche da noi, si accendevano le fotoelettriche, i riflettori militari che sciabolavano il cielo nella speranza, a volte ripagata, di “agganciare” qualche aereo, così da potere concentrare su quel puntino riflettente luce che procedeva contro un cielo nero, tutti i tiri; a volte, lo colpivano. E pensare che i nostri avversari possedevano già il radar.

Sul finire della guerra invece, le nuove formazioni aeree, dopo essere transitate cariche di bombe, ritornavano indisturbate e scariche; il cupo rumore iniziale emesso dai motori sotto carico era, al ritorno, meno pesante del primo, non per questo però meno lugubre. Tutto quell'andare e venire sopra le nostre teste, per fortuna, non interessò chi abitava lungo la battigia, se si esclude Recco e, rispetto agli anni che precedettero l’armistizio, si aveva l’impressione che gli obiettivi che intendessero colpire, ora fossero meglio individuati e più mirati. Evidentemente prima, quando le incursioni avvenivano di notte, erano condotte in maniera anche indiscriminata; l’importante era colpire, annientare il nemico e fiaccare i civili, non essendo facile, al buio, distinguere ogni specifico bersaglio in città rigorosamente oscurate. Se invece lo dovevano assolutamente individuare, lanciavano alcuni “bengala” (razzi illuminanti) che scendendo lentamente, trattenuti in aria da dei piccoli paracadute, illuminavano la zona a giorno, per un tempo tale da consentire d’individuare bene l’obiettivo.
All’epoca era ormai operante il movimento per la Libertà o dei Partigiani, il termine <Resistenza> l’imparammo dopo e, chi ci bombardava, da lì a poco sarebbe, come amico e liberatore, arrivato proprio nelle stesse zone che, appena il giorno avanti, aveva distrutto. E’ innegabile che una certa “confusione” regnava ovunque perchè, in quello stesso periodo, parte di Italiani uniti ai tedeschi, combattevano gli alleati ed i partigiani.
A proposito dei bersagli mirati, fui testimone di due indicativi episodi. Il primo è stato la distruzione di un tratto vitale della ferrovia che collega l’Italia con la Francia, proprio sulla costa a levante di Savona in zona disabitata; solo qualche tempo prima, Novembre 1943, pur di distruggere un simile obiettivo ferroviario, non esitarono a radere al suolo l’intera cittadina di Recco effettuandovi decine di bombardamenti, il cui centro abitato è, da sempre, scavalcato dal gran ponte ferroviario, punto nevralgico e vitale per collegare Ventimiglia con La Spezia.
Torniamo all’episodio che ho iniziato a descrivere; nella tarda mattinata di quel giorno soleggiato, preceduti dal consueto lugubre e appesantito rombo dei motori, arrivarono dal mare gli aerei che, compiendo un ampio semicerchio, si portarono sul bersaglio, volando paralleli alla spiaggia. Da ogni formazione vidi sganciare una quantità di bombe lucide come confetti d‘argento, il cui scoppio, data la distanza dalla quale, emozionato, osservavo la scena, subito non avvertii; mano a mano che le bombe toccavano terra, si vedeva elevarsi un parallelepipedo di fumo che si allungava nella stessa direzione della loro marcia, come gigantesco bruco grigio scuro dalle zampette rosso fuoco che, mantenendo ferma un’estremità, distenda lentamente il suo corpo segmentato. Il fragore della spaventosa, prolungata esplosione giunse qualche istante dopo, assieme all’allarmante sobbalzare della terra su cui poggiavo i piedi, come scossa da un innaturale sussulto.
Solo dopo si seppe che quello che avevo visto era uno dei tre bombardamenti strategici, effettuati pressoché simultaneamente, nell’Agosto del ’44 per evitare che truppe tedesche fresche, accorressero a dar man forte ai camerati impegnati in Provenza a contrastare lo sbarco degli Alleati, fra Cannes e Tolone, effettuato nell’ambito dell’operazione <Dragoon >.
L’altro episodio, verificatosi proprio sopra la mia testa, avvenne nella stessa estate del gran bombardamento descritto; quella mattina, al solito, passarono aerei carichi di bombe e dopo un po’, mentre noi ragazzi stavamo ancora giocando, avvertimmo il familiare rombo degli aerei scarichi, di ritorno dall’ennesima missione. Qualche istante dopo, uno, volando insolitamente solo e a bassa quota, ci passò sopra in fiamme, sorvolò l’Aurelia sfiorando il Castelluccio, un vecchio fortilizio anti-saraceni al confine fra le spiagge di Prà e di Pegli, sul quale avevano installato una mini batteria antiaerea dotata di un cannoncino rapido ma di piccolo calibro. Appena giunto sul mare, vi sganciò il residuo micidiale carico di bombe ancora a bordo per poi, poco più avanti, inabissarsi. Non avemmo neppure il tempo di spaventarci, tanto fu rapido e spettacolare il susseguirsi degli eventi. Una cosa però ricordo bene; se si è nei pressi dell’obiettivo che intendono bombardare, si vedono le bombe cadere a grappolo avvertendo il caratteristico penetrante sibilo prodotto dalle loro alette mentre fendono l’area per mantenerne posizione e direzione, ma se ti trovavi sul bersaglio, quel sibilo sopra di te si trasforma in un assordante e convulso frullare d’ali che cessa solo al momento della lacerante esplosione a seguito della quale, se hai fortuna, ti ritrovi scaraventato a terra da una fortissima, irrefrenabile ventata d’aria calda che travolge quella respirabile.
Quel giorno, passata la paura, uscimmo dal pertugio dove c’eravamo ritrovati senza volerlo, e cercammo di scorgere se, in mare d’ove era caduto il bombardiere, ci fosse qualcuno o galleggiasse qualcosa. Si vedevano solo militari tedeschi che, di guardia sulla spiaggia, si affannavano per trovare una barca da varare per catturare il pilota che loro, con i binocoli, avevano scorto galleggiare; non trovarono alcunché perché, essi stessi avevano imposto che le spiagge fossero sempre sgombre, avendovi fatto costruire degli inutilizzati muraglioni di vallo, intercalati da fortilizi, pronti a difenderci dagli sbarchi Alleati, che non erano neppure nei loro piani mancandone i presupposti logistici e strategici.
Restammo a guardare per cercare di individuare anche noi cosa loro vedessero, quando improvvisamente spuntò, volando a pelo d’acqua e controluce in direzione della terra, un aereo che, arrivato all’altezza del fortilizio, cabrò improvvisamente mostrando sotto le ali, l’inconfondibile stella, simbolo dell’aeronautica americana; dopo un mezzo “loop”, come uno squalo che in acqua mostri, rivoltandosi, il ventre, fulmineamente si allontanò.
Presi in contropiede, gli addetti al cannoncino, giovani bersaglieri arruolati nel nostro ultimo esercito raccogliticcio, non restò che sparargli pateticamente dietro in ritardo e mentre si allontanava; contemporaneamente, inosservato, un idrovolante alleato ammarò vicino al luogo del naufragio, recuperò il pilota e, sempre indisturbato, se ne ripartì mentre tutti erano ancora impegnati a colpire l’aereo, “falso scopo”.
Fui felice per quell’uomo perché, coraggiosamente e rischiando la propria vita, sganciò le bombe solo all’ultimo momento e in mare, un attimo prima di cadere; poteva alleggerirsi prima, per garantirsi una maggior autonomia che gli permettesse d’allontanarsi di più dalla costa a lui nemica ma, così facendo, avrebbe raso al suolo parte dell’abitato di Prà e di Pegli.

Quest'episodio sarebbe rimasto come uno dei tanti fatti bellici a sé stanti se, ogni tanto, qualche giovane aitante funzionario della Soprintendenza alle Antichità della Liguria, stimolato ed indirizzato dai sempre interessati difensori del territorio, non scoprisse, ignorando i precedenti, che proprio nel sito in cui caddero quelle bombe esistono, sparpagliati sul fondale, dei minuti reperti di cocciame antico, già studiati e classificati “insignificanti” da chi la materia la conosceva bene. L’ultima volta bloccarono ritardandolo, spensierati ed impuniti, l’avanzare del porto commerciale di Voltri e affossarono il progetto di un porticciolo turistico, ultimo tentativo di risollevare Pegli dalle ormai perdute speranze di farla risorgere.
Questo costosissimo fervore, è certamente imputabile al fatto che, chi subentra al precedente funzionario, per far sapere che c’è, si precipita a ritrovare a Pegli ciò che tutti ormai sanno esistere: anonimi, minuti cocci di terracotta romana.

Quei reperti, di cui è piena la nostra costa, furono oggetto di una campagna di studi subacquei già nel 1952, condotta dal Professor Lamboglia, padre dell’archeologia sottomarina italiana, che concluse ritenendoli <non interessanti > come risulta da <La nave romana di Alberga - Vol.18, 1952- Rivista Studi Liguri >. Ciò nonostante, regolarmente, si emettono ordinanze di divieto di transito per i natanti e per i pescatori e, per alcuni giorni, pagati ovviamente dai contribuenti, gruppi specializzati nelle ricerche archeologiche sottomarine delle forze dell’ordine, sono inviati sul posto ad effettuare ormai vane ricerche; i lavori vengono regolarmente sbandierati sulla stampa cittadina ma i risultati poi, regolarmente, tenuti ben nascosti in un cassetto di una qualche scrivania istituzionale. Ad aumentare la tensione degli “scopritori” c’è anche il fatto che, fra tutto quel cocciame, ogni volta scoprono dei frammenti di legno, subito attribuiti a schegge di nave romana ma che, invece, appartengono a “chiatte” da lavoro, barconi un tempo in uso in porto, lì inabissati dall’Università di Genova in accordo con l’Autorità portuale, sia per liberarne il porto alla fine della guerra che richiedeva nuove tecnologie di lavoro che per tentare di ricreare un habitat ittico allo scopo di ripopolare di pesci il sito. Vana speranza.
Nel classificare la zona come archeologicamente non interessante, il Lamboglia scriveva < ..si è avuta la certezza che non eravamo di fronte ad un relitto di nave, ma semplicemente a un avanzo di carico di una nave o capovoltasi o affondata e trasportata altrove dalle correnti.>
Pochi però sanno, e certamente meno che meno lo sapeva quel pilota che, se si continuano a ritrovare <scarsi oggetti interi e così “insolitamente” sparpagliati >, la colpa è anche di quel sant’uomo che salvò parte di Pegli e, tornando alla base da quella sfortunata azione, non avrà neppure verbalizzato di aver, piuttosto che niente, distrutto gli avanzi di una vecchia, anzi vecchissima nave.
Renzo BAGNASCO
Rapallo, 17 Aprile 2014
TEMPO DI GUERRA... amarcord 3
TEMPO DI GUERRA
AMARCORD ... 3
La mia guerra fra Prà e Pegli
Dal libro < Liguria amore mio> di Renzo Bagnasco. Mursia Editore. Capitolo X
Il giorno in cui fu dichiarata l’ultima guerra ero, con la famiglia, in villeggiatura a Visone, un paesino vicino ad Acqui Terme; sentimmo l’annuncio, anche se di quel messaggio io capii ben poco. Dall’evidente immediata preoccupazione dei miei genitori e dall’improvviso silenzio che piombò nelle vie del piccolo borgo, in contrasto con il clangore che dalla Piazza di Roma la radio faceva arrivare sino a noi, avrei dovuto capire che qualcosa di grave stava succedendo ma, si sa, i ragazzi, privi d’esperienze di riferimento e sensibili solo alle cose che vedono, non avvertono il pericolo se non quando ormai lo stanno correndo.
Mio padre, che aveva combattuto nella prima guerra mondiale e mia madre, che quella guerra l’aveva subita, compresero subito il dramma; io ci arrivai solo dopo qualche anno.
La prima reazione dei miei fu di ritornare subito a casa come se, una volta là, fossimo al sicuro; ma la “tana” é pur sempre, in emergenza, il luogo istintivamente più protettivo in cui rifugiarsi.
Trascorso il primo anno, la guerra promessa come veloce e facilmente vincibile, si rivelò, per chi sapeva esaminarla obiettivamente, aver preso ben altra piega. A mano a mano che il tempo passava, sempre più frequentemente si sentiva riferire da conoscenti che loro amici, rientrando dal fronte di guerra per curarsi da ferite sofferte o per una convalescenza seguita a quelle, riportavano notizie d’enormi inspiegabili sbagli, di presunti sabotaggi perpetrati dai nostri contro i nostri combattenti e di un’allarmante generale impreparazione.

Tutte queste cose contrastavano con quanto quotidianamente si sentiva dalla radio o io leggevo sul giornalino il <Balilla >, che il “regime” distribuiva nelle scuole; però anche sul <Vittorioso >, Romano vinceva sempre.
Ben presto, la mamma, sorella di un “marcia su Roma” e promotrice essa stessa di una colletta per erigere, nel suo paese natale, un monumento al fante italiano caduto per la Patria nella prima guerra, cominciò a disapprovare quello che stavano facendo i nostri governanti; come tutte le madri aveva intuito, per istinto, che la strada imboccata era quella sbagliata.
I versi che Vito Elio Petrucci ha voluto dedicarle, mi pare centrino il personaggio:
….a cammin-na in to tempo
comme’ na ciossa attenta
a-e vire do farchetto….
Libera traduzione: …e cammina nel tempo come una chioccia attenta ai volteggi del falco…
Mio padre, questa nuova guerra non la capì mai perché era partito, nel 1915, volontario in marina per combattere e vincere, come fece, i tedeschi; a lui che per onorare la parola una volta data era disposto a tutto, non andava proprio giù doverli accettare adesso come alleati. Così facendo avrebbe dovuto considerare nemici da combattere, i figli di quelli che, ventitré anni prima vide arrivare da altri continenti per dargli una mano e molti morire al suo fianco mentre, assieme, combattevano l’austriaco nemico comune.
Credo che questo fosse lo stato d’animo di molti italiani, sicuramente di quelli che, da sempre, rappresentano la maggioranza silenziosa, nel subire la tragedia che ci coinvolgeva.
Noi ragazzi scoprivamo le cose giorno dopo giorno, maturando più in fretta di quanto non lo avesse fatto la generazione che ci aveva preceduto e certamente più di quella che, dopo poco, ci seguì e così le successive; c’entusiasmavamo ad ogni atto eroico del “Balilla” di turno, colpiti anche dalle illustrazioni sempre puntuali d’Achille Beltrame sulla <Domenica del Corriere >, una specie di C.N.N. di allora, non certo per la tempestività dell’informazione ma per la dovizia di particolari disegnati che facevano rivivere al lettore la drammaticità dell’episodio evocato.
A fronte delle festanti “oceaniche” adunate, documentate dalla stampa e dal cinegiornale Lux, contrastavano gli improvvisi, disperati scoppi di pianto in casa dei vicini, dopo che un carabiniere n’era uscito frettolosamente; qualcuno doveva pur portare le ferali notizie. Sempre più andavo prendendo coscienza che il tutto non fosse un gioco.

Le notti poi, destati di soprassalto dal lugubre ululato delle sirene d’allarme, bisognava fuggire nei rifugi antiaerei, veri e propri cantieri mai finiti, sommariamente avvolti in coperte e con in gola l’immancabile alitosi sulfurea dovuta alla levataccia che interrompeva la digestione; ad ogni incursione aumentava sempre più la gente che ricorreva alle gallerie-rifugio, assolutamente inadatte perché ancora in costruzione. Era gente tremante, infreddolita e rannicchiata in quegli acquitrinosi cantieri, mentre il cielo si rischiarava, a sprazzi, per i laceranti, fragorosi scoppi delle cannonate della contraerea. Tutte queste cose innescarono paure mai più sopite; ancor oggi continua a mettermi a disagio il sentire lo scoppio lacerante del “colpo tonante” che avverte della fine dei fuochi d’artificio, sparati in occasione di feste patronali.
A noi però bastava una successiva giornata di sole per dimenticare, apparentemente, la squassante notte, ma non così per gli adulti che assommavano alla loro, anche la paura per la nostra incolumità, con davanti, ogni giorno, sempre più nere prospettive.
Il 25 Luglio del ‘43 ed il successivo 8 Settembre, sconvolsero la vita della mia famiglia; l’alleato tedesco, sentitosi tradito dai nostri governanti, si tramutò di colpo in aguzzino, cercando di evitare che il soldato italiano gli sgusciasse fra le grinfie, rivestendosi in borghese con abiti rimediati, aiutati in ciò dalla popolazione e per di più convinto, visto che nessuna autorità lo smentiva, che la guerra fosse davvero finita e, comunque, da sfuggire. Non voleva essere lui a pagare le colpe di codardi pasticcioni che in quel dramma ci avevano trascinato e poi, felloni, erano fuggiti lasciandoci soli e senza guida.
Era obiettivamente difficile capirci qualche cosa; noi ormai parteggiavamo per quello che, ufficialmente, avrebbe dovuto essere ancora il nostro nemico.
Ascoltavamo i suoi notiziari, diffusi da Radio Londra nel buio della sera; si cercava di captarla, sintonizzandosi sino a che non si sentiva l’inconfondibile lugubre ripetitivo tambureggiare che segnalava l’inizio del notiziario, subito seguito dalla trasmissione vera e propria che, ancorché disturbata dalle interferenze emesse dalla censura fascista, riuscivamo, in qualche modo, a sentire, compreso i criptici <messaggi speciali > che l’emittente mandava in onda in chiusura e rivolti ai partigiani per coordinarli; ognuno di noi, sentendoli, li interpretava a modo suo, decifrandone ad orecchio l’astruso significato.


Erano i nuovi alleati che, da nemici, erano tornati amici come nel ’15 -’18, anche se continuavano a bombardarci o tenerci svegli con il loro onnipresente “Pippetto”, l’estenuante ricognitore De Havilland “moschito” costruito per non essere facilmente individuabile da eventuali radar che noi non avevamo e idoneo al volo notturno.
Mio padre, non avendo aderito alla causa fascista, non trovava facilmente lavoro e, buon per noi che, almeno alla fine ci sia riuscito, rimediandone uno insolito e “asettico”; poco prima dello sfascio nazionale, lo accettò anche perchè fuori Genova: il cercatore d’oro alle Ferrere, due cascine poste sopra il lago di Lavagnina, nella zona di Lerma, ad Ovada. Và anche detto che quelle miniere erano già state sfruttate e abbandonate dalle legioni romane e, poi, dai napoleonici.
Solo ora capisco che la società che gli garantì il lavoro, sicuramente aveva, all’italiana, trovata la strada per ottenere un qualche finanziamento per il recupero e la riattivazione di vecchie miniere d’oro, nell’intento, ormai vitale, di procurare nuove ricchezze da buttare nel divorante crogiuolo della guerra.
Per la verità, d’oro se n’estraeva una quantità ininfluente, ma evidentemente sufficiente ad ottenere nuovi finanziamenti, specie se elargiti da mano compiacente. A tutte queste cose però all’epoca nessuno pensava e, meno che meno, mio padre che, concordato lo stipendio, si buttò nella nuova avventura con l’entusiasmo che lo contraddistinse in tutte le sue intraprese che, prima di tutto, per attirarlo dovevano stimolarlo. Molto giocò sulla scelta il fatto di poterci portare lontano dai pericoli insiti nel restare a vivere in Città.
Mi ricordo di quando si inventò un’attività, sempre per cercare di sbarcare il lunario durante il conflitto senza dover arrivare a compromessi con le sue convinzioni contrariamente a molti suoi colleghi che invece lo fecero ritrovandosi, alla fine, ricchi e incensurati. Il suo atteggiamento d‘allora, ancor oggi condivido. Ma torniamo alla nova iniziativa: si mise a rigenerare le lime perchè durante quegli anni terribili non si trovava quasi nulla, essendo tutto finalizzato alla produzione bellica. Immaginarsi quindi l’acciaio che era divenuto, al di fuori del giro bellico, introvabile per chi, artigiano, lavorava senza poter accedere alle “commesse” militari. Realizzò dei vasconi di legno che riempì con soluzione elettrolitica e, nei quali immergeva vecchie lime usurate; la corrente galvanica che le attraversava, corrodeva uniformemente le superfici esposte, rimodellando in qualche modo le asperità iniziali. Meglio che niente!
Tutta la famiglia, non appena noi figli terminammo il lacunoso anno scolastico, frequentato a singhiozzo fra un allarme aereo ed un bombardamento, si trasferì nel basso Piemonte a Cravaria, ai piedi delle Ferrere e poco prima della diga che formava il lago della Lavagnina, zona lontana dalle incursioni e che, essendo agricola, garantiva la farina, il latte delle vacche locali ed un forno a legna per cuocervi del pane casereccio e potervi arrostire la selvaggina che mio padre, abile cacciatore, ci procurava. Per noi ragazzi tutti quei prati da potersi godere in assoluta libertà ci facevano scoprire un’indipendenza inattesa; la fantasia era poi stimolata da dei grandi cumuli di sassi, ancor oggi esistenti, ammonticchiati lungo il fiume da generazioni successive di cercatori d’oro, che immaginavamo rovine di vecchi castelli, crollati sotto i nostri assalti. E’ paradossale ma in tempo di guerra si gioca alla…..guerra.
Lì ci sorprese l’8 Settembre del 1943.
Con mio fratello, dopo aver procurato ai pochi soldati italiani presenti in zona a protezione della menzionata diga, degli abiti civili per consentir loro di tornare alle rispettive case, andammo ad ispezionare le due batterie di mitragliatrici pesanti antiaeree, sistemate ai lati di quello sbarramento e proprio sopra la casa del guardiano. Arrivati, anche se non molto pratici, c’industriammo per sabotare quelle armi e, tanto toccammo e girammo, che riuscimmo a smontarne tutti gli otturatori, gettandoli poi nel sottostante lago assieme alle cassette contenenti i pezzi di ricambio. Convinti di non essere stati visti da alcuno, dopo l’irreparabile sabotaggio rientrammo a casa senza far menzione della nostra impresa; purtroppo le cose non andarono lisce come noi pensavamo. Il guardiano pare ci avesse visto e subito riferì ai suoi superiori; questo è almeno quello che ci siamo sempre sforzati di credere per scartare la delazione politica, che ci avrebbe visto, all’epoca, nei panni di vendicatori impietosi.
Fatto si è che due giorni dopo una colonna militare motorizzata, composta di quattro o cinque mezzi tedeschi, sbucò dalla polvere sollevata dalla strada di terra battuta che arriva da Lerma, fermandosi al bivio di Cravaria davanti all'allora nostra casa; ancor oggi, proseguendo in piano, si va alla centrale elettrica mentre, salendo, si arriva alla diga.
Mia madre, alla quale avevamo poi raccontato quel segreto per noi troppo grande, seguì, celata dalla tendina, i movimenti di quei militari, cercando di capire, attraverso gli atteggiamenti e i gesti, quali ne fossero le intenzioni. Dalla prima anfibia, che seguiva la staffetta in moto, dopo un concitato parlottare e sbattere di tacchi, si staccò un Maresciallo dei Carabinieri, certamente guida e interprete, che si diresse senza titubanze verso di noi e bussò alla porta.
Facile immaginare l’effetto che quel battere fece su tutti noi; quando mia madre aprì, papà era per fortuna a lavorare, credo le si leggesse in viso tutto il dramma. Il Maresciallo, usando un linguaggio volutamente burocratico, fece finta di non averci identificati ma ci fece chiaramente capire che sarebbe stato meglio, anzi, molto meglio se quando fossero ritornati dalla loro ispezione, dopo aver attinto maggiori notizie dal guardiano delatore, non ci fossimo fatti più trovare. Per il momento avrebbe preso tempo, riferendo che non gli eravamo sembrati i ricercati.
Sono convinto che la nostra famiglia gli debba la vita; da quel giorno ho capito perché l’arma è nota anche come “Benemerita”. Quel sant’uomo, che non abbiamo mai più rivisto, speriamo non abbia pagato con la vita, altri gesti di generosità compiuti, come questo, per puro altruismo.
Tornati a Pegli, per noi ragazzi ci fu un solo scopo; continuare a fare quello che iniziammo lassù. C’intrufolammo fra i tedeschi che occupavano la zona, giocando alla guerra con divise e finte armi simili alle loro ma da noi confezionate, in modo da accattivarci le loro simpatie; alcuni erano padri e altri addirittura nonni, richiamati alle armi come truppe d’occupazione, così da liberare i loro giovani per poterli mandare a morire al fronte.
Di loro mi è rimasto l’acre afrore del sego, largamente usato per mantenere morbidi gli stivaletti e le pelletterie, parte importante dell’abbigliamento e l’insolito gusto e odore della loro gialla margarina spalmata sullo squadrato, acidulo pane di segale. Da queste frequentazioni ricavammo la notizia che stavano ultimando di minare i sentieri e i dintorni che portavano alla batteria contraerea della Bastia, posta sulla punta del colle che accoglie la Torre Cambiaso, a Prà, subito a ponente di quella della Marina installata sul Castellaccio, una collina che sovrasta il Lido di Pegli.
Decidemmo di “dare una mano agli alleati” anglo-americani, sminando quei sentieri. Il pomeriggio stabilito mio fratello, il cucino Franco ed io c’intrattenemmo, più a lungo del solito in modo che, al primo buio, anziché tornare a casa, avevamo informato i nostri ignari genitori che saremmo rimasti più tempo colà, c’inerpicammo per le “fasce” per raggiungere la zona prefissata.
La luce della luna, sbucando ogni tanto fra le smagliature delle nuvole che correvano veloci sfilacciate dallo scirocco, rischiarava ad intermittenza non prevedibile, la zona, stagliando, ogni volta contro il cielo scuro, ma non del tutto nero, la sagoma della sentinella armata che, alla sommità della collina, faceva la guardia girando fra le varie piazzole della batteria camminando sul basso muretto che le contornava. Noi, inerpicandoci dal di sotto, eravamo nascosti alla sua vista dalle lunghe ombre dei cespuglietti mentre, lei, era visibile ogni volta che ispezionava quelle proprio sopra di noi; raggiunto il sentiero, avanzando carponi, dovevamo innanzi tutto capire dove e com’erano state sotterrate le mine antiuomo, congegni anch’essi a noi sconosciuti. Più tardi scoprimmo che erano scatolette di legno con, appena appoggiato sopra, un coperchio mobile e imbottite d’esplosivo; pigiando inavvertitamente con il piede sul coperchio, questi si rincalcava sulla scatola sfilando la sicurezza che tratteneva la molla con il percussore che, colpendo il detonatore, innescava l’esplosione.
Camminavamo gattonando in fila indiana; il primo sondava con un bastoncino di legno il tratturo antistante nel tentativo di scoprire almeno un po’ di terreno smosso; al primo indizio, scavammo con delicatezza e vedemmo che avevano sotterrata quella mina vicina al ciglio esterno dello stretto percorso, mentre, al centro, la terra appariva compatta; lentamente, con le mani la dissotterrammo scoperchiandola, così da evitarci brutte sorprese in caso d’inavvertita pressione.
Chi la scavò la passò, aperta, a chi lo seguiva e, da questi, una volta neutralizzato il percussore-detonatore, al terzo che doveva riporla in un sacco. Riprendemmo, sempre acquattati, a ricercare la seconda; impresa non facile per chi, come noi, non aveva la più pallida idea di come le avessero dislocate. Bisognava, ad ogni bagliore di luna, individuare altra terra smossa, prima di poter avanzare o appoggiare le mani su un territorio così infído; occorreva anche controllare che la sentinella non ci scorgesse, ogni qual volta il suo ripetitivo giro di ronda la portava sopra di noi.
Finalmente ecco la seconda mina; era occultata alla base della scarpata, dalla parte opposta della prima, sul lato verso monte del sentiero, ma mezzo passo più avanti della prima trovata; fu facile poi scoprire lo schema perché le avevano seppellite a scacchiera lungo i lati del percorso, distanziate dello spazio di un normale passo, lasciando invece accessibile il centro. Trovata la chiave, proseguimmo estraendo la terza e poi la quarta; la quinta, nel passarcela di mano, sfuggì alla presa.
Trattenemmo il fiato mentre la scatoletta, per fortuna senza più il coperchio che, rotolando, avrebbe potuto far scattare il percussore nel bel mezzo di un campo minato, ruzzolava balzellando lungo la scarpata. Morti di paura ad ogni suo cozzare contro un ostacolo, la seguivamo senza neppure più respirare; finalmente si fermò e, tutto quello che a noi sembrò un trambusto, non fu avvertito dalla sentinella che si trovava in quel momento, evidentemente, dalla parte opposta. Senza parlarci ma con gli occhi dilatati, decidemmo di abbandonare l’impresa e, quatti quatti, tornare a casa.
Finita la guerra, solo vedendo i film sui marines intuimmo il perché di quell’inspiegabile posizionamento; vedemmo che abitualmente avanzavano in fila, camminando sui cigli, così da lasciar sgombra la corsia centrale per usi di servizio ed, in oltre, in caso d’attacco aereo era più facile sottrarvisi, buttandosi al riparo delle scarpate, piuttosto che rimanere facile bersaglio, visibile a centro strada.
Naturalmente, come capita ai ragazzi, una volta che scoprimmo il “giochino” ne scemò anche l’interesse e non vi ritornammo più; la paura del pericolo scampato non c’influenzò più di tanto, perché solo ora ne capiamo il vero rischio di quello che, all’epoca, ci sembrava un eccitante gioco.
Per fortuna gli alleati non aspettarono il nostro contributo per venirci a liberare.
Nel frattempo, eravamo agli inizi del ’44, alla Lavagnina e dintorni, molti ragazzi genovesi in età di leva, vi si rifugiarono per non partire per il fronte, essendo voce comune che la guerra, ormai definitiva persa, da lì a poco, sarebbe finita; l’idea di <resistenza > venne dopo, anche se proprio in quel periodo iniziarono a coagularsi le Brigate partigiane, che capitanate da ex ufficiali dell’esercito italiano cominciarono a darsi un’organizzazione, collegandosi con gli alleati.
La presenza in zona di sempre più numerosi “renitenti” che i nazisti chiamavano “banditi”, non passò inosservato ai tedeschi sino a che, un brutto giorno, una nutrita autocolonna risalì quelle strade, non più accompagnata da comprensivi Carabinieri ma, questa volta, spalleggiata dalle squallide Brigate Nere con il compito di fare piazza pulita di tutti quei giovani disarmati. Fu una carneficina; un folto gruppo fu tradito dal fanciullesco attaccamento ad un cagnolino randagio, che, adottatolo, portarono con loro a nascondersi nel buio delle gallerie delle miniere d’oro, i cui lavori, ripresi da mio padre, erano nuovamente sospesi per il precipitare degli eventi. Al vociare dei perlustratori, il bastardino iniziò ad abbaiare, tradendo il gruppo. Nessuno si salvò.
Un altro, studente di medicina all’Università di Genova, fu ferito in un bosco, di là del fiume, proprio davanti a Cravaria e lì dovette morire dissanguato, fra lamenti strazianti, perché fu proibito ai contadini di portargli soccorso; la prima a scoprirlo fu un'anziana pia donna, tale fu davvero la pietosa signora Volpe, che sino a che il giovane era in vita, nonostante le lacrimevoli perorazioni, non riuscì ad impietosire il responsabile di quella carneficina. Solo quando, dopo quarant’otto ore, la voce non si avvertì più, le fu concesso di avvicinarsi al corpo di quel martire che, a furia di sfregare la nuca a destra e sinistra per il dolore, aveva lasciato nel terreno un incavo.
Mi piace pensare, e questo ho sempre detto ai miei figli, che anche da quella piccola cavità, sia germogliato l’albero della nostra libertà.
Dovettero passare molti anni per non sentire più, nelle notti di vento, quelle strazianti invocazioni di soccorso, inutilmente emesse da un giovane, non ancora ventenne, rimasto anonimo e che non accettava una morte così atroce ed inutile.

Tutti quei giovani, anche quelli i cui nomi non sono incisi nel marmo, ma che egualmente caddero, sparpagliati, nelle zone vicine, sono e debbono essere accomunati con i <Martiri della Benedicta >.
Ogni qual volta ritorno in quella vallata salendo da Lerma, fermo la macchina poco più avanti del bivio con Casaleggio e, nel silenzio di quei luoghi non frequentati, nell'ascoltare dall’alto lo sciacquio del sottostante torrente Lavagnina, penso a quanto scrisse il poeta Edoardo Firpo né <Ai Martiri di Crovasco >
………………………………
Ma in ta gran paxe di monti
se sente l’eco de l’aegua
lontan ch’a-i ciamma, ch’a-i ciamma.
Libera Traduzione: ■ Ma nella gran pace dei monti si sente l’eco dell’acqua lontana che li chiama, che li chiama.
In quel periodo, noi tre, sempre più affiatati, eravamo consapevoli di appartenere alla medesima “banda”; nonostante imbevuti di spirito patriottico che, come Balilla, c’era stato inculcato il senso dell’onore e della patria, come per tutti i ragazzi, la libera “banda” d’appartenenza, era cosa più importante. Certo una mano ad alimentare il nostro disincanto ce la davano, senza saperlo, anche i famigliari, evidenziando gli errori che commetteva chi governava l’Italia in quei tempi.
Il termine <partigiano > cominciò a circolare poco dopo, anche se loro, per i nazisti e per i residui fascisti erano ricercati, lo abbiamo già visto, come <banditi>; a noi, tali non parevano e fu quindi naturale che il nostro giovanile spirito di contraddizione ce li facesse, al di là delle nostre convinzioni, ammirare; decidemmo di stare con loro visto che molti di loro erano nostri amici anche se un po’ più anziani di me. La ricostituzione dell’esercito italiano dopo l’otto Settembre, avvenne al Nord, sotto il pungolo e il controllo nazista che, allo scopo, manovrava i fascisti aderenti alla appena inventata Repubblica di Salò; crearono reggimenti che, almeno nel nome, usurpavano pagine di gloriose eroiche epopee passate, nella vana speranza di accattivarsi le simpatie del popolo. Ricostituirono così gli alpini, gli assalitori di marina, la X MAS ed, in fine, i bersaglieri.
Contemporaneamente un altro esercito si era ricostituito sotto l’egida alleata e capitanato dai vecchi comandanti, iniziò, al fianco di quelli, a risalire l’Italia per liberarla. Di loro e di tutti i loro morti, la strumentalizzata propaganda del dopoguerra non ne parla mai, così come non menziona mai i seicentomila militari italiani lasciatisi marcire nei lager nazisti pur di non aderire al nuovo governo fantoccio che continuamente li blandiva assicurando loro una mendace libertà. E si che gli uni e gli altri sono stati, a tutti gli effetti, combattenti e morti per la nostra libertà, quindi dovrebbero essere commemorati ogni qual volta si parli di Resistenza. Ma si preferisce esaltare chi molto spesso occupò le città solo dopo che i tedeschi occupanti se ne erano andati, vedi Genova e Milano.
Al confine fra Prà e Pegli, nella grande area delle ex ferriere Ratto, poi divenuta ILVA, c’erano dei capannoni abbandonati con un gran piazzale che li univa, attraversato e servito da binari dell'abbandonata rete ferroviaria interna che, un tempo, collegava il vicino pontile sul mare cui attraccavano i battelli che fornivano il minerale ferroso, alle fonderie e, da queste, alla rete ferroviaria nazionale. Queste peculiarità fecero sì che tutti gli eserciti che si sono succeduti, utilizzassero il sito come prima zona d'accorpamento e successivo smistamento. Iniziarono i tedeschi che la occuparono in forze così come fecero con il resto dell’Italia non ancora liberata dagli alleati; poi, ricostruito l’esercito italiano fantasma, vi acquartierarono i giovani di leva, chiamati a difendere il nuovo regime, ma che non avevano però pienamente aderito da poter essere inquadrati fra le forze fasciste, tipo Brigate Nere o Muti. A loro bastava non essere considerati renitenti.
Furono accorpati in un raccogliticcio reggimento di bersaglieri e, proprio lì, completavano il loro addestramento; n'approfittarono anche per utilizzarli, come comparse, in documentari cinematografici che il regime faceva “girare” nei boschetti di Villa Doria a Pegli, ambientandovi improbabili azioni anti-partigiane che, distribuiti nelle sale cinematografiche sotto il loro controllo, dovevano figurare essere avvenute sul serio e in montagna.
Quando toccò il turno degli Alleati, anche loro la requisirono per mettervi a riposare, nell'attesa d'ordini, i loro uomini stanchi del fronte. Noi della “banda”, a quel tempo, abitavamo in quella che era stata una vecchia masseria dei Marchesi Cambiaso, proprio al di qua del muro di cinta di quel piazzale e non potevamo quindi che subire l’influenza e il fascino di tanta variegata umanità in divisa.
Durante l’occupazione dei bersaglieri e della Wermach, quel parco ferroviario con annesse officine, divenne luogo ove raggruppare per effettuare riparazioni e manutenzione, treni ricolmi di mezzi cingolati avariati sui vari fronti; un giorno arrivò un convoglio stracolmo di carri armati leggeri italiani, nuovi di fabbrica, con la tipica mimetizzazione da utilizzarsi nella guerra d’Africa; peccato però che nel frattempo l’avevamo già persa unitamente al Sud e al Centro d’Italia.
Di notte il treno era minuziosamente sorvegliato mentre, di giorno, vista la contemporanea presenza di tanti militari, aveva fatto ritenere superfluo un tale impegno. Nell’ora del rancio, mio cugino Franco, senza avvisarci, salì su di un vagone, s’infilò nel carro armato più vicino al gran cancello in disuso, arrugginito, rabberciato e utilizzato solo raramente come uscita d’emergenza dei treni. E’ poi rimasto un mistero come, lui ragazzino, possa essere riuscito, ci disse di essersi aiutato utilizzando gli attrezzi in dotazione al carro trovati all’interno, a smontare e trascinare fuori la mitragliatrice che affiancava il cannone, il cui peso è elevato; basti pensare alla canna esterna che, per proteggerla dalle armi nemiche, era costruita con esuberanza di acciaio. A cose fatte ci venne a chiamare e, poco prima del coprifuoco, allora ormai in vigore, andammo a prelevare l’arma da lui sommariamente nascosta, per riporla nel nostro nascondiglio segreto che, ben presto, si riempì d’armi d’ogni tipo, tutte sottratte a quello che, nel frattempo, era divenuto il nemico della nostra “banda”.
Tutta quest'attività non poteva poi che sfociare nelle Squadre d'Azione Partigiana, nel frattempo formatesi e operanti in Città in appoggio coordinato con i partigiani sui monti; l’unico rammarico fu che, solo mio fratello, il più anziano dei tre, fu accolto nel locale 334 Brigata Partigiana di Prà. La nostra “banda” però continuò ad operare come prima ma, adesso, fiancheggiando chi si era prefissata un’azione orientata al bene comune; questa decisione ci diede la prima vera responsabilità.
Senza saperlo avevamo dato l’addio al ragazzino che ormai non era più in noi.
Renzo BAGNASCO
Rapallo, 17 Aprile 2014
TEMPO DI GUERRA ...amarcord 2
TEMPI DI GUERRA
AMARCORD... 2
Un mio NATALE da ragazzo

L’inverno del ’44 – 45 non finiva mai. Era di un freddo mai sofferto prima e con certe nevicate inusuali, almeno per noi del ponente di Genova. Nessuno sapeva che era l’ultimo Natale di guerra. Il mare, in certi giorni, dava l’impressione che ‘fumasse’ per l’impatto con l’aria gelida. Un giorno vidi, quasi sotto costa, due balene che avanzavano affiancate sbuffando.

Per ragioni di sicurezza, in mare non passava alcuna imbarcazione ormai da tempo. Le uniche unità erano dei rari scuri motoscafi tedeschi, in giro di perlustrazione.
All’imbrunire scattava il coprifuoco e chiunque, non autorizzato, fosse stato sorpreso per le strade, poteva essere passato subito per le armi. Noi ragazzi subivamo queste ristrettezze ma chi più ne soffrivano erano i nostri genitori impossibilitati, ad esempio, a poter, la sera, aiutare un congiunto ammalato a casa sua. Per riscaldarci si bruciavano palle di carta che facevamo in casa, macerandola e facendole poi asciugare al sole. La legna era pressoché introvabile.
La settimana prima di Natale noi ragazzi cominciavamo a tirar fuori da una sdrucita scatola sistemata sotto al letto, i vecchi “macachi” in terracotta di Albissola; quando si rompevano il problema era incollarli. Non esistevano, come ora, tutti i tipi di colla per qualunque qualità di materiale: l’unica era la colla da falegname, la stessa che già usava San Giuseppe quando Gesù era ancora Bambino! ma quella colla non reggeva l’umidità ne resisteva ai colpi. Tutto il vantaggio del progresso e dell’aggiornamento, da noi arrivò solo dopo la guerra.
Mio fratello, mio cugino Franco ed io andavamo poi sulle colline sopra a Prà per staccare con le spatole il pan di bosco che, con il freddo e l’umido, ricopriva certe rive ombrose lungo i piccoli corsi d’acqua. Tutto il mancante lo realizzava la fantasia e la carta che sporcavamo, illudendoci rassomigliasse a roccia. Il cielo di carta blu con le stelle lo vendevano i cartolai e, se era “velina”, si poteva, con il meccano, giocare sulla trasparenza creando un’asta rotante con in cima una lampadina da pila, a simulare il percorso lunare. Gli stessi vendevano anche i presepi “autarchici”, cioè fogli di cartone con su stampate a colori, le figurine del presepio, da poi ritagliare.
Non si usava l’albero. L’unico era l’antico ramo d’alloro ( a ramma d’ofêuggio ) che i macellai legavano all’esterno del negozio; per la Festa, donavano ai migliori cliente i “berodi” ( sanguinacci) e qualche “ scianchetto” d’alloro. In alcune case si allestiva una specie di albero, addobbando un ramo con cioccolatini, mandarini e canestrelli. In genere erano marittimi che avevano visto qualcosa di simile nelle Americhe: insomma, un albero di Natale ante litteram.

Il vero e proprio albero di Natale, quello classico, lo scoprimmo per la prima volta attraverso le finestre del bovindo del Comando che la Wehrmacht aveva insediato nel Castello Vianson, in cima alla passeggiata di Pegli. Quello sì era tutto un brillio e lustrini.
Il pomeriggio della vigilia eravamo andati in casa di Franco ad aiutarlo a realizzare il suo Presepio. Visto che si faceva buio, anche se eravamo abbondantemente nell’ora “libera” dal coprifuoco, decidemmo , mio fratello ed io, di rientrare.

Intanto giungevano dall’attigua caserma delle Brigate Nere schiamazzi e spari di festa. Alcuni, ormai ubriachi, sostavano cantando davanti al portone d’entrata della stessa. Come arrivammo sulla strada, uscendo dal giardinetto che la distanziava dalla casa, li sentimmo vociare e muoversi di corsa verso di noi. Rientrammo naturalmente nel giardino ma loro irruppero, sparandoci. Ci appoggiammo al muro della casa e quelli, urlando, ci bloccarono puntandoci le armi al petto. Uscirono anche le zie e, dopo un lungo battibecco alternato ad urli, quei ceffi puzzolenti d’alcool se ne andarono. Sul muro i segni dei proiettili ci sono ancora.

Nel frangente mio fratello, poco più grande di me, che aveva in tasca delle pallottole da moschetto ed operava già con la SAP di Prà ( Squadra Azione Patriottica) le aveva fatte scivolare per terra mentre quelli ci tenevano fermi per il collo. Per fortuna, cadendo, non avevano fatto rumore perché eravamo finiti con i piedi dentro ad una bassa aiuola. Solo il mattino dopo le raccattammo ma quella sera, avute le loro assicurazioni, rientrammo di corsa a casa a raccontare l’accaduto. Il mattino dopo, Natale, i nostri genitori andarono a protestare con gli Ufficiali che, imbarazzati porsero le scuse, adducendo l’accaduto al fatto che quei “masnadieri”, sentendosi proprio sotto Natale, soli, invisi alla cittadinanza e ormai terrorizzati per la imminente fine, aggiungo io, si erano ubriacati per darsi coraggio e affogare i rimorsi e le inquetudini.
C’è andata bene. Ricordo bene quel Natale perché, dopo quell’episodio, mai più nessuno mi ha festeggiato a colpi di …. mitra.
Renzo BAGNASCO
Rapallo, 17 Aprile 2014
TEMPO DI GUERRA ...amarcord 1
TEMPO DI GUERRA
AMARCORD...1
Mi ricordo di quando vidi per la prima volta le truppe americane arrivare al Castelluccio di Pegli, al ponente di Genova, dove allora abitavo. Fu la mattina del 27 Aprile ’45. Era una bella giornata primaverile di sole e si “respirava” un’aria strana, d’attesa. Dopo anni, non si sentivano più spari.

Seppur lentamente e tra mille difficoltà, la V Armata proseguì l’avanzata lungo l’Italia raggiungendo Pisa e dopo aver sfondato la “Linea Gotica” anche le altre città del nord tra cui Genova.
Avevamo saputo che la sera prima gli uomini della V Armata americana erano entrati in Genova, trovandola già liberata dai partigiani. Noi ragazzotti, il mattino dopo ci schierammo lungo l’Aurelia, là dove fiancheggia la ferrovia che la protegge dal mare. Eravamo accorsi per vedere gli americani, che per tante notti ci avevano tenuti svegli con i loro bombardamenti. Li conoscevamo solo attraverso i manifesti del “regime”, disegnati da Boccasile; in particolare quello < il liberator>, dove un ceffo, pilota negro, massacrava le nostre città. Ciò nonnostante non c’era risentimento tanto era l’odio e l’avversione verso i nazi-fascisti che ci avevano oppressi e coerciti. Tutto silenzio e i binari, raramente usati, arrugginiti. La strada era stranamente vuota, senza neppure le rare auto tedesche o i loro camion grigio-scuri; i mezzi privati, quelli, erano da tempo scomparsi a furia di ordinanze ostative imposte sia dalle Brigate Nere che dalla Wehrmacht. Solo alcuni medici potevano circolare avendo però i fari schermati e i parafanghi dipinti di bianco per individuarli. Finalmente a metà mattinata, in questa ovattata attesa, vediamo scendere lungo il rettilineo, una strana e buffa auto color senape simile ad una scatola scoperchiata, che in seguito imparammo a chiamare < Jeep>, quasi un cartone animato, occupata da giovanotti con divise attillate e con gli “anfibi” appoggiati al di fuori di quella “mezza” auto, mancante della parte superiore. Seguiva una colonna di grandi camion pieni di soldati festanti che, passandoci davanti, ci buttarono sigarette e cioccolata; dai mezzi usciva musica e per la prima volta vedemmo gli occhiali “ray ban”. Che contrasto con i nostri poveri militari indossanti sformate divise sdrucite e con i polpacci stretti da fasce che, se si allentavano, cadendo ti facevano inciampare; bastava correre un po’ perché ciò avvenisse o con i rigidi e anziani soldati richiamati della Wehrmacht, dagli stivaletti ferrati, sempre odoranti del grasso utilizzato per ammorbidire i loro accessori in cuoio, e di margarina spalmata sull’acidulo Roggenbrot. Gli americani, appena potevano, giocavano. Acquartieratisi nelle caserme abbandonate dal Regio Esercito ormai scomparso e poi da quello fantoccio della Repubblica Sociale Italiana, che raggruppava in “Bersaglieri” i giovani di leva che non avevano il coraggio di andare con i partigiani ma decisamente ostili a continuare la guerra. Di loro né i padroni tedeschi ne le sanguinarie Brigate Nere si fidavano; li tenevano lì in quiescènza. Alcuni di quei locali erano, sino a due giorni prima, ancora occupati dai tedeschi. Gli americani, trascorrevano il tempo giocando tirandosi una palla, utilizzando grandi guantoni. Era l’esercizio per tenersi in forma con quello che poi conosceremo essere il “baseball”; altri leggevano i loro fumetti formato tascabile (quelli i cui eroi ancor oggi leggiamo) dalla caratteristica stampa che odorava di citrato. Tutti i confort, carta igienica e dentifricio compresi, li seguivano da sempre al pari dei loro armamenti e al vettovagliamento così come la posta, che veniva distribuita giornalmente. Il rancio poi, anziché versato nella italica gavetta con gli eterni rigatoni al monotono sugo di pomodoro, veniva servito nei vassoi a scomparti che permetteva ai singoli di scegliere nel vasto menù. Una cosa m’è rimasta impressa: il loro pancarré sfacciatamente bianco e il cibo che avanzavano. Se penso al menù del nostro esercito che ammetteva una sola variante: solo se ne avanzava potevi richiedere il bis. Bevevano acqua spillandola da loro sacche scure appese e disinfettate ad evitare possibili infezioni. Sulle loro bottigliette di birra, per la prima volta vedemmo la scritta < non conservare, buttare >. Dopo pochi giorni di stanziale permanenza, incominciò l’approccio con la cittadinanza; i più ardimentosi portavano a lavare la loro biancheria alle nostre donne e davano, per poterlo fare, elmetti pieni di benzina come se avessimo in casa il lavaggio a secco. La potevano portare perché i loro elmetti erano scodelle metalliche senza fori che si calzano su di un sotto-elmetto di fibra, completo di aereazione e adattamento alla testa. La benzina, rivenduta poi, valeva ben più di un pezzo del residuato caustico sapone di guerra. Spesse volte dalla biancheria passavano al letto, battezzando con un nuovo nome un vecchio mestiere: “segnorine”. Dei partigiani, quelli con il fazzoletto al collo, gli americani avevano paura e diffidavano, evidentemente frutto del loro indottrinamento; se in un Bar ce ne fossero stati, quelli non entravano.

A far rispettare al loro interno la disciplina, ci pensavano gli < MP>, eternamente in jeep e armati con lunghi manganelli di legno dipinti di bianco. La bianca fascia al braccio con la scritta <MP>, Military Police, li rendeva riconoscibili e temuti.
Tutti avevano camicie e pantaloni sempre con la riga: capimmo poi che quelle “righe” non erano il frutto di continue stirature ma rese stabili con la macchina da cucire. I loro graduati, contrariamente ai nostri e a quelli tedeschi carichi di orpelli, gambali e brillii d’oro, erano vestiti come gli altri soldati: unico ‘distintivo’ erano dei rettangolini dorati , uno o più a seconda del grado, fissati sulle punte dei colletti e sugli elmetti.
Il fatto che ricordi queste cose mi rattrista: sto’ diventando veramente vecchio. Mi consolo pensando però che, almeno, io le ho viste e vissute.
Renzo BAGNASCO
Rapallo, 17 Aprile 2014

