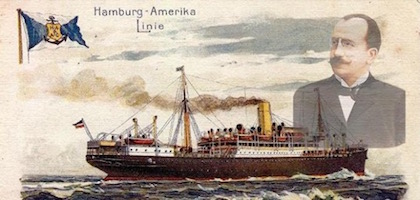TEMPO DI GUERRA ...amarcord 1
TEMPO DI GUERRA
AMARCORD...1
Mi ricordo di quando vidi per la prima volta le truppe americane arrivare al Castelluccio di Pegli, al ponente di Genova, dove allora abitavo. Fu la mattina del 27 Aprile ’45. Era una bella giornata primaverile di sole e si “respirava” un’aria strana, d’attesa. Dopo anni, non si sentivano più spari.

Seppur lentamente e tra mille difficoltà, la V Armata proseguì l’avanzata lungo l’Italia raggiungendo Pisa e dopo aver sfondato la “Linea Gotica” anche le altre città del nord tra cui Genova.
Avevamo saputo che la sera prima gli uomini della V Armata americana erano entrati in Genova, trovandola già liberata dai partigiani. Noi ragazzotti, il mattino dopo ci schierammo lungo l’Aurelia, là dove fiancheggia la ferrovia che la protegge dal mare. Eravamo accorsi per vedere gli americani, che per tante notti ci avevano tenuti svegli con i loro bombardamenti. Li conoscevamo solo attraverso i manifesti del “regime”, disegnati da Boccasile; in particolare quello < il liberator>, dove un ceffo, pilota negro, massacrava le nostre città. Ciò nonnostante non c’era risentimento tanto era l’odio e l’avversione verso i nazi-fascisti che ci avevano oppressi e coerciti. Tutto silenzio e i binari, raramente usati, arrugginiti. La strada era stranamente vuota, senza neppure le rare auto tedesche o i loro camion grigio-scuri; i mezzi privati, quelli, erano da tempo scomparsi a furia di ordinanze ostative imposte sia dalle Brigate Nere che dalla Wehrmacht. Solo alcuni medici potevano circolare avendo però i fari schermati e i parafanghi dipinti di bianco per individuarli. Finalmente a metà mattinata, in questa ovattata attesa, vediamo scendere lungo il rettilineo, una strana e buffa auto color senape simile ad una scatola scoperchiata, che in seguito imparammo a chiamare < Jeep>, quasi un cartone animato, occupata da giovanotti con divise attillate e con gli “anfibi” appoggiati al di fuori di quella “mezza” auto, mancante della parte superiore. Seguiva una colonna di grandi camion pieni di soldati festanti che, passandoci davanti, ci buttarono sigarette e cioccolata; dai mezzi usciva musica e per la prima volta vedemmo gli occhiali “ray ban”. Che contrasto con i nostri poveri militari indossanti sformate divise sdrucite e con i polpacci stretti da fasce che, se si allentavano, cadendo ti facevano inciampare; bastava correre un po’ perché ciò avvenisse o con i rigidi e anziani soldati richiamati della Wehrmacht, dagli stivaletti ferrati, sempre odoranti del grasso utilizzato per ammorbidire i loro accessori in cuoio, e di margarina spalmata sull’acidulo Roggenbrot. Gli americani, appena potevano, giocavano. Acquartieratisi nelle caserme abbandonate dal Regio Esercito ormai scomparso e poi da quello fantoccio della Repubblica Sociale Italiana, che raggruppava in “Bersaglieri” i giovani di leva che non avevano il coraggio di andare con i partigiani ma decisamente ostili a continuare la guerra. Di loro né i padroni tedeschi ne le sanguinarie Brigate Nere si fidavano; li tenevano lì in quiescènza. Alcuni di quei locali erano, sino a due giorni prima, ancora occupati dai tedeschi. Gli americani, trascorrevano il tempo giocando tirandosi una palla, utilizzando grandi guantoni. Era l’esercizio per tenersi in forma con quello che poi conosceremo essere il “baseball”; altri leggevano i loro fumetti formato tascabile (quelli i cui eroi ancor oggi leggiamo) dalla caratteristica stampa che odorava di citrato. Tutti i confort, carta igienica e dentifricio compresi, li seguivano da sempre al pari dei loro armamenti e al vettovagliamento così come la posta, che veniva distribuita giornalmente. Il rancio poi, anziché versato nella italica gavetta con gli eterni rigatoni al monotono sugo di pomodoro, veniva servito nei vassoi a scomparti che permetteva ai singoli di scegliere nel vasto menù. Una cosa m’è rimasta impressa: il loro pancarré sfacciatamente bianco e il cibo che avanzavano. Se penso al menù del nostro esercito che ammetteva una sola variante: solo se ne avanzava potevi richiedere il bis. Bevevano acqua spillandola da loro sacche scure appese e disinfettate ad evitare possibili infezioni. Sulle loro bottigliette di birra, per la prima volta vedemmo la scritta < non conservare, buttare >. Dopo pochi giorni di stanziale permanenza, incominciò l’approccio con la cittadinanza; i più ardimentosi portavano a lavare la loro biancheria alle nostre donne e davano, per poterlo fare, elmetti pieni di benzina come se avessimo in casa il lavaggio a secco. La potevano portare perché i loro elmetti erano scodelle metalliche senza fori che si calzano su di un sotto-elmetto di fibra, completo di aereazione e adattamento alla testa. La benzina, rivenduta poi, valeva ben più di un pezzo del residuato caustico sapone di guerra. Spesse volte dalla biancheria passavano al letto, battezzando con un nuovo nome un vecchio mestiere: “segnorine”. Dei partigiani, quelli con il fazzoletto al collo, gli americani avevano paura e diffidavano, evidentemente frutto del loro indottrinamento; se in un Bar ce ne fossero stati, quelli non entravano.

A far rispettare al loro interno la disciplina, ci pensavano gli < MP>, eternamente in jeep e armati con lunghi manganelli di legno dipinti di bianco. La bianca fascia al braccio con la scritta <MP>, Military Police, li rendeva riconoscibili e temuti.
Tutti avevano camicie e pantaloni sempre con la riga: capimmo poi che quelle “righe” non erano il frutto di continue stirature ma rese stabili con la macchina da cucire. I loro graduati, contrariamente ai nostri e a quelli tedeschi carichi di orpelli, gambali e brillii d’oro, erano vestiti come gli altri soldati: unico ‘distintivo’ erano dei rettangolini dorati , uno o più a seconda del grado, fissati sulle punte dei colletti e sugli elmetti.
Il fatto che ricordi queste cose mi rattrista: sto’ diventando veramente vecchio. Mi consolo pensando però che, almeno, io le ho viste e vissute.
Renzo BAGNASCO
Rapallo, 17 Aprile 2014
LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…
LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…
TRA MITO e LEGGENDA
Dice che era un bell'uomo e veniva,
veniva dal mare... parlava un'altra lingua...
però sapeva amare … (Lucio Dalla)


LA MELORIA
Anche la farinata venne dal mare… un viaggio breve e fu portata da uomini “cazzuti” che sapevano amare anche la buona cucina!

Una leggenda racconta che sia nata per pura casualità nel 1284, mentre infuriava la battaglia della Meloria che vide vittoriosa Genova su Pisa. Si racconta che le navi da guerra genovesi si trovarono coinvolte in una tempesta, ma é più probabile che la nave della farinata genovese sia stata colpita da un colpo di bombarda a pelo d’acqua… in direzione della cambusa. In ogni caso, si verificò una via d’acqua (termine marinaro che sta per falla) e alcuni barili d’olio e sacchi di ceci si rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata.
Ciutòsto che röba avanse, creppa pansa.
(Piuttosto che far avanzare del cibo, mangiamo tutto anche se poi stiamo male).
Non c’era alternativa: morire di fame oppure abbuffarsi su quelle provvidenziali scodelle di purea di ceci, olio e acqua di mare. A questo punto il destino volle che alcuni marinai, miga tanto abbelinae, optassero per una terza soluzione e lasciassero questo composto al sole che asciugandosi si sarebbe trasformata in una strana specie di frittella. Alla fame non si comanda e i marinai si convertirono a quella sconosciuta pietanza scoprendo una nuova ricetta che, per puro caso, diventò famosa a partire dal quel lontano 1284 fino ai giorni nostri.

Venditrice di farinata genovese (inizi ‘800)
Rientrati vittoriosi nei caroggi Genovesi senza sole…, i marinai provarono a cuocere quell’impasto nel forno a legna. Il risultato fu eccellente e venne chiamato “l’oro di Pisa” per deridere i nemici sconfitti…
Secondo un altro “ciaeto storico” (pettegolezzo):
la farinata affonda le sue radici addirittura nell’antica Roma quando le truppe romane occuparono Genova e dintorni.
A quel tempo la farina di grano era considerata un lusso e i soldati preparavano questa pizza rudimentale con un impasto di farina di ceci e acqua, che poi cuocevano al sole, utilizzando i propri scudi come “forni”.
Prendiamo quindi atto che la farinata di ceci (fainà in dialetto) ha navigato, a fasi alterne, per oltre duemila anni da un porto all’altro, anzi da un angiporto all’altro essendo un piatto “povero” ma estremamente gustoso e nutriente che i marinai in franchigia gustavano passando tra i piaceri di un lupanare e l’altro.
Liguria, Toscana e Piemonte sembrano essere le culle della farinata classica per altro conosciuta anche in altre regioni italiane, magari con delle varianti locali vendute come apprezzati street food.
C’è però chi sostiene che i natali di questa specialità non si debbano alla Superba, ma alla Toscana, precisamente a Pisa. La sconfitta dei pisani é dura ancora oggi da digerire… naturalmente noi ci scherziamo! Ma loro no!
Che la farinata non si faccia solo in Liguria è vero, poiché la si prepara anche sulla costa francese, più o meno nei dintorni di Nizza, dove viene chiamata socca. Ma non c’é da meravigliarsi, Nizza é stata genovese fino al 1860. Si può trovare anche nel basso Piemonte, dove é conosciuta come bela cada. Vi propongo una originale testimonianza della mia amica Marilena, torinese di nascita:
"Proprio alla torta verde, sempre reperibile nei forni e in qualche macelleria, è dedicata una festa in concomitanza della fiera del Santo Cristo, che a fine aprile fa rivivere le storiche usanze di Nizza. Dove le sagre sono l’occasione giusta pure per assaggiare la belecàuda, altrimenti acquistabile in alcuni panifici: non è altro che la farinata - con farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva - da cuocere in teglie di rame nel forno a legna e servire (come suggerisce il nome) “bella calda”. Esattamente come la serviva Tantì, che nel secolo scorso portava con una bicicletta a tre ruote la teglia con la farinata calda, un “tantì” indicava una porzione ed è diventato il soprannome del venditore ambulante."
Sulla costa della Toscana del nord viene chiamata cecina o torta di ceci.
Nel savonese la si fa anche con farina di grano tenero e viene chiamata farinata bianca.
Fatevi questa domanda: se la farinata si prepara in una regione e in tutte le zone ad essa confinanti, dove potrà essere nata? In attesa della vostra riflessione e di fonti storiche inoppugnabili, una cosa mi pare certa: ovunque sia nata, la farinata in Liguria è tradizione, territorio, cultura e appartenenza. Questo prodotto da forno viene eseguito in maniera eccelsa in tutta la Liguria, ma Genova è la sua città d’elezione.
Consegnata la farinata alla Storia di ieri … entriamo ora nella FARINATA di oggi e vediamo di capire qualcosa della sua “cosiddetta” semplicità la quale, come abbiamo visto, é intrisa di olio d’oliva e acqua salata, ma anche di tanti segreti mai confessati agli estranei della casta dei “sacerdoti” locali, i soli che possano tramandare la tradizione con riti di iniziazione di natura similmente religiosa …
Chissà se funziona ancora così? Ma di sicuro un tempo non lontano era proprio così!

CECI
Amedeo, quando andava per pagelli al largo di Rapallo, portava con sé un residuato bellico: la tanka di una Jeep Willys che riempiva di acqua di mare trasparente; la usava per l’impasto della farinata ma anche per fare il sale domestico, raro da reperire durante la guerra e nel primo dopoguerra.
Amedeo non era un “sacerdote”, ma le fisse per la farinata le aveva eccome … Si sentiva, per esempio, in competizione con il mitico fornâ (fornaio) Ö BANSIN della perla del Tigullio, verso il quale nutriva un complesso di superiorità …
Ogni tanto si partiva per il basso Piemonte, prima tappa Novi Ligure, provincia di Alessandria, dove si compravano i ceci a seme grosso: il cece di Merella, il migliore del mondo?!? Se li faceva macinare… e si proseguiva per Gavi Ligure; la seconda tappa era dovuta alla scorta di vino bianco che, a suo dire, era l’unico vino in grado di convolare a nozze con a fainà. Secondo la filosofia del suo tempo, questi ingredienti facevano la differenza tra le due benemerite categorie in gara: il professionisti sapienti e i dilettante trìsti e belinoin.
Era dura stargli dietro… ma la farinata che usciva da quel forno a legna, disastrato dalla guerra, mi ritorna regolarmente in sogno ancora oggi!

RICAPITOLIAMO
La ricetta della farinata di ceci (tradizione ligure) possiamo riassumerla così:
E’ una torta salata, preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio extra vergine d’oliva. La farinata (fainà) é una prelibatezza che viene cotta nel forno a legna, in teglia (testo di stagno ramato), da cui il caratteristico colore dorato che assume con la cottura.
Pochi ingredienti con tanti segreti??? Avviamo l’indagine!
300 gr di farina di ceci
1 litro d'acqua
5 cucchiai di olio extravergine di oliva
Sale quanto basta
LE VARIE FASI
Dosi
Semplicissime: il rapporto tra farina e acqua deve sempre essere di 1 a 3. Vale a dire che per ogni etto di farina di ceci servono tre etti di acqua. Non dimentichiamo il sale, nella misura di circa un grammo ogni etto di composto: se la somma tra acqua e farina è 400 grammi, saranno necessari circa 4 grammi di sale, o poco meno.
Teglia
Nelle farinaterie si usa una teglia apposita, il cosiddetto “testo”, una grande padella rotonda a bordi bassi in rame stagnato, disponibile anche in versione casalinga con un diametro di 30-32 cm.
Se non avete il testo, potrete rimediare con una teglia da forno a bordi bassi, preferibilmente rotonda. Se invece non siete puristi fanatici della tradizione ma mirate alla sostanza, la classica teglia rettangolare andrà comunque bene.
Impasto
Una volta muniti di teglia e ingredienti, è il momento di passare alla preparazione. Mettete la farina di ceci in un’ampia ciotola e cominciate ad aggiungere l’acqua a poco a poco, sempre girando con una frusta per non formare grumi.
Siete tipi da poche storie? Allora prendete un frullatore a immersione e frullate per qualche secondo: avrete un impasto liscio e vellutato in pochi secondi. Aggiungente quindi il sale.
Per un testo di circa 32 cm di diametro, corrispondente a una teglia rettangolare di cm 40 x 20, le dosi indicative sono di circa 130 grammi di farina, 390 di acqua e 5 grammi di sale.
Riposo
Una volta fatto il laborioso impasto, bisogna farlo riposare, almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.
Durante il riposo, si formerà una sorta di schiuma in superficie: levatela con un cucchiaio, altrimenti brucerà durante la cottura.
Ci siamo quasi
Impasto pronto, riposo effettuato, forno caldo, anzi caldissimo. Non rimane che infornare. Non prima, però, di aver unto la teglia con un generoso strato di olio, dello spessore di circa due millimetri.
Girate bene l’impasto della farinata e rovesciatelo sulla teglia, allo spessore di circa un centimetro o poco più. Girate il tutto leggermente con un cucchiaio di modo da mescolare l’olio della teglia con l’impasto appena rovesciato. Se vi piace, aggiungete qualche ago di rosmarino.
Cottura
Non resta che aspettare: 10-13 minuti in genere sono sufficienti, ma ovviamente il tempo dipende dalla temperatura raggiunta dal vostro forno. Tenete presente che la farinata è pronta quando assume la classica colorazione dorata in superficie. E soprattutto, che non deve essere eccessivamente cotta, ma presentare l’interno ancora morbido e cremoso, e non asciutto e stopposo.
Sfornate e spolverizzate infine con pepe fresco, macinato al momento.
Il Vino
Con la farinata – a base di farina di ceci, olio, sale e pepe, cotta nel forno a legna ben si abbina il Coronata Val Polcevera, vino bianco sapido e fresco.
I consigli del nonno:
Ungi bene la teglia, cala la broda, metti l'olio, batti il fondo e inforna caldo-caldo.
Quando sopra si forma una crosta semidura (croccante) é pronta! Senza muovere la teglia, deve essere ben in piano quando cuoce, altrimenti resteranno zone crude e zone troppo cotte.
Preferiscila appena sfornata, praticamente ustionante e con una spolverata di pepe.
ALCUNI APPROFONDIMENTI NELLA PREPARAZIONE DELLA FARINATA.
LA PAROLA AGLI ESPERTI DI OGGI
"Io faccio la farinata da 17 anni e impasto tutti giorni 25 chili di ceci!"
I requisiti sono: morbida dentro e crespolosa in superfice.
La temperatura del forno deve essere da 300 a 350 gradi.
Il forno dove lavoro e profondo 240 cm. le teglie (testi) sono di 80 cm di diametro. Quindi ne posso infornare anche tre a temperature più alte.
Lo spessore della farinata deve essere 1 cm, poi dipende dai gusti se piace secca o morbida
ALCUNI TRUCCHI

Nelle nostre farinaterie, a seconda dell’area geografica, i legni più adoperati sono il faggio e la quercia. Talvolta il càrpino, ma questo è un prodotto che potremmo definire di scappatoia.

Faggio segato con corteccia
Diversi tipi di legno da usare nel forno a legna

Faggio
· FAGGIO: +fiamma / -brace. Ottimo rapporto qualità prezzo

Quercia
· QUERCIA: +brace / - fiamma. Fa una bella fiamma all’inizio poi lentamente si abbassa e trasforma in brace. La brace mantiene il calore a lungo.
· ULIVO: +brace +fiamma. Introvabile molto raro e caro.
· CARPINO Alternativa a basso costo al legno di quercia.
LEGNA DA NON USARE: Pioppo e Castagno perché scoppiettano, pezzetti di braci ardenti potrebbero finire sulla farinata durante la cottura, questa è legna da camino.
ABETE, PINO E RESINOSE contengono resine tossiche, inoltre trasferiscono odori estranei ai prodotti in cottura.
- È meglio adoperare legno italiano e se possibile con origine certificata, meglio ancora se fornita in un sistema di autocontrollo.
- Se serve fiamma molto vivace la legna di faggio va preferita a quella di quercia.
- Viceversa se occorre una brace più longeva e una fiamma meno incisiva l’ideale è la quercia;
- Prediligere legni stagionati almeno 8 mesi.
Il potere calorico del faggio a zero umidità è pari a 4.456 kcal/kg ma:
- 15% di umidità 3700 kcal/kg;
- 30% di umidità 2940 kcal/kg;
- 50% di umidità 1930 kcal/kg;
Carlo GATTI
Rapallo, Mercoledì 9 Maggio 2018
M/N BOCCADASSE, nacque dall'unione di due Liberty Ships
La M/N BOCCADASSE
Nacque dall'unione di due relitti di Liberty Ships
In una nostra precedente pubblicazione, definimmo i Liberty USA:
“Le navi che vinsero la guerra e poi la pace”

“L’operazione Liberty” prese il via il 27 Settembre 1941 con l’entrata in linea dell’ormai celebre “PATRICK HENRY”, e si concluse con la consegna dell’ultimo esemplare, il “RODA SEAM” del tipo “collier” (carboniero) il 13 Ottobre 1945 da parte del Cantiere “Delta” di New Orleans-Louisiana. Tra queste due date ne scesero in mare ben 2710.
Queste carrette dei mari furono costruite per compiere una traversata oceanica durante la Seconda guerra mondiale, tra gli agguati dei sottomarini dell’Asse, che agivano negli Oceani adottando la ben nota tattica “a branco di lupi”. In seguito a queste azioni belliche, affondarono circa 200 Liberty.
Subito dopo la fine del conflitto “i brutti anatroccoli”, come li definì F. D. Roosvelt, ripresero a navigare e i più longevi lo fecero dignitosamente per circa trent’anni, partecipando alla ricostruzione della flotta mercantile di quasi tutti i paesi belligeranti.
Nel 1945 si concluse una tragica guerra che fu combattuta in cielo, in terra ed in mare, lasciando ovunque distruzione, miseria e rovina.
Soltanto poche cifre sono sufficienti per mettere a fuoco un quadro spaventoso:
- nel 1939 la flotta mercantile italiana contava 3.3 milioni di tonnellate di stazza lorda per un totale di oltre 1200 navi.
- nel 1945 le navi superstiti erano ridotte ad un numero molto esiguo che non raggiungeva in totale le 200.000 tsl. Inoltre le strutture ed infrastrutture portuali erano distrutte ed inagibili, i fondali da sgomberare da centinaia di relitti e da bonificare per la presenza di migliaia di proiettili e bombe inesplose.
A questo punto cruciale della storia martoriata del nostro paese, era necessario reagire con fermezza alla pericolosa situazione di stallo, ed era oltremodo impellente chiamare a raccolta tutte le forze vive e disponibili sul territorio, per passare ad un rapido piano di ricostruzione.
In quel periodo in cui c’era solo da rimboccarsi le maniche, anche il cervello degli uomini più attivi esplodeva d’idee: non c’era nulla da buttare, ma tanto da recuperare, specialmente dai relitti che nel Mediterraneo erano presenti a migliaia, a tutte le profondità.
Da questa idea nacque la storia che ora andiamo a raccontarvi.
Siamo alla fine del 1946. La Liberty “Natahaniel Bacon” è in piena burrasca. Per chi non conosce le “Spiagge Romane”, ventose e senza ridossi, è portato a sottovalutare le difficoltà che le navi incontrano da sempre in questa zona di mare. In questo caso si tratta di una nave carica di scatolame, con scarsa potenza di macchina e quindi con poche possibilità di allontanarsi verso zone più calme. Le onde le imprimono forti movimenti di rollio e beccheggio, sollevano schiuma e limitano la visibilità. La zona non è stata ancora bonificata dalle mine più o meno vaganti ed il comandante è cosciente o forse incosciente di scarrocciare proprio verso una zona “rossa” pericolosamente infestata da questi terribili ordigni. Non ha scampo! Poco dopo si ode una deflagrazione immane: della Liberty galleggia solo la poppa che si allontana alla deriva.
La seconda storia prende inizio nell’aprile del 1948. Complice è sempre la burrasca.
la Liberty “Bert Willians”, va ad incagliarsi al largo del faro di Al Shrat nel Mar Rosso. Viene deciso il rimorchio a Genova, ma dopo un lungo, pericoloso e travagliato viaggio, quando finalmente si trova in Mediterraneo, s’incaglia nuovamente nelle vicinanze di Marsa Matruk (Egitto). Il mare finisce per un terzo l’opera di demolizione, a galla rimane solo la prua, rimorchiata in un primo momento verso il porto di Taranto e poi definitivamente verso il Porto di Genova.
Si sa: “quando il gioco si fa duro, in duri entrano in gioco”.

E furono senza dubbio dei duri gli uomini che pensarono di realizzare, con quei due tronconi galleggianti, un TERZO LIBERTY. La nave che risultò allungata di 10 metri, fu chiamata BOCCADASSE, da una famosa frazione balneare affacciata come un balcone sul mare di Genova.
Giunti a questo punto, ho scelto il servizio più completo che ho trovato su questa operazione. Si tratta di un breve estratto dell’ articolo:
La tecnica che Genova ha dimenticato /La STORIA
di Alberto Quarati – 08 Marzo 2016.
Tratto dalla Rivista SHIPYARD & OFFSHORE
“Le vecchie dinastie vennero affiancate da nuove società di navigazione, alcune destinate a dominare il mercato, altre semplici meteore. Della Industriale Marittima - che ordinò la “Boccadasse”, prima e penultima nave costruita con la prua e la poppa di altre due - rimane solo una citazione presso l’archivio storico della Banca commerciale italiana.


Il creatore della “Boccadasse”, nel 1950, fu Angelo Cassanello, direttore delle Officine meccaniche navali Campanella, allora nel pieno dell’attività. Pietro Campanella, figlio del fondatore Tito, è stato presidente degli industriali genovesi nel primo dopoguerra, e lo stesso Cassanello sarebbe stato tra i fondatori dell’associazione dei riparatori navali. Gli stabilimenti di Savona e Genova (uno per costruire le navi, l’altro per ripararle) erano ancora lontani dalla crisi degli anni Ottanta, dai passaggi di proprietà, dalle divisioni. Il lavoro delle maestranze genovesi dirette da Cassanello produsse quella che gli americani battezzarono “super-Liberty”, una nave di 136 metri in luogo dei 127 standard, e circa 7000 tonnellate di portata lorda.
La novità stava anche nel modo con cui l’operazione venne condotta, cioè tramite elettrosaldatura, e la società che ha fornito questa tecnologia - la svedese Esab - è l’unica realtà ancora esistente tra i protagonisti di questa storia. Per diverso tempo la “Boccadasse” ha navigato per i mari di tutto il mondo, fino al suo smantellamento del 1962, alla Spezia”.
Concludiamo con alcune osservazioni:
Da quell’operazione siderurgica di grande impatto ingegneristico, sono passati 66 anni densi di grandi evoluzioni nel settore navale. Tuttavia, lo straordinario esperimento della BOCCADASSE, è degno di essere ricordato perché fu il primo, nell’era moderna, di una lunga serie di “allungamenti” eseguiti su navi passeggeri, petroliere e container per renderle più “economicamente competitive”.
All’epoca della BOCCADASSE, l’obiettivo era quello di creare navi che fossero in grado di far circolare merci, unica vera “linfa vitale” per la ripresa dell’economia del mondo, oggigiorno gli allungamenti, frutto di quella antica esperienza genovese, sono sempre di moda, ma l’obiettivo appare rovesciato nel suo significato: occorre favorire la massima circolazione di merce con poche navi.
Questo fenomeno si chiama: GIGANTISMO NAVALE ed impensierisce il mondo moderno per le sue cruciali controindicazioni.
Sul sito di Mare Nostrum Rapallo abbiamo affrontato questo problema con molti servizi mirati che trovate in NAVI E MARINAI - Sezione Mondo Marittimo.
Carlo GATTI
Rapallo, 27 Settembre 2016
LA VIA DELLE SPEZIE
LA VIA DELLE SPEZIE

Le antiche vie delle SPEZIE terrestri e marittime
Un po’ di Storia:
Enrico il Navigatore
Il principe portoghese Enrico il Navigatore fu l’ideatore ed il promotore della ricerca di una via marittima per l'India che fu realizzata con la missione di Vasco da Gama nel 1498. Il successo di questo progetto significò fin dall’inizio l’eliminazione di quella vasta gamma d’intermediari composta da commercianti arabi, persiani, turchi e veneziani, che gravava sul prezzo delle spezie orientali insiemi agli elevati dazi richiesti dall'Impero Ottomano.
I Portoghesi per primi, attraverso la circumnavigazione dell’Africa aprirono una nuova via marittima che consentiva di raggiungere l’Oriente evitando l’attraversamento dei Paesi arabi. Ciò comportò la decadenza di fiorenti città commerciali, come Antiochia e Alessandria.
La rottura del monopolio commerciale di veneziani, turchi e arabi nel commercio delle spezie ebbe, come conseguenza immediata, il calo dei prezzi che produsse il rialzo della domanda e dell’offerta. La seconda ripercussione a livello mondiale di quell’epoca, si ebbe con la consapevolezza che l'apertura della rotta marittima avrebbe segnato la fine di un’epoca riducendo al minimo l'importanza delle antichissime rotte terrestri come la Via della seta e la Via dell'Incenso e la via transafricana.
A partire dalla fine del XVI secolo, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali (Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC) riuscì a conquistare un gran numero di basi portoghesi nell'Asia orientale e a portare sotto il loro controllo la Rotta delle Spezie, che da allora in poi aveva come snodi principali Batavia (l'odierna Giacarta) in Indonesia e, dall'altra parte, Anversa e Amsterdam.
La ROTTA DELLE SPEZIE - Fu quindi aperta da esploratori portoghesi tra il XV e il XVI secolo.

Posizione delle Molucche (Maluku) – (verde chiaro) - ad EST dell'Indonesia

Carta generale delle Indie Orientali

Una delle tante isole di Banda

Mappa delle isole MOLUCCHE (Maluku Utara)
Dall'Europa all'India, proseguiva fino alle Isole delle Spezie (Molucche-Indonesia). E’ stata la via marittima più rappresentativa dell’espansione europea nel mondo e del colonialismo, in parte ottenuta con l’uso della forza militare. Queste isole offrono numerose opportunità: distendersi sulla sabbia bianca a Ohoidertawun o Pasir Panjang, ammirare il tramonto da Pulau Ternate contemplando i raggi dorati del sole che risplendono sul vulcano ammantato di fitta giungla della vicina Pulau Tidore, scoprire idilliache spiagge deserte e tracce della seconda guerra mondiale sulle isole disabitate intorno a Morotai.
Volendo seguire il percorso dell'originaria Via delle Spezie, occorre visitare le dieci Isole Banda, un minuscolo ma incantevole arcipelago. Nel Medioevo la preziosa noce moscata veniva prodotta quasi esclusivamente sulle Banda. Gli abitanti del posto la cedevano ai mercanti arabi, cinesi, giavanesi e bughinesi in cambio di cibo e abiti, ma la situazione cambiò rapidamente quando arrivarono gli europei (i portoghesi nel 1512 e gli olandesi a partire dal 1599), che pretesero il monopolio.

Porti scalati dalle navi “Indiaman” in Estremo Oriente
PERCORSO – La prima parte della navigazione iniziava da Lisbona fino a doppiare il Capo di Buona Speranza, risaliva le coste dell’Africa orientale e, attraverso il Mare Arabo, raggiungeva le città di Goa, Calicut, e Cochin nel Malabar (costa occidentale dell’India). La seconda parte “commerciale” della Rotta delle Spezie proseguiva circumnavigando India e Ceylon, attraversava il Golfo del Bengala, lo Stratto di Malacca (tra Indonesia e Malaysia), il Mar di Sonda (tra Sumatra e Java) e il Mar di Banda fino alle Isole delle Spezie: Ambon, Tidore e Ternate. (Vedi carta Molucche)
COMMERCIO – Su questa rotta dell’Estremo-Oriente, le navi venivano caricate soprattutto di spezie come il pepe, i chiodi di garofano, la noce moscata e la cannella. In Europa questi prodotti avevano un valore commerciale immenso, poiché non servivano solo per insaporire i cibi, ma venivano utilizzate anche per la produzione di farmaci e dei profumi. Altre merci importanti erano la mirra e l'incenso.

Spezie indiane

Suk di Marrakesch - Marocco

Marrakesch

Spezie in un mercato di Istambul (Turchia)

Zafferano indiano in un mercato del Cairo (Egitto)

Spezie in un SUK del Magreb

In un Suk del Nord Africa

Campionario di SPEZIE a Giacarta (Indonesia)

Spezie a Dubai

Spezie Indiane

Polvere delle “Cinque Spezie Cinesi”
La Polvere cinque spezie o polvere delle cinque spezie è un tradizionale miscuglio de spezie utilizzato in origine nella cucina cinese e poi diffusosi in altre cucine orientali, ad esempio in quella vietnamita.
CONCLUSIONE
Nel 3000 a.C. erano già note 5.000 spezie, nel Medioevo il pepe era usato come moneta. A Firenze si quotavano radici, erbe e semenze. Tuttavia desideriamo aggiungere ancora qualcosa sulla curcuma, in quanto é oggetto ancora ai giorni nostri di studi scientifici molto interessanti.
La curcuma nella cura del cancro (Dal web: Studenti)

La curcuma delle Molucche
La curcuma è una spezia dalle molteplici virtù e la curcumina, pigmento naturale contenuto appunto nella curcuma, e responsabile del colore giallo del curry, è oggetto di ricerche particolari in materie di salute. Fra le sue preziose proprietà è stata, infatti, recentemente annoverata la capacità di rallentare lo sviluppo di alcuni tumori come il cancro.
Seppur lo studio sia ancora in fase di sperimentazione, la propensione a ritenerla attivamente positiva in questo campo, apre sicuramente nuove speranze sul fronte della ricerca anti cancro. Le premesse di questi studi sulla curcuma, rilevano come la spezia in questione sia capace di esercitare un effetto anti-cancro grazie alle sue ben note proprietà antinfiammatorie. Una recensione del 2011 pubblicata nella “Gazzetta della National Academy of Sciences”, ha rilevato che quasi il 25% delle forme tumorali sono causate da infiammazioni croniche; queste infiammazioni provocano l’aumento di una molecola, l’RNA-155, responsabile dell’abbassamento dei livelli della proteina addetta alla riparazione del DNA danneggiato. La curcumina è in grado, secondo alcuni studi, di ostacolare questo processo distruttivo, riportando le cellule al loro equilibrio.
Questo potere specifico della curcuma è stato scoperto dai ricercatori del Jonsson Comprehensive Cancer Center dell’Università della California, i quali hanno evidenziato l’azione anti-cancro della curcumina soprattutto in relazione ai tumori della zona cervico-facciale. La dottoressa Marilene Wang, coordinatrice dello studio, ha affermato che la curcumina opera nella bocca dei pazienti affetti da tumori della testa e del collo, riducendo le attività che promuovono la crescita del cancro.
In questa specifica ricerca sono stati presi 21 pazienti, con tumore alla testa o al collo, ai quali è stato prelevato un campione di saliva, prima e dopo la masticazione di due compresse a base di curcumina. Trascorsa un’ora è stato prelevato un altro campione di saliva. Contemporaneamente è stato condotto lo stesso esperimento su un gruppo di controllo, formato da 13 soggetti affetti da carie dentale e 5 soggetti sani. I risultati hanno evidenziato che mangiare curcumina mette in contatto cancro e saliva, riducendo i livelli di citochine (molecole proteiche che presentano sovente alti livelli in stati tumorali) collegate alla crescita del tumore.
Ovviamente la straordinaria capacità della curcuma nella cura del cancro, ancora in fase di sperimentazione, non può sostituire le terapie tradizionali, scientificamente comprovate, ma può sicuramente svolgere un’importante azione preventiva e di supporto. Infondo unire sapore e salute può diventare una buona e sana abitudine per noi occidentali, arricchendo i nostri piatti con spezie che oltre a rendere la cucina deliziosa contribuiscono al benessere dell’organismo. Questa scelta di vita può risultare utile e benefica per qualsiasi persona, ancor di più in persone sottoposte a un maggior rischio per abitudini di vita, come i fumatori e i bevitori, o affette da patologie specifiche come i portatori di HPV.
GATTI Carlo
Rapallo, 18 settembre 2015
LE SPEZIE IN CUCINA - OGGI
ANICE STELLATO - l’albero, chiamato “badiana”, è originario della Cina e del Nord Vietnam e se ne usano essenzialmente i frutti a forma di stella. Si utilizza per aromatizzare aperitivi, “vin brulè”, pane speziato cioccolato ma anche pesce.
CANNELLA - proviene dallo Sri Lanka e se ne utilizza la scorza. Profuma qualunque dolce a base di frutta (strudel, crumble) o the, cioccolato e il classico vin brulé”.
CARDAMONO – pianta tropicale che vive principalmente in Nepal.Dal gusto vagamente di menta, lo si utilizza nei dolci per insaporirli e come spezia nelle carni o il riso.
CORIANDOLO - origine Europea e Marocchina; se ne utilizzano le foglie e i semi. Indicato per insaporire qualunque verdura, pesci e carni.
CUMINO - proviene dal Nilo ma è coltivato ormai tutto attorno al Mediterraneo e se ne utilizza il seme. Insaporisce i formaggi cotti, le carni, le verdure; indicato per carote e/o patate al forno.
CURCUMA - origine indiana e zone tropicali. Sostituisce, a basso costo, il colore dello zafferano, avendo però un sapore quasi ininfluente. Colora riso o semola (cuscus) o brodo o pesci o verdure cotte. In combinazione con lo zafferano, ne incrementa il colore.
CURRY - miscela composta in Estremo Oriente, non appartiene alle spezie naturali ma è un’insieme di droghe; molto vari ne sono quindi i gusti, determinati dalla diversa percentuale dei componenti che lo formano. Indicato per quasi tutti i tipi di “umidi”.
GAROFANO - sono coltivati in India, Malaisia e Madagascar e se ne utilizzano i fiori immaturi essiccati. Insaporiscono brodi, stracotti, brasati, marinate, selvaggina da pelo e conserve sott’aceto; indispensabile nel “vin brulè”
GINEPRO - proviene dal Nord e se ne utilizzano le bacche. Insaporisce la cacciagione, le marinate, gli arrosti, i cavoli crauti ecc.
MACIS - è il rivestimento esterno della noce moscata. Essicato e polverizzato, anche se meno profumato di quella, può sostituirla. Il suo vero uso è però in salumeria e nelle miscele per formare altre spezie.
NOCE MOSCATA - proviene dalle isole Molucche, dall’india e dalle Antille e se ne utilizza il nocciolo essiccato mentre, dalla polpa che lo ricopre, se ne ricava il macis (vedere). Insaporisce tutti manicaretti a base di uova e di formaggi, come bechamel, soufflè, gratin di verdure oppure per aromatizzare biscotti, cakes, panpepati e “vin brulè”.
PAPAVERO - proviene dal Medio Oriente e se ne utilizzano i semi azzurri. Lo si incontra sul pane, nei dolci, con lo yogurt, il miele, miscelato alla pasta di certi formaggi, ecc.
PAPRICA - nasce in Ungheria ma oggi è difficile distinguerla dai peperoncini piccanti che colà esportiamo, per poi tornarci con il nome di “paprica”. Profuma tutte le ricette di carne che si vogliano insaporire oppure nelle minestre, o nelle verdure o nel pollo allo spiedo.
PEPE - quello nero, il verde e il bianco si ricavano dalla stessa bacca della omonima pianta a seconda di quando, nella stagione, lo si raccoglie e lo si essicca. Il rosa è originario del Brasile mentre quello rosso, pepe non è, e dovrebbe chiamarsi <pimento della Giamaica>. L’uso è a tutti noto ma forse lo è meno il suo potere irritante delle mucose interne, ben più del nostrano peperoncino.
SESAMO - nasce in India, Indonesia, Africa e Cina e se ne utilizzano i semi. Nota la spolverata per insaporire i pani, tostati con le verdure o con insalate, sul pesce o su spiedini di carne prima di cucinarli. Molto presente nella cucina siciliana
VANIGLIA – è originaria del Messico ma oggi viene coltivata anche in Madagascar, Isole della Reunion e Tahiti ed è simile ad lungo fagiolino che, lavorato ed essicato, si presenta come quella che conosciamo. Profuma il latte, le creme, soufflé, charlotte, torte, biscotti e le uova; miscelata allo zucchero diviene zucchero vanigliato. Non tutti sanno che le bacche si possono riutilizzare più volte; basta recuperarle e sciacquarle.
ZENZERO - originario dell’Asia tropicale e della Giamaica; se ne utilizzano i rizomi. E’ componente essenziale in molte misture come il Curry e profuma piatti di pesce o carne oppure biscotti, cakes,panpepati, ecc. Lo si può anche candire.
a cura di
Renzo Bagnasco®
da <<GARGANTUA, idee per cucinare>> edito da Panesi Edizioni, in versione a-book
ANNI '60 - RICORDI DI BORDO E DINTORNI...
ANNI '60
RICORDI DI BORDO E DINTORNI...
Breve introduzione.
I marittimi non amano raccontare i propri trascorsi in mare perché pensano di non essere capiti dai “terrestri”... Ma come ben sappiamo, ogni regola ha le sue eccezioni, il comandante Nunzio Catena é una di queste.
Il saggio che oggi ci dà in lettura, riporta indietro di mezzo secolo le lancette dell’orologio facendo rivivere i personaggi di bordo con le loro mansioni sulle “carrette” dei mari. Nunzio é stato imbarcato su quei “brutti anatroccoli” come Roosevelt definì i LIBERTY nella cerimonia del primo varo. Pochi naviganti del Nuovo Millennio conoscono l’epopea di queste navi che furono costruite e montate in pochi giorni nei cantieri USA, con l’obiettivo di rifornire l’Europa in guerra. Esse dovevano compiere soltanto una traversata atlantica, ma per molte di loro, la carriera terminò con la demolizione verso la fine degli anni ’60. In un’altra sezione del sito di Mare Nostrum Rapallo, abbiamo riportato una serie di articoli dedicati a queste navi definendole:
“Le navi che vinsero la guerra e poi la pace”
Alcune Liberty furono rimotorizzate e trasformate internamente per il trasporto di auto-FIAT dall’Italia agli Stati Uniti adeguandosi, in parte, alle nuove esigenze del mercato. Nunzio ci parlerà di questo trasporto, del quale segnaliamo anche un video e altri simpatici aneddoti. Riteniamo pertanto che molti anziani “lupi di mare”, leggendo questi ricordi, rivivranno una parte della loro gioventù, ma siamo inoltre convinti che anche le nuove generazioni di studenti nautici e giovani ufficiali in servizio troveranno in queste “testimonianze” notevoli spunti di riflessione su come si navigava al tempo dei loro nonni, senza strumenti elettronici, con il radar che andava in avaria nel momento in cui serviva, con il radiogoniometro inattendibile... molto spesso affidandosi soltanto al sestante e al buon senso marinaresco.
Buona lettura!
Carlo Gatti
webmaster

FINALMENTE SI NAVIGA...
Quando finalmente iniziai il Corso Capitani di coperta, ero talmente motivato che terminai l’anno scolastico 1961 con una buona media e fui invitato a partecipare al concorso della Lega Navale Italiana, a livello nazionale - alunni IV° Corso Istituti Nautici Italiani - e nel mese di Luglio, m’arrivò la comunicazione che avevo vinto il Viaggio Premio con la Flotta Lauro-Napoli (che aveva navi passeggeri dislocate in tutto il mondo).
Mamma, sempre previdente, mi disse: "micc(i) cacche maj de lan(a).. 'nz pò mai sapè, t(e) mann a dò fa lu fredd ..?!!!
(Traduzione: metti qualche maglia di lana, non si può mai sapere, se ti mandano dove fa freddo.? !!!")
Mamma aveva ragione! Grazie alle potenti raccomandazioni che avevo... quando mi presentai all’Armamento Lauro di Napoli, mi dissero: "vada ad Augusta (Sicilia), imbarchi sulla petroliera 'VOLERE' noleggiata sulla rotta Mina al Ahmadi (Golfo Persico) - Augusta! “
Data la calura del Golfo Persico in estate, quel viaggio era noto con il nome: per l’inferno e ritorno. L’aria condizionata all’epoca era soltanto un privilegio di non molte navi passeggeri.
Partii e portai a termine il viaggio con soddisfazione e tanto interesse, e lo avrei anche ripetuto, ma non fu possibile per la riapertura della scuola a Ottobre. Ebbi delle ottime referenze da parte del Comandante, il quale mi disse: “Quando prende il Diploma, puo' imbarcare con Lauro..!!

IL 26/7/62, conseguito finalmente il diploma di Allievo di Coperta (vedi il sospirato primo grado nella foto), un mio amico che aveva navigato mi consigliò d'inoltrare domanda d’imbarco alla Compagnia Italnavi di Genova. Era il 10 settembre e scrissi:
“Mi chiamo ... Nato il... a... ecc. ecc... Se sono necessarie raccomandazioni, non leggete oltre.”
In pratica, mi ero raccomandato da solo...!
Infatti, a stretto giro di posta, mi risposero di inviare il Libretto di Navigazione per essere messo al turno particolare, il che significava che sarei stato assunto, ma la mia partenza sarebbe dipesa dal numero di Allievi che mi precedevano.
Avrei dovuto baciare per terra per essere stato assunto..., ma quanto avrei dovuto aspettare? Non potevo più aspettare, ero logorato dall’attesa! Sarei ritornato da Lauro, magari anche con il diavolo, ma dovevo assolutamente partire. Subito!
All’epoca viaggiavo gratis in treno e quella sera stessa partii per Genova. La mattina seguente alle 9, mi presentai in Via Fiasella n.1, sede dell’ufficio d’Armamento. Mi presentai con la “lettera d’assunzione” all’addetto agli imbarchi che mi chiese il “libretto di navigazione”.
Al che io domado:
“Quanto tempo devo aspettare per imbarcare? Quanti Allievi sono prima di me?”
E quello con voce alterata mi risponde: “Cinque o sei!”
Al che io di rimando:
“No, grazie! mi ridia il libretto... Io devo imbarcare subito!”
Mentre stavamo parlando entrò un signore anziano con le sopracciglie che sembravano cespugli, ed in dialetto genovese chiese qualcosa all'impiegato. Intuii e m’intromisi:
“Comandante, io non posso aspettare, mi dispiace ma...”
Lui guardò il libretto, mi riguardò e disse all'impiegato":
“mettilo per primo!”
Tornai a casa passando da Roma. Il 25 sett. 1962 mi arrivò il telegramma: "Presentarsi domattina per imbarco".
Non sapevo in quel momento se dovevo essere finalmente Felice! In realtà lo ero... Però c'erano troppe cose alle quali ero legato. Mio nipote Vanni, sopratutto, aveva solo due anni, mi chiamava "ziò" e durante l'estate lo portavo con me.

La "vela" di nunzio

I "massi"
Mamma e papa' sarebbero rimasti soli, ma il loro dispiacere, minimamente dimostrato, era compensato dal fatto che dopo tanto ero riuscito a fare quello che volevo: la barca, i massi, gli amici e tutto ciò con cui ero cresciuto assieme e che ora dovevo lasciare.
In ultimo presi un po' della mia terra (sabbia), salutata mamma senza una lacrima mi disse:
"abbad a te mamm, pe' nu, nun tene' pensiero!"
traduzione: bada a te, mamma, per noi non aver pensiero.
Non avevo un’agenda vera e propria, ma una piccolina dove annotai le ore degli ultimi saluti... Alle 21,30 partiva il treno per Torino. Bisognava cambiare a Voghera per Genova dove si arrivava al mattino, in tempo per andare al "diurno" sotto la Stazione e lavarsi (con le locomotive a carbone s'arrivava neri come un marocchino..!!) per poi presentarsi in Compagnia. Sarei imbarcato su una nave nuova, la "PORTOVADO" che si trovava a Taranto.
Nel viaggio da Genova a Taranto, visto che dovevo passare da casa, mi sono fermato tra un treno e l'altro con la gioia di tutti...


A Taranto imbarcai sulla PORTOVADO, una nave da carico nuova e bella..! Caricammo grandi tubi di acciaio per un gasdotto costruito dalla SNAM che univa la Patagonia a Buenos Aires. Quel viaggio prevedeva lo scalo a Bahia Blanca, la navigazione lungo il Rio della Plata per caricare mais a Rosario e Villa Costitution, si completava il carico a Buenos Aires per poi ripartire per Genova. Viaggi meravigliosi, soste abbastanza lunghe nei porti, belle citta' e sopratutto belle ragazze! Ebbi la fortuna d’incontrare un equipaggio meraviglioso. Mi volevano tutti bene! Appena imbarcato, facevo la guardia con il 2° Ufficiale Nardini dalle 20 alle 24. Con lui mi sento ancora oggi al telefono.

M/n PORTOVADO
Ero felice e non mi sembrava vero di poter fare quello che avevo tanto sognato. Ho sempre dormito poco, mi ritiravo a mezzanotte ed alle 4 ero fresco come una rosa... e andavo dietro a tutto l'equipaggio per imparare il più possibile. Quando a bordo seppero la storia dei miei due diplomi: di macchina e di coperta, mi dissero: "noi siamo stati 'dei belinuin' ad aver fatto questa scuola. Ma tu sei un doppio 'belinun'..." Non voglio parlare delle varie avventure nel periodo che sono stato a bordo. Con alcuni diventammo proprio amici (Benvenuto, l'Allievo piu' anziano di me, Cesare Ferrero 3° ufficiale (I tre dell'ave maria!). Dopo un anno, anche se spesso cambiavano i viaggi, dal punto di vista professionale, avrei voluto fare esperienze diverse per imparare meglio la professione. Un anziano Comandante mi diceva: “la barca vecchia fa il buon Capitano”! Cosi' quando vidi quei liberty feci come Ulisse con la maga Circe, ne fui incantato anche se fu molto difficile rinunciare a tutto quello che avevo a bordo di quella nave nuova!

Toccavo e ritoccavo quell'anello che avevo al dito regalatomi da mia madre il giorno del mio ventesimo compleanno, dove era scritto: "Nunzio e il Mare". Il destino ha voluto cosi': farmi incontrare Peppino di Bartolomeo... Il mio compagno di classe che ‘scappava’ dal Liberty Italvega. Io gli proposi il cambio e come ho già raccontato in altre occasioni, sono andato dal Comandante di Armamento che mi aveva conosciuto e gli dissi":
“Comandante, sono sul 'Portovado' da un anno e conosco anche quanti chiodi ci sono a bordo. Vorrei andare sull'Italvega”.
Mi guardò, abbozzò un sorriso e mi accontentò.
Così tagliai i ponti con il Sud America! Ma quando ritornai a casa, mi venne a trovare il famoso Peppino il quale, dopo l’esperienza del Portovado, si diede all’agricoltura per coltivare le sue terre. Peppino aveva un pacchetto in mano, me lo diede dicendomi il nome del mittente. Premetto che avevo sempre odiato indossare amuleti d'oro, all’epoca portavo al collo una catenella di rame con un'ancoretta usata dai modellisti di navi. Nel pacchetto c’era l'ancora che la sera dell'addio era rimasta impigliata nel 'suo' vestito... Viene da pensare alla Madama Butterfly. Quando arrivò il Portovado, lei stava aspettando sulla banchina insieme alle sue amiche. Peppino era imbarcato al mio posto e proprio a lui, prima della partenza, riconsegnò il pacchetto che conteneva un bigliettino: "Il Mare ha la forza di rompere anche le catene più forti..! Buon vento, Capitano". In quel momento, per quanto fossi troppo felice, la cosa mi fece pensare un pò: “Quella persona non mi era affatto indifferente!” Forse ci sto' pensando più in questo momento in cui il tempo ha offuscato anche la sua immagine. Quanti ricordi!

Allievo di Coperta del Nuovo millennio
L’ALLIEVO DI COPERTA DEGLI ANNI ’60 lavorava in simbiosi con il 1° UFFICIALE DI COPERTA, ossia il COMANDANTE in seconda della nave.

I gradi del 1° Ufficiale di coperta
Quando ritorno con la mente a quel periodo mi prende la nostalgia...
Io ho sempre sostenuto che buon Ufficiale si diventa da Allievo, perchè solo da Allievo puoi chiedere le cose che non sai e, se non lo fai in quei mesi, saràa difficile farlo in seguito, perchè una volta diventato 3° Ufficiale, ti viene male chiedere ad un altro Ufficiale quella cosa che non sai... e così quelle ombre te le porti dietro...
Le mie FUNZIONI e MANSIONI di Allievo di Coperta.
Sono di “guardia” (la cosiddetta “DIANA”) con il 1° Ufficiale di coperta nei seguenti orari 04/08 - 16/20
Dopo aver salutato il personale di guardia sul Ponte di Comando, il mio primo lavoro é quello di caricare il cronometro della nave in senso antiorario. Alla domanda: “perché”? Segue la risposta: “così ti svegli meglio”. Segue l’eventuale “correzione” da apportare su apposito registro (qualora l’Ufficiale R.T. (Marconi) avesse preso il segnale orario). Calcolo l’eventuale avanzo/ritardo del CRONOMETRO di bordo, altrimenti il Primo dirà di quanti minuti; dopodiché faccio il giro di tutti gli orologi di bordo: cabina del Comandante, sale mensa, cucina e avviso la Sezione Macchina.

Nella parte alta: Calcolo del Punto Nave. Esempio di Retta d'Altezza di sole trasportata all'ora della Meridiana

Calcolo del Punto Nave. Le sette Rette d'Altezza s'incrociano quasi nello stesso punto del grafico. Si tratta di un'ottima performance.
Varie ... a disposizione del 1° Ufficiale: navigazione in corso, controllo se vi sono modifiche alle caratteristiche dei fari e fanali, se la navigazione é sottocosta, oppure mi dedico alla preparazione del calcolo astronomico chiamato: “osservazione astri al crepuscolo” per ottenere il punto nave, se la navigazione é in altomare. Ore 06,00 - Arriva il Nostromo con le “sonde sentine”, DDFF (doppi fondi), depositi acqua dolce ed altri depositi; aggiornamento dati sull’apposito registro e riporto il consumo giornaliero dell’acqua dolce, controllo eventuali anomalie con sonde precedenti. Seguono gli ordini del 1° Ufficiale al Nostromo per i lavori da effettuarsi in giornata. Appena giunge l’ora dell’osservazione, si procede con la seguente annotazione dati: orario esatto cronometro, allertato prima da: "Lesta" e poi "Stop" – e dalla contemporanea lettura dell’altezza dell’astro sull’orizzonte misurato al sestante dal 1° Ufficiale che scandisce il nome dell’astro. La stessa operazione si ripete per tutti gli astri osservati. Terminate le osservazioni astronomiche si procede piuttosto rapidamente con il calcolo del punto nave. Tempi operativi del 1°Uff. = 10/15 min, con conseguente senso di sconforto dell’Allievo... 2 ore se andava bene - specialmente le prime volte.
Al “Sorgere del sole”, si calcola l’Amplitudine (ortiva), per il controllo dell’eventuale errore della bussola che si registra sull’apposito Registro, con conseguente correzione della rotta al timoniere.
Sul brogliaccio del Ponte di Comando viene annotato tutto ciò che ha rilevanza nautica: di un punto cospicuo (faro, costa, boa ecc.), cambi di rotta, tutto quello che interessa la navigazione ed alla fine della guardia il tutto viene trascritto sul Giornale Nautico parte 2a, nell'apposito riquadro e firmato dall’Ufficiale di guardia.
Smontato di guardia, il compito più odioso, almeno per il sottoscritto, (non ammettevo all’epoca di fare errori per colpa di altri), devo andare dal Cambusiere e chiedere il Menù del giorno per la Mensa del Com.te-D.M. degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, quindi scriverli e metterli sui rispettivi tavoli. Premessa: a casa mia si mangiavano minestre semplici, chiamate per quelle che erano. La domenica, gnocchi o pasta all'uovo, (magari 'alla chitarra', specialità abruzzese). A bordo invece, il Cambusiere cominciava a dettare piatti con dei nomi stranieri che io non avevo mai sentito e quindi non ero in grado di scrivere, allora lo chiedevo all’interessato, il quale mi rispondeva in dialetto ligure: “che ne so io! Ho fatto la 5a Elementare. Tu hai le scuole alte..!!” Avevo il terrore di sbagliare, non sapevo a chi chiedere, se ci ripenso, mi sento male ancora adesso.
Ritorno sul ponte di comando per seguire la navigazione. Stiamo navigando sottocosta. Dò un’occhiata alla carta nautica, visualizzo i punti cospicui, prendo i rilevamenti e li disegno ottenendo il punto nave sulla carta nautica. Ripeto l’operazione con intervalli di tempo divisibili per 6.
Ogni lunedì devo cambiare la carta al barografo ed altri registratori settimanali. Un quarto d'ora prima della fine del turno di guardia, registro le voci richieste dalla pagina a sinistra del Giornale Nautico p. 2a (Rv, Rm, Rb, Mare: direzione e forza – Vento: direzione e forza - Cielo,...... – Visibilità .......- Barom. ....., tendenza... - Temper. term.asc...., term.bgt....- Umid.Rel......%. ed altri dati meteo.
Dalle 8 in poi: controllo lavori in coperta, e poi inizia il lavoro in segreteria. Nota dolente: a scuola nessuno mi aveva consigliato di imparare a scrivere a macchina, poiché a bordo sarebbe stato essenziale... Non voglio qui raccontare di quanti fogli ho buttato nel cestino perchè non me la sentivo di presentare al Comandante una lettera con una cancellatura!! Ho proprio sofferto per questa mia carenza e bastava che avessi qualche minuto libero, per fermarmi in segreteria ed esercitarmi. In quella specie di “ufficio” finivo per passarci gran parte della giornata.
Poco prima delle 10.00 interrompo il lavoro che ho intrapreso, mi cambio e ritorno sul Ponte di Comando per il rito della retta d'altezza di sole, da “trasportare” e utilizzare con la meridiana alle 12.00 per la determinazione del Punto Nave a mezzogiorno.
Ritorno al lavoro che stavo facendo regolandomi di terminarlo per le 11.45, orario stabilito, fin dall’antichità, per l’incontro del Comandante con gli Ufficiali di Coperta sul Ponte per il calcolo congiunto del Punto Nave a mezzodì.
Come Allievo, mi pianto con gli occhi sul cronometro per annotare l'orario della MERIDIANA del sole (l’altezza massima del sole nella giornata), e quindi l'angolo misurato dagli Ufficiali che sono tre e di solito, anche se di pochi secondi, le misure sono diverse. Quello che conta è la lettura effettuata del 1° Ufficiale, ma é d’uso fare anche la media matematica delle altezze rilevate, che è quella della quale si tiene conto nei calcoli. Ottenuto il Punto Nave a ½ dì, viene messo sulla carta, ed ogni Ufficiale calcola con le formule analitiche, la distanza percorsa dal ½ dì precedente e la velocità nelle ultime 24 ore. Si passa infine al calcolo delle miglia percorse dalla partenza ed alla velocità generale del viaggio.
Il Comandante controlla il punto-nave sulla carta e decide se ci sono le condizioni necessarie per apportare eventuali correzioni alla ROTTA.
Terminati i calcoli si va tutti a pranzo, eccetto il 3° Ufficiale che ha già pranzato alle 11, ed ora monta di quardia fino alle 16.00. L’ultimo compito della mattinata per l’Allievo di coperta consiste nel consegnare alla Sez. Macchinisti i dati giornalieri: la posizione della nave, le miglia percorse, la velocità effettuata, tramite i quali verranno calcolati i consumi di carburante, acqua ed altro. Poi di corsa a mensa, perchè la fame si fa sentire.
Se a bordo c'è un bell'ambiente, il pranzo è il momento più bello della giornata in cui ci si racconta le proprie avventure, ci si prende anche in giro e finalmente si dimenticano le malinconie ecc...
Di solito si festeggia sempre qualcosa... un buon pretesto per bere del buon vino e non il solito 'cancarone', quello che passa il 'convento'.
Di solito sono gli Allievi al primo imbarco che 'offrono o soffrono da bere...' per il passaggio di Gibilterra (le Colonne d'Ercole), per il passaggio dell'Equatore, la prima volta nel Nuovo Continente ecc. ma di solito si é felici di pagare (eccetto qualche soggetto ligure!!). A bordo c'é anche il "quaderno delle musse" una specie di SPIA che segnala gli errori VERBALI (non professionali) degli ufficiali che incorrono in qualche “SVISTA” per cui si deve offrire da bere! Una volta ho detto: "sono passato all'una e il tuo oblò era 'acceso'..." - “paga da bere gondone!”
Dopo il pranzo segue l’ora della SIESTA, ma io non ho problemi di sonno, anzi, dormo pochissimo e ne approfitto per vedere sempre qualcosa di nuovo. Vado in segreteria ad esercitarmi a scrivere a macchina, se a qualcuno non dà fastidio il ticchettio della macchina da scrivere, altrimenti me ne andavo sul ponte, se al 3° Ufficiale non dà fastidio, ma credo che non gli sembri vero d’avere un Allievo pure lui, ed a me non sembra vero essere finalmente a bordo... la casa più bella del mondo!
Dalle 16.00 alle 20.00, monto di nuovo di guardia sul Ponte di Comando insieme al 1° Ufficiale. Il lavoro si svolge con più calma, specie in navigazione in mare aperto e con buona visibilità. Il Primo ha più tempo da dedicare a me: mi fa delle domande per saggiare la mia preparazione, mi spiega cose nuove, ed io ne approfitto per fargli quelle domande che ho in mente da tanto e finalmente trovo chi me le spiega.
Ho sempre pensato che buoni Ufficiali si diventa a partire dal grado di Allievo, quando è lecito e doveroso “chiedere” ciò che non si sa. Se ti restano delle lacune professionali te le trascini quando sarai 3° e oltre, ma non avrai più il coraggio di chiedere lumi denunciando in giro la tua ignoranza....
L’esperienza che si accumula vicino al Primo Ufficiale é davvero notevole, lui é il Comandante in 2° della nave, e deve sapere tutto per poter sostituire il Comandante in caso di necessità. Al suo fianco si ha modo di imparare tutti i suoi compiti: la preparazione del piano di carico, con tutti i problemi che esso comporta, la stabilità, l’assetto, evitare 'tramacchi' per scaricare merce nei porti successivi, ecc.. ecc..
Ritorniamo agli incarichi dell’Allievo di coperta. E’ necessario aggiornare i Portolani, l’Elenco dei Fari e Fanali, la cui differenza consiste nella portata: sopra le 15 miglia i primi, sotto le 15 miglia i secondi. Inoltre ci sono le correzioni delle carte del viaggio tramite i Notices to Mariners che arrivano con la posta in ogni porto scalato. Oppure, se mancano pochi giorni all'arrivo in un grande porto come Genova, occorre fare le richieste di tutto il necessario che possa servire per il viaggio successivo. Nel nostro caso, si parla di un viaggio di tre mesi (in Pacifico, con il Liberty, con destinazione Vancouver).
C'é uno stampato diviso per settori: Coperta, Camera, Cucina e varie...comincia con: Aghi da velaio... ecc. e seguono centinaia di altre voci. Per fare la richiesta, occorre scrivere, per ogni voce, la rimanenza, che l'Allievo deve calcolare con il responsabile di ogni settore.
Il pennese, per esempio, é il responsabile delle pitture, pennelli e accessori vari. Il carpentiere é colui che provvede al rizzaggio del carico con travi, puntelli, costruzione di casci, quindi maneggia tavole, putrelle, chiodi, vernici ecc... Il nostromo é colui che segnala l’usura e la mancanza di cavi di ormeggio, cavi di acciaio consumati dei verricelli, ghie, lezzino ecc. C’é poi il cuoco/cambusiere con le sue ordinazioni di piatti, bicchieri, posate ed anche gli stuzzicadenti e la carta igienica... ed a proposito di quest'ultima, c'è un aneddoto un po’ pesante, ma che non posso fare a meno di raccontare. Per ogni voce, il 1°Ufficiale scrive la richiesta, ed all'arrivo in porto, il Com.te d'Armamento esamina la richiesta, chiede ragguagli e di solito ne taglia una buona parte del quantitativo (i tagli ci sono sempre stati...non meravigliamoci di quelli odierni!). Il nostro viaggio, come abbiamo detto, dura circa 100 giorni, siamo 45 persone, quindi i rotoli di carta igienica sono diverse centinaia. Alla richiesta di tanta carta igienica il Com.te d'Armamento, esclama in dialetto genovese: "Belan, quantu papè da cù". Al che il 1° Uff.le, senza scomporsi, risponde:" 'scia sà Cumandante, qui a bordo g’han tutti u vizio maledettu de nettase u cù..!!"
Beh, sto divagando un po’! Torniamo al calcolo dell'ora del tramonto del Sole e l'ora del crepuscolo, anche perchè dalle 18.00 alle 19.00 c'é il rilievo da parte del 3° Uff.le per permettere al 1° Uff.le di andare a cena insieme al sottoscritto, ma la mia cena é subordinata a quelle ore astronomiche che ho già calcolato in anticipo e che, in verità, mi interessano molto di più. Così accade che spesso mi faccio lasciare un panino che divoro tranquillamente dopo le 20. Quindi c'é da misurare e calcolare l'amplitudine (occasa) e, come al mattino, compio le stesse operazioni: calcolo l’errore della bussola magnetica, seguita dalle registrazioni sugli appositi registri. L'unica differenza é che di solito, al tramonto, specialmente in certi posti, c'é un cielo meraviglioso e ti prende quella malinconia che solo Dante, con poche parole, poteva riassumere:
“Era già l'ora che volge il disio
ai naviganti 'ntenerisce il core
lo dì c'han detto ai dolci amici addio"
Beh! non lasciamoci prendere dalla commozione.
C'e da preparare il calcolo per l'osservazione delle stelle che devono essere prese al crepuscolo serotino, finchè l'orizzonte è ancora ben definito. Quindi si procede con le stesse operazioni del crepuscolo mattutino.
Si procede con l’annotazione dell’orario-osservazione. Altezza di quattro stelle misurata con il sestante sull’orizzonte dal 3° Uff.le. Segue il calcolo per la determinazione del Punto Nave. Mentre gli Ufficiali possono usare un metodo più sbrigativo, l'Allievo deve usare le Tavole Logaritmiche, perchè all'esame di Patentino, é prescritto l’uso di quelle tavole. (Siamo nei primi anni ’60, l’esame é scritto ed orale, se non si supera la prova, si deve aspettare sei mesi per ripeterla).
Alle 19.00 il 1° Ufficiale torna sul ponte. Quindi viene messo il punto nave sulla carta nautica, e seguono le stesse procedure del mattino (brogliaccio, compilazione del Giornale Nautico Parte 2a, riordino della Sala Nautica. Alle 20.00 monta il 3° Ufficiale e il 1° Ufficiale gli lascia le consegne: se vi sono navi in vista, riferisce per ognuna la direzione e in particolare quelle che vengono rilevate con lo stesso angolo.
In vicinanza della costa mostra i vari fari con le proprie caratteristiche e le eventuali consegne lasciate dal Comandante.
Alle 20,00 termina il mio servizio di guardia. Mangio il mio panino, se non ho fatto in tempo a mangiarlo prima, poi vado a fumarmi una sigaretta a poppa... Mi piace tanto vedere la scia della nave, specie se nell'acqua ci sono quei microrganismi che la rendono fosforescente e mi fanno pensare...
Se la temperatura lo permette, vado in cabina, scrivo le cose più importanti della giornata sul mio diario, poi leggo qualcosa oppure scrivo a qualcuno/a.
Questo succede in navigazione, con tempo buono. Se il tempo é cattivo le cose da imparare sono altre.
Le cose cambiano quando la nave si trova in porto. Occorre dotarsi soprattutto di un block notes (formato tasca-camicia caki) e matita. Si deve prendere appunti di tutto: in quale stiva si lavora, a che ora è stata aperta. Se si lavora con mezzi di bordo o di terra. Annotare l’eventuali interruzioni nelle operazioni di carico/scarico, dalle .... alle....., la motivazione (se da addebitare al bordo, oppure a terra per la mancanza di camion, ecc...). Durante la caricazione o discarica, bisogna controllare, insieme all'addetto che carica/scarica, il numero dei pezzi (casse, cartoni, tavole ecc), perchè poi occorre riconsegnare quel quantitativo che abbiamo concordato (scritto poi sulle polizze di carico), per ogni divergenza avvisare il 1° Ufficiale. E tante altre cose che adesso non mi sovvengono, ma una la ricordo molto bene: CONOSCERE BENE LE LINGUE STRANIERE E SOPRATUTTO L'INGLESE..!!!!
Quanto ho scritto (e forse sembra tanto..!), sono i compiti principali che ogni giorno, tutti gli Allievi svolgevano abitualmente, su ogni tipo di nave nei primi Anni ’60. Chiaramente quello che “sembrava tanto” i primi giorni, in seguito diventava routine. Ma, oltre a questi incarichi, c'erano tante altre cose da fare che, a poco a poco, ti facevano conoscere la nave dalla sentina fino alla formaggetta.
Ora, di tutto quello che ho raccontato: di quanto si faceva a bordo, e si aveva a disposizione per conoscere la nostra posizione in mare e per poter navigare da un porto all'altro del mondo, non esiste più nulla o quasi.
Speriamo che, a bordo delle mega-navi villaggi turistici ambulanti, abbiano avuto il buon gusto di trovare un angolo (sacrificando qualche metro quadrato ai giardini con le palme), dove mettere una bacheca con questi oggetti: cronometro, bussola magnetica, chiesuola, effemeridi nautiche, sestante, squadrette, carte nautiche (cartacee), con delle frazioni sotto che indicavano: il numero di correzioni (Avvisi ai Naviganti) che dovevano essere apportate sulla carta. Oggi le carte elettroniche in uso a bordo, vengono aggiornate automaticamente).
Se devo essere sincero, mi piacerebbe sapere quali sono, oggigiorno, i compiti dell'Allievo di Coperta, oltre all'applicazione delle Norme per evitare gli abbordi in mare, che oggi sono facilitate dalla strumentazione esistente a bordo.
Avendo esercitato il ruolo di Allievo Ufficiale di Coperta 50 anni fa, come sopra ho descritto, non saprei se dire a quelli di oggi: beati voi !!
Ognuno, si sa, rimpiange sempre la propria giovinezza, ma io rifarei l’Allievo Ufficiale allo stesso modo: amando il Mare con tutto quello di romantico ed d’avventuroso che riusciva a trasmetterci.

Da sinistra, 3°Uff. M. Gambetta, 2°Uff.G.Tosco, All.Cop. N.Catena
Per un certo periodo ho navigato con il Comandante Stefano Galleano, un vero gentleman. In navigazione, alle 11 offriva l’aperitivo sul ponte di comando. Nei porti americani (il nostro era un Liberty USA), ci ordinava d’indossare la divisa con dignità per mostrare e ricevere rispetto dalle Autorità che salivano a bordo...... anche se non avevamo più navi.
“Colpi di mare in faccia !”
La nave “liberty” ITALVEGA paga un duro pedaggio alla barra del fiume Columbia River

M/n ITALVEGA (ex Liberty canadese) a Venezia (Foto di repertorio)
2/03/1964 – “Eravamo all'uscita del Columbia River, provenienti da Portland (Oregon), con una copertata di legname (tavole-red wood), assicurata tutto a regola d'arte (con cavi acciaio, catene, cavi ecc.). Avevamo il Pilota a bordo, il quale ci aveva avvisato che fuori c'era un po' di mare lungo. Il Com.te fece rizzare le ancore, i bighi e ordinò di sgombrare la prora. Io ero l’allievo di coperta, in manovra ero sul Ponte di comando, addetto al brogliaccio e al telegrafo di macchina (era ancora quello meccanico..!!). Avvicinandoci alla barra lo spettacolo si faceva sempre più interessante, ma anche ricco d’incognite per quei relitti che affioravano insabbiati e sbandati con gli alberi che sembravano croci battute dal vento e dal mare. La corrente piuttosto forte del fiume, incontrando l'onda di mare, ne provocava l'innalzamento. Si formava così un treno di onde di piccolo periodo e molto ravvicinate tra loro. La prora cominciò ad inabissarsi e poi a riaffiorare pesantemente, come cercasse di respirare affannosamente dopo una lunga apnea. Il punto di collisione tra il fiume ed il mare era ormai vicino e noi eravamo lì, tra l’incudine ed il martello per sfidare quella natura antica che recitava il suo ruolo con grande imponenza. Improvvisamente si formò un vuoto, la prora precipitò e poi s’innalzò come per difendersi davanti ad un'onda gigantesca che era lì, di prora a dritta. Il Pilota ebbe il tempo di urlare: “watch!” - Io mi attaccai ai galletti del finestrino, pensando ad alta voce: "se devo morire... lo voglio vedere!” - L'onda si abbatté su di noi come un maglio con tutto il suo immenso peso sulla parte prodiera, urlando, frangendo e avvolgendo il ponte comando. Ricevuto il colpo da K.O. L'Italvega, s’inclinò paurosamente a sinistra, ma poi riuscì lentamente a riemergere! Dopo vari scrolloni si rimise in assetto ...

Come si vede dalla foto, l'onda battendo sulla plancia, aveva sfondato il finestrino dal quale osservavo la scena atterrito, frantumandomelo in faccia! Schegge pesanti di vetro antisfondamento, oltre il mio viso, andarono a picchiettare la paratia dietro il timoniere! Io subii diverse ferite da contusione e da taglio, ma ne valse la pena, ero ancora vivo !! Non sono credente, ma le continue preghiere di mia madre, credo, siano valse a qualcosa....!!
Da una prima stima dei danni emerse che dalla coperta erano stati strappati interi settori di legnami, altri erano stati divelti e sparpagliati dappertutto, come si vede bene dal gruppo di foto riportate successivamente. In stiva i danni erano ancora più ingenti. Fortunatamente non ci furono gravi danni alle persone. Alcuni marinai si salvarono attaccandosi ai tubi passanti in coperta, oppure trovando altri appigli sul cielo del corridoio. Resistettero con la forza delle loro braccia e della disperazione a quell’improvvisa valanga d'acqua che scese da prora verso poppa con una forza selvaggia, ma si salvarono!! Fuori dalla barra del fiume, il mare aveva riacquistato la sua dignità, era diventato improvvisamente docile e composto, proprio come l’umore dell’equipaggio che dopo lo scampato pericolo, imprecò reagendo a modo suo: “All'arrivo sbarco e non metterò più piede su una barca...! Magari vado a fare il minatore..., ma il mare non mi vedrà più!... ecc....”.
Tutti ripresero ben presto il proprio lavoro per rimettere in sicurezza la nave, ben sapendo che non era “straordinario retribuito”, ma pura normalità marinaresca.
Poi... bastava un po' di bonaccia, un bel tramonto, un porto, una lettera... e si dimenticava tutto..., perché quella era la vita che avevamo scelto, almeno fino alla prossima tempesta..!!
Rapporto e foto dei danni riportati dalla M/N ITALVEGA in uscita alla foce del Columbia River.
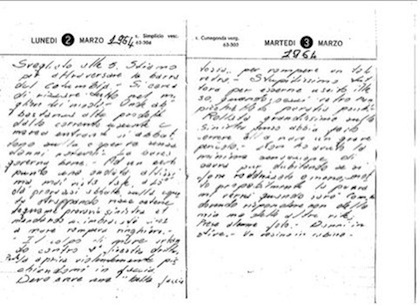

DANNI (Archivio Nunzio Catena)

Sul sito di MARE NOSTRUM Rapallo, nella sezione Video della Home Page, abbiamo inserito un interessante Film-documentario della Liberty ITALTERRA, rimotorizzata e adattata al trasporto di autoveicoli FIAT sulla rotta Savona-Los Angeles. S’intitola:
LA NAVE DELLE MILLE AUTO
Qualche giorno dopo quel brutto episodio alla barra del Columbia River, per il quale rischiai di perdere la vista o fors’anche la testa..., ebbi modo di conoscere un signore il quale mi invitò a passare un weekend con la sua famiglia, presso una tenuta che avevano presso la foce di un fiume, credo si chiamasse Clyde.
Un posto bellissimo sul Pacifico, dove onde lunghe e maestose rotolavano sulla spiaggia respingendo tutto ciò che il fiume tentava di riversare in mare ogni giorno. M’incamminai lungo la seaside e di fronte a quell’infinita bellezza mi sembrava di pregare a modo mio facendo lo slalom tra dune di rami secchi da anni bruciati dal sole e dal sale. Ad un certo punto mi trovai davanti ad una piccola radura, in mezzo alla quale il mio sguardo cadde su questa radice a forma di croce.

Era proprio una croce naturale, non costruita. Rimasi bloccato e pensoso, non sapevo se raccoglierla come ricordo o lasciarla al suo destino “oceanico”. Poi decisi di prenderla pensando che forse era lì proprio per me. L' ho presa e l'ho appesa sulla paratia della mia cuccetta e, da allora, decisi che quella Croce sarebbe stata sempre con me...!! Così è stato. Appena sposati, per prima cosa la sistemai sopra sul letto. Oggi é ancora al suo posto. Non posso dire che mi abbia portato fortuna, ma è ancora lì. La guardo ogni tanto e le pongo qualche domanda...!
L'ho lasciata sempre così, come l'ho trovata. Non le ho passato neanche una mano di copale, per renderla più lucida affinché potesse emanare dalle sue cellule la sua protezione.
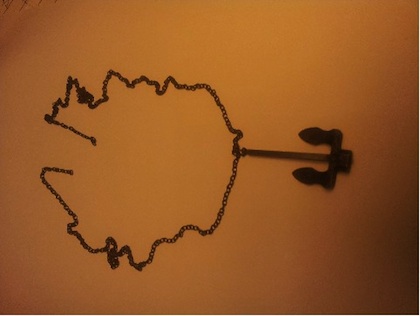
Anche l’ancora, ricordandomi vagamente la CROCE, l’ho sempre portata al collo come simbolo marinaro di speranza e fortuna.

M/n ITALTERRA in uscita dal porto di Genova

Questa foto é stata scattata quando ero 3° Ufficiale sulla M/n ITALTERRA. Da qualche parte ho scritto che sulla Liberty ITALTERRA era stata costruita la plancia sulla esistente controplancia, come si vede dalle tavole attaccate ai candelieri, per lasciare libera la plancia dove era stato costruito un lungo tavolo, per poter facilitare la compilazione dei piani di carico ed altro.

I Barracudda immortalati in queste foto, entrarono in sintonia con la velocità del nostro Liberty e finirono in pentola... Questi esemplari, li catturò il Comandante. Su questa nave (M/n ITALTERRA) sono stato imbarcato da 3° Ufficiale, per più di un anno, con il Com.te SOPRANI (nella foto), professionalmente in gamba e non solo come pescatore di BARRACUDA. In Adriatico, i miei amici li pescano insieme agli sgombri, ma non sono più grandi di 30 cm. Tra qualche anno, con la tropicalizzazione del Mediterraneo raggiungeranno le stesse misure delle foto.
Dopo aver sostenuto con successo a Genova l'esame del Patentino per diventare 3° Ufficiale, volli ritornare su un altro Liberty.


IL 3° UFFICIALE Coperta – ITALNAVI

Su quasi tutte le navi mercantili di 50 anni fa, il servizio di guardia del 3°uff.le, era il seguente: 08.00/12.00 - 20.00/24.00
Il significato di questa “guardia quasi giornaliera” é intuitivo: in quanto si parla del più giovane ufficiale di bordo, capo guardia, che non disdegna sicuramente della presenza/consulenza del Comandante che spesso, durante il giorno, sale sul Ponte di Comando. Con la Soc. Italnavi, invece, il 3° Ufficiale faceva la guardia 12.00/16.00 e 00.00/04.00 ritenuta, giustamente la più solitaria. L'ultimo periodo da Allievo di coperta, il 1° Ufficiale o perchè avesse davvero da fare, o perchè faceva parte del tipo di 'addestramento', sempre più spesso mi lasciava solo di guardia (con la frase di rito: “se c'è qualcosa, chiama!”). Nei punti di traffico, in occasione di accostate ed anche nei momenti delle osservazioni stellari, me la sono sempre cavata egregiamente, forse perchè dietro di me c'era qualcuno a quale rivolgermi!!
Ricorderò per sempre l’emozione della mia prima esperienza di “capo guardia” alla partenza da Genova come 3° Uff.le. Dopo le consegne passatemi dal 2° Uff.le, sempre gli stessi fari, le stesse operazioni da fare, eppure, mi tremavano le gambe! I punti nave li facevo ogni 15 minuti e sempre con i binocoli agli occhi, per controllare le luci delle navi in vista. Sembravo un soldatino con la carica, se ci ripenso ora, sono state sicuramente le 4 ore più lunghe della mia vita. Dietro di me non c'era nessuno che suggerisse... era subentrata la RESPONSABILITA’ che faceva la differenza. Da quel momento era tutto cambiato e solo allora ne sentivo il peso. Da Allievo, dinnanzi a qualsiasi dubbio o problema, volevo sapere il perchè, e per il 1° Ufficiale dovevo essere una bella rottura di p...! Ma da 3° Ufficiale, se avevo qualche dubbio a chi lo avrei chiesto? C’era di mezzo la dignità, l’onore, la professionalità. Il dubbio sarebbe rimasto con me. E credo che una buona massima sia questa: BUONI UFFICIALI, SI DIVENTA DA ALLIEVI.
Naturalmente, giorno dopo giorno, la tensione si allentava e poco alla volta le cose, sempre con la dovuta attenzione, rientravano nella normalità.
Oltre la guardia, il compito più gravoso per il 3° Ufficiale era:
LA CONTABILITÀ DI BORDO.
Sulle navi di bandiera italiana era consolidata tradizione di bordo che la contabilità fosse a carico del 2° Ufficiale di bordo. Faceva eccezione la Società Italnavi che attribuiva questo incarico al 3° Ufficiale di coperta.
Senza aver mai studiato qualcosa inerente la ragioneria, senza un manuale della materia da consultare a bordo, molto spesso capitava, da Allievo Ufficiale di coperta aspirante al grado di 3° Ufficiale, di voler imparare a fare le paghe dell’equipaggio. Purtroppo, capitava anche che il 3° in carica non volesse mostrarti le “formule magiche”, forse per essere rimpianto quando sarebbe sbarcato... A me è capitato proprio così, ma misi in pratica il consiglio di mio padre che spesso mi diceva: “Ricordati figliolo che il mestiere lo devi rubare!” Mi diedi da fare e mentre il 3° Ufficiale era di guardia, io approfittavo per rubargli qualche segreto. Noi avevamo il Contratto Nazionale, e le paghe dovevano essere fatte a bordo con tutte le trattenute di legge e naturalmente secondo le istruzioni che via via giungevano dagli uffici di terra con il variare delle leggi, decreti, emendamenti ecc... Insomma era il tipico lavoro che prima e dopo quegli anni ’60 era svolto normalmente dai ragionieri di terra nei loro uffici armatoriali (scagni).
Sarà dura da capire per chiunque, ma noi sull'Italterra, non avevamo neppure la calcolatrice, la prima la vidi sulla Cesana ed era del tipo a manovella.
Dovendo moltiplicare per 9, si doveva abbassare nove volte la manovella. Una manna piovuta dal cielo...
A fine mese, il 1° Ufficiale consegnava il quaderno con i turni di guardia in porto: diurno, notturno, festivo, con le relative tariffe... poi il registro dell’overtime (ore di straordinario compiuto dall’equipaggio) per le quali c'erano da considerare le domeniche e i sabati in navigazione per gli ufficiali, oltre ad altre voci come i ratei della tredicesima e quattordicesima ecc. che sarebbe troppo lunghe elencare. Di 45 persone, non c'erano due con lo stesso importo totale al quale, alla fine, si dovevano applicare le trattenute di legge. Terminata la contabilità per lo Stato e per la Compagnia, cominciava quella di bordo, vale a dire l’insieme delle spese fatte a bordo da ciascun membro dell’equipaggio che andavano in detrazione dallo stato paga.
1) Il Cambusiere presentava al contabile di bordo un’infinità di bigliettini, su cui scriveva i consumi di bevande di ogni marittimo per ogni giorno del mese ed il prezzo corrispondente.
2) Le rimesse alla famiglia in precedenza raccolte ed inviate all'Armatore
3) Anticipi presi nelle varie valute nei vari porti (con valore cambio uff. di quel giorno).
4) Sigarette, liquori, ed altri generi disponibili a bordo.
5) Costo telegrammi e operazioni varie effettuate nel mese dal Marconista.
6) Costo francobolli tramite Agenzia, (ultime lettere consegnate prima della partenza. Occorreva avere il Tariffario Postale di quello Stato per tutte le altre destinazioni, perchè spesso c'era qualche 'disgraziato' che scriveva dall'Argentina alla fidanzata svedese. A bordo c'era la bilancetta di precisione, cioé l’Ufficiale Postale.
Il 3° Ufficiale era addetto alla "salute pubblica"
1) Riempiva gli stampati per visita medica dei marittimi che ne facevano richiesta.
2) All’estero accompagnava i marittimi dal medico fiduciario della Cassa Marittima e preparava la documentazione per l’Agenzia ed il Consolato in caso di sbarco: Libretto Navigazione, conteggio liquidazione e dichiarazione di soddisfazione....
3) Eventuale acquisto medicinali qualora prescritti ma non presenti a bordo. Eventuali cure come da prescrizione medica.
Il 3° Ufficiale era anche addetto al "Servizio Doganale"
1) Prima dell’arrivo in porto, in ogni 'saletta' veniva lasciato un quaderno ove ogni membro dell'equipaggio, doveva annotare tutti i generi soggetti a dogana in suo possesso: sigarette, liquori, macchine fotografiche, apparati radio, registratori ecc.
Sigarette, liquori, caffé in dotazione alla nave erano tenuti in un apposito locale, al quale veniva applicato 'il sigillo'. La porta d’accesso poteva essere aperta soltanto dopo la partenza, fuori dalle acque territoriali di quel Paese. Spesso, durante la sosta, c'era una visita di controllo "la controvisita", per assicurarsi che gli articoli dichiarati fossero ancora a bordo e non venduti in quel porto. (Sarebbe interessante descrivere dove venivano nascoste certe merci di contrabbando, precisando tuttavia che in quegli anni non si sentiva ancora parlare di droga, ed era un genere completamente sconosciuto dai marittimi!).
Il 3° Ufficiale di coperta aveva anche il compito della cartografia, cioé la corretta tenuta dei testi di bordo: Portolani, Fari e Fanali e l’aggiornamento delle carte in dotazione alla nave, sia quelle dell'Istituto Idrografico della Marina, (Avvisi ai Naviganti), sia quelle internazionali soggette a correzioni (Notices to Mariners), oltre naturalmente a quelle che giungevano ogni giorno via radio a determinate ore.
L'Autorità Marittima esercitava periodicamente il controllo della cartografia di bordo.
Faceva parte della Sicurezza di bordo l’accurato controllo d’usura di tutti i mezzi di carico/scarico di bordo: bighi di carico, paranchi, pulegge, ghie, cavi ecc... con messa in evidenza, timbro e data controllo Ente classificatore. Ed altro. In questa operazione il 3° Ufficiale era coadiuvato dall’Allievo di coperta.
2° UFFICIALE di Coperta era responsabile della Sicurezza

Il 2° Ufficiale, sulle navi - "Italnavi" faceva la guardia dalle 08.00/12.00 ed dalle 20.00/24.00. Il suo compito principale era sicurezza di bordo:
1) Lance di salvataggio
Controllo di tutte le dotazioni prescritte:
Eventuale scadenza di segnali di soccorso - fuochi a mano, razzi a paracadute, fumogeni ecc.. loro scadenza ed eventuale richiesta.
Controllo dotazioni viveri, acqua, loro scadenza ed eventuale richiesta.
Controllo e manutenzione sistema ammaina/recupero Lance Salvataggio.
“Esercitazioni Periodiche di Abbandono Nave”, con istruzione equipaggio.
Prova RTF portatile lance salvataggio.
Ruolo emergenza aggiornato per tutte le persone dell'equipaggio con i vari compiti in caso di Abbandono Nave e consegna ad ognuno del cartellino indicante quale lancia assegnata e mansioni da svolgere.
Tenere aggiornato quaderno esercitazioni pratiche effettuate periodicamente e vistate da Com.te, per controllo Autorità Marittima.
Esercitazione simulata di "Uomo in Mare", con relativa prova di recupero di un fusto gettato fuoribordo.
2) Servizio Antincendio
Controllo scadenza e ricarica estintori esistenti a bordo.
Quadro generale della nave con ubicazione estintori con loro numero di riconoscimento ed altri mezzi antincendio, asce, tute ecc.
Ubicazione e numero identificazione idranti, controllo stati manichette.
Controllo Stazione fissa CO2
Controllo pompe emergenza esaurimento icendio
Illustrazione periodica sull’uso di tutti i mezzi antincendio.
Ricarica estintori a schiuma e CO2 ecc.
Simulazione Incendio Grave a bordo. Controllo se ogni componente l'equipaggio, sia in grado di svolgere il suo compito.
Le Annotazione sull’apposito registro erano vistate dal Com.te e, a richiesta, anche da parte della Autorità Marittima, il cui controllo generale poteva essere anche di questo tipo: Il Comandante di bordo riceveva improvvisamente un messaggio dalla Capitaneria di questo tenore: “alle ore..., si è sviluppato un incendio in quel punto della nave... Provveda alle necessarie misure richieste...”
Procedura prevista:
- Segnale con fischio per incendio grave a bordo, se in porto.
- Avvisare Autorità Marittima, Vigili del Fuoco che hanno a disposizione i mezzi antincendio.
- Altre precauzioni vengono prese qualora si tratti di una petroliera, nel qual caso può essere opportuno rimorchiare la nave in rada, secondo le normative di sicurezza vigenti.
Al termine della simulazione, l'Autorità Marittima rilasciava la sua valutazione sulla preparazione dell'equipaggio in base al tempo e ai mezzi impiegati.

M/n CESANA

In questa foto in divisa bianca da 2° Ufficiale, ero imbarcato sulla M/n CESANA (già dei COSTA). Anche il comandante Cervia, ci teneva che la indossassimo.
Quando mi sono sposato, a Roma, in una chiesa piuttosto esclusiva, c'erano tre fotografi ma siccome odiavo mettermi in posa per la foto con la zia, la cognata ecc. diedi 10.000 lire ad ognuno di loro purché se ne andassero. (Nel '67, 10.000 L. era una cifra...), non vi dico la reazione di quelli..”grazie dottò” e via. Ne ho tre o quattro, fatte di nascosto... da qualche parente. Che devo fare? Sono fatto così (male, lo riconosco).

Qui mi trovavo in una chiesetta...meravigliosa in mezzo ad un villaggio tropicale di palme e capanne. Dietro alla foto scrissi a mia futura moglie Marilena: “cerca una chiesetta così e ci sposiamo subito”.

La "giancada"
Quel villaggio era in un posto meraviglioso del Brasile, a Nord di Recife, era così bello che sono stato in forse se ripartire o meno... I pescatori usavano quelle giancade fatte di pochi tronchi, con vele di stracci ricuciti. Ogni mattina ne uscivano una decina e forse ne rientravano otto alla sera! C'era infatti una ragazza americana della FA0, che cercava di aiutare queste famiglie accudendo ad una marea di bimbi bisognosi e forse orfani. Ricordo che avevano un pozzo con una pompa non più funzionante e siccome da 2° Ufficiale avevo in carico i mezzi di sicurezza, provvidi a lasciargliene un paio che non erano più omolagate.
Prima di partire acquistai un carretto di generi alimentari che lasciai a quei bambini. So che non bisogna raccontare quando si fa del bene, ma oggi lo dico soltanto per far capire ciò che provavo per quelle persone. Da bordo presi cime e cimette per quei pescatori che mi diedero in cambio conchiglie, un carapace di tartaruga e persino un’ancora ancora in ottimo stato, a dimostrazione del loro elevato grado di “marineria”.
Quel giorno, tornando a bordo, mi capitò di vedere davanti ad una capanna una coppia di europei che mi raccontarono in breve la loro storia. M’invitarono insieme all’Allievo che mi ero portato dietro, nella loro capanna dove l'unico mobile era il baule con il quale avevano spedito le loro poche cose. Erano due insegnanti belgi che avevano fatto una nuova scelta esistenziale.
Il marito della coppia, cercava di organizzare la vendita del pescato. Quei poveri pescatori erano sfruttati dai mafiosi locali, dai quali era già stato seriamente minacciato...
La moglie era incinta ed il loro coraggio è stato premiato da Dio: da Baires mi mandarono un biglietto che annunciava la nascita di un bel maschietto.

Juanin
Avevano con loro una piccola scimmia della quale mi ero innamorato, prima di partire me la regalarono e me la portai a casa come ricordo di quella straordinaria conoscenza... solo un matto come me poteva sfidare quel forte cambio di clima dal loro caldo al nostro inverno.
Dovevo sposarmi di lì a due mesi... Marilena credeva che fossi scomparso. Purtroppo solo a Baires trovai un ufficio postale.
Avevamo scalato Baires per caricare una copertata di casse di ananas, e ricordo che il caricatore, per impedire che si toccasse il carico, ci regalò 60 casse di ananas, che imbevuto di whisky era la fine del modo.


Vi presento Juanin dopo il bagno... Notare l’eleganza con l’accappatoio fatto all’uncinetto dalla povera mamma.
L'ho chiamai così perchè il paese più vicino si chiamava Juan Pessoa. Ogni animale che “imbarcavo” lo chiamavo con il nome di provenienza.
Cercando di acclimatarlo, lì era estate e da noi inverno, mi feci dare dall'amico 1° Macchinista Giorgio Costaguta (riviera di levante, ma non ricordo il paese) una lampada a raggi infrarossi, credo venisse usata in Sala Macchine per asciugare i motori elettrici. Avevo costruito una scala che utilizzavo per tenere Juanin ad una certa temperatura. Era la mascotte di bordo e la tenevo libera in cabina. Quando mi sdraiavo in cuccetta, Juanin si metteva sulla guida della tendina ed io parlavo con lui... Ad un certo punto mi addormentavo e lui veniva giù e con le sue manine mi apriva un occhio, come per dire: che fai, adesso non mi parli più ?? Era di un’intelligenza paurosa.
Quando scrivevo a Marilena, Juanin s’incazzava perchè non parlavo con lui, si sentiva escluso ed allora si metteva con la schiena contro la mano e puntava i piedini, come per fermarmi.
Quello stesso viaggio, non ricordo che porto fosse, vidi un cane sulla banchina... un lupo incrociato, lo ricobbi subito come un "cane di bordo" di qualche nave diretta in Inghilterra. A quei tempi erano guai per chi teneva un cane a bordo, forse per questo lo avevano lasciato a terra.
Marilena mi dice spesso: “tu dovevi fare il frate..” Perchè ho sempre fatto il tifo per i meno fortunati: uomini, animali oppure persone anziane. Per farla breve, prima di partire, raccolsi pure il cane chiamandolo Bubu. Non ci crederete, ma Bubu si metteva accovacciato vicino a me e appena chiudeva gli occhi, Juanin scendeva giù e gli tirava i baffi...! Giustamente quello s’incazzava, ed io pensavo che prima o dopo Juanin sarebbe finito in un morso.. lo faceva 50 volte al giorno ed è riuscito a sopravvivere.
Quando portai Juanin a casa, gli feci la cuccetta con il guscio di mezza noce di cocco riempita di cotone e la sistemai sopra il caminetto.. a mia madre faceva un po’ impressione perchè diceva che assomigliava ad un topo...e ripensandoci, non aveva tutti i torti! Quando ripartii se ne prese cura Marilena.
Purtroppo, dopo un’intensa nevicata, forse a causa del freddo o altro, Juanin diventò cieco e poco dopo morì.
Per fortuna, subito dopo nacque la mia prima figlia Marina, perchè io sono stato male, fisicamente e moralmente!
È vissuto poco più di un anno. Gli avevo fatto una gabbia nel gardinetto dalla parte della ferrovia, dove poteva saltare come voleva al riparo di gatti ecc.

La cagnetta Palma
In quel gardinetto, c'era la gabbia delle poiane, la villetta di "Palma", la cagnetta che avevo riportato da Las Palmas, il soggiorno diurno del pappagallo "Pedro", da Bahia Salvador che ha vissuto 26 anni, la sistemazione del Gabbiano "Ubaldo", ammaestrato.

Ubaldo, il gabbiano ammaestrato
Quando voleva, andava con i suoi amici, poi ritornava; una volta, forse si sarà innamorato, se ne andò e non è più tornato..! Adesso a Ortona Mare è cambiato tutto, la ferrovia ha sistemato il secondo binario ed ha costruito il Muro di Berlino a due metri da casa.
Se devo essere sincero, quella casa non mi piace più, la spiaggia è cambiata. Prima i sassi erano puliti ed il mare era a 20 mt. da casa; ora tutta quella sabbia è quasi polvere!
Sono scomparsi, sepolti dalla sabbia, i blocchi di cemento, sopra i quali andavo a studiare e a prendere il sole. A dirla con Celentano “Ora é cambiato tutto”.
Non ho finito di raccontare di "Bubù", che era una femmina e non vi dico del mucchio di problemi quando partorì otto cuccioli da nutrire con l’integrazione di latte con il biberon e dei tentativi per lasciarlo ai portuali un po’ indecisi cercando di corromperli anche con numerose stecche di sigarette. Purtroppo a bordo nessuno se la sentiva di gestire una situazione così complessa e laboriosa.
In effetti, la mia passione per gli animali é andata anche oltre .... e non posso nascondere che a bordo ho avuto una foca, piccolina, "Madrin" perchè l'avevo presa a P.to Madrin, in Patagonia. La tenevo nel bagno di una di quelle cabine destinate all'isolamento. Per andare incontro alle sue abitudini climatiche avevo chiuso i termosifoni, la tenevo immersa nell’acqua fredda e si nutriva soltanto di pesce vivo che io stesso pescavo. In seguito, quei figli di buona madre di colleghi, aprirono il termosifone... e feci appena in tempo a liberarla!
Ancora oggi, quando si parla di Juanin, noto che mia moglie Marilena, purtroppo, non mi ha ancora perdonato quel mese senza posta... e s’incazza ancora come una vespa, come se il fattaccio fosse successo la settimana scorsa, magari con una sudamericana alla fine del mundo...
IL PAPPAGALLO PEDRO

Pedro era un pappagallo brasiliano che portai come ricordo dall’ennesimo viaggio in Sud America. Aveva imparato a parlare discretamente ed era davvero uno spasso per tutti i bambini che venivano a trovarlo e con i quali parlava e rideva, sopratutto con loro.
Quando mi trasferii in Sardegna, lo lasciai ai miei genitori che per motivi di salute lo affidarono a zio Ferruccio (Ferro). Quando tornai definitivamente non ebbi il coraggio di riprenderglielo. Stavano troppo bene insieme! Zio Ferro era un tipo tutto particolare... aveva una tromba-giocattolo di plastica con cui riusciva a suonare il Silenzio in maniera eccellente e 'Pedro' lo ripeteva alla Nini Rosso (di vecchia memoria). Gli zii non avevano figli e litigavano soltanto... così Pedro s’inserì nella famiglia assumendo il ruolo di paciere dialogando con Ferro dalla mattina alla sera.
Questo zio fumava anche il “bastone di S. Giuseppe” e dovette subire una tracheotomia che lo relegò parecchio tempo in ospedale. Una sera, rispettando l’orario di visita, gli portai Pedro dopo un viaggio avventuroso in auto... la povera bestia raccava come un mozzo al primo imbarco in mezzo ad una burrasca, ed ogni volta bestemmiava come un turco, perchè gli aveva insegnato anche quello, quando c'era qualcosa che non andava... Arrivati al varco, mi fermò il guardiano dicendomi: “dove va con quella bestia”. Di rimando risposi: “il Padrone di questo animale, è ricoverato qui da oltre due mesi, non ha parenti, questo è il suo unico convivente, perciò ha tutto il diritto di entrare!” Per farla breve, con un pacchetto di Marlboro risolsi, come sempre il problema. Quando si rividero fu davvero una scena commovente. Dall’agitazione, Pedro non sapeva più cosa fare e dire che ci volle il primario per ristabilire un po’ di ordine... Pedro aveva preso posizione sul trespolo delle flebo e non c’era modo di spostarlo. Pedro rimase con Ferro fino all’ultimo, poi lo riportai con me, ma improvvisamente, dopo alcuni giorni, si ammalò di crepacuore e morì per seguire il suo alter ego nell’al di là. Pedro stette con noi 26 anni e diverse generazioni di bambini lo conobbero, giocarono e crebbero con lui. Pedro e Ferro erano entrambi ghiotti di peperoncino rosso, mangiavano le stesse cose e vivevano in simbiosi. Erano nati l’uno per l’altro...
C.I.R.M. – Una BENEMERITA ISTITUZIONE

SERVIZIO GRATUITO DI TELEMEDICINA
Il Centro Internazionale Radiomedico è sorto nel 1935, allo scopo di fornire assistenza radiomedica ai marittimi, imbarcati su navi senza medico a bordo, di qualsiasi nazionalità, in navigazione su tutti i mari.
Il CIRM ha la sua sede in Roma ed i suoi servizi medici, sono gratuiti. Essi includono l’interessamento per un eventuale trasbordo del paziente su nave fornita di servizi medici o, se la distanza lo permette, il prelievo del malato con mezzi navali o aerei per una rapida ospedalizzazione.
Spesso durante le tempestose traversate Atlantiche, capitava qualche imprevisto di salute ad un membro dell’equipaggio che generava preoccupazione, specialmente nel Comando di bordo che doveva in qualche modo trovare una soluzione al problema. E’ quindi giunto il momento per raccontare com’era organizzato il “servizio sanitario di bordo”, tramite una delle poche istituzioni della quale l’Italia poteva essere orgogliosa (in quanto al mondo ne esisteva una simile soltanto a New York). Sto parlando del C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), fondato inizialmente dal conte dott. Guido Guida il quale, aiutato da altri medici, assicurava gratuitamente l’assistenza medica agli equipaggi delle navi mercantili di qualsiasi nazionalità. Il primo presidente fu Guglielmo Marconi, in quanto allora era indispensabile la trasmissione R.T. ed i messaggi via Roma Radio, avevano la precedenza su tutti gli altri (sigla PAM PAM) ed erano gratuiti. Il C.I.R.M. era un Ente senza fini di lucro e veniva finanziato da offerte volontarie di Armatori e Marittimi, ai quali periodicamente venivano chieste, ed ognuno rispondeva con una cifra che rispecchiava la propria possibilità e sensibilità. C’è stato un periodo in cui si è rischiato di perdere questa unica ed utilissima istituzione, che fu poi ripotenziata grazie all’interessamento del Com.te Prospero Schiaffino, (Armamento Italnavi). Premesso che ogni nave, a seconda dei viaggi e del numero delle persone imbarcate, doveva essere dotata di una infermeria e di medicine ben definite e consigliate dallo stesso C.I.R.M. che fossero quindi in grado di far fronte ai vari tipi malattie e soprattutto infortuni che spesso si verificavano durante il viaggio. Ogni sei mesi, veniva effettuata da parte di un Medico della Sanità Marittima, un controllo sui medicinali ed altre dotazioni prescritte e rilasciava un Certificato di Visita Cassetta Medicinali, compreso il controllo della morfina e di altri stupefacenti prescritti, riportati su un apposito Registro Stupefacenti. Di solito il compito sanitario di bordo, veniva assegnato al 3^ Ufficiale, il quale era responsabile della gestione di questo settore. Durante il Corso all’Ist.Tec.Nautico, era prevista una ora settimanale di Igiene Navale, durante la quale, oltre allo studio delle varie parti del corpo, venivano descritti i vari tipi di malattie ed i relativi rimedi da prendere. 50 anni fa, quando ci s'imbarcava da 3°Ufficiale, si era responsabili di questo settore senza aver mai praticato una puntura! Negli USA, dove per tradizione è stata data molta importanza alla sicurezza, all’arrivo in porto, ancor prima d’iniziare le operazioni commerciali, veniva a bordo un infermiere il quale chiedeva dove era ubicata l’INFERMERIA, poi applicava sulle paratie della nave le frecce che indicavano il percorso per raggiungerla. Spesso appariva la scritta : “SAFETY FIRST” e sottobordo era già pronta una apposita barella in caso di necessità. In fondo al pontile, lungo il quale erano ormeggiate diverse navi da entrambi i lati, c’era una Autoambulanza sempre operativa, con Medico a Bordo.
Dopo qualche anno ricordo che anche in Italia si fecero dei passi avanti nella preparazione sanitaria degli ufficiali naviganti. Per esempio, fu richiesto agli ufficiali di coperta di presenziare un certo numero di ore in un Pronto Soccorso. La prestazione veniva registrata sul Libretto di Navigazione dell’interessato. Purtroppo, come ho riferito in precedenza, da 3° Ufficiale, il mio primo impatto con la siringa fu traumatico. A farne la spesa fu il Direttore di Macchina che stoicamente subì il mio tremolio con le titubanze della prima puntura. Pur conoscendo la tecnica esatta di come fare un'iniezione, lottavo contro la paura di fargli male e la mortificazione qualora la mia imperizia fosse venuta all’orecchio del Comandante...
Con l’anzianità di servizio acquisii esperienza. Quando facevamo rifornimento di medicinali a Genova, mi facevo regalare dei profilattici da consegnare all’equipaggio, soprattutto a quei ‘disgraziati’ cui non mancavano le tentazioni... durante i viaggi in Sud America (Argentina e Brasile). Ricordo una loro tipica definizione: “i gondoni in vendita da quelle parti li fanno con pezzi di camera d’aria di biciclette”. Comunque, dopo un paio di giorni, dalla partenza dal Brasile, si formava la coda davanti all’infermeria di bordo. “Sior purtroppo mi brucia...” - La diagnosi era sempre la stessa: scolo (Blenorragia!).
50 anni fa, non c’erano le siringhe "usa e getta" e sapendo come di solito si svolgevano le cose, avevo diversi bollitori per sterilizzare gli attrezzi che consegnavo ad ognuno dei pazienti che, istruiti adeguatamente, dovevano presentarsi alle 12 meno ¼, e alle 23,45 davanti alla mia cabina, pronti per la terapia di penicillina (tipo calce).
“Se ti fa male, domani non venire” - “No, sior, va bene, grazie!” Con un po’ di umorismo, devo dire che era divertente osservare i miei pazienti dal Ponte di Comando mentre camminavano verso la cala del pennese per prendere pennelli e pitture.... Camminavano tutti allo stesso modo: con una gamba tesa...!
Prima di continuare, desidero raccontare questo episodio, accaduto a LONG BEACH, a bordo dell’ “Italterra” quando ero 3° Ufficiale, addetto a questo servizio. Eravamo in partenza. Durante la chiusura della stiva, si stavano sistemando i pannò sulle galeotte, un marinaio cadde accidentalmente in stiva. Data l’organizzazione appena descritta, in un attimo il marinaio si trovò sull’ambulanza e, presi alcuni suoi effetti personali, giungemmo a sirene spiegate all’ospedale dov’era tutto pronto per intervenire sul malcapitato. Il medico, Via Radio, aveva diagnosticato e concordato l’intervento. M'informai subito sul da farsi per procedere allo sbarco urgente del marittimo, la nave era in partenza. Con grande meraviglia mi risposero che nel giro di qualche ora il marinaio sarebbe stato dimesso e in grado d’affrontare il viaggio di ritorno. Infatti, poco dopo me lo riconsegnarono mummificato, con un rifornimento di qualche chilometro di garze e stecche di legno di varie misure, con raccomandazioni e istruzioni da osservare per il viaggio di ritorno. Adesso possiamo anche sorriderci sopra, ma quando occorreva medicarlo, soltanto per srotolarlo ci voleva più di una persona, era una specie di girarrosto e la persona più utile a bordo era il carpentiere che sapeva riposizionare tutte le stecche alle parti infortunate. Comunque all’arrivo in Italia, era migliorato di molto.
Ritorniamo all’organizzazione sanitaria di bordo.
Ogni marittimo, aveva una sua cartella clinica, ed in caso di necessità, il Comandante inviava al C.I.R.M. le notizie essenziali circa il tipo di malattia, con la descrizione dei sintomi e siccome non era permesso (privacy) trasmettere in fonia le notizie, queste venivano codificate con gruppi di 5 o 6 lettere, con un codice particolare. Il C.I.R.M. emetteva una diagnosi e, conoscendo le medicine esistenti a bordo, prescriveva la cura e dava l’appuntamento per i successivi appuntamenti per l'aggiornamento delle condizioni del paziente. Nei casi gravi in cui era ritenuto necessario d’intervento medico, il Centro si accertava della presenza in zona di navi passeggeri o militari, oppure consigliava il dirottamento verso il porto più vicino.
Un caso analogo successe proprio a noi. Partiti da Lisbona l’11 gennaio ‘64 diretti a Long Beach via Panama, l’Allievo M.F. vomitava ripetutamente, e subito si pensò che fosse a causa del mare molto mosso. Infatti, il Comandante per evitare danni al carico, accostò di 180°. Purtroppo il malessere continuava. Anche la cura prescritta dal C.I.R.M. sembrava inefficace. Alle 18.40 del 14 gennaio, il Comandante decise di tornare indietro per sbarcare l’Allievo sull’Isola di Madeira! Portata la velocità al massimo, si fece rotta per Funchal dove si arrivò il 15 gennaio ‘64 alle ore 06.35. Il Pilota ci portò alla fonda a ridosso del molo, e terminata la manovra giunse subito il medico. Seguì un'immediata visita del medico che consigliò lo sbarco del povero Allievo per sospetta peritonite. Alle 11.15 si salpò e si riprese navigazione per Panama.....!

Un altro salvataggio del C.I.R.M.
Le due foto riportate sotto, si riferiscono allo sbarco dell'Operaio Meccanico M.P. dall' "ITALTERRA" sempre a Funchal. Fui proprio io ad accompagnarlo all'ospedale, all’epoca ero il 3° Ufficiale di bordo, responsabile della "salute a bordo". Il marittimo era stato colpito tre giorni prima da 'angina pectoris' durante il viaggio di ritorno, da Panama a Gibilterra. Grazie ai consigli del CIRM fu sbarcato e, da notizie successive, fummo informati che aveva superato abbastanza bene gli effetti di quell'episodio.
In quella occasione sarei potuto morire, ma le preghiere di mia madre mi salvarono ancora una volta. Stavamo per toccare la banchina con un mezzo dei barcaioli locali del porto di Funchal, scivolai mentre mi accingevo a saltare e finii in mare tra la banchina e lo scafo di quel pesante barcone che preso dall'onda della risacca, stava per schiacciarmi. Proprio in quel momento in cui immaginai la mia fine, sentii una mano che mi afferrava da dietro sollevandomi verso la salvezza. Non era ancora giunto il momento segnato dal "Destino"!


Lo sbarco di un marittimo
IL MARCONISTA - “Marconi” – R.O.


Sulle navi passeggeri i Marconisti erano tre e coprivano le 24 h. Il 1° Radiotelegrafista (Capo Stazione Radio) aveva il grado di 1° Ufficiale, gli altri da 2° Ufficiale, mentre sulle navi da carico ve ne era uno soltanto e svolgeva un orario a seconda della posizione della nave.
Il loro regno era la Stazione Radio ed i loro compiti principali erano:
1) Ascolto continuo di eventuali messaggi di soccorso, pericolo ecc..
2) Ascolto liste traffico per eventuale traffico in arrivo.
3) Trasmissione eventuali messaggi da bordo a terra.
4) Ascolto segnale orario per correzione cronometro di bordo.
5) Ascolto Avvisi ai Naviganti, riguardanti la nostra zona di navigazione.
6) Ascolto Bollettini Meteo.
Quando c'era cattivo tempo, Marconi arrivava con quella 'velina' (un po’ diversa da quelle di Berlusca.. ) dove era scritto: Una depressione di ......mb, in posizione Lat..... e Long......., si muove in direzione..... E qualche altra notizia.., queste erano le previsioni disponibili del tempo. Il Comandante, a seconda della profondità della depressione e della sua direzione, delle caratteristiche della nave, del carico ed altri parametri, stabiliva la rotta più opportuna.
7) Ascolto notizie ANSA:
Come facesse quel “cristiano” con le cuffie a ricevere quella stampa trasmessa ad una velocità superiore a 120 caratteri al minuto, per me resta un mistero! So che il momento più bello della giornata per noi arrivava a mezzogiorno, quando si poteva leggere ciò che succedeva nel mondo, ed era il nostro unico contatto con la terraferma.

Questa era la 'potente', si fa per dire... RADIO dei LIBERTY con la quale il povero Marconi doveva inviare i messaggi dal Pacifico all’Italia!!
Ricevitori automatici. Tutte le navi hanno dei ricevitori automatici così sistemati:
1) Stazione radio/marconista, 2) Plancia 3) Cabina Com.te. Questi ricevitori si mettevano in funzione automaticamente allorquando una nave, prima di emettere l'SOS, trasmetteva il Segnale d’Allarme composto di una serie di 12 linee in 1 minuto con il compito di mettere in allarme tutti i ricevitori automatici delle navi in navigazione, alle quali perveniva anche il nominativo della nave in difficoltà e la sua posizione.

OROLOGIO DI BORDO - STAZIONE RT
I settori colorati dell'orologio (vedi foto) indicano tutt'oggi i tre minuti obbligatori di silenzio radio, in modo da poter ricevere anche i segnali radio di soccorso più deboli perché lontani. Sulla frequenza internazionale di soccorso 2182 in fonia, si esegue per 2 periodi all'ora, da xx.00 a xx.03 di ogni ora e da xx.30 a xx.33 di ogni mezz'ora. Sulla frequenza di 500 kHz in grafia, da xx.15 a xx.18 e da xx.45 a xx.48 .
E poi Marconi era la 'speranza' che risolveva qualsiasi problema elettrico.
Non funzionava quella specie di radar? Arrivava lui con il tester e tutti trattenevano il respiro nell’attesa del responso. Poi seguiva la ricerca affannosa del relais di rispetto nelle nelle spare parts.
Il Marconista di bordo era invidiato da tutti perchè all'arrivo in porto, essendo vietate le trasmissioni radio, era fuori servizio fino alla partenza. Per questo motivo l'ultima lettera alle famiglie, prima di partire, la spediva sempre lui.
Davvero struggente, per quelli della mia generazione, l'ultimo messaggio emesso da Roma Radio : CQ CQ CQ DE IAR IAR IAR che annunciava che dalle 00.00 UTC dei 01/01/2004 le Stazioni Radio Italiane terminavano il proprio servizio, e chiudeva:
"Good look and fair winds to maritime community stop"
Ormai le comunicazioni a bordo delle navi, sono regolate da quanto previsto dal GMDSS per quanto riguarda strumentazione e personale addetto.
Erano 'brutti tempi' per andare per mare allora, ma il tempo fa dimenticare le cose brutte ed il tutto, riguardandolo ora, sembra più bello, tanto da rimpiangerlo!
Il Marconista era la salvezza della nave, fino all'estremo SOS, ma a volte bastava ricevere una sola 'parola', per ridare il sonno ad una persona che l'attendeva con grande ansia.
Tra fidanzati, spesso si usava un brevissimo messaggio che significava tutto OK. La mia era "PENSOTI"...
Molto spesso Marconi era anche un amico e partecipava anche lui alle mie ansie: "Marco'... la prossima 'Lista di traffico' a che ora è? Senti pure Londra...vedi tu..!
Quando finalmente quel "Pensoti" arrivava, Marconi veniva di corsa a dirmelo in cabina, se ero da quelle parti!
Quel giorno, sul tavolo della Mensa Ufficiali, si notavano tanti fiaschetti di Chianti.. E alla domanda: “Chi offre”? La risposta era "U Cadenna", perchè? Per "INTIMO GAUDIO".
Testo e foto di
Nunzio Catena
Con la complicità del Presidente-Webmaster Carlo Gatti con il quale condivido tanti ricordi ed esperienze degli Anni '60.
Ortona, 31 Marzo 2014
O LEUDO - Fiorenzo Toso
O LEUDO
di
(Fiorenzo Toso)
Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì son stæto mainâ. Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì ò visto de tære lontañe, de dònne mäveggiose, e delongo m'assunnavo quelle træ fasce d'oivi derê a-a casa, che a mæ moggê scua e stondäia a mandava avanti quande mi navegavo.
Mæ poæ o m'à mostrou comme se deve scigoâ pe ciammâ o vento quande gh'é bonassa, e comme s'à da pregâ pe tegnî lontan e dragoñe, e coe de vento.
Oua che son chì, vegio, desnavegou, e che a mæ dònna a l'é mòrta, e e fasce di oivi son in zerbo, oua che i mæ figgi no navegan, ma tëgnan i stabilimenti da bagni pe-a demoa di foresti, oua che i mæ nëi parlan unna lengua che no capiscio, a coæ do mâ ghe l'ò delongo into sangue, a me s'inscia drento tutte e vòtte che vaggo à giandonâ in sciâ mæña, co-i atri dötræ da mæ etæ che se rebellan ancon pe-i caroggi do paise.
A-i nòstri tempi s'andava à veia. I capitagni braggivan i comandi in bon zeneise, giastemmando San Pê, e i peneixi portavan l'anelletta à l'oegia. S'arrivava à un pòrto e subito s'andava à beive pe scordâ e træ fasce e a moggê stondäia, ma intanto l'indoman l'ea pægio, e no gh'ea ninte da fâ. Unna vòtta, à Scingapore, mi e un de Carlofòrte emmo provou à fummâ l'eubbio, no ve diggo, paiva d'ëse in sce unna nuvia. N'an attrovou a-a mattin int'un caroggetto, sensa unna palanca, mezi nui e con un mâ de testa da scciuppâ. O capitagno, un de Camoggi, o ne l'aiva dito de no stâse à fiâ di cineixi, che son de gente gramme. Na che no son de gente gramme, no son miga pezo di atri. O l'é de naätri mæximi che no se doveivimo fiâ.
Pan cöse lontañe, e intanto pâ vëi... A-o Cao d'Orno, unna vòtta, mi e un compagno emmo visto unna dònna pescio. Segùo, a pâ unna föa, ma intanto mi l'ò vista, a l'ea nùa, de d'ato a l'ea pægia à unna dònna e de sotta a l'aiva a coa verde, co-e scagge e tutto.
Dixan che i mainæ, de stâ delongo pe mâ, no capiscian ciù ninte, veddan de cöse che no ghe son, se imaginan de istöie. O giorno dòppo, a borrasca a n'à streppou a veia grande, e quello mæ compagno lì o l'é cheito in mâ. Mi diggo ch'a l'é stæta a dònna pescio ch'a l'à vosciuo con lê. Ò insomma, l'é megio credde coscì, che pensâ ch'o segge mòrto apreuvo à un corpo de vento. Unna föa. E a saià ben unna föa, ma quante vòtte, inte quelli giorni, no me ghe saieiva bollou mi ascì in mâ, sensa quella föa?
À Bonnesaire andavimo delongo à mangiâ da un do paise ch'o l'aiva unn'ostaia donde favan o pesto, o menestron e a fainâ co-a säçissa. Mangiavimo, beveivimo, e in sciâ fin se metteivimo à cantâ e pagavimo coscì, à son de tralalleri, e i zeneixi de lazzù vegnivan à sentîne fin d'in fondo a-a Pampa.
Regòrdi. Ma no se peu vive solo de regòrdi. Oua mi, o Ciomê e o Dria emmo attrovou un leudo abbandonou into cantê do sciô Tasciæa, quello ch'an da cacciâ zu pe fâghe un atro stabilimento da bagni.
O l'é un bello leudo, ma dev'ëse ciù de vint'anni ch'o l'é lì, da quande o cantê o l'à fæto baracca: beseugnieiva cangiâghe o fasciamme, l'erboo meistro o l'é inte tanti tòcchi e o cöpresso se l'an portòu via. Emmo attrovou fiña e veie, ma son meze mangiæ da-i ratti. Seguo, à repessâle comme se deve, dovieivan ancon tegnî o vento.
Gh'emmo pensou, mi co-i atri doî. À dâghe recatto, o se porrieiva mette in mâ de lengê. O l'à unna bella armatua, nervosa, o l'à di scianchi comme unna figgia à sezz'anni. O n'asbrivieiva fin à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resäto. Ma niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Vernassa, dove o Dria o gh'à di pænti, a-a Bordighea, donde gh'é un mæ amigo, quello ch'o parlava co-i draffin e ch'o sunnava a tromba de succa. S'o l'é ancon vivo.
D'arescoso da-i figgi, tutti e trei emmo levou i dinæ d'in banca. Pöca cösa. Quello ch'aivimo guägno o l'é partio tutto, tòsto tutto, pe tiâ sciù a famiggia, pe dâghe da mangiâ, pe fâli studdiâ. E niatri lonten, à Caracas, à Hong Kong, à San Francisco, tanto che no an fæto in tempo à conoscine, i nòstri figgi.
O sciô Tasciæa o leudo o ne l'à regallou. O l'é mezo feua de testa, meschinetto, ma o l'à capio pægio: lê ascì o l'à navegou, o l'é stæto capitagno. Pöi o l'à averto o cantê e o s'é misso à fâ e barcasse pe-o pòrto de Zena, into momento che e barcasse no servivan ciù à ninte. Sò moggê co-o figgeu a se n'é anæta con un milaneise, un ch'o l'à un abergo à Sanremmo, e lê o l'é arrestou mezo alloou, o no s'é mai ciù repiggiou: oua o l'à tòsto novant'anni. Sò figgio o l'é cresciuo, o l'é vegnuo a-o paise l'anno passou e o gh'à fæto firmâ di papê. Coscì caccian zu quello che resta do cantê e ghe mettan di atri bagni, Bagni Paradiso, Bagni Sole e Mare, chi ô sa.
Co-i dinæ ch'emmo levou d'in banca cattiemo e cöse che serve pe dâ recatto a-o leudo. Beseugna trovâ i erboi – emmo zà parlòu co-o bancâ do caroggio drito, ch'o l'é stæto meistro d'ascia –, sarsî e veie, cartezzâ, vernixâ, desentegâ i ratti.
No finiemo sens'atro avanti d'ëse mòrti, mi, o Ciomê e o Dria. E se mai fescimo in tempo, no aviëscimo sens'atro ciù a fòrsa nì o bon d'avaâ o barco, de fâlo navegâ, de stâ apreuvo a-a rotta.
Ma de regòrdi solo no se peu vive. De föe, de seunni manco. E sto leudo o no l'é un seunno, o l'é bon legno saxonou, che à dâghe recatto o n'asbrivieiva à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resato. E niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Nöi, dove o Ciomê o l'à di amixi, a-o Tellâ, dove gh'é quello mæ coxin, quello ch'o l'addomestega i öchin e ch'o tia de cotello comme un singao. S'o l'é ancon vivo.
Alessandra Cutrì intervista Fiorenzo Toso

Docente di Linguistica generale presso l’Università di Sassari, Fiorenzo Toso è linguista e dialettologo specialista dell’area ligure, redattore principale del Vocabolario delle Parlate Liguri (1985-1992, 4 voll.) e autore della Letteratura genovese e ligure (1989-1991, 6 voll.), del volume Gli ispanismi nei dialetti liguri (1993), della Storia linguistica della Liguria (1995), della Grammatica del genoveseDizionario etimologico storico tabarchino (2004) e della Grammatica del tabarchinoXeneises. La presenza linguistica ligure in America Meridionale (2006), de La letteratura ligure in genovese e nei dialetti locali. Profilo storico e antologia (2009, 7 voll.), del Piccolo dizionario etimologico ligure (2015), per citare solo alcuni lavori maggiori. Fra le altre cose, si occupa anche di plurilinguismo (Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente, 2006), di fenomeni di insularità e di contatto linguistico (Linguistica di aree laterali ed estreme. Contatto, interferenza, colonie linguistiche e «isole» culturali nel Mediterraneo occidentale, 2008), di minoranze linguistiche (Le minoranze linguistiche in Italia, 2008; La Sardegna che non parla sardo. Profilo storico e linguistico delle varietà alloglotte. Gallurese, Sassarese, Maddalenino, Algherese, Tabarchino, 2012) e di etimologia (Parole e viaggio. Itinerari nel lessico italiano tra etimologia e storia, 2015). (1997), del (2005), del volume
A oltre 150 anni dalla nascita dello Stato italiano i dialetti stanno perdendo terreno a causa di cambiamenti politici ed economico-sociali che hanno portato all’emergere della lingua italiana mentre, a livello globale, si assiste parimenti al “trionfo” dell’inglese. L’aumentata mobilità delle persone, la diffusione di internet e la maggiore istruzione nell’epoca della globalizzazione portano spesso i parlanti ad allontanarsi dalle lingue originarie (in particolare dai dialetti) e ad “appiattire” le loro potenzialità comunicative nell’uso di un unico idioma dotato di maggior prestigio; si tratta, forse, di una tendenza ciclica e storicamente inevitabile. Mettere in atto misure di tutela dei dialetti è possibile e necessario? Potrebbe rivelarsi un’azione forzata, antistorica e regionalistica?
Ho iniziato a occuparmi del patrimonio linguistico ligure nel 1976, quando avevo circa 15 anni, raccogliendo le parole del genovese parlato al mio paese d’origine per quello che sarebbe diventato il Vocabolario delle parlate liguri, di cui divenni in seguito redattore. Ricordo il titolo di un articolo di Manlio Cortelazzo su una rivista locale, a sostegno dell’iniziativa: “Un’impresa urgente: salvare i dialetti”. Infatti, a quell’epoca, i linguisti e i sociologi – nel quadro di una certa temperie culturale – preconizzavano la scomparsa nel giro di pochi anni delle parlate locali. Siamo al 2017, e per quanto mi riguarda ho ancora molte occasioni di trascorrere ore discorrendo in genovese con persone di ogni età, genere, formazione e livello culturale. Attenzione, questo non significa che non ci sia una crisi – di uso, di funzionalità, di “immagine” se vogliamo – delle parlate locali, ma mi sento anche di dire che fare della sprachprognostik sui processi di obsolescenza linguistica non è facile, e che occorre essere molto prudenti nella valutazione dei fattori che possono contribuire a generarla. L’informatica, ad esempio: avrà pure contribuito a espandere lo spazio dei codici standardizzati di più larga diffusione – dalle lingue nazionali all’onnipresente inglese – ma è anche un veicolo potente e democratico di diffusione per qualsiasi altra lingua o dialetto. Oggi, attraverso i social, i siti dedicati ecc., un testo, un video, una trasmissione in una lingua di minor diffusione possono arrivare a un pubblico ampio, e con costi limitati. Più in generale: in giro, e per tanti motivi che sarebbe ozioso ripetere, c’è evidentemente una “domanda” di territorialità linguistica, che si manifesta in varie forme, dall’enfatizzazione della componente diatopica nell’uso dell’italiano a fini connotanti (è tutto un fiorire di comici con inflessioni locali, di insegne, denominazioni di prodotti, magliette che riportano parole “tipiche”, ecc.) fino a diverse forme e proposte di “recupero” di tradizioni linguistiche più genuine. Riguardo a quest’ultimo aspetto, i problemi che si pongono sono decisamente complessi. Anzitutto, rifacendomi alla domanda, in linea di principio eviterei di associare sempre e comunque un’eventuale prospettiva antistorica (e le relative forzature) alle manifestazioni in sé di una impostazione “regionalistica”. Comunque la si pensi, il regionalismo non è necessariamente antistorico, è un rispettabile atteggiamento politico e amministrativo, e il dibattito relativo riguarda in generale, attraverso letture complesse e dalle più svariate prospettive ideologiche, le diverse società occidentali. Ciò vale anche sotto l’aspetto dei patrimoni linguistici: persino un paese di grandi tradizioni centralistiche come la Francia parla oggi di “langues de France” come concetto esteso alle varianti dialettali (picard, champenois, gallo…), promuovendone anche lo studio accademico per singole realtà (cosa che in Italia ad esempio non viene fatta, raccogliendo questo tipo di interessi sotto la generica formula della “Dialettologia italiana”); e che nella corretta gestione del patrimonio storico-culturale dei territori siano anche implicati, quando ci sono, gli elementi di originalità linguistica, non mi pare di per sé un fatto scandaloso o eversivo. Di recente ho curato a Genova una mostra storico-documentaria sul genovese, che ha riscosso un notevole interesse di pubblico e di critica e ha contribuito, credo, ad avviare la riflessione anche su alcuni dei temi che stiamo discutendo. Bene, l’unica contestazione, del tutto fuori luogo e come tale generalmente percepita, è stata quella di uno storico della lingua e accademico della Crusca che ha trovato da ridire sul sottotitolo della manifestazione (Il genovese. Storia di una lingua), considerandolo lesivo del prestigio dell’italiano e… potenziale veicolo di promozione di un bilinguismo inglese-dialetto ai danni della lingua nazionale! Rendiamoci conto che se il livello di riflessione su questi temi rimane ancorato a queste forme di strumentalizzazione e di provincialismo reazionario, sarà sempre problematico impostare una riflessione seria sul tema della pluralità linguistica di un paese in cui, oltre tutto, le forme del multilinguismo vanno continuamente riformulandosi. Ammettiamo piuttosto che in Italia l’interesse per questi temi è stato cavalcato più facilmente da una certa area politica: ma aggiungiamo anche che un certo atteggiamento intellettuale, che riflette anche la difficoltà della cultura nazionale a convivere col “problema” del proprio policentrismo, ha fatto di tutto per consegnare, legato mani e piedi, il tema della regionalità (non solo linguistica) a quel contesto politico. Quanto al fatto se sia necessario o meno, e in che misura possibile, “tutelare i dialetti”, anche qui la risposta è per forza di cose articolata. Necessario: se si ammette che le forme della diversità linguistica sono un bene culturale e un elemento di ricchezza (non soltanto in termini espressivi o connotanti: penso anche ai vantaggi cognitivi del bi- e plurilinguismo ad esempio), la risposta dovrebbe essere implicita. Trovo però tremendamente ipocrita che nel momento in cui si formulano opinioni del tipo “il dialetto è una ricchezza, una risorsa” e così via, non si ammetta l’opportunità, almeno in astratto, di promuoverne la conservazione come si fa per qualsiasi altra risorsa, naturale, monumentale, culturale e così via. Possibile: la pianificazione linguistica ha cessato da tempo di essere un’opinione, è a tutti gli effetti una rispettabile branca della linguistica: di impossibile, in sé, non c’è nulla. Il punto è semmai un altro, nel momento in cui si manifesti una volontà condivisa e diffusa di approdare a questa tutela (cosa che del resto non è né scontata, né attuale): si tratterebbe di verificare i tempi, i modi e gli obiettivi, e di capire anzitutto cosa può significare la “tutela del dialetto”. L’uso parlato, che è anzitutto legato alle scelte e alla consapevolezza dei locutori? La sua rappresentazione identitaria, che di per sé è un guscio vuoto in mancanza di una pratica diffusa? La memoria storica attraverso la promozione degli studi, che è in ogni caso propedeutica allo sviluppo di qualsiasi altra iniziativa? Insomma, la risposta è aperta.
A che punto è la politica sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia? A quante lingue si può applicare e cosa resta ancora da fare? Su quali basi una lingua è definita “minoritaria” e quindi da tutelare? Penso, ad esempio, al caso del brigasco.
Con questa domanda ci riallacciamo ad alcuni dei temi sfiorati nella risposta precedente: il disagio tutto italiano per le problematiche del plurilinguismo e del policentrismo, che rappresentano da sempre altrettanti elementi costitutivi della realtà culturale del paese, si è manifestato in maniera particolarmente evidente proprio attraverso il fallimento della politica di tutela delle minoranze linguistiche. Prevista dalla Costituzione, raccomandata dalle istituzioni europee, essa riguardava storicamente, dal dopoguerra, le sole minoranze “nazionali”, ossia quei gruppi di popolazione che percepiscono la propria alterità linguistica in rapporto a un diverso senso di appartenenza culturale e nazionale, per di più sancito da accordi interstatali: i sudtirolesi (ed estensivamente i ladini della provincia di Bolzano), i valdostani, gli sloveni delle province di Trieste e di Gorizia. La legge 482 del 1999 è giunta con un clamoroso ritardo a “tutelare” un gruppo di altre “lingue” (ma più correttamente si sarebbe dovuto parlare di tutela dei parlanti, e dei loro diritti linguistici), scelte in base al criterio della distanza “genetica” dall’italiano, e senza tener conto delle implicazioni sociolinguistiche relative a ciascuna di esse. Da un lato quindi si è effettuata una selezione quanto meno arbitraria all’interno del panorama linguistico nazionale (friulano sì, veneto no; algherese sì, tabarchino no), dall’altra si è deciso, ad esempio, che minuscole comunità di parlanti dialetti germanici, ellenici o albanesi andassero in linea di principio “tutelate” alla stessa stregua e con le stesse modalità della compatta maggioranza etnica altoatesina, presso la quale la coufficialità con l’italiano riguarda una lingua di solidissime tradizioni culturali e amministrative. Questa idea di creare lingue a tavolino non è molto diversa dalle ipotesi – magari bollate come reazionarie ed eversive – di chi propone di standardizzare una “lingua piemontese” o una “lingua napoletana”, ma ha significato mettere a posto la coscienza delle istituzioni statali, ossificando un panorama linguistico in larga parte impreparato a tutto questo, e aprendo nei casi più controversi ulteriori elementi di disagio: l’urgenza di disporre di una lingua sarda o di una lingua occitana è diventata così l’alibi per forzare processi gestiti spesso e volentieri da minoranze attive ed élite politico-culturali, a discapito della volontà dei parlanti e di un sereno confronto sul opzioni possibili; al contempo, la gestione delle relative risorse (peraltro in progressivo calo nel corso degli anni) è diventata spesso e volentieri appannaggio di quanti, di tali processi, si sono fatti proponenti ed artefici. D’altro canto, queste forme di “ufficializzazione” non hanno dato, come del resto era logico aspettarsi, risultati concreti in termini di inversione del trend negativo che caratterizza l’uso delle lingue ammesse a tutela; per di più, isolate dal contesto plurilingue di cui sono storicamente parte, esse hanno finito per essere percepite come feticci identitari prima che come strumenti di comunicazione, restando quest’ultima prerogativa affidata all’italiano o ad altri idiomi concorrenti: nelle valli del Piemonte occidentale ad esempio, il carattere “occitano” dei dialetti locali viene molto rappresentato, a fini prevalentemente turistico-commerciali e latamente politici, ma la gente continua a usare prevalentemente l’italiano o il piemontese, e altrove non pare proprio probabile che il finanziamento di questa o quell’iniziativa didattica o amministrativa, per quanto volenterosa, farà nel tempo recuperare locutori al dialetto walser di Formazza o alla parlata albanese di Villa Badessa. Mancando, inoltre, una qualsiasi forma di vigilanza sui processi di riconoscimento e auto-riconoscimento delle comunità (meglio, delle amministrazioni) che intendevano dichiarare la presenza sul loro territorio della lingua minoritaria, si è verificata una vera e propria corsa all’auto-certificazione, dagli esiti a dir poco grotteschi. Per fruire di possibili finanziamenti, decine di comuni di solide tradizioni dialettali piemontesi, calabresi, venete e così via si sono dichiarate di volta in volta “occitane”, “grecofone”, “germanofone” o “ladinofone”, col risultato di sovvertire gravemente, anche in termini percettivi, il panorama linguistico locale: dai comuni dell’Isola d’Ischia che hanno cercato di farsi passare per centri di lingua tedesca (sembra una battuta di Totò, e invece non lo è) al caso appunto del brigasco, un dialetto inequivocabilmente e riconoscibilmente ligure, come tale noto al mondo degli studiosi (oltre che nella tradizione locale), ma scandalosamente “promosso” dal giorno alla notte al rango di varietà “occitana”. Questo caso in particolare, proprio per le reazioni che ha suscitato nel pubblico e tra gli studiosi, è forse l’esempio più tristemente noto (ma tutt’altro che isolato) dei fenomeni di malcostume amministrativo connessi con la 482. A quasi vent’anni dalla sua approvazione, quindi, questa legge per molti aspetti scandalosa andrebbe profondamente modificata – come opzione minima – o, preferibilmente, sostituita con provvedimenti nella cui formulazione siano coinvolti linguisti e giuristi competenti, che chiariscano anzitutto cosa si debba intendere per “tutela”, tenendo conto della varietà delle situazioni coinvolte (e di quelle rimaste fuori, spesso in maniera palesemente discriminatoria, dall’ammissione ai benefici di legge), del contesto interlinguistico complessivo in cui si manifesta l’alloglossia, e di altri parametri a vario titolo decisivi per una corretta applicazione di una “politica” linguistica che guardi anche alle più aggiornate esperienze internazionali in materia.
Fra le lingue minoritarie parlate sul suolo italiano vi è il tabarchino, idioma presente a Calasetta e Carloforte, in Sardegna, e nato dal genovese in epoca tardo-medievale per necessità di comunicazione legate agli scambi commerciali sulle sponde del Mediterraneo. Quale altra lingua ha contribuito alla formazione del tabarchino e quanto esso si è differenziato nel tempo rispetto al genovese moderno? Esistono isole genovesi al di fuori dell’Italia oggi?
Il caso del tabarchino è per l’appunto rappresentativo dei deficit e degli insuccessi della legislazione in materia di minoranze linguistiche. Tipico e riconosciuto esempio di eteroglossia, caratterizzato da percentuali d’uso della varietà locale che sono tra le più alte in assoluto in Italia, il tabarchino è stato oscenamente “dimenticato” nell’elencazione delle varietà ammesse a tutela perché considerato la variante di un “dialetto italiano” qual è il genovese. Le perplessità dei linguisti e dei giuristi, che hanno prodotto una ormai ricca letteratura in proposito, non sono valse finora a fare approvare i diversi emendamenti con i quali si è cercato di rimediare a questa incresciosa situazione, che vede anche il paradosso di due soli comuni in tutta la Sardegna privi di una qualche forma di valorizzazione del loro patrimonio linguistico (essendo il sardo e il catalano di Alghero ammessi a tutela), per quanto il tabarchino sia poi correttamente menzionato dalla legislazione regionale. Le comunità tabarchine attuano peraltro da anni forme efficaci di auto-tutela, che ne fanno anzi un modello rappresentativo di difesa “dal basso” della specificità linguistico-culturale locale: tuttavia, la mancata copertura legislativa, oltre a impedire l’accesso ad adeguate risorse, rappresenta una palese e inaccettabile discriminazione, ai limiti dell’incostituzionalità, una volta che nel bene o nel male la categoria degli idiomi ammessi a tutela preveda, tra i criteri di “selezione”, le prerogative dell’insularità linguistica. D’altro canto il tabarchino rappresenta in termini culturali una varietà riconoscibilmente “altra” anche rispetto al genovese, essendo il portato di un processo di immigrazione in Sardegna verificatosi nel corso del sec. XVIII a partire dagli stabilimenti liguri in Tunisia, risalenti a loro volta al Cinquecento. Le vicende per certi aspetti romanzesche della diaspora dei tabarchini dalla loro sede originaria su un isolotto al largo della costa africana, fanno del loro idioma un caso pressoché unico di conservazione e attualizzazione di una parlata che, dopo aver goduto nel tempo di prerogative importanti anche in termini comunicativi internazionali (come varietà dell’uso commerciale tra europei e tunisini) continua a esercitare oggi una funzione essenziale di riconoscimento collettivo all’interno delle comunità presso le quali la è diffusa. Vero è peraltro, che, proprio per la sua antica funzione di lingua commerciale, ancora vitale in Tunisia durante tutto l’Ottocento, il tabarchino non si è differenziato molto dal genovese, continuando fino a tempi relativamente recenti ad aggiornare i propri esiti fonetici, morfologici, sintattici e lessicali alla varietà metropolitana. Quel che fa del tabarchino una lingua a sé rispetto al ligure continentale sono quindi le peculiarità ambientali e culturali, tra Africa, Spagna e Sardegna, che hanno determinato il suo indissolubile legame con una cultura “altra”, meticcia, frutto di apporti molteplici e complessi, ben riconoscibile nel contesto sardo e italiano per le proprie peculiarità, tanto che l’eredità storica tabarchina è oggi candidata ad assumere il ruolo di patrimonio immateriale dell’umanità secondo la classificazione dell’UNESCO. Diverso è il caso di altre varietà liguri “trapiantate” fuori dall’area d’origine, come il bonifacino della Corsica meridionale, che rappresenta uno stadio prossimo al genovese duecentesco, o il monegasco, che è oggi la lingua nazionale del Principato di Monaco, frutto di un’immigrazione dalla Riviera di Ponente verificatasi durante il Trecento. Sono questi gli scampoli di quella che fu una presenza linguistica distribuita lungo le coste mediterranee e del Mar Nero nel corso della secolare esperienza mercantile dei genovesi, una presenza ben attestata sia dalla documentazione scritta (trattati politici e commerciali, atti legislativi ecc.), sia dalle sopravvivenze, soprattutto lessicali, di elementi liguri in diverse lingue e dialetti di quest’area estesissima: dal neoellenico dell’isola di Chio (la Scio dei Genovesi) allo yanito di Gibilterra (una varietà andalusa di contatto con l’inglese, in cui gli affioramenti lessicali liguri sono dati dalla presenza di una forte componente ligure sul territorio della colonia britannica); dai dialetti urbani della Corsica a quel che resta del figoun trapiantato in Provenza nel corso del sec. XV. Né va dimenticata l’esistenza di una componente ligure importante nel lessico dello spagnolo popolare rioplatense, il cosiddetto lunfardo, come risultato di un’immigrazione in America Latina che ha lasciato tracce di un uso comunitario del genovese, in parte ancora vitali, soprattutto sul versante pacifico del subcontinente.
La diffusione dell’inglese a livello internazionale ha reso questo idioma lingua veicolare moderna; nel periodo dell’Alto Medioevo, però, e per tutta l’età moderna, alcuni volgari italiani (come già visto, ad esempio, il genovese) e in seguito l’italiano e lo spagnolo, furono il codice privilegiato di comunicazione nei porti del Mediterraneo, spesso in forma di lingua franca, una sorta di pidgin fatto di elementi provenienti dalle diverse parlate delle popolazioni che entravano in contatto. Quali sono le nostre conoscenze su questa lingua franca, quali le fonti e le testimonianze? Quale fu l’apporto a questa lingua franca dell’arabo e del turco?
La lingua franca mediterranea è quello che si potrebbe definire un autentico phantôme terminologique, nel senso che al concetto tutto sommato ben definito che vi si accompagna (in estrema sintesi, un idioma semplificato destinato alla comunicazione interetnica tra popolazioni che parlano lingue geneticamente distanti) non si accompagna in realtà una documentazione storica sufficiente a confermarne la tipologia e persino la stessa esistenza storica. Anche il nome di questo “oggetto” risulta sfuggente da un punto di vista semantico (lingua dei “franchi”, ossia degli occidentali, o lingua “franca” in quanto scorrevole, semplice? o tutte e due le cose?), e ricompare in situazioni e contesti storici diversi, dall’Adriatico all’Africa settentrionale in età moderna, in maniera assai più labile in Oriente durante il medioevo, poi in Grecia tra Ottocento e Novecento, lasciando intendere che sotto la denominazione di “lingua franca” si celino in realtà forme di espressione assai differenti tra loro. D’altronde, le fonti che lo descrivono come un “italiano parlato male” utilizzano una formula che, oltre ad essere generica, viene parimenti utilizzata per indicare diversi idiomi italoromanzi utilizzati come lingue commerciali e coloniali (ad esempio, per un viaggiatore francese del Cinquecento, è “un italien corrompu” il genovese di Chio), mentre gran parte delle (presunte) attestazioni dirette di questo idioma, frutto in realtà di elaborazioni letterarie (da Molière a Goldoni) ripetono costantemente una fraseologia stereotipata, fatta di verbi all’infinito, di formule di cortesia e poco più. Elementi morfosintattici attribuibili a una modalità pidginizzante mancano invece nella documentazione riconducibile a situazioni di effettivo contatto tra parlanti le diverse lingue neolatine e varietà semitiche, come le lettere di schiavi europei ai tempi della corsa barbaresca, o la documentazione relativa a Tabarca, l’unica stabile comunità “europea” sulle coste dell’Africa settentrionale. La mia impressione quindi – ma è soltanto un’impressione sia chiaro – è che il concetto di lingua franca celi una realtà tanto complessa quanto difficilmente definibile, in cui potevano integrarsi di volta in volta l’uso interetnico di vere e proprie varietà romanze (come quello del genovese in Tunisia, ben documentato tra Quattrocento e Ottocento), modalità rudimentali di apprendimento dell’italiano da parte di arabofoni o turcofoni, forme di comunicazione basate sulla commistione di codice e sull’interferenza tra diversi idiomi romanzi, e così via. Non parlerei quindi di una vera e propria “lingua” nel senso di varietà riconoscibile e riconosciuta rispetto ad altri idiomi geneticamente affini, e neppure di un pidgin stabilizzato, quanto di un insieme di modalità di comunicazione, caratteristiche soprattutto, nel periodo che va dalla seconda metà del Cinquecento alla prima metà dell’Ottocento, dell’incontro e del confronto verificatosi nel panorama politico-culturale, davvero complesso, delle antiche reggenze barbaresche, col prevalere di modalità genericamente “italianizzanti” tra Algeri e Tunisi, e “ispanizzanti” verso il Marocco; del resto, l’unico repertorio ampio di “lingua franca”, un dizionarietto del 1830 a uso delle truppe francesi in Algeria, suona di estrema (e per certi aspetti tardiva) stilizzazione di un fenomeno assai più labile nelle sue manifestazioni. Quanto e cosa questo insieme di situazioni abbia lasciato in eredità alle lingue dell’Africa settentrionale e del vecchio Levante è difficile dire: certamente il lessico dell’arabo maghrebino, del turco, del greco e di altre varietà “mediterranee” è ricco di italianismi, ispanismi, venetismi, genovesismi, provenzalismi, francesismi e così via, non meno di quanto turcismi e arabismi siano presenti nelle varietà neolatine della sponda settentrionale del Mediterraneo, ma ciò non assicura necessariamente l’esistenza di un tramite rappresentato dalle modalità pidginizzanti della lingua franca. Il quadro così delineato ridimensiona un po’, in ogni caso, alcune teorie suggestive, come quella sull’origine monogenetica dei pidgin, che sarebbero nati, secondo alcuni studiosi, dal trasferimento dell’ossatura morfologica semplificata della “lingua franca mediterranea” lungo le coste della Guinea, subendovi una rilessificazione in senso portoghese. Non è chiaro tra l’altro, a mio modesto avviso (anche ad attribuire una decisiva importanza all’interazione ligure-lusitana lungo le coste dell’Africa atlantica ai tempi della tratta degli schiavi, secondo una suggestiva lettura, tra gli altri, di Germán De Granda), il contesto storico-culturale in cui si sarebbe verficato tutto ciò, mancando soprattutto una sostanza documentaria in grado di instaurare affinità specifiche tra la “lingua franca” mediterranea (oggetto sostanzialmente sconosciuto) e i pidgin africani e americani.
Quale influenza ha avuto il genovese, lingua di una delle repubbliche marinare, sull’italiano e sui dialetti: in quali parlate del suolo italiano, ad esempio, la sua presenza si avverte di più e quali sono gli ambiti semantici?
La mostra alla quale accennavo prima, tenutasi a Genova tra settembre e novembre di quest’anno, documenta anche, attraverso il suo catalogo, la ricchezza delle interrelazioni linguistiche e culturali che furono generate dall’espansione mercantile ligure nel Mediterraneo. Come ha scritto di recente Emanuele Banfi, anzi, probabilmente più ancora di quella del veneziano la storia oltremarina del genovese merita di essere conosciuta e approfondita in ragione delle modalità del suo radicamento in una pluralità di orizzonti linguistici differenti e con modalità d’impianto peculiari, legate anche alle esigenze di controllo di approdi e di basi commerciali, più che di territori estesi, da parte di una popolazione di mercanti caratterizzata da un limitato potenziale demografico. Lingua di incontro più che di dominio, il genovese si è caratterizzato così per una forte tendenza alla micro-colonialità, in quei luoghi, dalla Crimea a Gibilterra, dove i liguri rappresentarono essenzialmente una minoranza dominante o un elemento catalizzatore, per le loro stesse specializzazioni economiche, in grado di attrarre componenti etniche e demografiche di svariata provenienza: i diplomi bilingui in genovese e armeno o ebraico prodotti nell’ambiente turcofono di Caffa ne sono un esempio lampante, non meno delle attestazioni dell’uso del genovese, alla Boca di Buenos Aires, anche da parte della popolazione d’origine ispanica o degli immigrati di varia origine e provenienza, circostanza che spiega l’importante componente ligure nello spagnolo popolare rioplatense. Se si guarda più in dettaglio al contesto italiano, quantificare il lascito linguistico e in special modo lessicale genovese nella lingua nazionale e nei dialetti non è facile, considerando che le stesse affinità morfologiche e fonetiche tra gli idiomi italoromanzi rendono a volte difficile determinare l’esatta provenienza di una voce. È vero peraltro che Genova si propone anche, e precocemente, come centro di assunzione e di irradiazione di innovazioni della più svariata origine, orientale non meno che nordica e occidentale, soprattutto nel lessico delle costruzioni navali, marinaresco, commerciale, della pesca e così via. A livello dialettale, una notevole circolazione linguistica in area alto-tirrenica contribuì non poco a diffondere termini d’origine o di tramite ligure verso la Corsica (peraltro esposta a un apporto lessicale massiccio anche per la sua appartenenza politica a Genova) e la Toscana costiera e insulare (numerosi sono gli esempi lessicali che si possono trarre, fra gli altri, da un esame del dialetto di Capraia), con “discese” notevoli anche lungo le cose sarde, italiane meridionali e siciliane. Non è certo stupefacente allora che persino una parola percepita come essenzialmente “siciliana” quale mattanza, sia in realtà un antico ispanismo di tramite genovese, approdato tardivamente nel lessico delle tonnare siciliane anticamente gestite da imprenditori liguri. Dal porto di Genova passano inoltre, per diffondersi nell’italiano letterario, molti termini legati al mondo della navigazione e della marineria (da scoglio a prua, da ciurma a cavo, e alcuni ancora in tempi recenti, come il lusismo piovasco), ma anche a prodotti commerciali (penso di avere dimostrato recentemente l’origine genovese di baccalà), a innovazioni tecnologiche e così via. Spesso le datazioni di una voce, attestate in genovese o in italiano regionale ligure prima che in altre zone, contribuiscono a chiarire i processi di diffusione di questa terminologia, che fu particolarmente copiosa nel passaggio dal genovese al toscano anche per la maggiore vicinanza geografica del porto ligure rispetto a Venezia, che ha irradiato spesso il proprio lessico marinaro in area adriatica assai più che in direzione della Toscana. Uno studio sistematico dei genovesismi in italiano è del resto tra le attività connesse al mio lavoro di spoglio lessicale della documentazione ligure preottocentesca, dalla quale stanno emergendo elementi importanti di valutazione. Più difficile è parlare, al di là del lessico, di componenti liguri nel processo di formazione di varietà dialettali italiane: è ormai riconosciuto un fondamentale apporto di tale origine nel galloitalico meridionale, ossia in quell’insieme di dialetti, diffusi in Basilicata e in Sicilia, che presentano tracce inequivocabilmente “settentrionali” e che risalgono verosimilmente a fenomeni immigratori dei secc. XII-XIII, legati anche ai ripopolamenti promossi dopo la cacciata degli arabi dalla Sicilia; ancor più evidente è, come già accennavo, la componente ligure in alcuni dialetti urbani della Corsica, come quello di Ajaccio e quello di Calvi, la cui popolazione doveva parlare in passato un idioma “coloniale” (paragonabile a quello tuttora in uso a Bonifacio) sul quale si sovrapposero in seguito le varietà corse del contado. Proprio dal bonifacino dipende in gran parte il decisivo apporto ligure, anche di carattere morfologico, del dialetto “misto” corso-ligure dell’isola Maddalena, e una componente genovese variamente stratificata si riconosce anche nella parlata sassarese, come effetto di una commistione, su base corsa, di elementi fonetici, morfologici, sintattici e lessicali liguri e sardi.
Il sardo è considerato oggi, e a partire da quella che è considerata la prima classificazione scientifica dei dialetti italiani operata da Ascoli (1882), una lingua autonoma rispetto alle altre parlate italiane, caratterizzata da una notevole conservatività rispetto al latino, caratteristica mantenuta grazie al suo isolamento rispetto alla terraferma. Questa immagine corrisponde alla realtà? A chi o a cosa si deve l’idea del sardo come dialetto isolato e conservativo?
Nei dieci anni di insegnamento all’università di Sassari mi sono avvicinato con molto rispetto e con qualche titubanza al “problema” della lingua sarda, ma mi guardo bene dal definirmi uno specialista in materia. In ogni caso la specificità linguistica del sardo e il sua carattere di lingua (o se si preferisce, di insieme di varietà dialettali a se stante rispetto all’italiano) è un dato di fatto conclamato e accolto non soltanto dalla linguistica italiana, ma anche da quella internazionale. Detto questo, sarebbe opportuno rivedere alcuni luoghi comuni sul sardo, a partire soprattutto da quello della sua “staticità” e conservatività consustanziale, che in parte è anche il frutto di una interpretazione per certi aspetti “ideologica” della categoria di insularità, come conseguenza di una visione “resistenziale” della società sarda, e in fondo degli stessi entusiasmi del maestro riconosciuto della linguistica sarda, il tedesco Max Leopold Wagner. Certo, il sardo conserva caratteristiche particolarmente arcaiche rispetto ad altri idiomi romanzi, ma questo non riguarda anzitutto l’intera area linguistica sarda, divisa tra un meridione campidanese assai più dinamico e un settentrione logudorese-nuorese maggiormente conservativo; inoltre, un’evoluzione a partire da condizioni particolarmente precoci di radicamento del latino è continuata ovviamente e continua a manifestarsi, come avviene per qualsiasi lingua o dialetto, secondo modalità che risentono anche della collocazione sociolinguistica di una lingua, almeno finora, prevalentemente parlata. Più in generale, le condizioni di arcaicità non sembrano affatto dovute all’insularità del territorio, circostanza che ne fa anzi uno spazio vocazionalmente “aperto” fin dalla più remota antichità, quanto alla presenza all’interno della Sardegna di aree montane, maggiormente conservative come conservativo sotto molti punti di vista, non soltanto da quello linguistico si dimostra (secondo una ben nota considerazione di Fernand Braudel) anche il resto della montagna mediterranea. Che l’ambiente sardo dimostri una specifica propensione alla “resistenza” agli influssi esterni è del resto, come dicevo, un mito identitario e una forma di rappresentazione di se stessi assai prima che una realtà storica: basta solo guardare a quanto il lessico delle varie lingue che si sono susseguite in Sardegna con caratteri di superstrato, dal pisano al genovese, dal catalano allo spagnolo e all’italiano, abbia permeato il vocabolario isolano nei più ampi e disparati ambiti semantici. E non va infine dimenticato che la Sardegna, proprio per il suo carattere di spazio “aperto” ospita da secoli diverse varietà alloglotte orientate di volta in volta verso le rispettive “madrepatrie”, in modo tale da costituire veri e propri “ponti”, elementi di raccordo tra la sardità linguistica e un più ampio orizzonte romanzo: le parlate corse del nord dell’isola (gallurese, maddalenino e sassarese, le ultime due con interessanti interferenze liguri), il catalano di Alghero, il già citato tabarchino di provenienza ligure-tunisina. A queste diverse forme del contatto linguistico ho preferito dedicarmi, da quando lavoro in Sardegna, anche in considerazione del fatto che la lingua sarda ha i suoi validi specialisti, e tenendo conto del mio specifico interesse per le vicende “dinamiche” del contatto e dell’interferenza linguistica.
Il dialetto genovese ha subito l’influsso del toscano/dell’italiano? In caso affermativo, in quale epoca quest’influsso è stato più forte e da quale punto di vista? Il genovese è cambiato molto negli ultimi 150 anni?
Come ogni varietà neolatina sottoposta al “tetto” linguistico del toscano/italiano, il genovese e il sistema dei dialetti liguri hanno risentito e risentono dell’influenza di questa varietà enormemente prestigiosa in termini letterari, politici, sociali e di diffusione territoriale. Almeno dal Quattrocento il toscano è massicciamente presente nella scripta ligure, attraverso elementi lessicali, morfologici e sintattici che risultano anche dalla esportazione verso le Riviere di precisi modelli culturali e letterari. Nondimeno, e a differenza di altre regioni italiane, la Liguria esprime precocemente, a partire dalla fine del Duecento, una letteratura autonoma nell’idioma locale, che si sviluppa attraverso i secoli con una chiara consapevolezza della propria continuità e autonomia, sollecitando a più riprese programmi di défense et illustration del genovese, come “lingua del paese” contrapposta più o meno polemicamente all’uso dello “straniero” toscano: il jayro vorgà çenoeyse (“chiaro volgare genovese”, secondo una ricorrente formula trecentesca) si presenta costantemente come protagonista della vita culturale ligure, in aperta e spesso vincente concorrenza con l’italiano soprattutto nei termini dell’identificazione nella langue du pays dello strumento più idoneo a rappresentare i tratti costitutivi della specificità locale. Queste dinamiche sono particolarmente attive tra il Cinque e il Settecento, quando la promozione del genovese diventa un elemento strategico per la definizione ideologica di un’“alterità” promossa da una classe dirigente che si affanna a divulgare l’immagine di una Repubblica caratterizzata dall’originalità delle proprie istituzioni e dalle peculiari manifestazioni della propria “libertà”. Se consideriamo il fatto che i depositari di questa impostazione, ossia i poeti e gli altri autori che scrivono in genovese, appartengono nella stragrande maggioranza al ceto notarile, a diretto contatto con le memorie storiche e con le testimonianze linguistiche del medioevo, possiamo capire perché quella genovese, con i suoi caratteri di continuità, assomigli poco al “canone” concettuale che siamo abituati ad attribuire, in Italia, alla categoria di letteratura dialettale. D’altro canto, gli usi “alti” del genovese nelle discussioni politiche, in senato, nei tribunali, dureranno fino alla caduta della Repubblica (1797-1805) condizionando, assieme alla percezione dell’internazionalità dell’esperienza linguistica ligure nel Mediterraneo, anche i successivi, per quanto velleitari, tentativi di nobilitazione: la Liguria è così l’unica regione italiana, a quel che mi consta, a esprimere nella seconda metà dell’Ottocento un poema “nazionale” scritto nella lingua locale, al seguito dell’esperienza felibristica provenzale e anticipando di diversi anni quella catalana; ed episodi come la pubblicistica e il romanzo, o la traduzione non parodica della Divina CommediaChe l’inseBalilla); ma agendo al tempo stesso in maniera sistematica per una dequalificazione del genovese, attraverso meccanismi di persuasione che coinvolsero lo stesso panorama culturale e artistico locale, come nel caso del teatro di Gilberto Govi, che meglio di tante altre agenzie diffuse un’immagine degli usi linguistici locali (opportunamente italianizzati) stereotipata, passatista e dequalificata. Il periodo postfascista, caratterizzato anche dalle forti irrequietudini sociali di una città che negli anni Settanta venne investita in pieno dalla stagione del terrorismo, fu a sua volta caratterizzato dall’atteggiamento spesso francamente dialettofobo di una parte dell’ambiente intellettuale e accademico, che intepretò, ad esempio, il persistere delle tradizioni linguistiche locali come una forma di auto-ghettizzazione della classe operaia: di questo ha risentito non poco la ricerca, che si caratterizza a Genova per un clamoroso ritardo a fronte dell’indiscutibile ricchezza storica, documentaria e attuale del patrimonio linguistico-letterario regionale. Con tutto ciò, i dialetti liguri e il genovese in particolare denotano ancora una discreta vitalità in una molteplicità di usi, anche in ambito artistico, circostanza che spesso compensa in qualche modo, come accennavo, l’indiscutibile crisi delle funzioni comunicative. La letteratura in genovese, tradizionalmente lontana nei suoi esiti più alti da modalità “dialettali” continua così a produrre in poesia e in prosa esiti di eccellenza purtroppo assai poco divulgati; la canzone, da De Andrè in poi, si è profondamente rinnovata; è rinata di recente attraverso una pagina settimanale del principale quotidiano regionale una pubblicistica in genovese che interessa ed attrae un pubblico eterogeneo di lettori. A loro modo, sono tutti segnali interessanti di vitalità. di (1909) sono indizi importanti del fatto che, fino al fascismo almeno, il genovese non fu percepito in tutto e per tutto come varietà “subordinata” all’italiano. Ciò detto, gli ultimi due secoli, e la seconda metà del Novecento in particolare, segnano il netto e convinto orientamento della società ligure in direzione della cultura italiana (cosa non del tutto scontata, ad esempio, nel periodo barocco, quando l’influenza spagnola fu particolarmente vistosa), e l’adeguamento non meno convinto a modalità linguistiche di maggior prestigio, che, a partire dalla borghesia, defluiscono facilmente (a partire soprattutto dagli anni Settanta) verso gli strati popolari, particolarmente quelli urbani. Teniamo anche conto del fatto che la Liguria, entità per certi aspetti non territoriale, usufruisce meno di altre regioni di “serbatoi” di conservatività linguistica, col suo entroterra semispopolato, con la sua portualità internazionale e con le due Riviere da oltre un secolo costantemente aperte all’accoglienza di un turismo cosmopolita. Ne risulta una regione “poco dialettofona”, anche in base alle statistiche, ma nella quale il retaggio storico ha sempre garantito, soprattutto al genovese, un significativo prestigio: il “complesso di patois” vi è del tutto assente, per quanto la fase cruciale tra gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso abbia determinato un progressivo ridimensionamento di questa percezione. Sotto questo punto di vista il fascismo operò in maniera ambigua, dimostrando nei confronti dei dialetti liguri (utili per legittimare le pretese irredentistiche sul Nizzardo e sulla Corsica e per il raccordo con le comunità immigrate in America Latina) una singolare tolleranza, fino all’assunzione indebita di miti locali variamente intrisi di umori linguistici autoctoni (ilChe l’inseBalilla); ma agendo al tempo stesso in maniera sistematica per una dequalificazione del genovese, attraverso meccanismi di persuasione che coinvolsero lo stesso panorama culturale e artistico locale, come nel caso del teatro di Gilberto Govi, che meglio di tante altre agenzie diffuse un’immagine degli usi linguistici locali (opportunamente italianizzati) stereotipata, passatista e dequalificata. Il periodo postfascista, caratterizzato anche dalle forti irrequietudini sociali di una città che negli anni Settanta venne investita in pieno dalla stagione del terrorismo, fu a sua volta caratterizzato dall’atteggiamento spesso francamente dialettofobo di una parte dell’ambiente intellettuale e accademico, che intepretò, ad esempio, il persistere delle tradizioni linguistiche locali come una forma di auto-ghettizzazione della classe operaia: di questo ha risentito non poco la ricerca, che si caratterizza a Genova per un clamoroso ritardo a fronte dell’indiscutibile ricchezza storica, documentaria e attuale del patrimonio linguistico-letterario regionale. Con tutto ciò, i dialetti liguri e il genovese in particolare denotano ancora una discreta vitalità in una molteplicità di usi, anche in ambito artistico, circostanza che spesso compensa in qualche modo, come accennavo, l’indiscutibile crisi delle funzioni comunicative. La letteratura in genovese, tradizionalmente lontana nei suoi esiti più alti da modalità “dialettali” continua così a produrre in poesia e in prosa esiti di eccellenza purtroppo assai poco divulgati; la canzone, da De Andrè in poi, si è profondamente rinnovata; è rinata di recente attraverso una pagina settimanale del principale quotidiano regionale una pubblicistica in genovese che interessa ed attrae un pubblico eterogeneo di lettori. A loro modo, sono tutti segnali interessanti di vitalità.
Esiste nella realtà una varietà “ligure” e quanto questa si differenzia rispetto al genovese? Vi sono elementi di derivazione provenzale e/o piemontese?
Ho usato spesso, in questa conversazione, la formula “genovese e ligure”, con la quale ho inteso sottolineare il diverso peso storico, culturale e sociale della varietà cittadina, la “lengua zeneise”, rispetto alle varietà locali. Come ogni contesto regionale, anche quello ligure si caratterizza infatti per una forte variazione diatopica, che viene progressivamente meno a mano a mano che ci si avvicina al “centro” genovese, area innovativa per eccellenza. Dalla periferia occidentale di Savona fino a Sestri Levante sulla costa, così, i dialetti appaiono decisamente orientati sul modello urbano, secondo modalità koinizzanti che si estendono anche alle aree circostanti, soprattutto dell’entroterra, dove questo “genovese” convive spesso, nell’uso, con l’italiano e con varietà più eccentriche, in condizioni di macrodiglossia. A mano a mano che ci si allontana da Genova, emergono invece caratteristiche peculiari ed arcaiche, spesso con significative convergenze tra le due ali estreme della Liguria, dove lo spezzino e il ventimigliese, ad esempio, conservano ancora alcuni tratti del genovese medievale, noti attraverso la documentazione letteraria. Oltre a ciò, gli antichi centri amministrativi e mercantili delle due Riviere e dell’entroterra rivelano spesso, nella loro parlata, una più decisa connotazione in senso “genovesizzante” rispetto alle aree circostanti, con la conseguenza che la varietà urbana mostra di avere agito da un lato in senso centripeto, favorendo il processo di amalgama dei dialetti liguri e la loro percezione unitaria (“genovese” è la denominazione complessiva con la quale il ligure romanzo continua a essere prevalentemente noto), dall’altro in senso centrifugo, accentuando la differenziazione tra le varianti cittadine e i rispettivi contesti rurali. Non esiste quindi un tipo ligure, ma il carattere dei dialetti liguri è molto ben definito da una serie di isoglosse, che ne determinano la netta autonomia verso il tipo provenzale e quello toscano ai due estremi, ma anche rispetto alla galloitalicità settentrionale, dalla quale il tipo ligure si differenzia per numerosi e significativi aspetti, a partire dalla conservazione delle vocali atone e finali, fino a “fenomeni-bandiera” come l’indebolimento fino alla caduta di –r– intervocalica o le palatalizzazioni “spinte” dei nessi PL-, BL-, FL- (cianze ‘piangere’, gianco ‘bianco’, sciamma ‘fiamma’), tratto quest’ultimo che ha, come del resto la robustezza delle vocali, significative assonanze centro-meridionali, puntualmente confermate anche a livello morfologico e lessicale. D’altronde, al di là dello spartiacque che divide la Riviera ligure da un mondo “padano” tradizionalmente sentito come “altro”, i dialetti ancora liguri delle alte valli digradano progressivamente verso il piemontese, il lombardo e l’emiliano, così come non vi è una decisa soluzione di continuità tra le parlate liguri orientali e i dialetti (ancora settentrionali, ma a se stanti) della Lunigiana. Tra Liguria e Provenza passa invece uno dei confini linguistici forse più netti dell’intera Romània, che distanzia nettamente il tipo ligure da quello occitano, lasciando alla varietà italoromanza l’alta valle del Roia con Briga, Tenda, Breglio e Saorgio e il distretto di Mentone oggi in territorio francese. Parlare di elementi di “derivazione” piemontese o provenzale non è quindi corretto, al di là di singoli fenomeni lessicali (non meno significativi di quelli che sottolineano la reciprocità dell’influsso ligure in piemontese, in nizzardo e così via), mentre ha senso ricordare, come si diceva, l’esistenza di varietà “miste” sul versante padano, col prevalere spesso di componenti liguri anche al di fuori dei confini amministrativi: in alta Val Tanaro ad esempio (Briga Alta, Ormea, Garessio in provincia di Cuneo), nel cosiddetto Oltregiogo (a sud della linea Novi Ligure – Ovada in provincia di Alessandria), nelle alte valli emiliane della Trebbia e del Taro.
In che cosa consiste il concetto di “lingua polinomica” e a quali parlate può essere applicato relativamente all’area geografica italiana?
Il concetto linguistico di polinomia è stato elaborato negli anni Ottanta dal sociolinguista corso Jean-Baptiste Marcellesi con specifico riferimento al contesto isolano: nella difficoltà di identificare univocamente una “corsicità” dialettale, ma prendendo atto che l’esistenza di una “lingua corsa” corrispondeva alle esigenze identitarie e percettive della popolazione, lo studioso definì il corso come l’insieme delle varietà dialettali tradizionalmente parlate sul territorio, in quanto frutto di una volontà collettiva dei locutori di riconoscerne l’unitarietà. Si definisce quindi “polinomica” una lingua che, pur priva di uno standard riconosciuto, istituisce relazioni dinamiche con altri idiomi (soprattutto con quelli dominanti, nel caso specifico il francese) manifestando la sua autonomia indipendentemente dalla propria unità strutturale. La definizione supera quella di “sistema dialettale” nella misura in cui la lingua polinomica afferma la propria autonomia rispetto al “tetto” sovraordinato, eludendo i rischi di un equivoco ricorrente nella definizione di “dialetto” come concetto sociolinguistico, secondo l’interpretazione (piegata anche a considerazioni di carattere storico-culturale) che prevale ancora nel contesto italiano: un sistema dialettale che non sia geneticamente subordinato a una lingua può così affermare in linea di principio la propria autonomia anche in mancanza di uno standard di riferimento da contrapporre alla lingua egemone. Il concetto di polinomia non è quindi semplicemente un modo “politicamente corretto” di ridefinire la varietà dialettale di un’area, perché implica una presa di coscienza collettiva e l’instaurarsi di relazioni dinamiche con il codice sovraordinato. In questo senso sono lingue polinomiche le varietà dialettali i cui parlanti ne riconoscano collettivamente, anche attraverso un glottonimo univoco, la parentela di fondo, promuovendo un percorso comune di confronto rispetto alla lingua tetto. Questo modello implica però un’attitudine “militante” dei parlanti, o almeno di una parte visibile e significativa di essi, e sfugge quindi a un’applicazione sistematica ai singoli casi. È certamente una lingua polinomica il corso, ad esempio, e potrebbe definirsi tale il sardo, nel momento in cui vi fosse unanime consenso sull’esigenza di tutelarlo nelle sue varianti e non a partire da uno standard unificato. Nei processi attuali di promozione della tutela e rivitalizzazione di alcune varietà italoromanze, direi che l’attitudine polinomica si sta sempre più affermando, in maniera più o meno consapevole, mentre l’impostazione “occitanista” presente nel sud della Francia, ad esempio, che prevede l’affermazione di uno standard comune alle diverse aree regionali, collide con questa impostazione che è cara al contrario ai “provenzalisti”, sostenitori della tutela delle singole varietà, o quanto meno dell’elaborazione di diversi standard locali. D’altro canto un’impostazione polinomica esiste di fatto, anche precedentemente all’introduzione del concetto da parte di Marcellesi, nella realtà linguistica delle valli grigionesi, dove la definizione comune delle varietà neolatine locali (il romancio, rumantsch) non esclude la promozione delle diverse varietà locali: in questo caso anzi l’elaborazione di una varietà comune sovraordinata (rumantsch grischun) si è rivelata fallimentare, nella percezione dei parlanti, ai fini della elaborazione di una politica complessiva di tutela. In chiave glottopolitica e sociolinguistica il concetto linguistico di polinomia non è quindi privo di efficacia, garantendo pari dignità e prospettive comuni di sviluppo alle diverse varianti che si riconosco sotto un’unica denominazione. Resta peraltro incerto lo statuto polinomico di quei sistemi dialettali (come quello ligure o quello piemontese) in cui una parlata storicamente più forte delle altre può aspirare a essere considerata la varietà “di riferimento” dell’intero sistema, senza necessariamente esercitare, con ciò, un ruolo di “tetto” sulle varianti locali.
Lei si è occupato anche della lingua delle relazioni di missionari italiani in Africa nei secoli XVII-XVIII: cosa può dirci lo studio di queste fonti, insieme a quello dei diari e delle memorie, sulla storia della nostra lingua (e/o su quella delle lingue europee) e quali problematiche possono presentarsi nella valutazione dell’importanza del lessico che vi è impiegato?
In realtà si tratta di un tema che ho soltanto saggiato, a partire da alcuni esempi concreti e specifici, nell’ambito del mio più generale interesse per il contatto linguistico: mi interessava infatti verificare la possibilità che una lingua come l’italiano, sostanzialmente priva di una consistente proiezione extraeuropea ed extramediterranea, si dimostrasse in grado di assumere, per singoli segmenti semantici e in particolari situazioni, quote significative di lessico esotico. Da qui le considerazioni che in alcuni saggi ho dedicato allo statuto degli esotismi diretti, diverso da quello degli esotismi assunti per il tramite di altre lingue europee, nell’ambito di una riflessione complessiva sui concetti di etimologia prossima ed etimologia remota. Il lessico delle relazioni dei missionari nell’antico Regno del Congo (secc. XVI-XVIII) è particolarmente interessante sotto questo punto di vista perché dimostra la “costruzione” di un vocabolario tecnico-specialistico di origine esotica, assunto direttamente in italiano senza il tramite del portoghese; tuttavia, esso conferma al tempo stesso l’occasionalità di questi episodi di contatto linguistico di fronte alla preponderante assunzione di esotismi per via indiretta. Anche alla luce di ciò preferisco considerare a sé la categoria degli orientalismi lessicali, che introduce un apporto diretto e significativo nell’area italoromanza secondo modalità alquanto diverse da quelle che caratterizzano, ad esempio, l’assunzione prevalente di africanismi, amerindismi, nipponismi e così via: un termine arabo o turco passato direttamente in genovese, in siciliano, in veneziano, in italiano, ci racconta infatti una storia enormemente diversa di relazioni economiche, sociali e culturali rispetto a quella di una voce congolese o giapponese, anche se casualmente assunta per via diretta; figuriamoci allora nel caso, assolutamente prevalente, in cui gli esotismi arrivano in Italia attraverso lo spagnolo, il portoghese, il francese o l’inglese: in tali circostanze, il principio della prevalenza dell’etimologia prossima ai fini valutativi fa sì, secondo uno schema perfezionato tra gli altri da Žarko Muljačić, che queste voci siano da considerare prima di tutto ispanismi, lusismi, gallicismi o anglismi, con tutte le conseguenze, quantitative e qualitative, che ne risultano. Tuttavia su questo punto, come dicevo, la mia riflessione è stata fin qui piuttosto episodica, anche per il fatto che sulle scritture in lingua italiana (e nelle lingue d’Italia, per dirla ancora con Banfi) prodotte storicamente in contesti latamente “esotici”, c’è ancora molto da fare. Lo stesso ruolo dell’italiano come lingua diplomatica nel Levante, studiato da Francesco Bruni, tra gli altri, in alcuni importanti lavori, non è stato ancora oggetto di ricognizioni sistematiche, figuriamoci quindi le corrispondenze o i diari, ad esempio, di viaggiatori, missionari, mercanti italiani attivi in paesi remoti. Tempo fa, occupandomi di retrodatazioni, documenti di questo genere si erano rivelati assai promettenti per verificare la precocità nell’assunzione di alcuni esotismi di area malese e amerindia, ma questo tipo di ricerche meriterebbe una sistematicità tale da richiedere l’apporto collettivo e costante di diversi ricercatori impegnati nell’individuazione e nello spoglio delle fonti, con esigenze evidenti di contestualizzazione storica, di esegesi filologica, di approfondimento etimologico e così via. Per fortuna i giovani volenterosi e preparati non mancano, in questo come in altri campi, ed è quindi fondata la speranza che su molti temi affascinanti si possa costantemente tornare “in forze”, per assicurare alla ricerca linguistica quella continuità e quel progresso che da sempre ne fanno una delle discipline più dinamiche dello scibile, in ambito umanistico soprattutto.
ALBUM FOTOGRAFICO - LEUDI DA LAVORO

... Trasportavano sabbia

... Trasportavano botti di vino

Leudo "vinaccere"

... scarico delle botti in mare

A cura del webmaster Carlo Gatti
Rapallo, 2 Maggio 2018
CAPO HORN - L'inferno dei Marinai
VERSO CAPO HORN
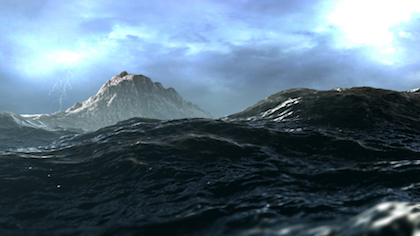
Foto Nejrotti

L’inferno dei marinai
Sabato 13 Agosto 2016 – ore 21.00 Piazza Gagliardo – Chiavari
Il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta con il patrocinio del Comune di Chiavari
Presentano

Com.te Ernani Andreatta - Fondatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari

Com.te Carlo Gatti - Presidente Associazione Culturale Mare Nostrum Rapallo
Nel 1616 due intrepidi olandesi videro ed affrontarono per primi il famigerato CAPO HORN. Dunque proprio 400 anni fa, il mercante-navigatore Jacob Le Maire (figlio di Isaac, uno dei fondatori della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali e finanziatore della spedizione) e il capitano di lungo corso Willem Cornelius Schouten. Salparono da Texel, nei Paesi Bassi, in cerca della Terra Australis, ma soprattutto di una nuova rotta per il Pacifico, con due navi, la Hoorn, il nome della città di Schouten, che andrà distrutta, e la Eendracht, con la quale doppiarono il fatidico “Scoglio” il 29 gennaio 1616:
La storia di Kaap Hoorn parte da qui, anche se per alcuni scritti il primato dell’avvistamento spetterebbe a Francis Drake, che avrebbe sottaciuto la scoperta. Capo Horn (55°58’28” Sud 67°16’20” Ovest) è uno sperone di roccia che segna la fine della Terra del fuoco, e con essa del continente americano. Si alza al cielo a 424 metri dal suolo dell’isla Hornos, la più occidentale del gruppo delle Hermite. È un pezzo di Cile e cileno è il presidio militare che si prende cura dei due fari che lo segnalano.


L'albatross. Scultura simbolo di Capo Horn
MALLYHAWK — “E' a Saint Malo, dove aveva sede l’Amicale, venne chiuso il libro delle firme”, conclude Flavio Serafini. Nel 2003, la cerimonia finale, sempre a Saint Malo, con lo scioglimento dell’Amicale. Resta il monumento di Imperia, i cimeli dei Cap Hornier nel suo Museo Navale e un altro monumento proprio a Capo Horn. Venne eretto nel 1992 in ricordo di quanti affrontarono e spesso persero la vita in quel mare che, nell’800 o a giorni nostri, a bordo di un brigantino o di una supertecnologica barca a vela come quella di Stamm e Le Cam, con o senza diavoleria elettroniche, che si arrivi da Est o da Ovest, impone, senza sconti e possibili scorciatoie, di essere un grande marinaio degno di diventare un cap hornier”.
Segue l’intervista del Comandante Ernani Andreatta, Fondatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, al Comandante Carlo Gatti, Presidente dell’Associazione Culturale Mare Nostrum di Rapallo.
E. Andreatta - PERCHE’ GLI HANNO DATO QUEL NOME?

C. Gatti – Nel 1616 – Lo avvistarono e lo rimontarono gli OLANDESI Shouten e Lemaire che lo chiamarono così in onore della città di Horn i cui mercanti avevano finanziato la spedizione.
Fino al 1400 – ebbero il predominio marinaro l’ITALIA (con le Repubbliche Marinare) e il Portogallo. Dopo essere arrivati in Brasile, esplorarono minuziosamente il Rio de la Plata che però era solo un fiume... dopo di ché la flotta ripartí verso SUD alla ricerca di una vera via d’acqua che collegasse i due OCEANI. Il 1° Novembre 1520, la Spedizione capitanata da Ferdinando Magellano entrò finalmente nello Stretto che fu subito battezzato: Stretto di Ognissanti e che solo in seguito fu rinominato: “Stretto di Magellano”. Le terre al Nord dello Stretto furono chiamate “Terre dei Patagoni” (Patagonia) e quelle al sud “Terra dei Fumi” (Tierra del Fuego). Ci vollero cinque settimane di navigazione difficile tra montagne, secche, fondali variabili, strettoie e venti ghiacciati, ma alla fine le tre navi superstiti si trovarono davanti un nuovo oceano che parve loro calmo, accogliente, invitante a tal punto da chiamarlo “Mare Pacifico”.
Nel 1500 – La SPAGNA ebbe il predominio sui mari / Nel 1600 – L’ OLANDA / Nel 1700 – la FRANCIA / Nel 1800 - l’INGHILTERRA
Ma dopo il 1616, per due secoli quella via di comunicazione rimase deserta. Soltanto qualche nave filibustiera di corsari o esploratori inglesi come Drake, Howe e più tardi Cook ebbero il coraggio di affrontarlo. Nel 1790 l’italiano Alessandro Malaspina, Capitano di Vascello nella Marina Spagnola (con le corvette Descubierta e Atrevida), rimontò Capo Horn da Ovest ad Est in rotta per Cadice.
E. Andreatta - QUANDO CAPO HORN DIVENNE IMPORTANTE E PER QUALI MOTIVI?
C. Gatti - Dopo il 1815 le cose cambiarono. Capo Horn cominciò ad essere frequentato dai velieri sardi in rotta per Valparaiso e Lima.
1) - L’esercito francese (Campagne Napoleoniche) occupò la SPAGNA che si ritrovò isolata dal suo impero d’oltremare. Le guerre in Europa fornirono ai creoli americani la possibilità di conquistare l'indipendenza dalla madre patria, e le rivoluzioni cosiddette Atlantiche iniziarono a scoppiare in tutta l'America Spagnola. Toccò anche a Garibaldi passare Capo Horn.....
2) - 1840 – La SCOPERTA DELL’ORO IN CALIFORNIA richiamò masse di pionieri che imbarcarono su centinaia di velieri diretti per l’unica via conosciuta: CAPO HORN. Una rotta che, con la corsa all’oro della California del 1848 diventò leggenda. Si calcola che solo nel 1849 dai porti dell’Atlantico ben 777 navi salparono per Capo Horn dirette a San Francisco. Navi che si aggiungevano a quelle che già battevano quella rotta.
CORSA ALL’ORO — “Gli equipaggi si imbarcavano con contratti di due o tre anni. Si sapeva quando si partiva, ma non quando si tornava. Se si tornava. Mesi e mesi in mare e a volte, semplicemente, si scompariva. E poi Horn. Le difficoltà di manovrare vele e cime ridotte a blocchi di ghiaccio manovrate da gente sottoalimentata, con abbigliamenti che non possiamo neppure immaginare, impegnati per settimane e settimane a tirare bordi controvento per guadagnare qualche miglio, scapolare il Capo e andare a nord”. Occorreva essere uomini di ferro prima che grandi marinai. Un’epopea quella di Horn che ha avuto un prezzo molto alto; si parla di oltre 800 navi e di 10.000 persone perse in quel mare. E un’epopea che finisce, oltre che per il Canale di Panama, anche con la prima guerra mondiale. “Il grosso dei grandi velieri italiani finì sott’acqua per i siluri tedeschi, ma erano bastimenti vecchi che avevano fatto Capo Horn al comando di capitani per la maggior parte liguri. Come quello, era di Recco (30 km da Genova), dell’ultima nave italiana che passò Horn nel 1914. C’erano anche comandanti che venivano da Procida, da Sorrento e Trapani, ma per lo più erano liguri, come i maggiori armatori dei velieri di allora”. Anche se l’ultima nave a vela a doppiare Horn è stata, nel 1949, la nave-scuola tedesca Pamir, l’epopea del Capo era da tempo finita. Tanto da spingere, nel 1937, un gruppo di capitani cap hornier francesi a fondare, a Saint Malo, l’Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers, per riunire e ricordare quella pagina, già allora lontana, della storia della navigazione. “L’associazione arrivò a contare cap hornier di 14 nazioni e nel 1983 la sezione italiana, di cui ero allora segretario, contava ancora una ventina di membri”, ricorda Serafini. “Fu in quella occasione che venne inaugurato il monumento ai cap hornier a Imperia”. Poi, naturalmente, come “la schiuma sul mare dopo la tempesta”, prendendo le parole della relazione del congresso del 1996 dell’Amicale tenuto a Brest, in Francia, il numero dei cap hornier scomparirono uno dopo l’altro. Quell’anno di comandanti cap hornier ne restava uno solo, un finlandese di 98 anni e se n’era rimasto a casa. Gli altri, età media 85 anni, erano mallyhawk. Ma se ne sono andati tutti.
3) - Una forte corrente commerciale navale da Capo Horn iniziò quando dal litorale peruviano iniziò il commercio del GUANO diretto in Europa.
Capo Horn divenne così l’incrocio obbligato delle rotte commerciali più importanti e quindi la via CLASSICA della marineria velica.
4) - Ma L’avvento del motore, la Prima Guerra mondiale, e soprattutto l’apertura del CANALE DI PANAMA (1914), fecero morire la vela mercantile e le acque di Capo Horn rimasero quasi deserte. Ma una cosa é certa: che per tutto l’800 e 900, Capo Horn fu il banco di prova per tutti i velieri del mondo e dei loro equipaggi.
E. Andreatta - Quando ebbe Origine l’emigrazione italiana in Cile ed in Peru’ ?

C.Gatti - Non c’é famiglia nella nostra Riviera di Levante che non abbia o non abbia avuto parenti in Cile e in Perù. Di una cosa siamo certi: I PRIMI ITALIANI CHE EMIGRARONO DA QUELLE PARTI furono marinai che per un motivo o per l’altro (paura di ripassare Capo Horn, malattie, incidenti di navigazione ecc....) disertarono, non rientrarono più a bordo, in pratica si stabilirono nelle principali città del Sud Pacifico e diedero vita ad attività di pesca e vendita del pescato, altri si diedero all’agricoltura, altri ancora diventarono commercianti aprendo negozi o magazzini (ALMACIEN). I più fortunati e intraprendenti iniziarono con piccole laboratori artigianali che divennero via via fabbrichette sempre più importanti le quali fecero nel corso degli anni da calamita per tanti loro parenti amici che poi lasciarono la Liguria in cerca di fortuna.
E.Andreatta - La ferrovia Transandina evitò a tanti emigranti di affrontare CAPO HORN e quindi si può dire che li salvò dai tanti naufragi.
La ferrovia Transandina attraversa la cordigliera delle Ande e collega le due sponde oceaniche; la parte centrale, aperta nel 1910, collega Buenos Aires-Mendoza-Valparaíso: è lunga 1420 km e raggiunge i 3150 mt. s.l.m.
La Transandina, Ferrovia del Nord, entrata in servizio nel 1962, unisce la città argentina di Salta, collegata a Buenos Aires, con il porto cileno di Antofagasta.
Questa opera fu di grande importanza per gli emigranti provenienti dall’Italia e dalla Europa che non erano più obbligati a doppiare Capo Horn rischiando la vita.... Arrivavano nei porti Argentini con i velieri, le navi passeggeri e da carico, sbarcavano e saltavano sul treno della Transandina e, in poco tempo, raggiungevano le loro destinazioni. Tuttavia, un rischio incombeva, su di loro: l’altitudine eccessiva che colpiva i cardiopatici. Non poche furono le vittime di questa situazione.
E.Andreatta - PERCHE’ CAPO HORN ERA COSI’ TEMUTO DAI NAVIGANTI?
C.Gatti - L'espressione Quaranta ruggenti (in inglese : Roaring Forties) è stata coniata dagli Inglesi all'epoca dei grandi velieri che passavano per Capo Horn. Poiché la forza del vento aumenta procedendo verso sud, oltre il 50° parallelo gli stessi inglesi parlavano di Furious Fifties (che in italiano viene tradotto conn Cinquanta urlanti).

Con Quaranta ruggenti e Cinquanta urlanti vengono convenzionalmente indicate nel mondo marinaro due fasce di latitudini australi caratterizzate da forti venti provenienti dal settore OVEST (predominanti), le quali si collocano rispettivamente tra il 40º e il 50º parallelo e tra il 50º e il 60º parallelo dell'emisfero meridionale. Tali venti hanno la stessa origine dei venti da Ovest dell'emisfero settentrionale), ma la loro intensità è superiore di circa il 40 per cento: ciò è dovuto alla serie di intense depressioni che interessano queste zone, dovute all'incontro tra l'aria fredda dell'Antartide e l'aria calda proveniente dal centro degli oceani, inoltre questi venti sono amplificati dalla relativa scarsità di terre emerse nell'emisfero sud, cosicché soffiando sempre sul mare non incontrano mai la terraferma che li potrebbe frenare.
La denominazione deriva dal nome dei paralleli alla cui latitudine soffiano questi venti: Quaranta o Cinquanta e dal rumore che il vento produce sibilando attraverso gli alberi, il sartiame e la velatura delle imbarcazioni a vela, che somiglia a un ruggito sui 40° e ad un grido sui 50°
E.Andreatta - CAPO HORN UN CIMITERO DI NAVI?

1983-Imperia - L’opera dedicata ai Cap Horniers è dell’artista genovese Stelvio PESTELLI.
C.Gatti - Il monumento al navigante di Capo Horn nel Borgo Marina / Imperia-Porto Maurizio, fu realizzato dallo scultore Stelvio Pestelli e inaugurato il 24 maggio 1983, in occasione del XXXIX Congresso Mondiale dei Cap Horniers, alla presenza del Presidente Pertini e dell’allora Sindaco Scaiola. Esso é dedicato ai naviganti di Capo Horn, agli 800 velieri affondati, ai 10000 marinai che giacciono sul fondo del mare più tremendo del globo.
La Statua rappresenta il classico Lupo di mare dal volto rugoso e barbuto, con cerata, "sudovest" e stivaloni, con le mani sulle caviglie della ruota del timone, teso nello sforzo di governare il suo veliero.
Eretta alla radice del molo di Porto Maurizio, alta m. 2,30, in bronzo, poggia su un piedistallo di m. 2 sul quale c’è la dedica dell’A.I.C.H. (Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers) di Saint Malo, sezione italiana. La facilità di navigazione di oggi rende ancora più leggendario il navigare di allora quando, chi doppiava Capo Horn per la prima volta, aveva il diritto di mettere l’orecchino all’orecchio che era dalla parte del Capo in quel momento e di "pisciare" controvento.
Sulla targa l'albatro, simbolo dell'Amicale e l'iscrizione: A ricordo / dei naviganti della / vela oceanica di / Capo Horn.
E.Andreatta – Poco a Nord di Capo Horn c’é una città: USHUAIA che é molto cara agli Italiani. Puoi raccontarci il perché?

C. Gatti - Una Storia dimenticata - Italiani alla Fine del Mondo - Ushuaia (Patagonia del Sud-Argentina)
Nell'immediato dopoguerra una nave, un'impresa italiana e tanta mano d'opera specializzata in cerca di lavoro e fortuna partono per la Terra del Fuoco, regione inospitale, difficile e senza strutture. Ushuaia si trova 140 km a NW di Capo Horn - Cile.
Ushuaia è la città più australe del mondo e si trova sulla costa meridionale della Terra del Fuoco, in un paesaggio circondato da montagne che dominano il Canale Beagle (Ushi = al fondo, Waia=baia). Baia al fondo, alla fine. È così che gli indigeni Yamanas, da oltre seimila anni, chiamano il loro mondo: la "fine del mondo".
Nell’immediato dopoguerra, la decisione del governo argentino di costruire la capitale Ushuaia nella Terra del Fuoco fu presa per riaffermare la sovranità del paese sull'isola Grande, all'epoca oggetto di aspre dispute con il confinante Cile. Siamo nel 1947 e le imprese italiane ricevono l’incarico di costruire opere pubbliche. L’unica struttura presente sull’isola è un vecchio penitenziario ormai fatiscente. Occorre partire da zero: case, strade, ospedale, scuola, centrale idroelettrica. Ad organizzare la spedizione è Carlo Borsari, imprenditore edile bolognese e proprietario di una fabbrica di mobili che convince il governo argentino di saper operare con le sue maestranze anche in climi molto rigidi. Nella primavera del 1948 il presidente Peròn firma il decreto che attribuisce all'imprenditore italiano la commessa di lavoro. Il 26 settembre 1948 salpa dal porto di Genova la prima nave che, guarda caso, si chiama “GENOVA”, con a bordo, 506 uomini e 113 donne, per un totale di 619 lavoratori.

La M/n GENOVA della Co.Ge.Da. è in partenza da Ponte dei Mille per la Terra del Fuoco. Questa rara fotografia è una preziosa testimonianza di quella grande spedizione.
Durante il lungo viaggio della nave, le autorità argentine vietano di scalare i soliti porti intermedi per evitare defezioni. La paga dei lavoratori è di circa 3,5 pesos, superiore rispetto ad altri luoghi in Argentina e permette di mandare soldi alle famiglie in Italia.
Il 28 ottobre 1948, dopo 32 giorni di oceano, la M/n Genova giunge ad Ushuaia con un carico umano colmo di speranze e con le stive stracolme di materiale. Ad accoglierla c’è il ministro della Marina argentina dell'epoca. La stagione è la più favorevole per iniziare i lavori. Per i primi mesi una parte degli operai è sistemata nei locali dell'ex penitenziario, il rimanente alloggia a bordo di una nave militare del governo.
La mano d'opera è soprattutto emiliana, ma non mancano piccole comunità di veneti, friulani e croati. Nelle ampie stive della nave c’è tutto l’occorrente per la costruzione ed il montaggio di un paese moderno. Del carico fanno parte 7.000 tonnellate di materiale per allestire una fornace e la centrale idroelettrica, vi sono mezzi di trasporto leggeri e pesanti, gru, scavatrici, case prefabbricate, generatori, l’attrezzatura per la costruzione di una fabbrica di legno compensato e persino le stoviglie per la mensa dei dipendenti. L’inventario della merce trasportata comprende tutto il necessario alla comunità per essere autosufficiente ed il suo valore attuale corrisponde a venti milioni di euro che il governo argentino, ha pagato all'impresa Borsari che li aveva anticipati.
Agli emigranti provenienti dal nord Italia, le montagne alle spalle di Ushuaia ricordano le Alpi, e per tutti loro la nuova terra significa un futuro migliore per se stessi e per i propri figli. I primi due anni pattuiti con Borsari sono veramente duri per il freddo, la neve, l’oscurità e con le difficoltà di costruire opere murarie e idrauliche. Onorato il contratto, in molti decidono di stabilirsi definitivamente in questa città che hanno creato dal nulla e che sentono ormai propria. Grazie al lavoro di un nucleo di avventurieri italiani, si assiste ad un fenomeno di migrazione di massa unico al mondo. Ushuaia cresce, si popola e si trasforma in una città viva, speciale per varietà di razze e culture.

Restano i ricordi. Lo sforzo per l’ambientamento climatico fu sostenuto dagli emigranti grazie anche al promesso ricongiungimento con le famiglie, che fu rispettato e si concretizzò con l’arrivo di una seconda nave italiana, la M/n "Giovanna C." che giunse a Ushuaia il 6 settembre 1949 con mogli e figli. Quel giorno la comunità italiana raggiunse le 1300 unità.
Gino Borsani aveva promesso due anni di lavoro ben pagato, terre e case ai suoi uomini. “Alcuni di noi non sapevano neppure dove erano diretti” - dice Elena Medeot 78 anni, nata a Zara – “In Italia c'era il mito dell' Argentina, ma quando siamo arrivati qui, dopo un mese di navigazione, abbiamo scoperto la verità. Per scaldarsi, in un posto dove in piena estate la temperatura raramente supera i 10 gradi, si doveva risalire la montagna per fare un po’ di legna. Le promesse del bolognese svanirono in pochi mesi, così come il sogno di tutti, mettere da parte un po' di soldi e tornare a casa.
“Però si mangiava carne tutti i giorni e questo già sembrava un miracolo”. Ricorda Dante Buiatti nato a Torreano di Martignacco. “Nel 1923 Avevo un lavoro in Friuli, ma era più importante dimenticare la guerra e a casa non ce la facevo”.
Dante fu uno dei pochi pionieri, arrivati ad Ushuaia con la ditta Borsari, che scelse di restare in quella terra al confine del mondo. La maggioranza, infatti, rincorse orizzonti più caldi, spostandosi in altre province “più ospitali” dell’Argentina. Buiatti s’impegnò nell’attività commerciale del paese, che oggi continua con sua figlia Laura; mentre Leonardo, il figlio minore, gestisce un albergo. Sempre col cuore rivolto alla sua cittadina natale, Dante Buiatti fu uno dei principali animatori dell’associazionismo friulano e italiano nella Terra del Fuoco. Fino al giorno della sua morte è stato il principale punto di riferimento per gli studiosi dei processi migratori, per la collettività italiana, per i giovani della comunità friulana di Argentina ed Uruguay e, fondamentalmente per i suoi cinque nipoti.
GATTI Carlo
Rapallo, 31 Agosto 2016
Göteborg-1-Nave a Palo VIKING

V I K I N G
La nave a palo in ferro quando navigava con bandiera danese
Il famoso windjammer di bandiera svedese ha cambiato vita riciclandosi in un rinomato Albergo a Göteborg. Il suo elegante scafo bianco simboleggia tuttora quella marineria che lottò strenuamente sino al 1950 per sopravvivere all’avvento del motore.
La navigazione a vela, dopo cinquemila anni di universale pratica, veniva lentamente sconfitta dal nuovo mezzo meccanico. Già! Lentamente, perché la lotta fu aspra e durò ancora nel corso della Prima guerra mondiale, quando gli U-BOOT tedeschi ne fecero scempio con il cannone.
Riservate ai velieri d’altomare rimanevano solo alcune rotte, quelle estreme dei collegamenti con le regioni più lontane (Australia e Cile). Regioni troppo lontane per la limitata autonomia della nave a vapore.
Il grande veliero da carico-WINDJAMMER presentava ancora due notevoli vantaggi:
- non doveva fermarsi per caricare carbone
- il vento non costava nulla
Facendo presa e insistendo coraggiosamente su questi due concetti, Francesi, Tedeschi e Scandinavi costruirono velieri sempre più grandi, destinati a caricare quantità sempre maggiori di merce. Mentre la flotta dei velieri americani andava lentamente declinando, quella inglese divenne la prima al mondo.

La nave a Palo VIKING
Di poppa si erge il grattacielo a strisce bianche e rosse Utkiken, familiarmente battezzato "il rossetto", alto 86 metri che domina il porto di Lilla Bommen.



L’autore
Dal 2013 la nave a palo VIKING è di proprietà della ESS Hotell AB di Göteborg, dov'è ancora conservata intatta, manutenuta ed utilizzata come Albergo, Ristorante e Bar galleggiante. La foto mosta la nave nell’attuale ormeggio nella Lilla Bommens Hamn sul canale Göta Älv e, con molto fascino, si erge a simbolo della tradizione marinara svedese nella splendida aerea interna del porto di Göteborg. La costruzione rossa e bianca che si erge di poppa alla VIKING si chiama Lilla Bomen, ma la gente la chiama Skanskaskrapan oppure Läppstiftet (perché ricorda il rossetto usato dal gentil sesso).
La nave a palo VIKING fu costruita nel 1906 dal cantiere Burmeister & Wain di Copenaghen per il consorzio di armatori chiamato "Den Danske Handelsflaadens Skoleskib for Befalningsmænd AS" per essere utilizzata come nave mercantile e nave scuola per gli allievi della marina mercantile danese, che lo tenne dal 1906 al 1915. E' il più grande veliero mai costruito in Scandinavia. Costò 591.000 corone danesi. Scafo in acciaio. Lunghezza ft 118 m, al ponte 97,30 metri. Larghezza 13,90 m. Immersione 7,30 metri. Stazza 2.959 tonnellate lorde, 2.665 nette. Superficie velica 3,690 m². Disponeva di vele di gabbia fisse e volanti, velacci, velaccini e vele di belvedere. Velocità massima di crociera 15,5 nodi. Dislocamento 6.300 tonnellate. Capacità di carico 4.100 t. Varato il 1° dicembre 1906, fece il suo “maiden voyage” il 19 luglio 1907. Dal 1915 al 1929 divenne proprietà della Società De Forenede Dampskibs AS di Copenaghen (It)-Köpenhamn (Sv)-Köbenhavn (Da).
Nel 1929 venne venduta al celebre armatore Gustaf Erikson di Mariehamn, Isole Åland, che la impiegò nei traffici del grano australiano verso l'Europa che la tenne sino al 1950.
Nel 1939, allo scoppio della seconda guerra mondiale, venne disarmata a Mariehamn insieme con la POMMERN e la PASSAT. Nel 1946-47 fece ancora due viaggi del grano in Australia e nel 1947-48 ne fece altri due con il Passat.
Nel 1950 venne rivenduta alla città di Göteborg ed utilizzata come nave scuola stazionaria sino al 1998.
ALBUM FOTOGRAFICO

Primo piano della VIKING


Lo scalandrone innevato della VIKING. Benvenuti a bordo! Hotell*Ristorante*Conferenze

Suggestiva immagine della VIKING e del “rossetto” a sinistra


La reception della nave

Sala delle Feste

Sala da pranzo











Carlo GATTI
Rapallo, 19 dicembre 2015
MOSCIAMME
MOSCIAMME
Esattamente 50 anni fa, ero imbarcato come Allievo di Coperta sulla nave tipo-Liberty "ITALVEGA" della Compagnia Italnavi di Genova. Effettuavamo i viaggi Mediterraneo – Stati Uniti, Costa del Pacifico e si saliva fino a Vancouver.
Una sera, passando per un caroggetto, ho visto un gruppetto di marinai i quali stavano gustando qualcosa di “curioso” nella loro saletta.
"Favorite Sior, senza complimenti!"
“Che mangiate di buono?”
“Musciame” risposero sorridendo.
“E che cos'è?” chiesi sorpreso credendo si trattasse di un lonzino, da come era stato tagliato sottile con l'affettatrice. Ma nel frattempo me lo avevano già offerto, con un boccone di pane, e stavo per addentarlo, quando qualcuno, con naturalezza aggiunse: “Delfino!” Mi fermai immediatamente e proferii con disappunto:
“Non vi vergognate? Il Delfino, una bestia così bella, che sembra indicarci la strada, quando di prora, veloci come noi, vengono fuori come per salutarci!!! È proprio peccato, specie per un marinaio ucciderlo...!”
"Si, Sior avete ragione, ma sulle navi si è sempre mangiato..., pensate che una volta a bordo non c'era niente da mettere sotto i denti!”.
“Assaggiate… sentite quanto è buono…”
In fondo pensai che avessero anche ragione: una volta tutta questa sensibilità verso gli animali non c'era. Infatti solo la Legge C.I.T.E.S, 161 Paesi, nella Convenzione di Washington del 3/12/1973, ha introdotto il divieto di caccia e pesca di alcune specie di animali, ma, nonostante tutto, ci sono dei luoghi, come le Isole Faroe, dove annualmente avviene ancora una mattanza di un tipo di delfino detto “calderones” in Argentina, che assomiglia a una balenottera e raggiunge il peso di 2 tonnellate. La stessa mattanza ha luogo in Giappone vicino l'isola Taiji, dove vengono uccisi circa 20.000 esemplari all'anno, in beffa a tutte le Leggi.
Oggi, pur essendone vietata la vendita, si trova a caro prezzo come spesso avviene con le merci vietate, fatto di tonno o di pesce spada. Di delfini, comunque, continuano a morirne tanti, perché molti capitano insieme ai tonni, ma poi chissà che fine fanno.
I delfini sono intelligentissimi e non sono molto amici dei pescatori. Infatti nella pesca a strascico, per quanto il sacco venga protetto da una specie di rete a maglie larghe fatta di gomma, e nonostante vi siano legati dei rami di spini sul sacco, i delfini riescono a aprire un foro dal quale fuoriesce del pesce, uno alla volta, grazie alla pressione dell'acqua nel sacco, poi, si saziano, dandosi naturalmente il cambio.
Ai pescatori che pescano con le reti da posta, il danno è superiore perché loro afferrano la preda e tirano, procurando dei grossi buchi alle reti con maglie piccole difficilmente riparabili.
Comunque, visto che ormai avevo già l'acquolina in bocca, mi decisi di mandare giù quel boccone ed era qualcosa di una bontà indescrivibile!
Dopo qualche giorno di navigazione, cominciai a vedere la nave che a volte era circondata da migliaia di dorsi luccicanti di delfini che ci accompagnavano.

Branco di delfini nell’oceano
Cominciai a vedere strane manovre a prora: era il nostromo che, insieme ad altri, stava armando la “delfiniera”: un arpione montato su una lunga asta, legato ad una robusta sagola, che una volta conficcatasi nella schiena del delfino, con tanta pratica ed un po’ di fortuna, riusciva a prenderne qualcuno, perché la nostra “velocità” (per non chiamarla 'lentezza') di 10 nodi, era la massima per quel tipo di pesca, perchè l'arpione, data la forte resistenza della povera preda, a volte si strappava.
Una volta catturato, il delfino veniva tagliato e messo per tante ore in salamoia, successivamente era fatto a pezzi, della grandezza di un salame che, successivamente, venivano legati ad una sagola, strizzati per un paio di giorni per far uscire il sangue, messi al sole, legati e composti a mo’ di strallo. Lo strano disegno issato al vento richiamava l’attenzione delle navi in controbordo che ci chiedevano spiegazioni su quel segnale....! Dopo una decina di giorni, il “Mosciamme” era pronto.
Gli specialisti di questa attività erano in genere siciliani, abituati sin da piccoli a pescare con le “spadare”. Quelle barche fatte proprio per la cattura del pesce spada. Con quegli alberi altissimi per la vedetta e quelle passerelle lunghissime dove stava il fiocinatore!
A loro non faceva più impressione la cattura di un delfino, come al macellaio il povero agnello. Ce n’erano migliaia intorno alla nave, prenderne uno non sembrava una grande crudeltà, forse era un peccato di gola ed un gesto atletico molto maschilista!!
Era uno spettacolo grandioso vederli sciare ai lati e sotto il tagliamare di quella prora annerita dalla ruggine. Giocavano come i ragazzini che scivolano sulla tavola spinta dall’onda sulle spiagge, ignari di ciò che sarebbe successo di lì a poco...! Ed ecco l'arpione, scagliato con forza, sopra uno di loro. “Tutto a dritta, (per diminuire la velocità) fila la sagola..., agguanta piano piano... “, finché non si riesce a tirarlo a bordo.

La fiocina scagliata dal Nostromo entra nel dorso del delfino.
Non volevo parlarne... prima dicevo delle “spadare”..., ricordate la canzone di Modugno: “U' pisci spada”. La struggente storia d'amore di due pesci spada: la femmina viene presa ed il maschio, per quanto la compagna lo esorti a fuggire, preferisce subire la stessa sorte e va a mettersi sotto il fiocinatore. Si ritroveranno insieme, in fondo alla barca, anche se morti!

La femmina viene presa ed il maschio le sta vicino per farsi prendere anche lui.
La stessa cosa accadde con quel delfino, la cui compagna era stata presa. Gli altri erano fuggiti tutti, solo lui correva con noi e facendo dei salti altissimi, emetteva un gemito, non so se fosse un pianto, oppure l'esortazione al fiocinatore di prendere anche lui. La scena struggente durò per molto, ma non era previsto prenderne due!!

La femmina viene tirata a bordo
Quel delfino non lo dimenticherò mai… corse con noi finché ne ebbe la forza, poi chissà… forse vagò per l'oceano immenso, cercando le prore delle navi per fare la stessa fine della sua compagna!
Da quel giorno non ho più mangiato il MOSCIAMME".

Il maschio ci precede per tanto tempo nella speranza di essere fiocinato anche lui
Questa storia spesso mi torna in mente.
Solo pochi mesi dopo questa storia, durante l'estate, mentre ero in licenza a casa mia, quella vicino al mare, ho avuto modo di conoscere due ragazzi giovani che correvano lungo quella spiaggia, tra schizzi d'acqua, proprio come due giovani delfini, con i quali andavano a giocare con la barca a vela, ebbri di gioia come loro, ai quali davano in pasto gli sgombri che prendevano con la traina. Al mattino, sembrava che li aspettassero! Infatti ce n'era uno, con un taglietto sulla pinna, facile da riconoscere!
Questi ragazzi, amati da tutti in quel piccolo posto, si sposarono. Passò poco più di dieci anni di quello stato idilliaco, durante il quale sono nate tre meravigliose bambine, e mentre insegnavano a giocare anche a loro a correre con le prore delle navi, ignari del pericolo, un fiocinatore strisciò con l'arpione la mamma!!

L'autore con la moglie Marilena e i due piccoli delfini Marina e Selene
Sembrava un graffio da niente..., ed invece quel graffio è stato capace, con il passare degli anni, in maniera infinitesimale a ridurla molto male, tanto che a volte resta senza respiro...!!
Successivamente, prima che si rendessero conto di ciò che stava succedendo, venti anni fa, il 'Fiocinatore', ha prodotto anche al marito, un danno gravissimo, ora sono soli, "uniti nella buona e nella cattiva sorte"! (le figlie sono fisicamente lontano). Quando avviene, e spesso, quel momento che la moglie diventa cianotica, e gli parla solo con gli occhi.., il marito, come il Delfino maschio, prega il 'Fiocinatore', affinché fiocini anche lui!!
Ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale!

Inizio operazione mosciamme

Pacifico 1963 - Prora Liberty "ITALTERRA" - ('Italnavi' ) –Ge "MUSCIAME"
Nunzio Catena
Ortona, 10 Gennaio 2014
MA BELAN...!
PREMESSA:
Il seguente “sàggio du belin”… é dedicato all’AMICO Comandante Nunzio Catena di Ortona il quale, avendo navigato a bordo di navi genovesi, capisce ed ama il nostro dialetto fino al punto di chiedermi una ricerca anche “limitata” sull’argomento. Ho cercato di accontentarlo inizialmente con un po’ di ritrosia poi, all’improvviso, mi é venuto in mente una lettura studentesca di molti anni fa: Marco Valerio Marziale 38-104 d.C. (ed altri) – gli epigrammi proibiti che mi sono andato a rileggere sul web. Devo confessarvi che: “MA BELIN”… al confronto é un giochetto da educande…
Giusto per non confondere la lana con la seta, gli antichi latini usavano il termine MENTULA al posto del nostro….
MA BELIN…!
L’argomento é serio… per tale motivo partiamo da modelli scientifici consolidati per poi arretrare verso i “recanti” della storia ed infine per calarci nella quotidianità con quelle espressioni che esplodono dalle viscere sanguigne così vicine alle nostre radici storiche e territoriali.

La nota guida del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, Giancarlo Boaretto introduce l’argomento così:
“Attenzione qui siamo in presenza di uno strumento a lunga gittata che può lasciare conseguenze…”.
Capìta l’antifona… i liguri presenti scoppiano in una folle risata…!
Il Comandante Ernani Andreatta racconta: “Che cos'è? Ma c’era, il fax, molto tempo fa? Non c’era, però state a sentire qualcosa che molta gente non sa e così, poi, glielo potrete raccontare. In Francia, quasi un secolo fa, l’ingegnere Edouard Belin inventò un congegno che trasformava l’elettricità in segni di scrittura o di disegno. Così, in pace, e purtroppo in guerra, fu usato per trent'anni, e inviava i suoi messaggi per tutta la terra. Quel fax antico, come si chiamava? È il belinografo!”
Trovandoci in un Museo Marinaro, ci viene in mente quella nave passeggeri che, negli Anni ’20, portava il nome di Albert Ballin il quale fu il primo armatore che pensò di realizzare navi dedicate esclusivamente alle crociere. Albert Ballin fu Direttore Generale della Compagnia di Navigazione Hapag (divenuta nel 1970 Hapag-Lloyd dopo la fusione con la grande rivale Norddeutscher Lloyd).
Rientrando velocemente nel tema, stiamo pensando a tutti quei marittimi genovesi di quegli anni che, incrociando quel transatlantico in oceano, avranno sicuramente pronunciato il suo nome alla genovese, forse per sentirsi un po’ a casa…
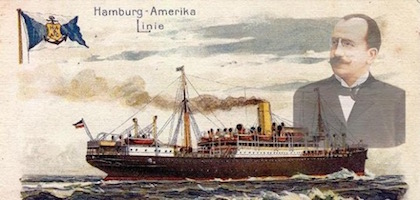
La Albert Ballin in navigazione
L’occasione della visita al Museo Marinaro ci offre l’occasione d’introdurre un argomento un po’ particolare; infatti, col successo del comico genovese Maurizio Crozza in televisione e in teatro, l’intercalare genovese BELIN viene usato senza risparmio anche due o tre volte nella stessa frase sollevando molte curiosità e altrettante domande da parte di chi ligure non é. Pertanto, non indugeremo oltre sul Belinografo, ma ci concentreremo sull’intercalare genovese BELIN che si presta a molti significati e a svariate interpretazioni che cercheremo di riassumere in seguito. Ma ora, come é nostra abitudine, partiamo da lontano con alcune ipotesi storiche sulle origini di questo termine.
BELIN … nella Storia!
1° Ipotesi
"Belin", rappresenta l’imprecazione, l’esclamazione più usata nel dialetto genovese, potendo assumere tono affermativo, risentito, solenne, stupito, iroso, sconsolato, beffardo, e altro ancora.
Sentiamo cosa ne pensa l’illustre etimologo E. Mori:
“occorre seguire contemporaneamente il filone storico e quello psicologico, perché i popoli hanno, in materia di parole, una loro psicologia. Una regola psicologica ci dice che in nessuna lingua l'organo maschile è indicato con un diminutivo. Gli antichi dizionari ricollegavano belin al greco balanos (glande) ed era, psicologicamente, una stupidaggine perché gli antichi liguri non avevano di certo aspettato i greci per dare un nome al loro pisello! Però un fondo di vero c'era e già un linguista del 1940 ricollegava belin al dio fenicio Baal, individuando una radice indeuropea che con bal indicava la divinità in genere. Ed infatti per i Galli la loro divinità (Henri Dontenville, Mythologie française) era un essere che era Padre e Figlio ad un tempo. Come Padre, si chiamava Belenus; equivaleva sostanzialmente ad Apollo, era il grande dio solare originariamente adorato dalle popolazioni pre-indoeuropee. In qualità di Figlio era sentito come più vicino alla terra, in qualche modo legato alle pietre, agli alberi e alle acque; si chiamava Gargano.
Il territorio francese, per limitarci a questo, è costellato di luoghi il cui nome si collega etimologicamente a quello di Belenus (Bel o Belen in francese) o di Gargano. Si tratta, a seconda dell'evoluzione fonetica delle varie zone, di Balan, Blesme, Belfait (l'albero di Bel), Montbelair, Baleine, Blaine, Ballons, Corblin (la pietra di Belin), Blainville, Belmont, Montbel... Si tratta delle antiche roccheforti dei Galli, Gergobina e Gergovie; a Guérande, il castello Gorgon; si tratta di fiumi: Gorganne, Gorgonne, Gargonne, Gargonde; di alture: Gargatte, Jariatte... Non è raro che i due nomi si affianchino; oppure - e può essere ancor più sintomatico - non lungi dal luogo che richiama Belenus, sopravvive (o sopravviveva fino a poco tempo fa) una leggenda popolare il cui eroe è un gigante perlopiù chiamato Gargantua.
È quindi certo che nell'area francese-provenzale-ligure il termine belin era diffuso per indicare la divinità. In Val Varaita vi è il paese Bellino, quasi certamente riconducibile alla stessa origine (Belin, Belinium, Belinius, nom d'homme gaulois ou de divinité. Charles Rostaing, "Dictionnaire des noms de lieux", Ed. Larousse p.68). La dimostrazione del collegamento tra belin genovese e divinità galliche è data dal fatto che in francese esiste la parola antica beliner proprio con il significato di “scopare”. È vero che tutti gli etimologisti francesi dicono che la parola deriva da belin, termine che fin dal medioevo indica il montone, ma si sono dimenticati che nella preistoria, quando vi erano ancora i culti totemici, l'animale totem di un popolo dava il nome anche al dio, o viceversa (giove, giovenco, juvenes, ecc.).
Quindi la tesi probabile al 90% è che la parola genovese belin derivi dall'antica parola dei galli-liguri Belenus”.
2° Ipotesi
Maria Elena Dagnino, cogoletese, é stata professoressa di italiano e latino nei licei per 40 anni. Ora é docente per l’Unitre di Arenzano Cogoleto, di cui é socia storica.
Secondo la studiosa, l’intercalare ebbe origine dal popolo dei Celti.
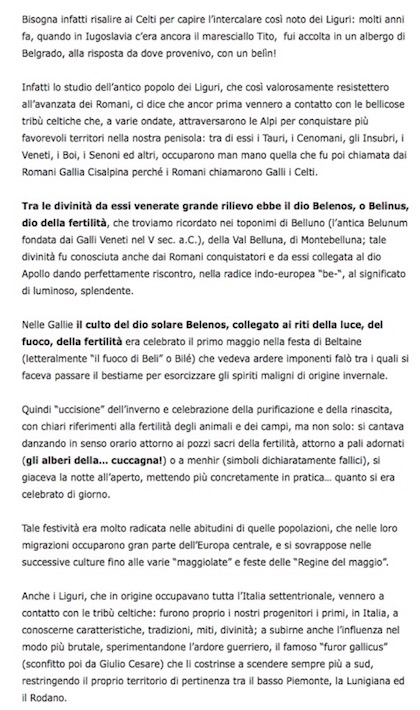
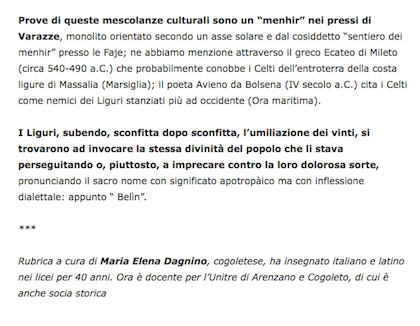
Al lettore eccessivamente sensibile e di gusti alquanto raffinati consigliamo di fermarsi sull’uscio di Paolino… Un scito do belin!
Da cui accogliamo e pubblichiamo le seguenti espressioni dialettali più comuni
"A belin de can": "a ca… di cane" (si dice d’ogni cosa sgraziata, mal costrutta).
"Sottî comme i péi do belin de ‘na mosca": "sottile come i peli del c… di una mosca".
"Açimentâ o belin": "cimentare, irritare il c…": (annoiare, infastidire)
- Eguale significato hanno le espressioni:
"Menâ, ronpî, sciaccâ, sgarbellâ, spellâ, sussâ, tiâ o belin": "mungere/menare, rompere, schiacciare, scalfire, sbucciare, succhiare, tirare il c…".
"Avéi o belin inverso (o inböso)": essere in gran collera, essere di malumore.
"Avéine o belin pin": essere all’ estremo limite della pazienza, o averlo superato.
"Battisene o belin (inti schéuggi)": non darsi pensiero, non preoccuparsi, fregarsene (negli scogli)
- Ma chi è accusato a torto di ciò, può controbattere:
"In sce ‘n ‘articiòcca": "su un carciofo"; che non è cosa di poco conto.
"Fâ di discorsci do belin": "fare dei discorsi (o ragionamenti) del c…" (cioè sciocchi, futili).
"Fâ rîe o belin": si dice di parole o decisioni molto sciocche.
Levâse co-o belin amâo": "alzarsi col c… amaro" svegliarsi di cattivo umore.
"No distingoe o belin da-a còrda": non avere nessuna capacità speculativa.
"Portâ via o belin": andarsene bruscamente.
"Rataieu da belin": "trappola da c…" (si riferisce a donna decisamente non casta).
"Tocâse o belin co-a camîxa": "toccarsi il c… con la camicia" (mostrarsi straordinariamente casto o schizzinoso, affettare modi esageratamente raffinati)
"Travaggio do belin": "lavoro del c…" (impresa ardua, ma anche - secondo i casi - lavoro molto facile, sciocco).
"Un belin che te neghe": "un c… che ti strozzi" (esclamazione imprecativa).
"O deve avéi o belin a manego de paegoa": "deve avere il c… a manico d’ ombrello" così si ipotizza a proposito di persona dalle forme tutt’altro che armoniose; spesso, anche di chi, andando alla toilette, bagna tutt’attorno).
Locuzioni riferite a un pene di iperboliche dimensioni:
"Un belin ch’o pâ un figieu picin ch’o rîe": "un c… che pare un bambino piccolo che ride".
"Un belin che se ti gh’apendi un cavagnin, o pâ un figieu ch’o vadde a l’azilo": "un c… che se gli appendi un cestino, pare un bimbo che va all’asilo".
"Un belin che se ti ghe metti ‘na beretta o pâ un garaventin": "un c… che se gli metti una berretta pare un garaventino" (cioè un marinaretto della Nave Scuola Garaventa).
Espressioni allusive:
"O l’à a mêz’asta": "l’ha a mezz’asta" (è incapace d’erezione).
"O l’à coscì picin, che se o dâ da mangiâ a un gatto de venardì, o no fa manco pecòu": "l’ha così piccolo che se lo dà da mangiare a un gatto di venerdì (evidentemente quando era ancora prescritto il magro) non fa neppure peccato".
"Ti te l’æ mâi visto a-o ciæo da lùnn-a? ": "te lo sei mai visto al chiaro di luna?" (espressione usata nei confronti di chi formula una richiesta assurda, pretende impresa irrealizzabile).
"Òmmo picin tutto belin": "uomo piccolo tutto c…." (a confronto dell’uomo non dotato di imponente statura).
"Chi l’à ciù gròsso de mi, l’à gonfio": "chi l’ha più grosso di me, l’ha gonfio".
"Cangiâ l'ægoa a-o canâio": "cambiare l’acqua al canarino" (orinare).
"Pociâ o beschéutto": "inzuppare il biscotto" (avere un rapporto sessuale).
CONCLUSIONE
Non possiamo terminare questa nostra stravagante escursione … senza elencare i principali sinonimi di Belin:
Affare, Anghilla, Anghæzo, Beschéutto, Canâio, Canetta, Canociâle, Cantabrùnn-a, Caròttoa, Ciciòllo, Manubrio, Macacco, Nenne, Oxello, Pigneu, Pistòlla, Pinfao, Radiccia, Suchin.
Per ovvi motivi estetici… mi scuso per la mancata pubblicazione di foto sull’argomento!
CARLO GATTI
Rapallo, 26 Aprile 2018