CAMOGLINI, uomini di mare

Così, come il vecchio sagrestano che, per eccessiva familiarità ormai non si genuflette più passando davanti all’altare, altrettanto capitava ai genovesi che, eterni dirimpettai del mare, raramente si lasciavano irretire dall’esotica, suadente pubblicità delle crociere; e pensare che, all’epoca, la più grande Compagnia specializzata nel ramo era genovese ed aveva sede proprio a Genova.
Mia moglie ed io invece ce ne lasciammo tentare; felice scelta. Ci fece scoprire e gustare un mare sino allora insolito; era la crociera di fine d‘anno che, passato in navigazione quando i figli sono ormai grandi, ti fa rivivere tempi e ritmi dimenticati, fugando immancabili malinconie.

Per il pranzo del primo dell’anno eravamo ospiti del Comandante, genovese D.O.C.; attraverso i velari delle vetrate della grande sala da pranzo, s’intravedeva una fredda ma soleggiata giornata illuminare il mare piatto e lucido, quasi fosse mercurio.
In tavola caviale, salmone e certamente a seguire, da quanto l’inizio lasciava intuire, ogni ben di Dio; la garrula signora del tavolo accanto disquisiva, con quella sua voce penetrante, sulla temperatura di servizio del caviale e del “bouquet” dello champagne che lo accompagnava.
Occupammo i nostri posti e il cameriere, garbatamente, accompagnò la poltrona mentre mi accingevo a sedermi di fronte al Comandante; non so perché ma, per un attimo pensai, “metto i piedi sotto la tavola” e, con il poeta Vito Elio Petrucci, anch’io pensai:
E gambe sott’ä töa
euggi che rïan in gïo:
derrùe o mondo che mi l’ammio.
Libera traduzione; Le gambe sotto alla tavola occhi che ridono in giro: crolli il mondo che io lo sto a guardare.
Inaspettata, una rasoiata di sole s’infilò fra le tende appena discoste e il suo riflettersi nel piatto, mi abbacinò; quel lampo, mentre ancora cercavo di capire il perché quella frase mi fosse affiorata proprio in quel momento, m’illuminò un ricordo legato al mare.

Il Santuario della Madonna del Boschetto

A Camogli ho conosciuto un Comandante, forse l’ultimo cresciuto e vissuto all’antica perché aveva imparato l’abbecedario del mare facendo il mozzo sugli ultimi velieri e, anche lui, come tutti i camoglini, era devoto alla Madonna del Boschetto. Anticamente quella Vergine, per loro, non era solo la Regina dei Mari ma anche una “socia”; e che socia!
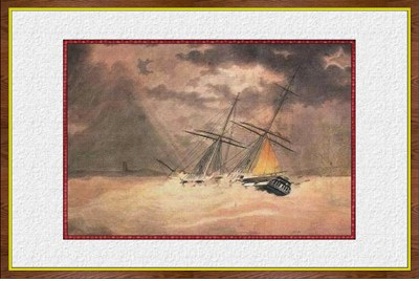
Fu proprio in questa cittadina che nacque il moderno concetto di multiproprietà; allora fu inventato per permettere alla marineria locale di trovare i soldi necessari per costruirsi e gestirsi i propri vascelli. Il piccolo paese, dalle scarse risorse e dai bassi redditi, non avrebbe mai potuto, contrariamente a Genova dove poche, ricche casate, erano le vere proprietarie dell’intera flotta della Repubblica, permettersi di possedere velieri. Con questo marchingegno finanziario invece, riuscirono a costruirsi bastimenti a vela, contando sull’autofinanziamento reperito fra più persone che si univano per sostenerne gli oneri, con la prospettiva di dividersene gli utili.
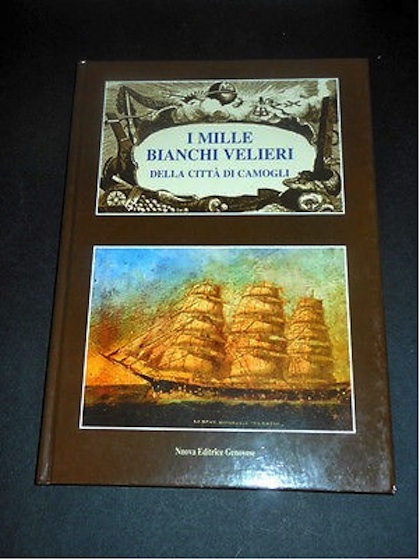
Basti pensare che con questo sistema di finanziamento, nella seconda parte dell’ottocento, la flotta camoglina registrata poteva contare su oltre 800 velieri, escludendo i grossi Leudi e le Bilancelle.
Ognuno poteva partecipare comprando quote dette “carati” da un unico soggetto responsabile: l’armatore. Ogni carato corrispondeva alla ventiquattresima parte del valore del vascello ma, a loro volta i carati erano cedibili dividendoli per due, quattro e così via, in modo da permettere anche a molti piccoli risparmiatori di partecipare. Per snellire la gestione ed avere la rappresentatività anche delle piccole parti che altrimenti avrebbero potuto intralciarne l’operare, abbiamo visto che, inizialmente, la totalità dei carati interi veniva sottoscritta da un armatore che ne rispondeva quale responsabile unico ma, a sua volta, suddividendoli nel modo sopra detto, li rivendeva a tanti che da lui si facevano rappresentare. Ancora oggi questo “modus operandi” ha fatto la fortuna di armatori coraggiosi ma con poche sostanze personali da impegnare.

Un’ulteriore peculiarità, tutta camoglina, consisteva nell’accattivarsi la benevolenza divina, indispensabile a quei tempi per chi andava per mare, devolvendo una delle tante carature alla Madonna del Boschetto. Per evidenti ragioni pratiche, quel carato era consegnato al Parroco “pro tempore”, identificando in lui il legale rappresentante della Vergine…. quantomeno in quel di Camogli e limitatamente a quel frangente.
A quest’ultima insolita compartecipazione, molti concorrenti dell’epoca attribuivano le leggendarie fortune dei marittimi del borgo; senza voler sminuire l’intervento soprannaturale, questo vincolarsi l’uno all’altro, senza perciò farsi concorrenza ma anzi agendo come una sola flotta, fece la loro fortuna.
Si potevano possedere carati di più navi, come pure partecipare in molte iniziative; tutti erano interessati al buon esito, a cominciare dagli stessi Comandanti che, a loro volta, spesso erano comproprietari del vascello di cui erano al comando e, contemporaneamente, anche di altri che navigavano per i mari sotto il comando di colleghi camoglini. Sempre con lo stesso principio crearono anche un sistema di copertura assicurativa, che poi verrà ripresa dai mitici Lloyd’s di Londra.
Di Camogli e della sua flotta ce ne parla il poeta Nicolò Bacigalupo (1837 – 1904) nella sua <Camogli>
Camogli, bella naiade accuegâ
Coi pê in te l’aegua e a testa sotto i pin,
Che ombrezzan dal’artùa de Portofin
A valle dove ti te spegi in mâ,
Ricca e bella t’han reiso i brigantin
Che andavan da-o to porto a caregâ
O carbon, che ò t’ha faetro guadagnâ
Di milioni adreitùa de cavorin.
………………………………..
Libera traduzione: Camogli, bella naiade sdraiata con i piedi nell’acqua e la testa sotto i pini che ti fanno ombra dall’altura di Portofino sino a valle dove ti specchi in mare, ■ ricca e bella t’hanno resa i brigantini che andavano dal tuo porto a caricare carbone, che ti ha fatto guadagnare milioni, addirittura in pezzi da due lire.

L’attuale Stemma di Genova
A Genova invece, l’abbiamo visto, ciascuna delle potenti famiglie in eterna lite l’una contro le altre, possedeva le proprie navi, poi passate alla storia come la <flotta della Repubblica >; ma non era per nulla così. Ogni qual volta si riteneva necessario che una flotta di Genova dovesse combattere un nemico comune, in genere un concorrente commerciale, si riunivano le famiglie più importanti, che erano poi le più interessate e, allestite e armate le proprie navi per la guerra, provvedevano alla bisogna sotto un unico gonfalone, quello della Repubblica di Genova affidando il comando ad un solo capo responsabile; prima di farlo però ottenevano il beneplacito e la garanzia della rifusione dei costi, dal Senato della Repubblica, guarda caso anch’esso formato da membri delle stesse famiglie dominanti.
L’aver invece cointeressato anche il comandante alle fortune della nave posta sotto il suo comando fece sì che, quelli di Camogli più d’ogni altro, agissero sempre portando a termine ciascuna intrapresa, badando primariamente al bene del battello nel quale avevano investito anche il loro personale patrimonio; non a caso erano stimati e apprezzati in tutti i porti del Mediterraneo.
Torniamo però a “quell’ultimo” Comandante da me conosciuto; di taglia robusta, eterno signorino, era cresciuto sul mare avendo avuto come maestri, ai quali seppe carpire i più remoti segreti, gente del livello degli Schiaffino, i Ferrari o i Mortola, veri e propri miti della marineria locale. Dal diverso “arzillo” dell’aria o dall’umidità che avvertiva nei capelli, prevedeva infallibilmente il tempo del giorno dopo, cognizione indispensabile per non trovarsi, impreparati, in mezzo ai guai anche se ormai non si navigava più con i velieri.
Appena finita la guerra, comandava le petroliere quando il trasporto dell’oro nero dava utili inimmaginabili; era noto perché, ogni primavera e sempre in anticipo sugli altri, inaugurava la rotta artica. Infilava la sua prua fra le crepe che l’iniziale disgelo apre nella banchisa che ricopre, per mesi, il mare del Nord, risparmiando preziose giornate di viaggio fra oriente e occidente, a discapito della concorrenza che quella rotta non osava ancora solcare. Una vera fortuna per i suoi armatori che, nel tempo, gli rimasero sempre fedeli, cosa insolita in un’epoca in cui, offrendo di più, si cercava di accaparrarsi i Comandanti migliori sulla piazza perché, i più validi, erano purtroppo defunti nell’ultima guerra da poco terminata. Logico quindi che lo coccolassero come fosse una prima genitura dalla salute cagionevole e, ogni suo eventuale capriccio, era da loro esaudito; ma lui di “capricci” non ne fece mai.
Una sola debolezza lo rendeva irrazionale; quando, dopo mesi di navigazione senza sbarcare per più di un giorno, non potendone proprio più, inviava agli armatori il solito telegramma con il quale li avvisava, appunto, di <non poterne più >. Al primo porto concordato, puntuale come un orologio svizzero, non a caso i suoi armatori erano per l’appunto elvetici, c’era ad attenderlo il supplente e lui, a costo di trasvolare tre quarti del globo, tornava diritto a Camogli. Certamente, anche lui, si sarebbe ritrovato nella poesia di Vito Elio Petrucci intitolata <Se no ghe fïse > dove, meglio di ogni altro poeta, ha saputo descrivere l’amore viscerale che lega i genovesi alla loro terra:
Se no ghe fïse un ciaeo,
se no ghe fïse lunn-a e manco stelle,
s’avesse i euggi bindae a ancon serrae
comm un figgieu in nascion;
e fïse a-o largo con un mâ de ciappa,
sensa ‘na bava d’äia;
se mettesse o mae cheu in sce’n timon
mì m’attrovièva a-a Foxe
Libera traduzione : Se non ci fosse un lume, se non ci fosse la luna e neppure le stelle, se avessi gli occhi bendati o ancora chiusi come un bimbo quando nasce; ■ e fossi al largo con un mare piatto, senza un filo d’aria; ■ se mettessi il mio cuore sopra un timone mi troverei alla Foce. (la foce del Bisagno, primitivo porto di Genova.)

A qualunque ora arrivasse, abbracciata la madre che sempre più invecchiava ma ogni volta, come quand’era ragazzo, qualcosa da lagnarsi aveva sempre, andava alla vecchia Manuelina (non ancora nel luogo del nuovo ristorante che oggi onora Recco, né era altrettanto famosa) in allora gestito dalla prima proprietaria, capostipite della famiglia, una sempre disponibile e tollerante matura “Sporcacciona”, dal soprannome che nei vecchi borghi si appioppava con tanta incosciente facilità.
Lì saziava la sua nostalgia degli aromi che gli avevano profumato l’infanzia, le sue uniche irrinunciabili radici. Era un formidabile mangiatore, come oggi se ne vedono sempre meno, che non ha mai sofferto di mal di testa né tanto meno di pesantezza allo stomaco. Molte volte, noi giovani nottambuli, finivamo le nostre serate ritrovandoci, a tarda ora ma sarebbe più corretto dire sulle prime del giorno dopo, nella stessa, tollerante, trattoria; a volte lo incrociavamo mentre usciva per rincasare e allora, regolarmente, rientrava unendosi al nostro gruppo per ricominciare a cenare sino a che, alla fine, si usciva tutti quando il chiarore iniziava ad illuminare le ultime nicchie scure della notte nel sottostante torrente Recco.
Così trascorreva il suo tempo a terra da “sbarcato” ma, giorno dopo giorno, ci avvedevamo delle sue crescenti manifestazioni d’insofferente irrequietezza, lo stesso stimolo che in precedenza lo aveva indotto a sbarcare. Il suo potere a bordo, monarca assoluto, qui non gli era riconosciuto e tutte le nostre quotidiane vessazioni, per lui divenivano insopportabili; era costretto perfino ad attendere il suo turno, in fila, prima di essere servito nei negozi. Era intollerabilmente troppo e così, come i primi sintomi ci avevano lasciato presagire, inviava un altro telegramma, questa volta per segnalare la sua ritrovata disponibilità; e subito, in qualche parte del globo, gli restituivano il comando.
Al momento dell’ultimo tradizionale brindisi conviviale, sapevamo che per molti mesi non lo avremmo più rivisto ma, di una cosa eravamo certi: il mezzogiorno di Natale, ogni anno, fermava le eliche in qualunque mare si trovasse, perché tutti dovevano pranzare “da fermi e con i piedi sotto la tavola, come dei veri cristiani”. Lui, già dal primo mattino era sceso nelle cucine e aveva preparato, personalmente, i ravioli misti alla genovese, perpetuando la tradizione del Natale, nel modo che suo padre gli insegnò; quello doveva essere <giorno dell’uomo, non delle macchine >
Altra figura camoglina, oggi scomparsa, era il “Comandante”, dal soprannome che lo individuava ma che in realtà, questo grado, mai volle raggiungere, per sua scelta.
A detta di chi lo conosceva bene, era il miglior “Secondo” che un comandante potesse desiderare perché tutti i porti del mondo, il mare, lo stivaggio, l’equipaggio, per lui non avevano segreti; li conosceva a memoria come l’<Angelo di Dio >.
Sempre gioviale, era fisicamente una specie di tenente Kojak, ma grande e grosso il doppio o, forse meglio, un’incarnazione di <Poldo mangiapanini > dei cartoons, ma senza i caratteristici baffi.
Omone dai modi un po’ affettati, più familiari ad un Commissario di bordo che non ad un graduato di coperta, specie su una nave mercantile, ha vissuto con l’incubo di passare “Comandante”, riconoscimento che l’età e il curriculum ampiamente meritavano. Non avrebbe retto alla responsabilità diretta che il grado, e lo stipendio, comportavano, anche se in pratica, a bordo, in più di un’occasione si comportò come se lo fosse perché, lo abbiamo già visto, a quei tempi circolavano certi Comandanti che solo la moría bellica dei migliori, aveva promosso a quell’immeritato ruolo. La responsabilità totale, quella che solo in mare spetta a chi comanda, lo terrorizzava; il sapere che un altro, per contratto, se l’era assunta, lo rendeva deciso, scaltro, coraggioso e accorto.
Un brutto giorno o, meglio, una brutta notte, chi n’aveva il ruolo, spirò senza lasciargli alternativa alcuna; vittima di un secco infarto che, con il fulmineo arrivo e la subitanea dipartita, si portò via, oltre all’anima del comandante di ruolo, anche la tranquillità del nostro amico. Lui, novello Cireneo, si trovò a farsi carico di condurre la nave al porto più vicino programmato e, raggiuntolo, si sbarcò con effetto immediato, nonostante l’armatore lo blandisse con un’alettante offerta.
Traumatizzato, si rifugiò a Camogli per riprendersi dallo shock patito e la cosa durò alcuni anni. Era continuamente sollecitato da chi ricercava gente in gamba, onesta e di provata perizia ma, ogni profferta, era per lui come se una mano sadica gli rigirasse un coltello arrugginito in una piaga ancora sanguinante; dopo qualche anno, ormai uscito dal giro, gli capitò l’occasione d’imbarcarsi nel suo ruolo “naturale” di Secondo e partì da Camogli. L’età non era certo più compatibile con il grado, ma lui, entusiasta come lo fu al suo primo imbarco da <Allievo di prima nomina >, partì dopo averci invitati, la sera prima, tutti dalla solita Manuelina.
Anche lui era una formidabile forchetta e, durante il convivio, gli piaceva parlare delle molte cucine che, per il mondo, aveva avuto la ventura di assaporare; affascinante affabulatore, con quella sua voce baritonale, trasformava il locale in cui era nel ponte dei cannoni, in piena battaglia di Trafalgar.
Durante l’ultima guerra questo suo timbro da bombarda gli servì per sovrastare il frastuono di una taverna nel porto di Buenos Aires, all’epoca territorio neutrale. Un’orchestrina, a pagamento, suonava le canzoni richieste dal miglior offerente.
Capita sovente ai marinai che per tanto tempo stanno lontani da casa di ricercare il “calore” nell’alcool o nelle facili avventure; lo stesso accadde al Nostro quando, prima inconsciamente poi dando al gioco valore di sfida, si trovò a competere con altri per far suonare la propria canzone del cuore.
A mano a mano che la posta aumentava per la ripicca di qualcuno, uno dopo l’altro i vari concorrenti rappresentanti mezzo mondo, da giocatori si tiravano fuori, divenendo spettatori; lui si ritrovò da solo a fronteggiare un gruppo di marinai americani, unici, irriducibili concorrenti. I vari perdenti avrebbero potuto far proprie nei suoi confronti le parole che Plinio scrisse a proposito della conquista della Liguria < difficilius erat invenire quam vincere >.
D’altra parte, sulla puntigliosità ligure, il Nostro aveva precedenti assai più illustri in Genova.

La Basilica di Carignano, quella le cui inconfondibili cupole dominano il cuore della Città ben visibili da chi vi giunge dall’autostrada e percorre la Sopraelevata, è opera cinquecentesca dell’Alessi, da sempre Cappella privata, gestita dalla Curia, ma non di sua proprietà. L’opera sorse a seguito di una motivazione, quantomeno, inusitata. Questa monumentale Chiesa fu il frutto di una ripicca ad uno sgarbo subito dalla contessa Fieschi quando, una Domenica, inviò un suo servo dai marchesi Sauli nella cui loro Chiesa, Santa Maria in Via Lata lì vicino, la Fieschi si recava abitualmente a santificare la festa, con la richiesta di voler, eccezionalmente per quella mattina, ritardare l’inizio della funzione di mezz’ora perché lei, impegnata, vi sarebbe altrimenti giunta in ritardo; i Sauli, per tutta risposta, le fecero sapere che <Chi vuole dei comodi, se li procuri >. Detto fatto: la risposta fu….. l’attuale Basilica di Carignano.
Immaginarsi quindi il Nostro davanti ai continui “rilanci” degli americani; lui offriva lire, moneta dei perdenti e quelli, dollari dei vincitori. Si dissanguò bruciandosi l’intero ingaggio del viaggio ma, alle prime luci dell’alba l’orchestra intonò, quale canzone vincente di quella notte brava, la sua < Ma se ghe penso >.
Lui aveva vinto mentre noi, dall’altra parte del mondo, stavamo definitivamente perdendo.
Questi erano i marinai di un tempo, aperti al mondo ma legati come bambini cocciuti alla loro casa, l’unica che riconoscevano come vera patria.
RENZO BAGNASCO
Rapallo, 10 Febbraio 2015
