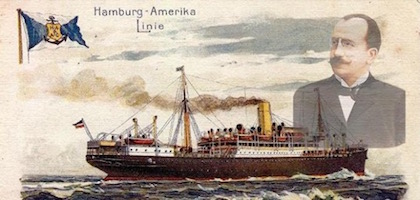YACHT PASSE PARTOUT
YACHT PASSE PARTOUT
Siamo tutti sulla stessa barca!
Ma in pochi sullo stesso yacht.
(Gianni Palladino)
Attratto dall’eleganza e dall’altezza degli alberi del PASSE PARTOUT, ho scattato alcune fotografie; nel frattempo é comparso lo Skipper dal quale ho avuto i dati tecnici che ho riportato in questo servizio.
PASSE PARTOUT é uno Yacht molto lussuoso con lo scafo in acciaio e sovrastrutture in alluminio.
Architetto Navale: Tony Castro Design
Costruito da Jongert Yachts - fu Varato nel 2001 – Ultimo refitting nel 2009.
Lo Yacht PASSE PARTOUT ormeggiato nel porto di Santa Margherita Ligure


Gli alberi hanno un’Altezza rispettivamente di 50 mt. e 38.5 mt.
Lunghezza= 46 é lungo 42.00 mt.
Larghezza= 8.50 mt.
Superficie Velica= 924 m/2
Compartimento attuale= Barcellona – Spagna
E’ dotato di un’elica di prora
PASSE PARTOUT offers accommodation for up to 8 guests in 4 suites comprising 1 owner cabin, 1 double cabin, 2 twin cabins, 3 pullman cabins. She is also capable of carrying up to 6 crew onboard to ensure a relaxed luxury yacht experience.
ALBUN FOTOGRAFICO












La vera pace di Dio comincia in qualunque luogo
che sia mille miglia distante dalla terra più vicina.
(Joseph Conrad)
Carlo GATTI
Rapallo, Venerdì 15 Giugno 2018
LA FOCACCIA SA DI MARE ...
LA FOCACCIA SA DI MARE …
PREMESSA:
Regione che vai, focaccia che trovi!
Non c’è angolo d’Italia che non abbia una sua specialissima e tradizionale focaccia da gustare lungo la strada, a casa, ovunque…
In Italia se si vuole gustare una focaccia non c’è che l’imbarazzo della scelta e le varianti sono davvero numerose. Qualche esempio? La focaccia alla genovese, la focaccia di Recco, la schiacciata, la pinza veneta, la pinsa romana, la stria emiliana, lo gnocco al forno con ciccioli, la focaccia di Susa, quella barese e quella messinese, la crescia marchigiana e umbra, la pitta calabrese, la puccia salentina e chi più ne ha più ne metta.
Tra le specialità più amate della Liguria c’è senza dubbio la famosa focaccia alla genovese (in dialetto fugàssa). Prima dell’ultima lievitazione questa focaccia viene spennellata con un'emulsione composta da olio extravergine d’oliva, acqua e sale grosso. Nei forni liguri si trova anche la focaccia di Recco, preparata con una sfoglia sottilissima ripiena di formaggio fresco. La specialità, che ha conquistato il marchio di Indicazione Geografica Protetta, risalirebbe al XII sec. C’è anche la focaccia di Voltri che ha gli stessi ingredienti della classica di Genova, ma la consistenza dell’impasto e la sua cottura sono diversi.

Dopo la consueta premessa, il lettore avrà capito la “rotta” che faremo e dove andremo a dare fondo l’ancora…
Quando verso le 05 smontavo dal turno di notte in porto, era ancora troppo presto per tornare a casa, svegliare Kendo, il nostro Akita Inu, che a sua volta avrebbe svegliato mia moglie e i nostri quattro studenti...
Era meglio soprassedere onde evitare “cagnare” nel vicinato infine, sarebbe stato più divertente svegliare la truppa con il profumo della focaccia con la cipolla sotto le narici…
L’alternativa era sempre molto attraente: si trattava di ripetere un “pellegrinaggio” costiero ormai collaudato da anni, il Tour della focaccia a tappe che si snodava al buio per 30 km lungo l’Aurelia fino a Rapallo.
Se smontavo di guardia dal Porto Petroli di Multedo andavo addirittura qualche chilometro nella direzione opposta fino a Voltri, presso il famoso panificio Priano: un mito sacro per gli amanti della focaccia alla genovese tradizionale e con la cipolla, la mia passione!

Se invece smontavo dal Porto di Genova facevo tappa da BRI, a pochi metri dalla spiaggia di Priaruggia per l’incontro settimanale o quasi con il panettiere Giuan e qualche gabbiano nella baia. Era sempre buio e tra noi ed il solito guardiano notturno che chiamavo “baffo”, per ovvi motivi, si era stabilita una simpatica complicità, anche perché eravamo gli unici esemplari viventi in posizione eretta tra 600.000 genovesi allungati…
Conoscendo l’orario della prima sfornata, mi presentavo al momento giusto per ritirare il mio primo chilo di focaccia “bionda” con la cipolla, ma era pronto anche il secondo chilo di quella tradizionale che avvolgevo nella carta gialla tradizionale e poi in un plad per mantenerla al caldo; belin! riflettevo tra me: “ma guarda un po’ come li ho viziati questi gattini!”
La nostra cambusa di casa, finalmente, cominciava a stivarsi di roba buona! A parte mi facevo allungare due etti di “bionda morbida” che divoravo insieme a Giuan.
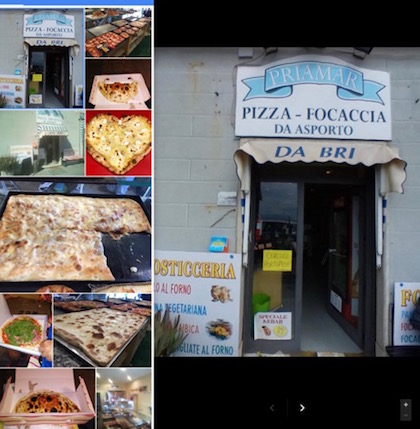

La focaccia con la cipolla va innaffiata col bianchino ed il mio amico, in cambio di un paio di pacchetti di Marllboro ricevute in regalo da un Comandante soddisfatto della manovra, mi allungava un gotto di quello buono di “Coronata” che teneva sotto il banco…, si brindava al GENOA e alla salute dei nostri vecchi.
Ora vi é persino più facile capire quanto fosse giustificata quella sosta notturna al termine di una tirata di 24 ore di sali e scendi dalle biscagline delle navi!
Devo solo aggiungere che quella piccola “crociera” era un rito famigliare, simile ad una nuotata nell’azzurro mare o nella piscina sotto casa in cui vedi o sogni un altro mondo perché sai che l’altro sta dormendo!
Uscivo dal negozio ma non riuscivo a staccarmi fisicamente da quella baia, e con la complicità delle note di Bruno Lauzi m’intrattenevo ancora un po’ con i gabbiani che non disdegnavano il lancio di piccoli bocconi di focaccia impregnata di olio buono; quella con la cipolla non la volevano, forse sentivano che non gliela avrei mai data…
Il più aggressivo e sfacciato lo chiamavo “gundun” e quello che invece si faceva fregare il boccone era u “belinun” di turno, e così lo chiamavo. Abitavano lì da sempre per abbellire l’alba e animare le giornate invernali, erano sempre gli stessi, mi conoscevano bene e leggevo nei loro occhietti il desiderio che fossi sempre di notte. Si sentivano i custodi di quel piccolo paradiso ai confini della Grande Genova.

Priaruggia di notte
ANCHE LA FOCACCIA HA LA SUA STORIA
Congedandomi dai miei amici di Priaruggia, Giuan mi diceva sempre la stessa frase: “Salutami la concorrenza” – “Gente de Rivëa, gente de galëa!”
Sapeva che la tappa successiva era Recco dove mi sarei tuffato su un paio di chili di focaccia col formaggio …
Una volta gli raccontai la vera storia da “fugassa rechelinna”: “Chissà quante volte l’hai mangiata quella di Recco, ma forse non conosci la sua origine: la focaccia di Recco nacque nel XII secolo, o meglio, a quell'epoca risalgono i primi documenti che parlano di questa specialità gastronomica.
Come veniva impiegata? Ebbene, sembra proprio che a fugassa de Recco venisse offerta ai crociati in partenza per la Terra Santa. Ma c'è anche chi dice che questa ricetta semplice e genuina fu "ripescata" nel '500 quando - a causa delle invasioni dei saraceni - la popolazione di Recco era costretta a rifugiarsi sulle alture, sopravvivendo con poche provviste e tanta fantasia. Ma non mancano altre testimonianze che risalgono alla letteratura del XIX secolo”.
“ Amiâ Charly che quelli de Recco no dàn un belin a nisciun. Ti pàrli de musse a mi che n’ho faeto di libri…”.
Giuan era il tipico personaggio da caroggi, schietto e genuino e ci soffriva che la sua focaccia col formaggio non fosse da me apprezzata come quella di Recco.
Non siamo qui per fare la réclame ai panifici nostrani tuttavia, chi legge ha anche il diritto di sapere chi merita almeno un sincero ringraziamento per la dedizione e indubbia capacità di realizzare focacce che portano il marchio della Riviera di Levante nel mondo.
Siamo a Recco per la penultima tappa presso il Panificio MOLTEDO, il quale é soprattutto celebre per la focaccia col formaggio.
Prima di lasciarvi in compagnia di chi ne sa più di me, cioè del Consorzio Recco Gastronomia, posso assicurarvi che esistono privati cittadini che nelle loro ville tra Recco e Camogli s’improvvisano focacciai di primissimo ordine, in quanto portatori di segreti orali che si tramandano da padre in figlio da secoli, senza comunicazioni con l’esterno… Tra questi vi é un mio carissimo Amico, un Comandante-Pilota di navi che tutti conoscete, ma che evito di rendere pubblico perché, come dicono i camoglini, maniman….. che esprime un concetto intraducibile!

SOSTA “NON FOCACCIERA” A SAN LORENZO DELLA COSTA

Isola del Tino - Faro di San Venerio
La tappa successiva non posso definirla tale perché si tratta soltanto della sosta doverosa del marinaio, una specie d’inchino al MARE ed ai suoi abitanti. Alcuni potrebbero definirla “romantica”, ma per chi scrive é un’altra cosa, forse si tratta di una deformazione professionale: del ritorno al passato di navigante, quando venendo da lontano, vedevo la “spazzola” del faro all’orizzonte e sentivo l’odore di casa…
Arrivato tra il “lusco e il brusco” a San Lorenzo della Costa - (300 mt. s.l.m.) - presso il bivio dove l’Aurelia si divide per chi scende a Santa o prosegue per Rapallo, c’é un piccolo spazio per posteggiare. Se il tempo é sereno, da quell’osservatorio speciale si vede il faro di San Venerio situato sull’isola del Tino:
Elevazione 99 m s.l.m. – Ultima costruzione 1884 – Portata 25 miglia nautiche -
Tempo fa, durante una di quelle soste con “vista sul Tino” mi capitò un fatto insolito… Una pantera della polizia mi piombò alle spalle, in un baleno uscirono due militari in mimetica armati di mitra! Era il periodo delle brigate rosse. “Venga fuori con le mani alzate!” – Urlarono -
“Avrò dimenticato di pagare la focaccia…!” – Pensai tra me –
“Mi faccia vedere i documenti! Cosa fa a quest’ora con il binocolo in mano?”
Ridendo gli spiegai il motivo della mia sosta e con una certa ironia scartai la focaccia ancora calda e dissi: “La preferite con o senza cipolla? Potremmo anche stapparci una bottiglia di bianco di Coronata”
Scoppiarono a ridere e quella sosta si concluse con la mia dotta spiegazione delle caratteristiche del faro del Tino:
3 lampi bianchi - periodo 15 secondi
Ultima sosta a Rapallo
Giancarlo Mangini ha scritto:
“I rapallini si dividono, per quel che riguarda la focaccia, tra le Pellegrine e Vivaldi. Il panificio delle Pellegrine si trova sotto i portici di via Garibaldi, è una istituzione a Rapallo; invece il panificio di Vivaldi è nella parte pedonale di via Mameli, quasi sotto al campanile pendente della basilica. Io sono vivaldiano – così ora i pellegrinisti mi odieranno, ma entrambi i panifici sono, a mio parere, al top dell'arte bianca, ma ognuno ha le sue preferenze”.
Giustissimo! Ognuno ha le sue preferenze e se proprio devo dire la mia aggiusterei il tiro in questo modo “diplomatico” ma sincero:

“Apprezzo molto Vivaldi, ma il mio cuore batte per le Pellegrine per la sua location medievale a ridosso del mare e per i tanti ricordi dell’ultima tappa del mio laico Pellegrinaggio mattutino che mi sono rimasti dentro.
Gustare la focaccia calda sugli scogli della passeggiata, con gli spruzzi delle mareggiate in faccia, ha un sapore unico di Riviera che rimane scolpito non solo nello stomaco…”

Un posto del cuore, per i ricordi che evoca, è il sotto portico delle Pellegrine a Rapallo.

Il panificio Le PELLEGRINE lo si raggiunge facilmente seguendo il profumo della focaccia nell'aria di Caroggio Drito.
Concludiamo con alcune RICETTE per gli appassionati
LA FOCACCIA GENOVESE
Ma la focaccia a Genova non si mangia solo a colazione: ci si ferma a comprarla e si mangia strada facendo come spuntino, è la merenda che si portano i bambini a scuola, sostituisce il pane durante i pasti, sempre presente nei buffet delle feste e per i nottambuli ci sono posti dove dopo la discoteca si trova calda già alle due o tre di notte.
Insomma, è una vera istituzione. E’ una presenza costante, sfornata a tutte le ore.
Inutile dire che ogni genovese ha i propri gusti e di conseguenza il proprio forno e la propria focaccia di riferimento, fermo restando che ci sono alcuni requisiti che una Focaccia con la effe maiuscola non può non avere.
Prima di tutto, se non lascia le dita unte, allora non è lei!
A deve coa d’eujo, deve colare olio, essere ben unta e salata, avere tanti œggi (tanti occhi) cioè tanti buchetti, nè molle nè elastica, ma morbida dentro con il bordo e la superficie croccanti, soprattutto mai e poi mai deve essere troppo alta! in tal caso si chiama marinara.
“Una volta sfornata la focaccia avrà una crosta color nocciola, bianco-avorio nelle occhiature.
Nella parte inferiore deve presentarsi giustamente unta, bianca e dorata. Deve essere alta mediamente due centimetri. L’occhiatura irregolare e profonda con tracce d’olio. Nella parte superiore possono essere presenti alcuni brillantini di sale.
Il profumo deve essere discretamente intenso, di leggera persistenza, non avere sensazioni dolciastre, ma tradire sfumature aromatiche dovute all’olio extravergine di oliva. Al palato è morbida, equilibrata nei gusti fondamentali (acido, dolce, salato), mai gommosa, ma croccante in superficie. Una leggera sensazione di amarognolo, dovuta all’olio, può essere lievemente percettibile. E’ invece chiaramente riscontrabile la sensazione di untuosità.”
La prova del nove comunque è data dalla durata, difficile che superi il giorno dopo, però una buona focaccia fatta al mattino alla sera è ancora mangiabile.
Vi consiglio in ogni caso di consumarla tiepida o comunque entro alcune ore dopo averla sfornata per gustarne appieno la bontà.
Per la focaccia in fondo ci vogliono pochi e semplici ingredienti: farina, acqua, olio d’oliva, lievito, malto e sale.
E’ la lavorazione che fa la differenza oltre alla qualità degli ingredienti, quindi seguite minuziosamente tutti i passaggi che ho descritto in attesa che sia in grado di creare un video.
Se siete abituati ad usare il lievito madre, potete sostituire al lievito di birra circa 150 g di lievito madre, fermo restando che la ricetta DOC riconosciuta della vera focaccia genovese è quella che vi ho scritto sotto.
La durata della lavorazione (dall’inizio dell’impasto all’infornata, comprese le varie lievitazioni) è stimata dal disciplinare in 10 ore (non può comunque essere inferiore alle otto ore), con tolleranze che tengono conto del tempo atmosferico: umidità, temperatura.
La cosa più difficile secondo me è imparare a fare i buchi, perchè ci viene d’istinto farli con la punta dei polpastrelli e delicatamente, invece dobbiamo imprimere con un movimento deciso ed una certa forza tutta l’ultima parte delle ultime falangi.
La focaccia ligure

Ricetta di Ezio Rocchi
Ingredienti
Per la biga:
- 500 g di farina Manitoba
- 225 g di acqua
- 5 g di lievito di birra
Per l'impasto:
- 150 g di biga
- 500 g di farina Pizza e Focaccia Molino Grassi
- 300 g di acqua
- 30 g di olio extravergine d'oliva
- 15 g di lievito di birra
- 10 g di malto
- 12 g di sale
Dosi di salamoia per una teglia di 30x40:
- 100 g di acqua salata (55 g di sale in 1 l di acqua)
- 50 g di olio extravergine d'oliva
Istruzioni
- La sera prima preparare la biga che deve fermentare 12/14 ore a temperatura ambiente (18-20°C): impastate brevemente tutti gli ingredienti, circa 4 minuti nell'impastatrice.
- Il mattino dopo iniziate l'impasto con farina, biga, sale, malto ed acqua (tenendone da parte il 5% che andrà aggiunta verso la fine).
- Dopo 5 minuti aggiungete il lievito e successivamente l'olio.
- Dopo circa 8 minuti aumentate la velocità dell'impastatrice ed aggiungete la restante acqua.
- Impastate ancora circa 4 minuti.
- Terminato l'impasto dividete subito senza tempo di riposo in pezzature da 500 g, date una piega e date una forma rettangolare, schiacciando leggermente.
- Lasciate riposare 30 minuti su una tavola infarinata con la chiusura verso il basso.
- Stendete con il mattarello e mettere su una teglia unta con 20 g di olio senza preoccuparsi di coprire tutta la teglia.
- Lasciate lievitare 30 minuti e poi schiacciate e stirate con le mani fino a coprire l'intero spazio della teglia.
- Lasciate lievitare per un'altra ora.
- Spolverate con farina e fate i buchi.
- Per fare i buchi è necessario usare le dita di entrambe le mani che lavorano in parallelo, partendo da un'estremità della teglia per arrivare all'altra. Fate attenzione a non usare solo la punta delle dita ma tutta l'ultima falange!!!
- Versare sull'impasto la quantità indicata per ogni teglia di salamoia ed olio - non preoccupatevi se vi sembra eccessiva - dovete coprire bene ogni buco.


FOCACCIA GENOVESE CON LA CIPOLLA
La focaccia genovese con la cipolla è un’altra squisitezza della nostra città, una variante alla classica focaccia genovese che piace moltissimo anche ai “foresti”. Moltissimi turisti che arrivano a Genova per la prima volta e la scoprono, trovano la focaccia deliziosa, quando qualcuno se entra in confidenza con loro, gli dice che nella versione classica, possono accompagnarla al cappuccino e le facce stupite del turista medio sono sempre divertenti da osservare.
La ricetta della versione con la cipolla che vi presentiamo oggi in collaborazione con I Viaggi del Goloso è un’ altra golosa alternativa alla focaccia classica, una precisazione, la vera focaccia genovese è sottile, unta, con i bucherellini che invitano al morso senza esitazioni, tutte le altre chiamate “focacce” spesse, con bordi improponibili e frequentemente mal cotte, non hanno nulla a che vedere con la focaccia genovese.
LA RICETTA:
Focaccia genovese con la cipolla
Ingredienti:
300 gr. di farina 00
200 gr. di farina manitoba
25 gr. di lievito di birra
250 ml. di acqua
sale
olio d’oliva extravergine
2 grosse cipolle
Preparazione:
Mettiamo sul tavolo la farina 00, aggiungiamo il sale e sopra la farina manitoba, sciogliamo il lievito nell’acqua tiepida e incominciamo a impastare, quando l’impasto risulta amalgamato, lasciamo lievitare coperto per circa 1 ora. Nel frattempo puliamo le cipolle le affettiamo e le mettiamo a bagno in una ciotola con acqua.
Riprendiamo ora l’impasto lievitato e stendiamo la pasta con un mattarello della grandezza della teglia che andremo ad adoperare, ungiamo bene la teglia con l’olio, appoggiamo la pasta stesa, deve essere abbastanza sottile e la lasciamo nuovamente lievitare coperta per circa 1 ora.
Prepariamo ora un’emulsione di olio e acqua in parti uguali e andiamo a cospargere la superficie della focaccia premendo con le dita per formare i famosi buchi.
Scoliamo le cipolle dall’acqua, le condiamo con l’olio d’oliva mescolandole bene e cospargiamo tutta la superficie della focaccia, spolveriamo di sale e mettiamo in forno caldo a 220° per 15 minuti, poi proseguiamo sotto il grill per altri 5 minuti controllando. Sforniamo, lasciamo intiepidire e gustiamo questa prelibatezza …
Le tre fasi fotografiche: prima, durante e dopo la COTTURA



FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO
Ecco come si presenta…


Formaggio fuso al centro di due strati sottilissimi di pasta. Un gusto inconfondibile che l'ha resa celebre in tutto il mondo.
Cos’è la focaccia di Recco
Esistono parecchie versioni di focacce al formaggio, ma quella di Recco è sicuramente particolare, oltre ad essere la più conosciuta e celebrata. Quest’ultima è un prodotto da forno fatto con un impasto di farina di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, acqua e formaggio vaccino fresco a pasta molle. A differenza di altre versioni di focaccia al formaggio, quella di Recco è composta di due sottilissimi strati di pasta che racchiudono una farcitura di formaggio fuso, quasi liquido.
La sua forma può variare; potremo così incontrarne versioni tonde, quadrate o rettangolari ma il suo aspetto la rende comunque decisamente riconoscibile. Si presenta infatti particolarmente sottile, con una superficie irregolare punteggiata da bolle, striature marroni e dalla caratteristica fuoriuscita di formaggio. Il formaggio usato era storicamente la prescinseûa, un antico prodotto caseario ligure che, considerato poi troppo liquido e acido, venne sostituito con lo stracchino e la formaggetta. Con la classificazione, il 2 marzo 2012 (è stato riconosciuto dall’Unione Europea il 3 giungo 2013), tra i prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) è stato introdotto l’uso della crescenza di origine ligure, prodotta in valle Stura.


Come si fa - la ricetta originale della focaccia di Recco fatta in casa
La ricetta originale della focaccia di Recco non è affatto difficile da realizzare in casa anche perché si basa su ingredienti molto semplici da reperire e di base della tradizione culinaria italiana.
Ingredienti
- 500 g di farina 00 o Manitoba
- 50 ml olio EVO
- Acqua minerale naturale
- 1 kg di formaggio fresco (es. stracchino)
- sale
Preparazione della focaccia di Recco
1- Su un piano da lavoro di legno iniziare a lavorare insieme gli ingredienti (farina, acqua, olio evo e sale) fino ad ottenere un impasto omogeneo e leggermente colloso.
2- Lasciare a riposare per mezz’ora l’impasto a temperatura ambiente e sotto un panno leggero di cotone.
3- Dopo mezz’ora, prendere una metà dell’impasto realizzato e iniziare a lavorarla con le mani facendola ruotare fino ad ottenere una forma circolare di uno spessore di pochi millimetri (dovrà essere molto sottile, quasi trasparente ma senza buchi).
4- Ungere una teglia cilindrica della dimensione di 60 cm di olio EVO e adagiare la prima sfoglia realizzata sul fondo.
5- Tagliare a pezzetti il formaggio fresco e distribuirlo su tutta la superficie dell’impasto.
6- Prendere la seconda parte di pasta e fare la stessa cosa di prima realizzando una forma circolare.
7- Posizionare la nuova sfoglia sopra al formaggio e schiacciare con le dita i bordi in modo tale da uniformarli ed impedire al formaggio di fuoriuscire dai bordi in cottura.
8- Cospargere di olio EVO e bucherellare leggermente con le dita la superficie.
9- Infornare ad una temperatura elevata di 240°-320° per 4-8 minuti fino a che la superficie non sarà dorata.
Buon appetito! Una porzione di focaccia di Recco (circa 250 g) contiene circa 320 kcal.

Bibliografia:
- Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Focaccia di Recco col formaggio”
- Non di solo pane – La focaccia genovese
- Focaccia con la cipolla – Le ricette di VivaLaFocaccia
- Storia della focaccia di Recco. Consorzio Recco Gastronomia
- La storia della focaccia di Recco-Cultura
- Genova Golosa – Focaccia genovese
- Wikipedia - Focaccia classica di Genova - Focaccia alla genovese - Focaccia genovese.
CARLO GATTI
Rapallo, 13 Giugno 2018
FONS GEMINA - SAN MARTINO DI NOCETO - RAPALLO
FONS GEMINA – RAPALLO

L’ACQUA DI FONTE CI RICORDA LE APPARIZIONI DI MARIA VERGINE…
In molti poeti e scrittori di tutti i tempi aleggia, al di là di ogni dubbio, la suggestione e la malinconia di una devozione filiale per la Madonna, vista come lo Spirito dell’acqua simbolo di vita, Stella del mare, Regina del Cielo corredentrice del Verbo che dà la vita.
Quando appare, la Madonna non di rado lascia dietro di sé una fonte miracolosa. La più celebre è quella di Lourdes, naturalmente, ma ce ne sono di più antiche, come quella di Caravaggio, e di più moderne, come quella di Montichiari, Santuario di Maccio (Como), Madonna dello Splendore (Giulianova), Amore Misericordioso (Collevalenza), Marvicio nel cuore dell’Aspromonte, ma l’elenco sembra infinito perché esce dai confini nazionali per andare in Francia, Polonia, Russia ed oltremare.
LA FINE DELLA SETE NON È BERE A SAZIETÀ,
MA DIVENTARE FONTANA PER DISSETARE ALTRI,
FACENDOSI SORGENTE PER L'ALTRUI ARSURA.
LORENZO PIVA
"NON BISOGNA CHE CESSI LA PIOGGIA PER METTERCI IN CAMMINO. E' BELLO ANCHE BAGNARSI DI ERRORI E RIMPIANTI PUR DI ARRIVARE IN CIMA ALLA MONTAGNA DELLA VERITÀ"
(FONTE NON SPECIFICATA)
Il racconto sulla FONS GEMINA può soltanto iniziare il suo breve viaggio con il ricordo che tutti i rapallesi hanno nel cuore:
Nostra Signora di Montallegro
Dedichiamo la sintesi ai nostri numerosi followers stranieri.
Secondo la tradizione locale la Vergine apparve nel primo pomeriggio di venerdì 2 luglio 1557 al contadino Giovanni Chichizola, originario di San Giacomo di Canevale, frazione del comune fontanino di Coreglia Ligure, di ritorno dal mercato ortofrutticolo di Genova. Giunto nell'entroterra rapallese, nelle proprietà boschive della famiglia di fazione ghibellina Della Torre, all'altezza del monte Letho (conosciuto dai locali come "monte di morte" o "della morte" a causa delle numerose scorribande dei briganti), l'uomo - affaticato dal lungo viaggio a piedi e stremato dal caldo - si addormentò nei pressi di uno sperone di roccia.
All'improvviso, fu destato da un bagliore: al contadino apparve una "dama vestita d'azzurro e bianco e dall'aspetto grazioso e gentile", come testualmente riportò in seguito ai primi popolani e alle autorità civili e religiose accorsi sul monte. La donna pronunziò solo poche parole, che per la comunità cristiana rapallese risuonano ancora vive:
“Va’ e dì ai Rapallesi che io voglio essere onorata qui”

Il Santuario di N.S. di Montallegro
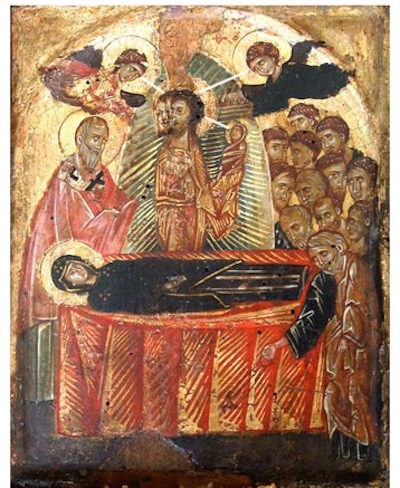
DORMITIO MARIA (Il TRANSITO di MARIA SANTISSIMA)
Per dar prova della "miracolosa apparizione", la Madonna lasciò in dono al contadino un quadretto di “arte bizantina” raffigurante la Dormitio Maria (il Transito di Maria Santissima), da donare alla comunità rapallese. Dopo l'improvvisa scomparsa della "Bella Signora", sulla stessa roccia in cui era avvenuta l'apparizione cominciò inoltre a sgorgare acqua fresca e pura.
FONS GEMINA
Un po’di storia…
Il Prof. Massimo Bacigalupo ce la racconta così:
“L’ultimo capitolo della prima edizione di Rapallo nei secoli (di Pietro Berri-1964, a cura del Comune di Rapallo) è il più ridente e ci porta a San Martino di Noceto alla scoperta della Fons Gémina, monumentino di cui nessuno sembra aveva trattato prima di Berri, il quale ce ne fornisce la storia e ne trascrive e traduce le dotte epigrafi. In realtà questo capitolo è il racconto di una gita lungo la rotabile che sale a Ruta passando per S. Maria, ed è animato da un entusiasmo che ci dice molto sulla personalità di Berri, uomo non facile alle esternazioni sentimentali, ma ben sicuro nei suoi gusti e nelle sue convinzioni, come fermo e autorevole nello stile. Eccolo invece per un attimo confessare fra le righe il suo amore per questa vallata e per la fonte sulla quale ha lasciato traccia un vecchio arciprete latinista, per il quale evidentemente egli prova la simpatia del compagno di studi a distanza di decenni. Inoltre Berri accetta l’ipotesi del Ferretto che nei pressi della fonte, nella Villa Granello, si trovasse un’antica pieve ospite della quale sarebbe morto il Vescovo Onorio fuggiasco da Milano, il giorno 23 febbraio del 570. 1400 e passa anni fa, altro che Rapallo nei secoli! San Martino è intitolata al guerriero e poi vescovo di Tours che proprio in Liguria nel IV secolo avrebbe diviso il mantello con un mendicante.

Camogli: Il mosaico simbolo della STELLA MARIS che guida e protegge i naviganti

Scopriamo che la frazione è sempre stata legata a Camogli per lo smercio dei prodotti agricoli e per la vocazione marinaresca degli abitanti, e che “i Camogliesi avevano ricambiato questa reciprocità di interessi e questa fraternità nell’aspro lavoro sulle tolde sbattute dalle onde, e, ai margini dell’antica via pedonale, occhieggiano tuttora tra il folto della vegetazione, le villette che i vecchi lupi di mare avevano fatto costruire sulle ombreggiate pendici”.
ALBUM FOTOGRAFICO



I due ruscelli gemelli a destra e sinistra s’incontrano formando un piccolo laghetto… la FONS GEMINA



Venendo da Rapallo in direzione Ruta di Camogli, la Cappelletta é situata a circa 300 metri dalla Chiesa di San Martino di Noceto.

Fonte Canala (Fons Gemina)
Nel territorio rapallese, oltre alla chiesa parrocchiale di San Martino di Noceto, è presente un'antica fonte denominata fons gémina realizzata nel 1810 così come testimonia una lapide marmorea in latino; nella nicchia sopra l'arco a sesto acuto è conservata una statuetta della Madonna Coronata di argentei gigli.
Fons Gemina significa, in latino, “fonte gemella” ed è una fonte che trae il nome dalla particolarità che da essa sgorgano due fonti distinte. Essa è, molto probabilmente, di origine romana e risale invece solo al 1810 la struttura a sesto acuto in cui è posta una statuetta marmorea della Madonna.
La fonte è sita a San Martino di Noceto, una frazione di Rapallo che in passato era ricca di noccioli e castagni, da cui dovrebbe derivare il nome “Noceto”.
UN APPUNTAMENTO:
Rapallo: “Fons Gemina”, Concerto alla Fonte a San Martino
Rapallo: “Fons Gemina”, Concerto alla Fonte a San Martino
Da Filippo Torre di “Fons Gemina” riceviamo e pubblichiamo:
A coronamento del suo sesto anno di attività, il Circolo Culturale “Fons Gemina” presenta un evento lungamente atteso e mai realizzato prima: il concerto presso il monumento di cui l’associazione porta il nome.
Nel 2012 i soci fondatori del circolo scelsero infatti la “Fonte Gemella” (“Fons Gemina”, in latino) di San Martino di Noceto per simboleggiare la propria aspirazione a rappresentare un sicuro punto di riferimento nell’ambito del tessuto culturale di Rapallo; nel corso degli anni l’associazione ha voluto quindi rappresentare per la città una vera e propria “sorgente di idee”, così come espresso dal proprio motto.
La Fons Gemina, uno dei monumenti meno noti di Rapallo, è nel contempo uno dei più antichi; esso si trova tra la chiesa millenaria di Ruta e quella di S. Martino di Noceto e il suo aspetto attuale è frutto di una ristrutturazione realizzata nel XVII secolo. La sua origine è tuttavia riconducibile al X secolo, periodo nel quale la fonte viene citata come “speciale” in quanto caratterizzata da due sorgenti perenni gemelle.
Ci è parso quindi che il Concerto alla Fonte fosse il modo migliore per suggellare un anno particolarmente ricco di eventi, incentrato come consuetudine sulla multidisciplinarietà delle proposte.
L’appuntamento, che si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, è fissato alle 17.00 di sabato 19 maggio. Ne sarà protagonista il quartetto d’archi composto da Alessandro Alexovits (violino I), Massimo Vivaldi (violino II), Simona Merlano (viola) e Paola Siragna (violoncello). Il repertorio, incentrato su composizioni di diverse epoche e stili, non mancherà di proporre alcuni dei brani più celebri della storia della Musica.
In caso di pioggia, il concerto si svolgerà presso l’attigua Chiesa Parrocchiale di S. Martino di Noceto.
Vi aspettiamo come sempre numerosi.

Chi scrive, dedicò nel 18.5.2011 un saggio sul sito di
MARE NOSTRUM RAPALLO:
Rapallo: SANTUARIO DI N.S.MONTALLEGRO: Navi, Marinai e la Devozione Mariana
CARLO GATTI
Rapallo, 16 Maggio 2018
LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…
LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…
TRA MITO e LEGGENDA
Dice che era un bell'uomo e veniva,
veniva dal mare... parlava un'altra lingua...
però sapeva amare … (Lucio Dalla)


LA MELORIA
Anche la farinata venne dal mare… un viaggio breve e fu portata da uomini “cazzuti” che sapevano amare anche la buona cucina!
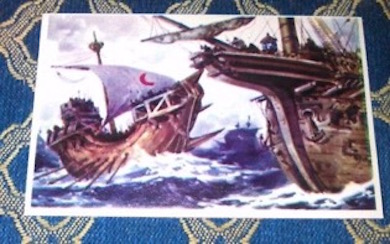
Una leggenda racconta che sia nata per pura casualità nel 1284, mentre infuriava la battaglia della Meloria che vide vittoriosa Genova su Pisa. Si racconta che le navi da guerra genovesi si trovarono coinvolte in una tempesta, ma é più probabile che la nave della farinata genovese sia stata colpita da un colpo di bombarda a pelo d’acqua… in direzione della cambusa. In ogni caso, si verificò una via d’acqua (termine marinaro che sta per falla) e alcuni barili d’olio e sacchi di ceci si rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata.
Ciutòsto che röba avanse, creppa pansa.
(Piuttosto che far avanzare del cibo, mangiamo tutto anche se poi stiamo male).
Non c’era alternativa: morire di fame oppure abbuffarsi su quelle provvidenziali scodelle di purea di ceci, olio e acqua di mare. A questo punto il destino volle che alcuni marinai, miga tanto abbelinae, optassero per una terza soluzione e lasciassero questo composto al sole che asciugandosi si sarebbe trasformata in una strana specie di frittella. Alla fame non si comanda e i marinai si convertirono a quella sconosciuta pietanza scoprendo una nuova ricetta che, per puro caso, diventò famosa a partire dal quel lontano 1284 fino ai giorni nostri.

Venditrice di farinata genovese (inizi ‘800)
Rientrati vittoriosi nei caroggi Genovesi senza sole…, i marinai provarono a cuocere quell’impasto nel forno a legna. Il risultato fu eccellente e venne chiamato “l’oro di Pisa” per deridere i nemici sconfitti…
Secondo un altro “ciaeto storico” (pettegolezzo):
la farinata affonda le sue radici addirittura nell’antica Roma quando le truppe romane occuparono Genova e dintorni.
A quel tempo la farina di grano era considerata un lusso e i soldati preparavano questa pizza rudimentale con un impasto di farina di ceci e acqua, che poi cuocevano al sole, utilizzando i propri scudi come “forni”.
Prendiamo quindi atto che la farinata di ceci (fainà in dialetto) ha navigato, a fasi alterne, per oltre duemila anni da un porto all’altro, anzi da un angiporto all’altro essendo un piatto “povero” ma estremamente gustoso e nutriente che i marinai in franchigia gustavano passando tra i piaceri di un lupanare e l’altro.
Liguria, Toscana e Piemonte sembrano essere le culle della farinata classica per altro conosciuta anche in altre regioni italiane, magari con delle varianti locali vendute come apprezzati street food.
C’è però chi sostiene che i natali di questa specialità non si debbano alla Superba, ma alla Toscana, precisamente a Pisa. La sconfitta dei pisani é dura ancora oggi da digerire… naturalmente noi ci scherziamo! Ma loro no!
Che la farinata non si faccia solo in Liguria è vero, poiché la si prepara anche sulla costa francese, più o meno nei dintorni di Nizza, dove viene chiamata socca. Ma non c’é da meravigliarsi, Nizza é stata genovese fino al 1860. Si può trovare anche nel basso Piemonte, dove é conosciuta come bela cada. Vi propongo una originale testimonianza della mia amica Marilena, torinese di nascita:
"Proprio alla torta verde, sempre reperibile nei forni e in qualche macelleria, è dedicata una festa in concomitanza della fiera del Santo Cristo, che a fine aprile fa rivivere le storiche usanze di Nizza. Dove le sagre sono l’occasione giusta pure per assaggiare la belecàuda, altrimenti acquistabile in alcuni panifici: non è altro che la farinata - con farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva - da cuocere in teglie di rame nel forno a legna e servire (come suggerisce il nome) “bella calda”. Esattamente come la serviva Tantì, che nel secolo scorso portava con una bicicletta a tre ruote la teglia con la farinata calda, un “tantì” indicava una porzione ed è diventato il soprannome del venditore ambulante."
Sulla costa della Toscana del nord viene chiamata cecina o torta di ceci.
Nel savonese la si fa anche con farina di grano tenero e viene chiamata farinata bianca.
Fatevi questa domanda: se la farinata si prepara in una regione e in tutte le zone ad essa confinanti, dove potrà essere nata? In attesa della vostra riflessione e di fonti storiche inoppugnabili, una cosa mi pare certa: ovunque sia nata, la farinata in Liguria è tradizione, territorio, cultura e appartenenza. Questo prodotto da forno viene eseguito in maniera eccelsa in tutta la Liguria, ma Genova è la sua città d’elezione.
Consegnata la farinata alla Storia di ieri … entriamo ora nella FARINATA di oggi e vediamo di capire qualcosa della sua “cosiddetta” semplicità la quale, come abbiamo visto, é intrisa di olio d’oliva e acqua salata, ma anche di tanti segreti mai confessati agli estranei della casta dei “sacerdoti” locali, i soli che possano tramandare la tradizione con riti di iniziazione di natura similmente religiosa …
Chissà se funziona ancora così? Ma di sicuro un tempo non lontano era proprio così!

CECI
Amedeo, quando andava per pagelli al largo di Rapallo, portava con sé un residuato bellico: la tanka di una Jeep Willys che riempiva di acqua di mare trasparente; la usava per l’impasto della farinata ma anche per fare il sale domestico, raro da reperire durante la guerra e nel primo dopoguerra.
Amedeo non era un “sacerdote”, ma le fisse per la farinata le aveva eccome … Si sentiva, per esempio, in competizione con il mitico fornâ (fornaio) Ö BANSIN della perla del Tigullio, verso il quale nutriva un complesso di superiorità …
Ogni tanto si partiva per il basso Piemonte, prima tappa Novi Ligure, provincia di Alessandria, dove si compravano i ceci a seme grosso: il cece di Merella, il migliore del mondo?!? Se li faceva macinare… e si proseguiva per Gavi Ligure; la seconda tappa era dovuta alla scorta di vino bianco che, a suo dire, era l’unico vino in grado di convolare a nozze con a fainà. Secondo la filosofia del suo tempo, questi ingredienti facevano la differenza tra le due benemerite categorie in gara: il professionisti sapienti e i dilettante trìsti e belinoin.
Era dura stargli dietro… ma la farinata che usciva da quel forno a legna, disastrato dalla guerra, mi ritorna regolarmente in sogno ancora oggi!

RICAPITOLIAMO
La ricetta della farinata di ceci (tradizione ligure) possiamo riassumerla così:
E’ una torta salata, preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio extra vergine d’oliva. La farinata (fainà) é una prelibatezza che viene cotta nel forno a legna, in teglia (testo di stagno ramato), da cui il caratteristico colore dorato che assume con la cottura.
Pochi ingredienti con tanti segreti??? Avviamo l’indagine!
300 gr di farina di ceci
1 litro d'acqua
5 cucchiai di olio extravergine di oliva
Sale quanto basta
LE VARIE FASI
Dosi
Semplicissime: il rapporto tra farina e acqua deve sempre essere di 1 a 3. Vale a dire che per ogni etto di farina di ceci servono tre etti di acqua. Non dimentichiamo il sale, nella misura di circa un grammo ogni etto di composto: se la somma tra acqua e farina è 400 grammi, saranno necessari circa 4 grammi di sale, o poco meno.
Teglia
Nelle farinaterie si usa una teglia apposita, il cosiddetto “testo”, una grande padella rotonda a bordi bassi in rame stagnato, disponibile anche in versione casalinga con un diametro di 30-32 cm.
Se non avete il testo, potrete rimediare con una teglia da forno a bordi bassi, preferibilmente rotonda. Se invece non siete puristi fanatici della tradizione ma mirate alla sostanza, la classica teglia rettangolare andrà comunque bene.
Impasto
Una volta muniti di teglia e ingredienti, è il momento di passare alla preparazione. Mettete la farina di ceci in un’ampia ciotola e cominciate ad aggiungere l’acqua a poco a poco, sempre girando con una frusta per non formare grumi.
Siete tipi da poche storie? Allora prendete un frullatore a immersione e frullate per qualche secondo: avrete un impasto liscio e vellutato in pochi secondi. Aggiungente quindi il sale.
Per un testo di circa 32 cm di diametro, corrispondente a una teglia rettangolare di cm 40 x 20, le dosi indicative sono di circa 130 grammi di farina, 390 di acqua e 5 grammi di sale.
Riposo
Una volta fatto il laborioso impasto, bisogna farlo riposare, almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.
Durante il riposo, si formerà una sorta di schiuma in superficie: levatela con un cucchiaio, altrimenti brucerà durante la cottura.
Ci siamo quasi
Impasto pronto, riposo effettuato, forno caldo, anzi caldissimo. Non rimane che infornare. Non prima, però, di aver unto la teglia con un generoso strato di olio, dello spessore di circa due millimetri.
Girate bene l’impasto della farinata e rovesciatelo sulla teglia, allo spessore di circa un centimetro o poco più. Girate il tutto leggermente con un cucchiaio di modo da mescolare l’olio della teglia con l’impasto appena rovesciato. Se vi piace, aggiungete qualche ago di rosmarino.
Cottura
Non resta che aspettare: 10-13 minuti in genere sono sufficienti, ma ovviamente il tempo dipende dalla temperatura raggiunta dal vostro forno. Tenete presente che la farinata è pronta quando assume la classica colorazione dorata in superficie. E soprattutto, che non deve essere eccessivamente cotta, ma presentare l’interno ancora morbido e cremoso, e non asciutto e stopposo.
Sfornate e spolverizzate infine con pepe fresco, macinato al momento.
Il Vino
Con la farinata – a base di farina di ceci, olio, sale e pepe, cotta nel forno a legna ben si abbina il Coronata Val Polcevera, vino bianco sapido e fresco.
I consigli del nonno:
Ungi bene la teglia, cala la broda, metti l'olio, batti il fondo e inforna caldo-caldo.
Quando sopra si forma una crosta semidura (croccante) é pronta! Senza muovere la teglia, deve essere ben in piano quando cuoce, altrimenti resteranno zone crude e zone troppo cotte.
Preferiscila appena sfornata, praticamente ustionante e con una spolverata di pepe.
ALCUNI APPROFONDIMENTI NELLA PREPARAZIONE DELLA FARINATA.
LA PAROLA AGLI ESPERTI DI OGGI
"Io faccio la farinata da 17 anni e impasto tutti giorni 25 chili di ceci!"
I requisiti sono: morbida dentro e crespolosa in superfice.
La temperatura del forno deve essere da 300 a 350 gradi.
Il forno dove lavoro e profondo 240 cm. le teglie (testi) sono di 80 cm di diametro. Quindi ne posso infornare anche tre a temperature più alte.
Lo spessore della farinata deve essere 1 cm, poi dipende dai gusti se piace secca o morbida
ALCUNI TRUCCHI

Nelle nostre farinaterie, a seconda dell’area geografica, i legni più adoperati sono il faggio e la quercia. Talvolta il càrpino, ma questo è un prodotto che potremmo definire di scappatoia.

Faggio segato con corteccia
Diversi tipi di legno da usare nel forno a legna

Faggio
· FAGGIO: +fiamma / -brace. Ottimo rapporto qualità prezzo

Quercia
· QUERCIA: +brace / - fiamma. Fa una bella fiamma all’inizio poi lentamente si abbassa e trasforma in brace. La brace mantiene il calore a lungo.
· ULIVO: +brace +fiamma. Introvabile molto raro e caro.
· CARPINO Alternativa a basso costo al legno di quercia.
LEGNA DA NON USARE: Pioppo e Castagno perché scoppiettano, pezzetti di braci ardenti potrebbero finire sulla farinata durante la cottura, questa è legna da camino.
ABETE, PINO E RESINOSE contengono resine tossiche, inoltre trasferiscono odori estranei ai prodotti in cottura.
- È meglio adoperare legno italiano e se possibile con origine certificata, meglio ancora se fornita in un sistema di autocontrollo.
- Se serve fiamma molto vivace la legna di faggio va preferita a quella di quercia.
- Viceversa se occorre una brace più longeva e una fiamma meno incisiva l’ideale è la quercia;
- Prediligere legni stagionati almeno 8 mesi.
Il potere calorico del faggio a zero umidità è pari a 4.456 kcal/kg ma:
- 15% di umidità 3700 kcal/kg;
- 30% di umidità 2940 kcal/kg;
- 50% di umidità 1930 kcal/kg;
Carlo GATTI
Rapallo, Mercoledì 9 Maggio 2018
O LEUDO - Fiorenzo Toso
O LEUDO
di
(Fiorenzo Toso)
Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì son stæto mainâ. Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì ò visto de tære lontañe, de dònne mäveggiose, e delongo m'assunnavo quelle træ fasce d'oivi derê a-a casa, che a mæ moggê scua e stondäia a mandava avanti quande mi navegavo.
Mæ poæ o m'à mostrou comme se deve scigoâ pe ciammâ o vento quande gh'é bonassa, e comme s'à da pregâ pe tegnî lontan e dragoñe, e coe de vento.
Oua che son chì, vegio, desnavegou, e che a mæ dònna a l'é mòrta, e e fasce di oivi son in zerbo, oua che i mæ figgi no navegan, ma tëgnan i stabilimenti da bagni pe-a demoa di foresti, oua che i mæ nëi parlan unna lengua che no capiscio, a coæ do mâ ghe l'ò delongo into sangue, a me s'inscia drento tutte e vòtte che vaggo à giandonâ in sciâ mæña, co-i atri dötræ da mæ etæ che se rebellan ancon pe-i caroggi do paise.
A-i nòstri tempi s'andava à veia. I capitagni braggivan i comandi in bon zeneise, giastemmando San Pê, e i peneixi portavan l'anelletta à l'oegia. S'arrivava à un pòrto e subito s'andava à beive pe scordâ e træ fasce e a moggê stondäia, ma intanto l'indoman l'ea pægio, e no gh'ea ninte da fâ. Unna vòtta, à Scingapore, mi e un de Carlofòrte emmo provou à fummâ l'eubbio, no ve diggo, paiva d'ëse in sce unna nuvia. N'an attrovou a-a mattin int'un caroggetto, sensa unna palanca, mezi nui e con un mâ de testa da scciuppâ. O capitagno, un de Camoggi, o ne l'aiva dito de no stâse à fiâ di cineixi, che son de gente gramme. Na che no son de gente gramme, no son miga pezo di atri. O l'é de naätri mæximi che no se doveivimo fiâ.
Pan cöse lontañe, e intanto pâ vëi... A-o Cao d'Orno, unna vòtta, mi e un compagno emmo visto unna dònna pescio. Segùo, a pâ unna föa, ma intanto mi l'ò vista, a l'ea nùa, de d'ato a l'ea pægia à unna dònna e de sotta a l'aiva a coa verde, co-e scagge e tutto.
Dixan che i mainæ, de stâ delongo pe mâ, no capiscian ciù ninte, veddan de cöse che no ghe son, se imaginan de istöie. O giorno dòppo, a borrasca a n'à streppou a veia grande, e quello mæ compagno lì o l'é cheito in mâ. Mi diggo ch'a l'é stæta a dònna pescio ch'a l'à vosciuo con lê. Ò insomma, l'é megio credde coscì, che pensâ ch'o segge mòrto apreuvo à un corpo de vento. Unna föa. E a saià ben unna föa, ma quante vòtte, inte quelli giorni, no me ghe saieiva bollou mi ascì in mâ, sensa quella föa?
À Bonnesaire andavimo delongo à mangiâ da un do paise ch'o l'aiva unn'ostaia donde favan o pesto, o menestron e a fainâ co-a säçissa. Mangiavimo, beveivimo, e in sciâ fin se metteivimo à cantâ e pagavimo coscì, à son de tralalleri, e i zeneixi de lazzù vegnivan à sentîne fin d'in fondo a-a Pampa.
Regòrdi. Ma no se peu vive solo de regòrdi. Oua mi, o Ciomê e o Dria emmo attrovou un leudo abbandonou into cantê do sciô Tasciæa, quello ch'an da cacciâ zu pe fâghe un atro stabilimento da bagni.
O l'é un bello leudo, ma dev'ëse ciù de vint'anni ch'o l'é lì, da quande o cantê o l'à fæto baracca: beseugnieiva cangiâghe o fasciamme, l'erboo meistro o l'é inte tanti tòcchi e o cöpresso se l'an portòu via. Emmo attrovou fiña e veie, ma son meze mangiæ da-i ratti. Seguo, à repessâle comme se deve, dovieivan ancon tegnî o vento.
Gh'emmo pensou, mi co-i atri doî. À dâghe recatto, o se porrieiva mette in mâ de lengê. O l'à unna bella armatua, nervosa, o l'à di scianchi comme unna figgia à sezz'anni. O n'asbrivieiva fin à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resäto. Ma niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Vernassa, dove o Dria o gh'à di pænti, a-a Bordighea, donde gh'é un mæ amigo, quello ch'o parlava co-i draffin e ch'o sunnava a tromba de succa. S'o l'é ancon vivo.
D'arescoso da-i figgi, tutti e trei emmo levou i dinæ d'in banca. Pöca cösa. Quello ch'aivimo guägno o l'é partio tutto, tòsto tutto, pe tiâ sciù a famiggia, pe dâghe da mangiâ, pe fâli studdiâ. E niatri lonten, à Caracas, à Hong Kong, à San Francisco, tanto che no an fæto in tempo à conoscine, i nòstri figgi.
O sciô Tasciæa o leudo o ne l'à regallou. O l'é mezo feua de testa, meschinetto, ma o l'à capio pægio: lê ascì o l'à navegou, o l'é stæto capitagno. Pöi o l'à averto o cantê e o s'é misso à fâ e barcasse pe-o pòrto de Zena, into momento che e barcasse no servivan ciù à ninte. Sò moggê co-o figgeu a se n'é anæta con un milaneise, un ch'o l'à un abergo à Sanremmo, e lê o l'é arrestou mezo alloou, o no s'é mai ciù repiggiou: oua o l'à tòsto novant'anni. Sò figgio o l'é cresciuo, o l'é vegnuo a-o paise l'anno passou e o gh'à fæto firmâ di papê. Coscì caccian zu quello che resta do cantê e ghe mettan di atri bagni, Bagni Paradiso, Bagni Sole e Mare, chi ô sa.
Co-i dinæ ch'emmo levou d'in banca cattiemo e cöse che serve pe dâ recatto a-o leudo. Beseugna trovâ i erboi – emmo zà parlòu co-o bancâ do caroggio drito, ch'o l'é stæto meistro d'ascia –, sarsî e veie, cartezzâ, vernixâ, desentegâ i ratti.
No finiemo sens'atro avanti d'ëse mòrti, mi, o Ciomê e o Dria. E se mai fescimo in tempo, no aviëscimo sens'atro ciù a fòrsa nì o bon d'avaâ o barco, de fâlo navegâ, de stâ apreuvo a-a rotta.
Ma de regòrdi solo no se peu vive. De föe, de seunni manco. E sto leudo o no l'é un seunno, o l'é bon legno saxonou, che à dâghe recatto o n'asbrivieiva à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resato. E niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Nöi, dove o Ciomê o l'à di amixi, a-o Tellâ, dove gh'é quello mæ coxin, quello ch'o l'addomestega i öchin e ch'o tia de cotello comme un singao. S'o l'é ancon vivo.
Alessandra Cutrì intervista Fiorenzo Toso
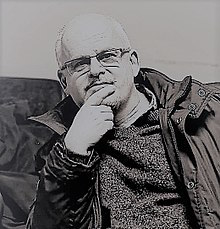
Docente di Linguistica generale presso l’Università di Sassari, Fiorenzo Toso è linguista e dialettologo specialista dell’area ligure, redattore principale del Vocabolario delle Parlate Liguri (1985-1992, 4 voll.) e autore della Letteratura genovese e ligure (1989-1991, 6 voll.), del volume Gli ispanismi nei dialetti liguri (1993), della Storia linguistica della Liguria (1995), della Grammatica del genoveseDizionario etimologico storico tabarchino (2004) e della Grammatica del tabarchinoXeneises. La presenza linguistica ligure in America Meridionale (2006), de La letteratura ligure in genovese e nei dialetti locali. Profilo storico e antologia (2009, 7 voll.), del Piccolo dizionario etimologico ligure (2015), per citare solo alcuni lavori maggiori. Fra le altre cose, si occupa anche di plurilinguismo (Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente, 2006), di fenomeni di insularità e di contatto linguistico (Linguistica di aree laterali ed estreme. Contatto, interferenza, colonie linguistiche e «isole» culturali nel Mediterraneo occidentale, 2008), di minoranze linguistiche (Le minoranze linguistiche in Italia, 2008; La Sardegna che non parla sardo. Profilo storico e linguistico delle varietà alloglotte. Gallurese, Sassarese, Maddalenino, Algherese, Tabarchino, 2012) e di etimologia (Parole e viaggio. Itinerari nel lessico italiano tra etimologia e storia, 2015). (1997), del (2005), del volume
A oltre 150 anni dalla nascita dello Stato italiano i dialetti stanno perdendo terreno a causa di cambiamenti politici ed economico-sociali che hanno portato all’emergere della lingua italiana mentre, a livello globale, si assiste parimenti al “trionfo” dell’inglese. L’aumentata mobilità delle persone, la diffusione di internet e la maggiore istruzione nell’epoca della globalizzazione portano spesso i parlanti ad allontanarsi dalle lingue originarie (in particolare dai dialetti) e ad “appiattire” le loro potenzialità comunicative nell’uso di un unico idioma dotato di maggior prestigio; si tratta, forse, di una tendenza ciclica e storicamente inevitabile. Mettere in atto misure di tutela dei dialetti è possibile e necessario? Potrebbe rivelarsi un’azione forzata, antistorica e regionalistica?
Ho iniziato a occuparmi del patrimonio linguistico ligure nel 1976, quando avevo circa 15 anni, raccogliendo le parole del genovese parlato al mio paese d’origine per quello che sarebbe diventato il Vocabolario delle parlate liguri, di cui divenni in seguito redattore. Ricordo il titolo di un articolo di Manlio Cortelazzo su una rivista locale, a sostegno dell’iniziativa: “Un’impresa urgente: salvare i dialetti”. Infatti, a quell’epoca, i linguisti e i sociologi – nel quadro di una certa temperie culturale – preconizzavano la scomparsa nel giro di pochi anni delle parlate locali. Siamo al 2017, e per quanto mi riguarda ho ancora molte occasioni di trascorrere ore discorrendo in genovese con persone di ogni età, genere, formazione e livello culturale. Attenzione, questo non significa che non ci sia una crisi – di uso, di funzionalità, di “immagine” se vogliamo – delle parlate locali, ma mi sento anche di dire che fare della sprachprognostik sui processi di obsolescenza linguistica non è facile, e che occorre essere molto prudenti nella valutazione dei fattori che possono contribuire a generarla. L’informatica, ad esempio: avrà pure contribuito a espandere lo spazio dei codici standardizzati di più larga diffusione – dalle lingue nazionali all’onnipresente inglese – ma è anche un veicolo potente e democratico di diffusione per qualsiasi altra lingua o dialetto. Oggi, attraverso i social, i siti dedicati ecc., un testo, un video, una trasmissione in una lingua di minor diffusione possono arrivare a un pubblico ampio, e con costi limitati. Più in generale: in giro, e per tanti motivi che sarebbe ozioso ripetere, c’è evidentemente una “domanda” di territorialità linguistica, che si manifesta in varie forme, dall’enfatizzazione della componente diatopica nell’uso dell’italiano a fini connotanti (è tutto un fiorire di comici con inflessioni locali, di insegne, denominazioni di prodotti, magliette che riportano parole “tipiche”, ecc.) fino a diverse forme e proposte di “recupero” di tradizioni linguistiche più genuine. Riguardo a quest’ultimo aspetto, i problemi che si pongono sono decisamente complessi. Anzitutto, rifacendomi alla domanda, in linea di principio eviterei di associare sempre e comunque un’eventuale prospettiva antistorica (e le relative forzature) alle manifestazioni in sé di una impostazione “regionalistica”. Comunque la si pensi, il regionalismo non è necessariamente antistorico, è un rispettabile atteggiamento politico e amministrativo, e il dibattito relativo riguarda in generale, attraverso letture complesse e dalle più svariate prospettive ideologiche, le diverse società occidentali. Ciò vale anche sotto l’aspetto dei patrimoni linguistici: persino un paese di grandi tradizioni centralistiche come la Francia parla oggi di “langues de France” come concetto esteso alle varianti dialettali (picard, champenois, gallo…), promuovendone anche lo studio accademico per singole realtà (cosa che in Italia ad esempio non viene fatta, raccogliendo questo tipo di interessi sotto la generica formula della “Dialettologia italiana”); e che nella corretta gestione del patrimonio storico-culturale dei territori siano anche implicati, quando ci sono, gli elementi di originalità linguistica, non mi pare di per sé un fatto scandaloso o eversivo. Di recente ho curato a Genova una mostra storico-documentaria sul genovese, che ha riscosso un notevole interesse di pubblico e di critica e ha contribuito, credo, ad avviare la riflessione anche su alcuni dei temi che stiamo discutendo. Bene, l’unica contestazione, del tutto fuori luogo e come tale generalmente percepita, è stata quella di uno storico della lingua e accademico della Crusca che ha trovato da ridire sul sottotitolo della manifestazione (Il genovese. Storia di una lingua), considerandolo lesivo del prestigio dell’italiano e… potenziale veicolo di promozione di un bilinguismo inglese-dialetto ai danni della lingua nazionale! Rendiamoci conto che se il livello di riflessione su questi temi rimane ancorato a queste forme di strumentalizzazione e di provincialismo reazionario, sarà sempre problematico impostare una riflessione seria sul tema della pluralità linguistica di un paese in cui, oltre tutto, le forme del multilinguismo vanno continuamente riformulandosi. Ammettiamo piuttosto che in Italia l’interesse per questi temi è stato cavalcato più facilmente da una certa area politica: ma aggiungiamo anche che un certo atteggiamento intellettuale, che riflette anche la difficoltà della cultura nazionale a convivere col “problema” del proprio policentrismo, ha fatto di tutto per consegnare, legato mani e piedi, il tema della regionalità (non solo linguistica) a quel contesto politico. Quanto al fatto se sia necessario o meno, e in che misura possibile, “tutelare i dialetti”, anche qui la risposta è per forza di cose articolata. Necessario: se si ammette che le forme della diversità linguistica sono un bene culturale e un elemento di ricchezza (non soltanto in termini espressivi o connotanti: penso anche ai vantaggi cognitivi del bi- e plurilinguismo ad esempio), la risposta dovrebbe essere implicita. Trovo però tremendamente ipocrita che nel momento in cui si formulano opinioni del tipo “il dialetto è una ricchezza, una risorsa” e così via, non si ammetta l’opportunità, almeno in astratto, di promuoverne la conservazione come si fa per qualsiasi altra risorsa, naturale, monumentale, culturale e così via. Possibile: la pianificazione linguistica ha cessato da tempo di essere un’opinione, è a tutti gli effetti una rispettabile branca della linguistica: di impossibile, in sé, non c’è nulla. Il punto è semmai un altro, nel momento in cui si manifesti una volontà condivisa e diffusa di approdare a questa tutela (cosa che del resto non è né scontata, né attuale): si tratterebbe di verificare i tempi, i modi e gli obiettivi, e di capire anzitutto cosa può significare la “tutela del dialetto”. L’uso parlato, che è anzitutto legato alle scelte e alla consapevolezza dei locutori? La sua rappresentazione identitaria, che di per sé è un guscio vuoto in mancanza di una pratica diffusa? La memoria storica attraverso la promozione degli studi, che è in ogni caso propedeutica allo sviluppo di qualsiasi altra iniziativa? Insomma, la risposta è aperta.
A che punto è la politica sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia? A quante lingue si può applicare e cosa resta ancora da fare? Su quali basi una lingua è definita “minoritaria” e quindi da tutelare? Penso, ad esempio, al caso del brigasco.
Con questa domanda ci riallacciamo ad alcuni dei temi sfiorati nella risposta precedente: il disagio tutto italiano per le problematiche del plurilinguismo e del policentrismo, che rappresentano da sempre altrettanti elementi costitutivi della realtà culturale del paese, si è manifestato in maniera particolarmente evidente proprio attraverso il fallimento della politica di tutela delle minoranze linguistiche. Prevista dalla Costituzione, raccomandata dalle istituzioni europee, essa riguardava storicamente, dal dopoguerra, le sole minoranze “nazionali”, ossia quei gruppi di popolazione che percepiscono la propria alterità linguistica in rapporto a un diverso senso di appartenenza culturale e nazionale, per di più sancito da accordi interstatali: i sudtirolesi (ed estensivamente i ladini della provincia di Bolzano), i valdostani, gli sloveni delle province di Trieste e di Gorizia. La legge 482 del 1999 è giunta con un clamoroso ritardo a “tutelare” un gruppo di altre “lingue” (ma più correttamente si sarebbe dovuto parlare di tutela dei parlanti, e dei loro diritti linguistici), scelte in base al criterio della distanza “genetica” dall’italiano, e senza tener conto delle implicazioni sociolinguistiche relative a ciascuna di esse. Da un lato quindi si è effettuata una selezione quanto meno arbitraria all’interno del panorama linguistico nazionale (friulano sì, veneto no; algherese sì, tabarchino no), dall’altra si è deciso, ad esempio, che minuscole comunità di parlanti dialetti germanici, ellenici o albanesi andassero in linea di principio “tutelate” alla stessa stregua e con le stesse modalità della compatta maggioranza etnica altoatesina, presso la quale la coufficialità con l’italiano riguarda una lingua di solidissime tradizioni culturali e amministrative. Questa idea di creare lingue a tavolino non è molto diversa dalle ipotesi – magari bollate come reazionarie ed eversive – di chi propone di standardizzare una “lingua piemontese” o una “lingua napoletana”, ma ha significato mettere a posto la coscienza delle istituzioni statali, ossificando un panorama linguistico in larga parte impreparato a tutto questo, e aprendo nei casi più controversi ulteriori elementi di disagio: l’urgenza di disporre di una lingua sarda o di una lingua occitana è diventata così l’alibi per forzare processi gestiti spesso e volentieri da minoranze attive ed élite politico-culturali, a discapito della volontà dei parlanti e di un sereno confronto sul opzioni possibili; al contempo, la gestione delle relative risorse (peraltro in progressivo calo nel corso degli anni) è diventata spesso e volentieri appannaggio di quanti, di tali processi, si sono fatti proponenti ed artefici. D’altro canto, queste forme di “ufficializzazione” non hanno dato, come del resto era logico aspettarsi, risultati concreti in termini di inversione del trend negativo che caratterizza l’uso delle lingue ammesse a tutela; per di più, isolate dal contesto plurilingue di cui sono storicamente parte, esse hanno finito per essere percepite come feticci identitari prima che come strumenti di comunicazione, restando quest’ultima prerogativa affidata all’italiano o ad altri idiomi concorrenti: nelle valli del Piemonte occidentale ad esempio, il carattere “occitano” dei dialetti locali viene molto rappresentato, a fini prevalentemente turistico-commerciali e latamente politici, ma la gente continua a usare prevalentemente l’italiano o il piemontese, e altrove non pare proprio probabile che il finanziamento di questa o quell’iniziativa didattica o amministrativa, per quanto volenterosa, farà nel tempo recuperare locutori al dialetto walser di Formazza o alla parlata albanese di Villa Badessa. Mancando, inoltre, una qualsiasi forma di vigilanza sui processi di riconoscimento e auto-riconoscimento delle comunità (meglio, delle amministrazioni) che intendevano dichiarare la presenza sul loro territorio della lingua minoritaria, si è verificata una vera e propria corsa all’auto-certificazione, dagli esiti a dir poco grotteschi. Per fruire di possibili finanziamenti, decine di comuni di solide tradizioni dialettali piemontesi, calabresi, venete e così via si sono dichiarate di volta in volta “occitane”, “grecofone”, “germanofone” o “ladinofone”, col risultato di sovvertire gravemente, anche in termini percettivi, il panorama linguistico locale: dai comuni dell’Isola d’Ischia che hanno cercato di farsi passare per centri di lingua tedesca (sembra una battuta di Totò, e invece non lo è) al caso appunto del brigasco, un dialetto inequivocabilmente e riconoscibilmente ligure, come tale noto al mondo degli studiosi (oltre che nella tradizione locale), ma scandalosamente “promosso” dal giorno alla notte al rango di varietà “occitana”. Questo caso in particolare, proprio per le reazioni che ha suscitato nel pubblico e tra gli studiosi, è forse l’esempio più tristemente noto (ma tutt’altro che isolato) dei fenomeni di malcostume amministrativo connessi con la 482. A quasi vent’anni dalla sua approvazione, quindi, questa legge per molti aspetti scandalosa andrebbe profondamente modificata – come opzione minima – o, preferibilmente, sostituita con provvedimenti nella cui formulazione siano coinvolti linguisti e giuristi competenti, che chiariscano anzitutto cosa si debba intendere per “tutela”, tenendo conto della varietà delle situazioni coinvolte (e di quelle rimaste fuori, spesso in maniera palesemente discriminatoria, dall’ammissione ai benefici di legge), del contesto interlinguistico complessivo in cui si manifesta l’alloglossia, e di altri parametri a vario titolo decisivi per una corretta applicazione di una “politica” linguistica che guardi anche alle più aggiornate esperienze internazionali in materia.
Fra le lingue minoritarie parlate sul suolo italiano vi è il tabarchino, idioma presente a Calasetta e Carloforte, in Sardegna, e nato dal genovese in epoca tardo-medievale per necessità di comunicazione legate agli scambi commerciali sulle sponde del Mediterraneo. Quale altra lingua ha contribuito alla formazione del tabarchino e quanto esso si è differenziato nel tempo rispetto al genovese moderno? Esistono isole genovesi al di fuori dell’Italia oggi?
Il caso del tabarchino è per l’appunto rappresentativo dei deficit e degli insuccessi della legislazione in materia di minoranze linguistiche. Tipico e riconosciuto esempio di eteroglossia, caratterizzato da percentuali d’uso della varietà locale che sono tra le più alte in assoluto in Italia, il tabarchino è stato oscenamente “dimenticato” nell’elencazione delle varietà ammesse a tutela perché considerato la variante di un “dialetto italiano” qual è il genovese. Le perplessità dei linguisti e dei giuristi, che hanno prodotto una ormai ricca letteratura in proposito, non sono valse finora a fare approvare i diversi emendamenti con i quali si è cercato di rimediare a questa incresciosa situazione, che vede anche il paradosso di due soli comuni in tutta la Sardegna privi di una qualche forma di valorizzazione del loro patrimonio linguistico (essendo il sardo e il catalano di Alghero ammessi a tutela), per quanto il tabarchino sia poi correttamente menzionato dalla legislazione regionale. Le comunità tabarchine attuano peraltro da anni forme efficaci di auto-tutela, che ne fanno anzi un modello rappresentativo di difesa “dal basso” della specificità linguistico-culturale locale: tuttavia, la mancata copertura legislativa, oltre a impedire l’accesso ad adeguate risorse, rappresenta una palese e inaccettabile discriminazione, ai limiti dell’incostituzionalità, una volta che nel bene o nel male la categoria degli idiomi ammessi a tutela preveda, tra i criteri di “selezione”, le prerogative dell’insularità linguistica. D’altro canto il tabarchino rappresenta in termini culturali una varietà riconoscibilmente “altra” anche rispetto al genovese, essendo il portato di un processo di immigrazione in Sardegna verificatosi nel corso del sec. XVIII a partire dagli stabilimenti liguri in Tunisia, risalenti a loro volta al Cinquecento. Le vicende per certi aspetti romanzesche della diaspora dei tabarchini dalla loro sede originaria su un isolotto al largo della costa africana, fanno del loro idioma un caso pressoché unico di conservazione e attualizzazione di una parlata che, dopo aver goduto nel tempo di prerogative importanti anche in termini comunicativi internazionali (come varietà dell’uso commerciale tra europei e tunisini) continua a esercitare oggi una funzione essenziale di riconoscimento collettivo all’interno delle comunità presso le quali la è diffusa. Vero è peraltro, che, proprio per la sua antica funzione di lingua commerciale, ancora vitale in Tunisia durante tutto l’Ottocento, il tabarchino non si è differenziato molto dal genovese, continuando fino a tempi relativamente recenti ad aggiornare i propri esiti fonetici, morfologici, sintattici e lessicali alla varietà metropolitana. Quel che fa del tabarchino una lingua a sé rispetto al ligure continentale sono quindi le peculiarità ambientali e culturali, tra Africa, Spagna e Sardegna, che hanno determinato il suo indissolubile legame con una cultura “altra”, meticcia, frutto di apporti molteplici e complessi, ben riconoscibile nel contesto sardo e italiano per le proprie peculiarità, tanto che l’eredità storica tabarchina è oggi candidata ad assumere il ruolo di patrimonio immateriale dell’umanità secondo la classificazione dell’UNESCO. Diverso è il caso di altre varietà liguri “trapiantate” fuori dall’area d’origine, come il bonifacino della Corsica meridionale, che rappresenta uno stadio prossimo al genovese duecentesco, o il monegasco, che è oggi la lingua nazionale del Principato di Monaco, frutto di un’immigrazione dalla Riviera di Ponente verificatasi durante il Trecento. Sono questi gli scampoli di quella che fu una presenza linguistica distribuita lungo le coste mediterranee e del Mar Nero nel corso della secolare esperienza mercantile dei genovesi, una presenza ben attestata sia dalla documentazione scritta (trattati politici e commerciali, atti legislativi ecc.), sia dalle sopravvivenze, soprattutto lessicali, di elementi liguri in diverse lingue e dialetti di quest’area estesissima: dal neoellenico dell’isola di Chio (la Scio dei Genovesi) allo yanito di Gibilterra (una varietà andalusa di contatto con l’inglese, in cui gli affioramenti lessicali liguri sono dati dalla presenza di una forte componente ligure sul territorio della colonia britannica); dai dialetti urbani della Corsica a quel che resta del figoun trapiantato in Provenza nel corso del sec. XV. Né va dimenticata l’esistenza di una componente ligure importante nel lessico dello spagnolo popolare rioplatense, il cosiddetto lunfardo, come risultato di un’immigrazione in America Latina che ha lasciato tracce di un uso comunitario del genovese, in parte ancora vitali, soprattutto sul versante pacifico del subcontinente.
La diffusione dell’inglese a livello internazionale ha reso questo idioma lingua veicolare moderna; nel periodo dell’Alto Medioevo, però, e per tutta l’età moderna, alcuni volgari italiani (come già visto, ad esempio, il genovese) e in seguito l’italiano e lo spagnolo, furono il codice privilegiato di comunicazione nei porti del Mediterraneo, spesso in forma di lingua franca, una sorta di pidgin fatto di elementi provenienti dalle diverse parlate delle popolazioni che entravano in contatto. Quali sono le nostre conoscenze su questa lingua franca, quali le fonti e le testimonianze? Quale fu l’apporto a questa lingua franca dell’arabo e del turco?
La lingua franca mediterranea è quello che si potrebbe definire un autentico phantôme terminologique, nel senso che al concetto tutto sommato ben definito che vi si accompagna (in estrema sintesi, un idioma semplificato destinato alla comunicazione interetnica tra popolazioni che parlano lingue geneticamente distanti) non si accompagna in realtà una documentazione storica sufficiente a confermarne la tipologia e persino la stessa esistenza storica. Anche il nome di questo “oggetto” risulta sfuggente da un punto di vista semantico (lingua dei “franchi”, ossia degli occidentali, o lingua “franca” in quanto scorrevole, semplice? o tutte e due le cose?), e ricompare in situazioni e contesti storici diversi, dall’Adriatico all’Africa settentrionale in età moderna, in maniera assai più labile in Oriente durante il medioevo, poi in Grecia tra Ottocento e Novecento, lasciando intendere che sotto la denominazione di “lingua franca” si celino in realtà forme di espressione assai differenti tra loro. D’altronde, le fonti che lo descrivono come un “italiano parlato male” utilizzano una formula che, oltre ad essere generica, viene parimenti utilizzata per indicare diversi idiomi italoromanzi utilizzati come lingue commerciali e coloniali (ad esempio, per un viaggiatore francese del Cinquecento, è “un italien corrompu” il genovese di Chio), mentre gran parte delle (presunte) attestazioni dirette di questo idioma, frutto in realtà di elaborazioni letterarie (da Molière a Goldoni) ripetono costantemente una fraseologia stereotipata, fatta di verbi all’infinito, di formule di cortesia e poco più. Elementi morfosintattici attribuibili a una modalità pidginizzante mancano invece nella documentazione riconducibile a situazioni di effettivo contatto tra parlanti le diverse lingue neolatine e varietà semitiche, come le lettere di schiavi europei ai tempi della corsa barbaresca, o la documentazione relativa a Tabarca, l’unica stabile comunità “europea” sulle coste dell’Africa settentrionale. La mia impressione quindi – ma è soltanto un’impressione sia chiaro – è che il concetto di lingua franca celi una realtà tanto complessa quanto difficilmente definibile, in cui potevano integrarsi di volta in volta l’uso interetnico di vere e proprie varietà romanze (come quello del genovese in Tunisia, ben documentato tra Quattrocento e Ottocento), modalità rudimentali di apprendimento dell’italiano da parte di arabofoni o turcofoni, forme di comunicazione basate sulla commistione di codice e sull’interferenza tra diversi idiomi romanzi, e così via. Non parlerei quindi di una vera e propria “lingua” nel senso di varietà riconoscibile e riconosciuta rispetto ad altri idiomi geneticamente affini, e neppure di un pidgin stabilizzato, quanto di un insieme di modalità di comunicazione, caratteristiche soprattutto, nel periodo che va dalla seconda metà del Cinquecento alla prima metà dell’Ottocento, dell’incontro e del confronto verificatosi nel panorama politico-culturale, davvero complesso, delle antiche reggenze barbaresche, col prevalere di modalità genericamente “italianizzanti” tra Algeri e Tunisi, e “ispanizzanti” verso il Marocco; del resto, l’unico repertorio ampio di “lingua franca”, un dizionarietto del 1830 a uso delle truppe francesi in Algeria, suona di estrema (e per certi aspetti tardiva) stilizzazione di un fenomeno assai più labile nelle sue manifestazioni. Quanto e cosa questo insieme di situazioni abbia lasciato in eredità alle lingue dell’Africa settentrionale e del vecchio Levante è difficile dire: certamente il lessico dell’arabo maghrebino, del turco, del greco e di altre varietà “mediterranee” è ricco di italianismi, ispanismi, venetismi, genovesismi, provenzalismi, francesismi e così via, non meno di quanto turcismi e arabismi siano presenti nelle varietà neolatine della sponda settentrionale del Mediterraneo, ma ciò non assicura necessariamente l’esistenza di un tramite rappresentato dalle modalità pidginizzanti della lingua franca. Il quadro così delineato ridimensiona un po’, in ogni caso, alcune teorie suggestive, come quella sull’origine monogenetica dei pidgin, che sarebbero nati, secondo alcuni studiosi, dal trasferimento dell’ossatura morfologica semplificata della “lingua franca mediterranea” lungo le coste della Guinea, subendovi una rilessificazione in senso portoghese. Non è chiaro tra l’altro, a mio modesto avviso (anche ad attribuire una decisiva importanza all’interazione ligure-lusitana lungo le coste dell’Africa atlantica ai tempi della tratta degli schiavi, secondo una suggestiva lettura, tra gli altri, di Germán De Granda), il contesto storico-culturale in cui si sarebbe verficato tutto ciò, mancando soprattutto una sostanza documentaria in grado di instaurare affinità specifiche tra la “lingua franca” mediterranea (oggetto sostanzialmente sconosciuto) e i pidgin africani e americani.
Quale influenza ha avuto il genovese, lingua di una delle repubbliche marinare, sull’italiano e sui dialetti: in quali parlate del suolo italiano, ad esempio, la sua presenza si avverte di più e quali sono gli ambiti semantici?
La mostra alla quale accennavo prima, tenutasi a Genova tra settembre e novembre di quest’anno, documenta anche, attraverso il suo catalogo, la ricchezza delle interrelazioni linguistiche e culturali che furono generate dall’espansione mercantile ligure nel Mediterraneo. Come ha scritto di recente Emanuele Banfi, anzi, probabilmente più ancora di quella del veneziano la storia oltremarina del genovese merita di essere conosciuta e approfondita in ragione delle modalità del suo radicamento in una pluralità di orizzonti linguistici differenti e con modalità d’impianto peculiari, legate anche alle esigenze di controllo di approdi e di basi commerciali, più che di territori estesi, da parte di una popolazione di mercanti caratterizzata da un limitato potenziale demografico. Lingua di incontro più che di dominio, il genovese si è caratterizzato così per una forte tendenza alla micro-colonialità, in quei luoghi, dalla Crimea a Gibilterra, dove i liguri rappresentarono essenzialmente una minoranza dominante o un elemento catalizzatore, per le loro stesse specializzazioni economiche, in grado di attrarre componenti etniche e demografiche di svariata provenienza: i diplomi bilingui in genovese e armeno o ebraico prodotti nell’ambiente turcofono di Caffa ne sono un esempio lampante, non meno delle attestazioni dell’uso del genovese, alla Boca di Buenos Aires, anche da parte della popolazione d’origine ispanica o degli immigrati di varia origine e provenienza, circostanza che spiega l’importante componente ligure nello spagnolo popolare rioplatense. Se si guarda più in dettaglio al contesto italiano, quantificare il lascito linguistico e in special modo lessicale genovese nella lingua nazionale e nei dialetti non è facile, considerando che le stesse affinità morfologiche e fonetiche tra gli idiomi italoromanzi rendono a volte difficile determinare l’esatta provenienza di una voce. È vero peraltro che Genova si propone anche, e precocemente, come centro di assunzione e di irradiazione di innovazioni della più svariata origine, orientale non meno che nordica e occidentale, soprattutto nel lessico delle costruzioni navali, marinaresco, commerciale, della pesca e così via. A livello dialettale, una notevole circolazione linguistica in area alto-tirrenica contribuì non poco a diffondere termini d’origine o di tramite ligure verso la Corsica (peraltro esposta a un apporto lessicale massiccio anche per la sua appartenenza politica a Genova) e la Toscana costiera e insulare (numerosi sono gli esempi lessicali che si possono trarre, fra gli altri, da un esame del dialetto di Capraia), con “discese” notevoli anche lungo le cose sarde, italiane meridionali e siciliane. Non è certo stupefacente allora che persino una parola percepita come essenzialmente “siciliana” quale mattanza, sia in realtà un antico ispanismo di tramite genovese, approdato tardivamente nel lessico delle tonnare siciliane anticamente gestite da imprenditori liguri. Dal porto di Genova passano inoltre, per diffondersi nell’italiano letterario, molti termini legati al mondo della navigazione e della marineria (da scoglio a prua, da ciurma a cavo, e alcuni ancora in tempi recenti, come il lusismo piovasco), ma anche a prodotti commerciali (penso di avere dimostrato recentemente l’origine genovese di baccalà), a innovazioni tecnologiche e così via. Spesso le datazioni di una voce, attestate in genovese o in italiano regionale ligure prima che in altre zone, contribuiscono a chiarire i processi di diffusione di questa terminologia, che fu particolarmente copiosa nel passaggio dal genovese al toscano anche per la maggiore vicinanza geografica del porto ligure rispetto a Venezia, che ha irradiato spesso il proprio lessico marinaro in area adriatica assai più che in direzione della Toscana. Uno studio sistematico dei genovesismi in italiano è del resto tra le attività connesse al mio lavoro di spoglio lessicale della documentazione ligure preottocentesca, dalla quale stanno emergendo elementi importanti di valutazione. Più difficile è parlare, al di là del lessico, di componenti liguri nel processo di formazione di varietà dialettali italiane: è ormai riconosciuto un fondamentale apporto di tale origine nel galloitalico meridionale, ossia in quell’insieme di dialetti, diffusi in Basilicata e in Sicilia, che presentano tracce inequivocabilmente “settentrionali” e che risalgono verosimilmente a fenomeni immigratori dei secc. XII-XIII, legati anche ai ripopolamenti promossi dopo la cacciata degli arabi dalla Sicilia; ancor più evidente è, come già accennavo, la componente ligure in alcuni dialetti urbani della Corsica, come quello di Ajaccio e quello di Calvi, la cui popolazione doveva parlare in passato un idioma “coloniale” (paragonabile a quello tuttora in uso a Bonifacio) sul quale si sovrapposero in seguito le varietà corse del contado. Proprio dal bonifacino dipende in gran parte il decisivo apporto ligure, anche di carattere morfologico, del dialetto “misto” corso-ligure dell’isola Maddalena, e una componente genovese variamente stratificata si riconosce anche nella parlata sassarese, come effetto di una commistione, su base corsa, di elementi fonetici, morfologici, sintattici e lessicali liguri e sardi.
Il sardo è considerato oggi, e a partire da quella che è considerata la prima classificazione scientifica dei dialetti italiani operata da Ascoli (1882), una lingua autonoma rispetto alle altre parlate italiane, caratterizzata da una notevole conservatività rispetto al latino, caratteristica mantenuta grazie al suo isolamento rispetto alla terraferma. Questa immagine corrisponde alla realtà? A chi o a cosa si deve l’idea del sardo come dialetto isolato e conservativo?
Nei dieci anni di insegnamento all’università di Sassari mi sono avvicinato con molto rispetto e con qualche titubanza al “problema” della lingua sarda, ma mi guardo bene dal definirmi uno specialista in materia. In ogni caso la specificità linguistica del sardo e il sua carattere di lingua (o se si preferisce, di insieme di varietà dialettali a se stante rispetto all’italiano) è un dato di fatto conclamato e accolto non soltanto dalla linguistica italiana, ma anche da quella internazionale. Detto questo, sarebbe opportuno rivedere alcuni luoghi comuni sul sardo, a partire soprattutto da quello della sua “staticità” e conservatività consustanziale, che in parte è anche il frutto di una interpretazione per certi aspetti “ideologica” della categoria di insularità, come conseguenza di una visione “resistenziale” della società sarda, e in fondo degli stessi entusiasmi del maestro riconosciuto della linguistica sarda, il tedesco Max Leopold Wagner. Certo, il sardo conserva caratteristiche particolarmente arcaiche rispetto ad altri idiomi romanzi, ma questo non riguarda anzitutto l’intera area linguistica sarda, divisa tra un meridione campidanese assai più dinamico e un settentrione logudorese-nuorese maggiormente conservativo; inoltre, un’evoluzione a partire da condizioni particolarmente precoci di radicamento del latino è continuata ovviamente e continua a manifestarsi, come avviene per qualsiasi lingua o dialetto, secondo modalità che risentono anche della collocazione sociolinguistica di una lingua, almeno finora, prevalentemente parlata. Più in generale, le condizioni di arcaicità non sembrano affatto dovute all’insularità del territorio, circostanza che ne fa anzi uno spazio vocazionalmente “aperto” fin dalla più remota antichità, quanto alla presenza all’interno della Sardegna di aree montane, maggiormente conservative come conservativo sotto molti punti di vista, non soltanto da quello linguistico si dimostra (secondo una ben nota considerazione di Fernand Braudel) anche il resto della montagna mediterranea. Che l’ambiente sardo dimostri una specifica propensione alla “resistenza” agli influssi esterni è del resto, come dicevo, un mito identitario e una forma di rappresentazione di se stessi assai prima che una realtà storica: basta solo guardare a quanto il lessico delle varie lingue che si sono susseguite in Sardegna con caratteri di superstrato, dal pisano al genovese, dal catalano allo spagnolo e all’italiano, abbia permeato il vocabolario isolano nei più ampi e disparati ambiti semantici. E non va infine dimenticato che la Sardegna, proprio per il suo carattere di spazio “aperto” ospita da secoli diverse varietà alloglotte orientate di volta in volta verso le rispettive “madrepatrie”, in modo tale da costituire veri e propri “ponti”, elementi di raccordo tra la sardità linguistica e un più ampio orizzonte romanzo: le parlate corse del nord dell’isola (gallurese, maddalenino e sassarese, le ultime due con interessanti interferenze liguri), il catalano di Alghero, il già citato tabarchino di provenienza ligure-tunisina. A queste diverse forme del contatto linguistico ho preferito dedicarmi, da quando lavoro in Sardegna, anche in considerazione del fatto che la lingua sarda ha i suoi validi specialisti, e tenendo conto del mio specifico interesse per le vicende “dinamiche” del contatto e dell’interferenza linguistica.
Il dialetto genovese ha subito l’influsso del toscano/dell’italiano? In caso affermativo, in quale epoca quest’influsso è stato più forte e da quale punto di vista? Il genovese è cambiato molto negli ultimi 150 anni?
Come ogni varietà neolatina sottoposta al “tetto” linguistico del toscano/italiano, il genovese e il sistema dei dialetti liguri hanno risentito e risentono dell’influenza di questa varietà enormemente prestigiosa in termini letterari, politici, sociali e di diffusione territoriale. Almeno dal Quattrocento il toscano è massicciamente presente nella scripta ligure, attraverso elementi lessicali, morfologici e sintattici che risultano anche dalla esportazione verso le Riviere di precisi modelli culturali e letterari. Nondimeno, e a differenza di altre regioni italiane, la Liguria esprime precocemente, a partire dalla fine del Duecento, una letteratura autonoma nell’idioma locale, che si sviluppa attraverso i secoli con una chiara consapevolezza della propria continuità e autonomia, sollecitando a più riprese programmi di défense et illustration del genovese, come “lingua del paese” contrapposta più o meno polemicamente all’uso dello “straniero” toscano: il jayro vorgà çenoeyse (“chiaro volgare genovese”, secondo una ricorrente formula trecentesca) si presenta costantemente come protagonista della vita culturale ligure, in aperta e spesso vincente concorrenza con l’italiano soprattutto nei termini dell’identificazione nella langue du pays dello strumento più idoneo a rappresentare i tratti costitutivi della specificità locale. Queste dinamiche sono particolarmente attive tra il Cinque e il Settecento, quando la promozione del genovese diventa un elemento strategico per la definizione ideologica di un’“alterità” promossa da una classe dirigente che si affanna a divulgare l’immagine di una Repubblica caratterizzata dall’originalità delle proprie istituzioni e dalle peculiari manifestazioni della propria “libertà”. Se consideriamo il fatto che i depositari di questa impostazione, ossia i poeti e gli altri autori che scrivono in genovese, appartengono nella stragrande maggioranza al ceto notarile, a diretto contatto con le memorie storiche e con le testimonianze linguistiche del medioevo, possiamo capire perché quella genovese, con i suoi caratteri di continuità, assomigli poco al “canone” concettuale che siamo abituati ad attribuire, in Italia, alla categoria di letteratura dialettale. D’altro canto, gli usi “alti” del genovese nelle discussioni politiche, in senato, nei tribunali, dureranno fino alla caduta della Repubblica (1797-1805) condizionando, assieme alla percezione dell’internazionalità dell’esperienza linguistica ligure nel Mediterraneo, anche i successivi, per quanto velleitari, tentativi di nobilitazione: la Liguria è così l’unica regione italiana, a quel che mi consta, a esprimere nella seconda metà dell’Ottocento un poema “nazionale” scritto nella lingua locale, al seguito dell’esperienza felibristica provenzale e anticipando di diversi anni quella catalana; ed episodi come la pubblicistica e il romanzo, o la traduzione non parodica della Divina CommediaChe l’inseBalilla); ma agendo al tempo stesso in maniera sistematica per una dequalificazione del genovese, attraverso meccanismi di persuasione che coinvolsero lo stesso panorama culturale e artistico locale, come nel caso del teatro di Gilberto Govi, che meglio di tante altre agenzie diffuse un’immagine degli usi linguistici locali (opportunamente italianizzati) stereotipata, passatista e dequalificata. Il periodo postfascista, caratterizzato anche dalle forti irrequietudini sociali di una città che negli anni Settanta venne investita in pieno dalla stagione del terrorismo, fu a sua volta caratterizzato dall’atteggiamento spesso francamente dialettofobo di una parte dell’ambiente intellettuale e accademico, che intepretò, ad esempio, il persistere delle tradizioni linguistiche locali come una forma di auto-ghettizzazione della classe operaia: di questo ha risentito non poco la ricerca, che si caratterizza a Genova per un clamoroso ritardo a fronte dell’indiscutibile ricchezza storica, documentaria e attuale del patrimonio linguistico-letterario regionale. Con tutto ciò, i dialetti liguri e il genovese in particolare denotano ancora una discreta vitalità in una molteplicità di usi, anche in ambito artistico, circostanza che spesso compensa in qualche modo, come accennavo, l’indiscutibile crisi delle funzioni comunicative. La letteratura in genovese, tradizionalmente lontana nei suoi esiti più alti da modalità “dialettali” continua così a produrre in poesia e in prosa esiti di eccellenza purtroppo assai poco divulgati; la canzone, da De Andrè in poi, si è profondamente rinnovata; è rinata di recente attraverso una pagina settimanale del principale quotidiano regionale una pubblicistica in genovese che interessa ed attrae un pubblico eterogeneo di lettori. A loro modo, sono tutti segnali interessanti di vitalità. di (1909) sono indizi importanti del fatto che, fino al fascismo almeno, il genovese non fu percepito in tutto e per tutto come varietà “subordinata” all’italiano. Ciò detto, gli ultimi due secoli, e la seconda metà del Novecento in particolare, segnano il netto e convinto orientamento della società ligure in direzione della cultura italiana (cosa non del tutto scontata, ad esempio, nel periodo barocco, quando l’influenza spagnola fu particolarmente vistosa), e l’adeguamento non meno convinto a modalità linguistiche di maggior prestigio, che, a partire dalla borghesia, defluiscono facilmente (a partire soprattutto dagli anni Settanta) verso gli strati popolari, particolarmente quelli urbani. Teniamo anche conto del fatto che la Liguria, entità per certi aspetti non territoriale, usufruisce meno di altre regioni di “serbatoi” di conservatività linguistica, col suo entroterra semispopolato, con la sua portualità internazionale e con le due Riviere da oltre un secolo costantemente aperte all’accoglienza di un turismo cosmopolita. Ne risulta una regione “poco dialettofona”, anche in base alle statistiche, ma nella quale il retaggio storico ha sempre garantito, soprattutto al genovese, un significativo prestigio: il “complesso di patois” vi è del tutto assente, per quanto la fase cruciale tra gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso abbia determinato un progressivo ridimensionamento di questa percezione. Sotto questo punto di vista il fascismo operò in maniera ambigua, dimostrando nei confronti dei dialetti liguri (utili per legittimare le pretese irredentistiche sul Nizzardo e sulla Corsica e per il raccordo con le comunità immigrate in America Latina) una singolare tolleranza, fino all’assunzione indebita di miti locali variamente intrisi di umori linguistici autoctoni (ilChe l’inseBalilla); ma agendo al tempo stesso in maniera sistematica per una dequalificazione del genovese, attraverso meccanismi di persuasione che coinvolsero lo stesso panorama culturale e artistico locale, come nel caso del teatro di Gilberto Govi, che meglio di tante altre agenzie diffuse un’immagine degli usi linguistici locali (opportunamente italianizzati) stereotipata, passatista e dequalificata. Il periodo postfascista, caratterizzato anche dalle forti irrequietudini sociali di una città che negli anni Settanta venne investita in pieno dalla stagione del terrorismo, fu a sua volta caratterizzato dall’atteggiamento spesso francamente dialettofobo di una parte dell’ambiente intellettuale e accademico, che intepretò, ad esempio, il persistere delle tradizioni linguistiche locali come una forma di auto-ghettizzazione della classe operaia: di questo ha risentito non poco la ricerca, che si caratterizza a Genova per un clamoroso ritardo a fronte dell’indiscutibile ricchezza storica, documentaria e attuale del patrimonio linguistico-letterario regionale. Con tutto ciò, i dialetti liguri e il genovese in particolare denotano ancora una discreta vitalità in una molteplicità di usi, anche in ambito artistico, circostanza che spesso compensa in qualche modo, come accennavo, l’indiscutibile crisi delle funzioni comunicative. La letteratura in genovese, tradizionalmente lontana nei suoi esiti più alti da modalità “dialettali” continua così a produrre in poesia e in prosa esiti di eccellenza purtroppo assai poco divulgati; la canzone, da De Andrè in poi, si è profondamente rinnovata; è rinata di recente attraverso una pagina settimanale del principale quotidiano regionale una pubblicistica in genovese che interessa ed attrae un pubblico eterogeneo di lettori. A loro modo, sono tutti segnali interessanti di vitalità.
Esiste nella realtà una varietà “ligure” e quanto questa si differenzia rispetto al genovese? Vi sono elementi di derivazione provenzale e/o piemontese?
Ho usato spesso, in questa conversazione, la formula “genovese e ligure”, con la quale ho inteso sottolineare il diverso peso storico, culturale e sociale della varietà cittadina, la “lengua zeneise”, rispetto alle varietà locali. Come ogni contesto regionale, anche quello ligure si caratterizza infatti per una forte variazione diatopica, che viene progressivamente meno a mano a mano che ci si avvicina al “centro” genovese, area innovativa per eccellenza. Dalla periferia occidentale di Savona fino a Sestri Levante sulla costa, così, i dialetti appaiono decisamente orientati sul modello urbano, secondo modalità koinizzanti che si estendono anche alle aree circostanti, soprattutto dell’entroterra, dove questo “genovese” convive spesso, nell’uso, con l’italiano e con varietà più eccentriche, in condizioni di macrodiglossia. A mano a mano che ci si allontana da Genova, emergono invece caratteristiche peculiari ed arcaiche, spesso con significative convergenze tra le due ali estreme della Liguria, dove lo spezzino e il ventimigliese, ad esempio, conservano ancora alcuni tratti del genovese medievale, noti attraverso la documentazione letteraria. Oltre a ciò, gli antichi centri amministrativi e mercantili delle due Riviere e dell’entroterra rivelano spesso, nella loro parlata, una più decisa connotazione in senso “genovesizzante” rispetto alle aree circostanti, con la conseguenza che la varietà urbana mostra di avere agito da un lato in senso centripeto, favorendo il processo di amalgama dei dialetti liguri e la loro percezione unitaria (“genovese” è la denominazione complessiva con la quale il ligure romanzo continua a essere prevalentemente noto), dall’altro in senso centrifugo, accentuando la differenziazione tra le varianti cittadine e i rispettivi contesti rurali. Non esiste quindi un tipo ligure, ma il carattere dei dialetti liguri è molto ben definito da una serie di isoglosse, che ne determinano la netta autonomia verso il tipo provenzale e quello toscano ai due estremi, ma anche rispetto alla galloitalicità settentrionale, dalla quale il tipo ligure si differenzia per numerosi e significativi aspetti, a partire dalla conservazione delle vocali atone e finali, fino a “fenomeni-bandiera” come l’indebolimento fino alla caduta di –r– intervocalica o le palatalizzazioni “spinte” dei nessi PL-, BL-, FL- (cianze ‘piangere’, gianco ‘bianco’, sciamma ‘fiamma’), tratto quest’ultimo che ha, come del resto la robustezza delle vocali, significative assonanze centro-meridionali, puntualmente confermate anche a livello morfologico e lessicale. D’altronde, al di là dello spartiacque che divide la Riviera ligure da un mondo “padano” tradizionalmente sentito come “altro”, i dialetti ancora liguri delle alte valli digradano progressivamente verso il piemontese, il lombardo e l’emiliano, così come non vi è una decisa soluzione di continuità tra le parlate liguri orientali e i dialetti (ancora settentrionali, ma a se stanti) della Lunigiana. Tra Liguria e Provenza passa invece uno dei confini linguistici forse più netti dell’intera Romània, che distanzia nettamente il tipo ligure da quello occitano, lasciando alla varietà italoromanza l’alta valle del Roia con Briga, Tenda, Breglio e Saorgio e il distretto di Mentone oggi in territorio francese. Parlare di elementi di “derivazione” piemontese o provenzale non è quindi corretto, al di là di singoli fenomeni lessicali (non meno significativi di quelli che sottolineano la reciprocità dell’influsso ligure in piemontese, in nizzardo e così via), mentre ha senso ricordare, come si diceva, l’esistenza di varietà “miste” sul versante padano, col prevalere spesso di componenti liguri anche al di fuori dei confini amministrativi: in alta Val Tanaro ad esempio (Briga Alta, Ormea, Garessio in provincia di Cuneo), nel cosiddetto Oltregiogo (a sud della linea Novi Ligure – Ovada in provincia di Alessandria), nelle alte valli emiliane della Trebbia e del Taro.
In che cosa consiste il concetto di “lingua polinomica” e a quali parlate può essere applicato relativamente all’area geografica italiana?
Il concetto linguistico di polinomia è stato elaborato negli anni Ottanta dal sociolinguista corso Jean-Baptiste Marcellesi con specifico riferimento al contesto isolano: nella difficoltà di identificare univocamente una “corsicità” dialettale, ma prendendo atto che l’esistenza di una “lingua corsa” corrispondeva alle esigenze identitarie e percettive della popolazione, lo studioso definì il corso come l’insieme delle varietà dialettali tradizionalmente parlate sul territorio, in quanto frutto di una volontà collettiva dei locutori di riconoscerne l’unitarietà. Si definisce quindi “polinomica” una lingua che, pur priva di uno standard riconosciuto, istituisce relazioni dinamiche con altri idiomi (soprattutto con quelli dominanti, nel caso specifico il francese) manifestando la sua autonomia indipendentemente dalla propria unità strutturale. La definizione supera quella di “sistema dialettale” nella misura in cui la lingua polinomica afferma la propria autonomia rispetto al “tetto” sovraordinato, eludendo i rischi di un equivoco ricorrente nella definizione di “dialetto” come concetto sociolinguistico, secondo l’interpretazione (piegata anche a considerazioni di carattere storico-culturale) che prevale ancora nel contesto italiano: un sistema dialettale che non sia geneticamente subordinato a una lingua può così affermare in linea di principio la propria autonomia anche in mancanza di uno standard di riferimento da contrapporre alla lingua egemone. Il concetto di polinomia non è quindi semplicemente un modo “politicamente corretto” di ridefinire la varietà dialettale di un’area, perché implica una presa di coscienza collettiva e l’instaurarsi di relazioni dinamiche con il codice sovraordinato. In questo senso sono lingue polinomiche le varietà dialettali i cui parlanti ne riconoscano collettivamente, anche attraverso un glottonimo univoco, la parentela di fondo, promuovendo un percorso comune di confronto rispetto alla lingua tetto. Questo modello implica però un’attitudine “militante” dei parlanti, o almeno di una parte visibile e significativa di essi, e sfugge quindi a un’applicazione sistematica ai singoli casi. È certamente una lingua polinomica il corso, ad esempio, e potrebbe definirsi tale il sardo, nel momento in cui vi fosse unanime consenso sull’esigenza di tutelarlo nelle sue varianti e non a partire da uno standard unificato. Nei processi attuali di promozione della tutela e rivitalizzazione di alcune varietà italoromanze, direi che l’attitudine polinomica si sta sempre più affermando, in maniera più o meno consapevole, mentre l’impostazione “occitanista” presente nel sud della Francia, ad esempio, che prevede l’affermazione di uno standard comune alle diverse aree regionali, collide con questa impostazione che è cara al contrario ai “provenzalisti”, sostenitori della tutela delle singole varietà, o quanto meno dell’elaborazione di diversi standard locali. D’altro canto un’impostazione polinomica esiste di fatto, anche precedentemente all’introduzione del concetto da parte di Marcellesi, nella realtà linguistica delle valli grigionesi, dove la definizione comune delle varietà neolatine locali (il romancio, rumantsch) non esclude la promozione delle diverse varietà locali: in questo caso anzi l’elaborazione di una varietà comune sovraordinata (rumantsch grischun) si è rivelata fallimentare, nella percezione dei parlanti, ai fini della elaborazione di una politica complessiva di tutela. In chiave glottopolitica e sociolinguistica il concetto linguistico di polinomia non è quindi privo di efficacia, garantendo pari dignità e prospettive comuni di sviluppo alle diverse varianti che si riconosco sotto un’unica denominazione. Resta peraltro incerto lo statuto polinomico di quei sistemi dialettali (come quello ligure o quello piemontese) in cui una parlata storicamente più forte delle altre può aspirare a essere considerata la varietà “di riferimento” dell’intero sistema, senza necessariamente esercitare, con ciò, un ruolo di “tetto” sulle varianti locali.
Lei si è occupato anche della lingua delle relazioni di missionari italiani in Africa nei secoli XVII-XVIII: cosa può dirci lo studio di queste fonti, insieme a quello dei diari e delle memorie, sulla storia della nostra lingua (e/o su quella delle lingue europee) e quali problematiche possono presentarsi nella valutazione dell’importanza del lessico che vi è impiegato?
In realtà si tratta di un tema che ho soltanto saggiato, a partire da alcuni esempi concreti e specifici, nell’ambito del mio più generale interesse per il contatto linguistico: mi interessava infatti verificare la possibilità che una lingua come l’italiano, sostanzialmente priva di una consistente proiezione extraeuropea ed extramediterranea, si dimostrasse in grado di assumere, per singoli segmenti semantici e in particolari situazioni, quote significative di lessico esotico. Da qui le considerazioni che in alcuni saggi ho dedicato allo statuto degli esotismi diretti, diverso da quello degli esotismi assunti per il tramite di altre lingue europee, nell’ambito di una riflessione complessiva sui concetti di etimologia prossima ed etimologia remota. Il lessico delle relazioni dei missionari nell’antico Regno del Congo (secc. XVI-XVIII) è particolarmente interessante sotto questo punto di vista perché dimostra la “costruzione” di un vocabolario tecnico-specialistico di origine esotica, assunto direttamente in italiano senza il tramite del portoghese; tuttavia, esso conferma al tempo stesso l’occasionalità di questi episodi di contatto linguistico di fronte alla preponderante assunzione di esotismi per via indiretta. Anche alla luce di ciò preferisco considerare a sé la categoria degli orientalismi lessicali, che introduce un apporto diretto e significativo nell’area italoromanza secondo modalità alquanto diverse da quelle che caratterizzano, ad esempio, l’assunzione prevalente di africanismi, amerindismi, nipponismi e così via: un termine arabo o turco passato direttamente in genovese, in siciliano, in veneziano, in italiano, ci racconta infatti una storia enormemente diversa di relazioni economiche, sociali e culturali rispetto a quella di una voce congolese o giapponese, anche se casualmente assunta per via diretta; figuriamoci allora nel caso, assolutamente prevalente, in cui gli esotismi arrivano in Italia attraverso lo spagnolo, il portoghese, il francese o l’inglese: in tali circostanze, il principio della prevalenza dell’etimologia prossima ai fini valutativi fa sì, secondo uno schema perfezionato tra gli altri da Žarko Muljačić, che queste voci siano da considerare prima di tutto ispanismi, lusismi, gallicismi o anglismi, con tutte le conseguenze, quantitative e qualitative, che ne risultano. Tuttavia su questo punto, come dicevo, la mia riflessione è stata fin qui piuttosto episodica, anche per il fatto che sulle scritture in lingua italiana (e nelle lingue d’Italia, per dirla ancora con Banfi) prodotte storicamente in contesti latamente “esotici”, c’è ancora molto da fare. Lo stesso ruolo dell’italiano come lingua diplomatica nel Levante, studiato da Francesco Bruni, tra gli altri, in alcuni importanti lavori, non è stato ancora oggetto di ricognizioni sistematiche, figuriamoci quindi le corrispondenze o i diari, ad esempio, di viaggiatori, missionari, mercanti italiani attivi in paesi remoti. Tempo fa, occupandomi di retrodatazioni, documenti di questo genere si erano rivelati assai promettenti per verificare la precocità nell’assunzione di alcuni esotismi di area malese e amerindia, ma questo tipo di ricerche meriterebbe una sistematicità tale da richiedere l’apporto collettivo e costante di diversi ricercatori impegnati nell’individuazione e nello spoglio delle fonti, con esigenze evidenti di contestualizzazione storica, di esegesi filologica, di approfondimento etimologico e così via. Per fortuna i giovani volenterosi e preparati non mancano, in questo come in altri campi, ed è quindi fondata la speranza che su molti temi affascinanti si possa costantemente tornare “in forze”, per assicurare alla ricerca linguistica quella continuità e quel progresso che da sempre ne fanno una delle discipline più dinamiche dello scibile, in ambito umanistico soprattutto.
ALBUM FOTOGRAFICO - LEUDI DA LAVORO
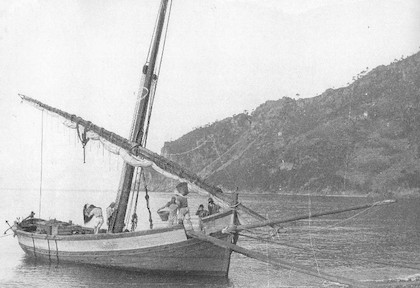
... Trasportavano sabbia

... Trasportavano botti di vino

Leudo "vinaccere"

... scarico delle botti in mare
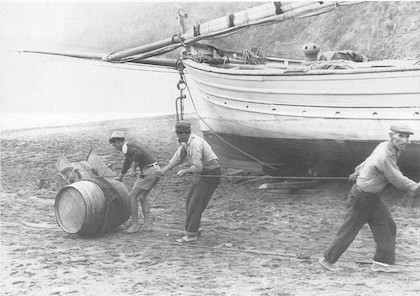
A cura del webmaster Carlo Gatti
Rapallo, 2 Maggio 2018
MA BELAN...!
PREMESSA:
Il seguente “sàggio du belin”… é dedicato all’AMICO Comandante Nunzio Catena di Ortona il quale, avendo navigato a bordo di navi genovesi, capisce ed ama il nostro dialetto fino al punto di chiedermi una ricerca anche “limitata” sull’argomento. Ho cercato di accontentarlo inizialmente con un po’ di ritrosia poi, all’improvviso, mi é venuto in mente una lettura studentesca di molti anni fa: Marco Valerio Marziale 38-104 d.C. (ed altri) – gli epigrammi proibiti che mi sono andato a rileggere sul web. Devo confessarvi che: “MA BELIN”… al confronto é un giochetto da educande…
Giusto per non confondere la lana con la seta, gli antichi latini usavano il termine MENTULA al posto del nostro….
MA BELIN…!
L’argomento é serio… per tale motivo partiamo da modelli scientifici consolidati per poi arretrare verso i “recanti” della storia ed infine per calarci nella quotidianità con quelle espressioni che esplodono dalle viscere sanguigne così vicine alle nostre radici storiche e territoriali.
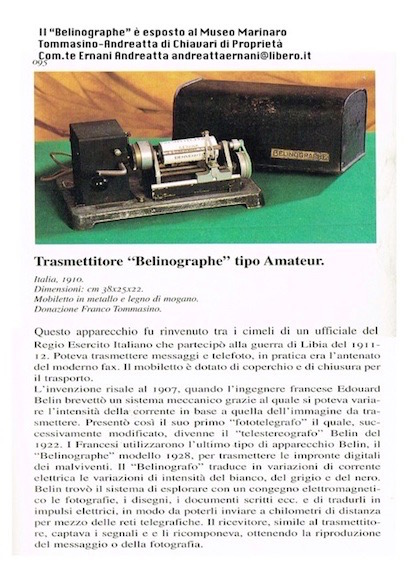
La nota guida del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, Giancarlo Boaretto introduce l’argomento così:
“Attenzione qui siamo in presenza di uno strumento a lunga gittata che può lasciare conseguenze…”.
Capìta l’antifona… i liguri presenti scoppiano in una folle risata…!
Il Comandante Ernani Andreatta racconta: “Che cos'è? Ma c’era, il fax, molto tempo fa? Non c’era, però state a sentire qualcosa che molta gente non sa e così, poi, glielo potrete raccontare. In Francia, quasi un secolo fa, l’ingegnere Edouard Belin inventò un congegno che trasformava l’elettricità in segni di scrittura o di disegno. Così, in pace, e purtroppo in guerra, fu usato per trent'anni, e inviava i suoi messaggi per tutta la terra. Quel fax antico, come si chiamava? È il belinografo!”
Trovandoci in un Museo Marinaro, ci viene in mente quella nave passeggeri che, negli Anni ’20, portava il nome di Albert Ballin il quale fu il primo armatore che pensò di realizzare navi dedicate esclusivamente alle crociere. Albert Ballin fu Direttore Generale della Compagnia di Navigazione Hapag (divenuta nel 1970 Hapag-Lloyd dopo la fusione con la grande rivale Norddeutscher Lloyd).
Rientrando velocemente nel tema, stiamo pensando a tutti quei marittimi genovesi di quegli anni che, incrociando quel transatlantico in oceano, avranno sicuramente pronunciato il suo nome alla genovese, forse per sentirsi un po’ a casa…
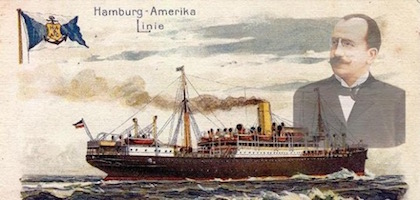
La Albert Ballin in navigazione
L’occasione della visita al Museo Marinaro ci offre l’occasione d’introdurre un argomento un po’ particolare; infatti, col successo del comico genovese Maurizio Crozza in televisione e in teatro, l’intercalare genovese BELIN viene usato senza risparmio anche due o tre volte nella stessa frase sollevando molte curiosità e altrettante domande da parte di chi ligure non é. Pertanto, non indugeremo oltre sul Belinografo, ma ci concentreremo sull’intercalare genovese BELIN che si presta a molti significati e a svariate interpretazioni che cercheremo di riassumere in seguito. Ma ora, come é nostra abitudine, partiamo da lontano con alcune ipotesi storiche sulle origini di questo termine.
BELIN … nella Storia!
1° Ipotesi
"Belin", rappresenta l’imprecazione, l’esclamazione più usata nel dialetto genovese, potendo assumere tono affermativo, risentito, solenne, stupito, iroso, sconsolato, beffardo, e altro ancora.
Sentiamo cosa ne pensa l’illustre etimologo E. Mori:
“occorre seguire contemporaneamente il filone storico e quello psicologico, perché i popoli hanno, in materia di parole, una loro psicologia. Una regola psicologica ci dice che in nessuna lingua l'organo maschile è indicato con un diminutivo. Gli antichi dizionari ricollegavano belin al greco balanos (glande) ed era, psicologicamente, una stupidaggine perché gli antichi liguri non avevano di certo aspettato i greci per dare un nome al loro pisello! Però un fondo di vero c'era e già un linguista del 1940 ricollegava belin al dio fenicio Baal, individuando una radice indeuropea che con bal indicava la divinità in genere. Ed infatti per i Galli la loro divinità (Henri Dontenville, Mythologie française) era un essere che era Padre e Figlio ad un tempo. Come Padre, si chiamava Belenus; equivaleva sostanzialmente ad Apollo, era il grande dio solare originariamente adorato dalle popolazioni pre-indoeuropee. In qualità di Figlio era sentito come più vicino alla terra, in qualche modo legato alle pietre, agli alberi e alle acque; si chiamava Gargano.
Il territorio francese, per limitarci a questo, è costellato di luoghi il cui nome si collega etimologicamente a quello di Belenus (Bel o Belen in francese) o di Gargano. Si tratta, a seconda dell'evoluzione fonetica delle varie zone, di Balan, Blesme, Belfait (l'albero di Bel), Montbelair, Baleine, Blaine, Ballons, Corblin (la pietra di Belin), Blainville, Belmont, Montbel... Si tratta delle antiche roccheforti dei Galli, Gergobina e Gergovie; a Guérande, il castello Gorgon; si tratta di fiumi: Gorganne, Gorgonne, Gargonne, Gargonde; di alture: Gargatte, Jariatte... Non è raro che i due nomi si affianchino; oppure - e può essere ancor più sintomatico - non lungi dal luogo che richiama Belenus, sopravvive (o sopravviveva fino a poco tempo fa) una leggenda popolare il cui eroe è un gigante perlopiù chiamato Gargantua.
È quindi certo che nell'area francese-provenzale-ligure il termine belin era diffuso per indicare la divinità. In Val Varaita vi è il paese Bellino, quasi certamente riconducibile alla stessa origine (Belin, Belinium, Belinius, nom d'homme gaulois ou de divinité. Charles Rostaing, "Dictionnaire des noms de lieux", Ed. Larousse p.68). La dimostrazione del collegamento tra belin genovese e divinità galliche è data dal fatto che in francese esiste la parola antica beliner proprio con il significato di “scopare”. È vero che tutti gli etimologisti francesi dicono che la parola deriva da belin, termine che fin dal medioevo indica il montone, ma si sono dimenticati che nella preistoria, quando vi erano ancora i culti totemici, l'animale totem di un popolo dava il nome anche al dio, o viceversa (giove, giovenco, juvenes, ecc.).
Quindi la tesi probabile al 90% è che la parola genovese belin derivi dall'antica parola dei galli-liguri Belenus”.
2° Ipotesi
Maria Elena Dagnino, cogoletese, é stata professoressa di italiano e latino nei licei per 40 anni. Ora é docente per l’Unitre di Arenzano Cogoleto, di cui é socia storica.
Secondo la studiosa, l’intercalare ebbe origine dal popolo dei Celti.
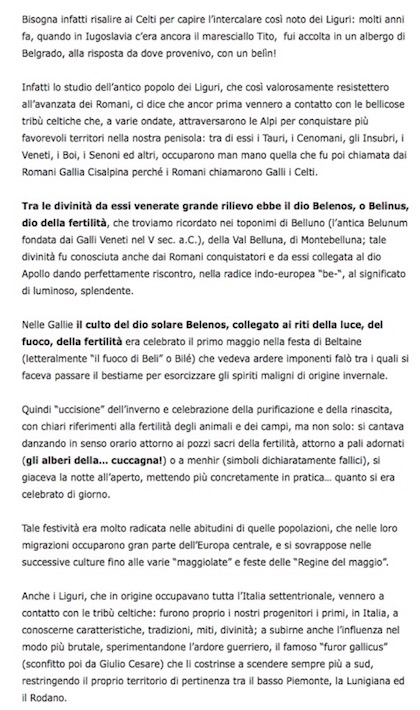
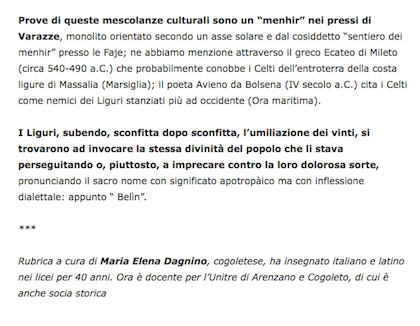
Al lettore eccessivamente sensibile e di gusti alquanto raffinati consigliamo di fermarsi sull’uscio di Paolino… Un scito do belin!
Da cui accogliamo e pubblichiamo le seguenti espressioni dialettali più comuni
"A belin de can": "a ca… di cane" (si dice d’ogni cosa sgraziata, mal costrutta).
"Sottî comme i péi do belin de ‘na mosca": "sottile come i peli del c… di una mosca".
"Açimentâ o belin": "cimentare, irritare il c…": (annoiare, infastidire)
- Eguale significato hanno le espressioni:
"Menâ, ronpî, sciaccâ, sgarbellâ, spellâ, sussâ, tiâ o belin": "mungere/menare, rompere, schiacciare, scalfire, sbucciare, succhiare, tirare il c…".
"Avéi o belin inverso (o inböso)": essere in gran collera, essere di malumore.
"Avéine o belin pin": essere all’ estremo limite della pazienza, o averlo superato.
"Battisene o belin (inti schéuggi)": non darsi pensiero, non preoccuparsi, fregarsene (negli scogli)
- Ma chi è accusato a torto di ciò, può controbattere:
"In sce ‘n ‘articiòcca": "su un carciofo"; che non è cosa di poco conto.
"Fâ di discorsci do belin": "fare dei discorsi (o ragionamenti) del c…" (cioè sciocchi, futili).
"Fâ rîe o belin": si dice di parole o decisioni molto sciocche.
Levâse co-o belin amâo": "alzarsi col c… amaro" svegliarsi di cattivo umore.
"No distingoe o belin da-a còrda": non avere nessuna capacità speculativa.
"Portâ via o belin": andarsene bruscamente.
"Rataieu da belin": "trappola da c…" (si riferisce a donna decisamente non casta).
"Tocâse o belin co-a camîxa": "toccarsi il c… con la camicia" (mostrarsi straordinariamente casto o schizzinoso, affettare modi esageratamente raffinati)
"Travaggio do belin": "lavoro del c…" (impresa ardua, ma anche - secondo i casi - lavoro molto facile, sciocco).
"Un belin che te neghe": "un c… che ti strozzi" (esclamazione imprecativa).
"O deve avéi o belin a manego de paegoa": "deve avere il c… a manico d’ ombrello" così si ipotizza a proposito di persona dalle forme tutt’altro che armoniose; spesso, anche di chi, andando alla toilette, bagna tutt’attorno).
Locuzioni riferite a un pene di iperboliche dimensioni:
"Un belin ch’o pâ un figieu picin ch’o rîe": "un c… che pare un bambino piccolo che ride".
"Un belin che se ti gh’apendi un cavagnin, o pâ un figieu ch’o vadde a l’azilo": "un c… che se gli appendi un cestino, pare un bimbo che va all’asilo".
"Un belin che se ti ghe metti ‘na beretta o pâ un garaventin": "un c… che se gli metti una berretta pare un garaventino" (cioè un marinaretto della Nave Scuola Garaventa).
Espressioni allusive:
"O l’à a mêz’asta": "l’ha a mezz’asta" (è incapace d’erezione).
"O l’à coscì picin, che se o dâ da mangiâ a un gatto de venardì, o no fa manco pecòu": "l’ha così piccolo che se lo dà da mangiare a un gatto di venerdì (evidentemente quando era ancora prescritto il magro) non fa neppure peccato".
"Ti te l’æ mâi visto a-o ciæo da lùnn-a? ": "te lo sei mai visto al chiaro di luna?" (espressione usata nei confronti di chi formula una richiesta assurda, pretende impresa irrealizzabile).
"Òmmo picin tutto belin": "uomo piccolo tutto c…." (a confronto dell’uomo non dotato di imponente statura).
"Chi l’à ciù gròsso de mi, l’à gonfio": "chi l’ha più grosso di me, l’ha gonfio".
"Cangiâ l'ægoa a-o canâio": "cambiare l’acqua al canarino" (orinare).
"Pociâ o beschéutto": "inzuppare il biscotto" (avere un rapporto sessuale).
CONCLUSIONE
Non possiamo terminare questa nostra stravagante escursione … senza elencare i principali sinonimi di Belin:
Affare, Anghilla, Anghæzo, Beschéutto, Canâio, Canetta, Canociâle, Cantabrùnn-a, Caròttoa, Ciciòllo, Manubrio, Macacco, Nenne, Oxello, Pigneu, Pistòlla, Pinfao, Radiccia, Suchin.
Per ovvi motivi estetici… mi scuso per la mancata pubblicazione di foto sull’argomento!
CARLO GATTI
Rapallo, 26 Aprile 2018
GENOVA - LA CASA DEL BOIA
GENOVA - LA CASA DEL BOIA
Il porto antico, il cuore della città vecchia dove è nata la Serenissima Repubblica di Genova, spazia dal Mandraccio al Galata e nasconde molti segreti spesso sconosciuti agli stessi genovesi.
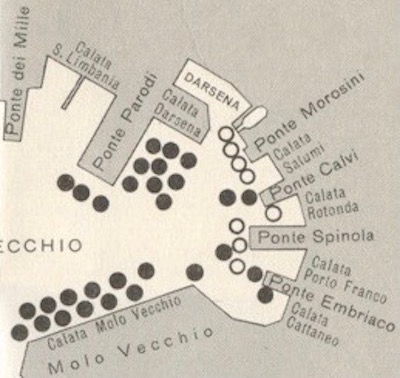
Dalle Calate Interne del Porto Vecchio, oggi chiamato Porto Antico, mille anni fa partivano i crociati per la Terrasanta dopo aver alloggiato nella retrostante COMMENDA di S. Giovanni in Pré. Da qui è passata la storia del capoluogo che dura da un millennio, ma questa Genova, “con quella faccia un po’ così…” conserva ancora la curiosa espressione di chi scopre facce sempre nuove, senza chiedersi se hanno una casa o una nave come casa.

Genova - Oltre alla simpatica nomea dei genovesi legata alla dubbia accoglienza, alla poca propensione nello spendere qualche soldino in più e al talento olimpionico per il mugugno, il genovese vive la sua quotidianità con eccessiva abitudine: come ogni difetto porta con sè i suoi rischi, uno fra tutti quello di arrivare a pensare che nel capoluogo ligure le visite guidate si esauriscano con la casa di Cristoforo Colombo, la Cattedrale di San Lorenzo o le Torri di Sant'Andrea.

Non è così. Un esempio: avete mai visitato la Casa del Boia a Genova? Conosciuta anche come Casa di Agrippa, è un edificio del centro storico risalente all'XI o al XII secolo, situato nel quartiere del Molo, all'estremità orientale di Piazza Cavour, proprio di fronte all'ex mercato del pesce.
Un'ottima idea per una visita guidata alternativa. Curiosi di visitarla? Il bello è che si può fare, grazie alla Compagnia Balestrieri del Mandraccio, che ha fatto della Casa del Boia la sua sede e che periodicamente organizza visite guidate. Dopo essere rimasta chiusa per un periodo a causa di lavori di ristrutturazione, ora la Casa del Boia è pronta ad accogliere i visitatori: eccezionalmente, la prima visita guidata è stata fissata per domenica 11 marzo 2018. Ne seguiranno altre.

Entrata della Casa del Boia, o casa di Agrippa

La freccia rossa indica l’esatta posizione un po’ anacronistica e surreale della Casa del Boia in Piazza Cavour sotto la “sopraelevata”. C’é un cumulo di pietre nella congestionata Genova di oggi che chiude a levante il Centro Storico più grande d’Europa, oltre il quale inizia la città moderna con corso Aurelio Saffi che sale e poi scende verso la Fiera del Mare.
Questo petit ensemble di rovine antiche, (indicato dalla freccia rossa nella foto sopra) é la cosiddetta Casa del Boia che tutti i rappresentanti istituzionali della città di Genova hanno inteso conservare nei secoli quale monito rivolto al passante affinché non perda la memoria dei tempi oscuri quando le parole: democrazia e giustizia avevano un significato che nel tempo si era allontanato a dismisura dagli ideali del mondo greco antico dove erano nate.
PIAZZA CAVOUR
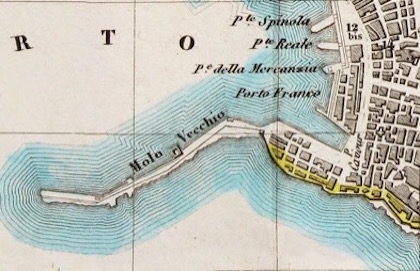
Notare nel quadrato a destra in basso: la scritta Piazza Cavour in cui si trova la Casa del Boia a pochi metri dal porto. (carta P.Allodi 1855)
Dietro le “calate interne”, a destra nel disegno sopra, c’é piazza Cavour che, con la sua lunghissima storia, é uno dei più antichi siti di Genova. Dopo le Crociate, da qui prendevano il mare i condottieri delle flotte genovesi, e la consuetudine si protrasse sino alla metà del 1400. Un imponente corteo accompagnava l’ammiraglio dalla cattedrale di San Lorenzo al luogo d’imbarco, dove si congedava dai nobili e dagli anziani tra squilli di trombe, salve di bombarde e i suoni a distesa delle campane.
Le case di allora sorgevano sulla piazza – e di cui alcuni resti sono incorporati nelle costruzioni attuali – appartennero agli Embriaci, ai Mallone ed ai Castello. Nei secoli passati vi si tenne anche un mercato di erbe e verdure.
La CASA DEL BOIA è conosciuta anche come la CASA DI AGRIPPA. Risale infatti al ritrovamento, nel 1902, in un edificio attiguo, di un'iscrizione riferita a Marco Vipsanio Agrippa (63 a.C. – 12 a.C.), genero di Augusto, che ebbe un importante ruolo politico al tempo della transizione tra repubblica e impero. La scoperta avvenne quando, nel corso di lavori di ristrutturazione di un edificio medioevale adiacente alla Casa del Boia, vennero alla luce resti di una costruzione di epoca romana imperiale, datata al III secolo, con una pavimentazione in lastre di marmo, una delle quali riportava la dedica ad Agrippa, recuperate da un precedente edificio del I secolo d.C. ed oggi conservata nel museo archeologico nella villa Pallavicini di Pegli.
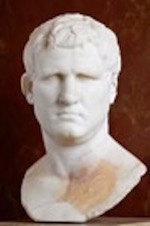
Busto di Marco Vipsiano Agrippa
Marco Vipsiano Agrippa é stato un politico, ammiraglio della flotta romana e architetto. Amico di Ottaviano il futuro imperatore Augusto, fu suo fedele collaboratore e anche suo genero. Agrippa fu artefice di molti trionfi militari di Ottaviano, il più considerevole dei quali fu la vittoria navale nella battaglia di Azio contro le forze di Marco Antonio e Cleopatra.

Sul frontone del Pantheon a Roma si legge: Marco Agrippa, figlio di Lucio, Console per la terza volta, edificò.
Nella foto sopra vediamo il frontone del PANTHEON di Roma sul quale l’imperatore Adriano (76 d.C.- 138 d.C.) volle ricordare l'architetto originario, e ripristinò l'iscrizione commemorativa di Agrippa "M. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT"), in bronzo, quale oggi si vede: l'attuale è tuttavia una copia di fine Ottocento, al posto dell'antica scritta che fu depredata in una delle tante razzie.
Ma ora ritorniamo un po' alla curiosa storia della CASA DEL BOIA.
Questa tradizione popolare derivava dal fatto che le esecuzioni avvenivano presso il vicino Molo Vecchio.
L'attuale edificio è solo una piccola porzione di quello originario, che si sviluppava su più piani e probabilmente si estendeva per tutta la larghezza della piazza, tra il camminamento delle mura delle Grazie e il duecentesco carcere della Malapaga, in cui erano rinchiusi i debitori insolventi. L'edificio è conosciuto soprattutto perché tradizionalmente era ritenuto l'abitazione di colui che eseguiva le pene capitali al tempo della Repubblica di Genova e per questo era detto comunemente Casa del Boia. La costruzione invece, più verosimilmente è medievale, dell’XII° sec. ed è ciò che rimane di un’abitazione civile, probabilmente appartenuta ad un pescatore, poiché la zona allora si trovava proprio a picco sul mare che era ove adesso si trova l’ex mercato del pesce. I genovesi conoscono questa costruzione come “Casa del Boia”, perché è certo che durante le vicissitudini della città dal XII° al XV° sec. le condanne capitali venivano eseguite proprio qui al molo e quindi la leggenda ci tramanda questo sito come l’alloggio del boia quando veniva chiamato a Genova da “fuori” per fare il suo lavoro.

Genova - Piazza Cavour, vicino al porto antico, c’ è un relitto di casa dell’XI secolo che viene chiamata la Casa del Boia. Nella foto é ripresa l’entrata. Il Ministero della Cultura l’ha data in concessione alla Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio. Questo edificio si ritiene per tradizione popolare fosse la casa di chi eseguiva le pene capitali al tempo della Serenissima Repubblica di Genova.
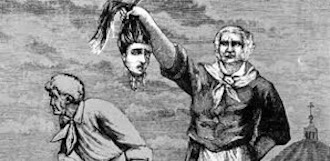

Qui il boia trascorreva la notte prima dell'esecuzione capitale assieme ad un aiutante chiamato tirapiedi, perché una volta aperta la botola dell'impiccato aveva il compito di strattonarlo al fine di velocizzare lo strangolamento. Ecco perché il servitore fedele, ma senza autonomia si chiama ancora oggi tirapiedi.


Dopo un lungo periodo di abbandono, nel 1988 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali lo ha dato in concessione alla Compagnia Balestrieri del Mandraccio, che grazie a lavori di recupero architettonico, nel 1990 vi ha aperto la propria sede sociale, arredando l'interno in stile quattrocentesco ed allestendovi un'esposizione di armi, armature e costumi di epoca medioevale.
CONCLUSIONE
Concludiamo l’argomento prendendo in prestito dal sito di Miss Fletcher una foto emblematica….
Vi lasciamo al suo commento originale:
“Si dice che nel XI secolo fosse questo il luogo presso il quale il boia compiva le sue esecuzioni.
Forse è realtà o forse è leggenda, derivata dal fatto che, al Molo, realmente si compivano le esecuzioni.
Tuttavia, circostanza ancor più strana ed ammantata di mistero, nel palazzo di fronte, ad angolo tra Via del Molo e Piazza Cavour, all’ultimo piano, in prossimità di un terrazzino, nel muro, c’è una scultura, che potrete vedere soltanto salendo i gradini di Piazza Cavour e puntando lo sguardo oltre la Sopraelevata.

E’ una testa, proprio di fronte alla casa del Boia.
Svariate e differenti sono le interpretazioni in merito a questa inquietante scultura e io davvero non saprei dirvi quale sia veritiera, mi limito a riportarvele, così come le conosco.
Il Miscosi, noto studioso delle storie di Genova, sostiene si tratti della testa di Giano, altri raccontano che schizzavano fin lassù le teste mozzate dalla scure, altri ancora sostengono che proprio lì sia murata la testa del temibile boia. Non so proprio quale sia la verità ma, in ogni caso, la scultura ha un aspetto decisamente sinistro”.
GATTI CARLO
Rapallo, 18 Aprile 2018
MUGUGNO ALLA GENOVESE...
MUGUGNO ALLA GENOVESE ...

La necessità “de mogognâ” dei marinai è un forte desiderio a non subire “chi gestisce il potere”; tanto da poter difendere i loro diritti, addirittura non rendendoli commerciabili. Questi “prestatori d’opera” hanno dato dignità al loro lavoro! Una forma embrionale di Democrazia. (Marcello Carpeneto)
Oggi il mugugno è un segno d’identità della città ma anche dell’intera regione, riconosciuta per la sua gente chiusa e stondäia (brontolona), apparentemente restia all’accoglienza e al turismo.
Un po’ di Storia
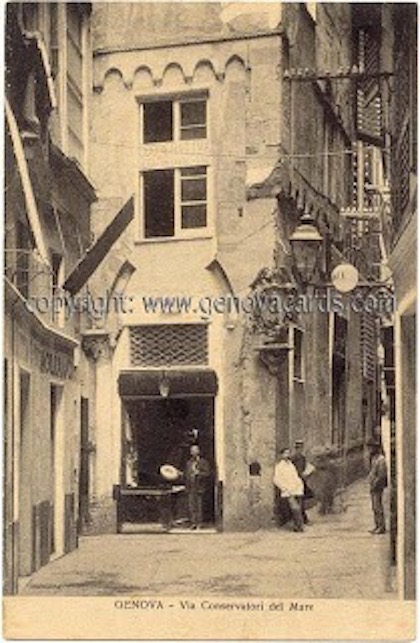
Genova - Via Conservatori del Mare

"Le mampae di Via dei Conservatori del mare". Cartolina tratta dalla collezione di Stefano Finauri.
Imboccando questo vicolo si vede ancora oggi una piccola lastra di marmo, doveva esserci l’apposita cassetta per gli avvisi per quegli illustri magistrati.
Ecco, per le denunce e i mugugni di competenza dei Conservatori del Mare bisognava venire qui!
La Magistratura dei Conservatori del Mare era la più antica Istituzione genovese che si occupava della sicurezza del porto e pure delle cause inerenti i sinistri marittimi. Questo organismo aveva sancito, fin dal 1300:
IL DIRITTO AL MUGUGNO
“Ius murmurandi”
Pare che tale privilegio sia stato accordato per la prima volta ai marittimi camoglini, la cui fama se l’erano guadagnata già nei tempi antichi per aver solcato e cavalcato i mari con sempre più crescenti successi. Una simile richiesta, proveniente da una “casta” benemerita, non poteva rimanere inevasa, anche perché si trattava della richiesta di un diritto che aveva un prezzo, anzi due tipi di ingaggio:
“il primo prevedeva paga elevata e niente mugugno, il secondo paga decurtata e diritto a lamentarsi”.
Nacque così, da origini marinare ben documentate, uno stile di vita che piano piano si estese a tutti i genovesi e i liguri in generale forgiando una mentalità sociale che si é protratta fino ai giorni nostri.
Gli armatori e i loro equipaggi, gli Agenti Marittimi, i Portuali e tutte le altre categorie del settore marinaro e portuale entrarono in questo modo di pensare che aveva come base fondante l’intolleranza a ricevere ordini ed ingerenze esterne che non si potevano accettare senza il diritto di mugugnare, quindi discutere “democraticamente”.
Seguendo il filone storico scopriamo che detto diritto/consuetudine trovò la sua pietra d’inciampo nel 1500 ad opera del grande Ammiraglio Andrea Doria che, temendo forse incrinature nella “disciplina di bordo”, preferì imboccare una strada più furba ma anche corretta sul piano della democrazia: “propose ai suoi equipaggi migliori condizioni di lavoro (ad esempio riduzione dei turni di voga) e alimentari (carne essiccata a bordo al posto delle solite sbobe) nonché un salario più cospicuo in cambio della rinuncia al mugugno”.
A questo punto possiamo aggiungere alcune riflessioni relative al mondo dei “bordi”. Chi ha navigato sa che gli ordini, per motivi di sicurezza, non si discutono, sia nella Marina Militare che in quella Mercantile. Questo concetto é sempre stato rispettato nella storia della navigazione fin dai suoi albori, pertanto é bene chiarire che il “mugugno” preso in considerazione in questa rubrica, ha dei limiti ben precisi rimanendo, si spera e si pensa, nell’ambito della dura vita del mare che va sempre tenuta sotto controllo, ma che mai può interferire con gli ambiti professionali della gerarchia di bordo.
Un altro interessante aspetto riguarda il CAMALLO DEL PORTO che di riflesso iniziò ad esercitare il diritto di mugugno percependo 9 soldi anziché 10 per una giornata di lavoro in porto, in compenso aveva il diritto di mugugno.
Si dice, fra i cultori della materia, che la percentuale di chi aderiva al diritto di mugugno fosse altissima tanto da potersi definire il mugugno come tratto distintivo del carattere di tutti gli “indigeni” della regione, alla faccia della presunta tirchieria…
Come scrive Miss Fletcher, un personaggio di grande simpatia e spessore culturale:
L’abitudine a lagnarsi è trasversale e assai diffusa, a Genova il mugugno è libero ed ogni occasione è buona per dar sfogo al proprio malcontento, si mugugna per il caldo e per il freddo, per le cose che non vanno e per quelle si vorrebbero in altra maniera, ogni circostanza può scatenare nuove lamentazioni.
Un’alzata di spalle, il sopracciglio che si inarca, il tono della voce che si fa cantilenante, il mugugno è un rituale e prevede una precisa gestualità. Al di là della propensione al mugugno, nella Superba ci sono tante persone creative e tenaci, vulcaniche ed entusiaste, animate da sincero desiderio di proporre alternative e continue occasioni di crescita per la città e per i suoi abitanti.
Esaltando le sue bellezze e le potenzialità, le ricchezze culturali e le possibilità, mostrando strade nuove da percorrere e modi diversi di guardare e di vivere i luoghi del nostro quotidiano, mettendo in risalto i lati positivi e ciò che altri non credono nemmeno immaginabile.
E questa per me è la Genova migliore, quella che sa fare la differenza.
Naturalmente cedere alla tentazione del mugugno è ammesso, lo facciamo tutti e può anche essere un peccato veniale se lo si fa con il giusto spirito, con una certa leggerezza, sapendosi prendere in giro e con la consapevolezza che lamentarsi e basta non serve proprio a niente.
ALBUM FOTOGRAFICO
LE METOPE SCELTE DA MISS FLETCHER RAPPRESENTANO IL MUGUGNO RIPRESO NELLE DIVERSE SUE ESPRESSIONI ARTISTICHE. FORSE NON E’ UN CASO CHE SI TROVINO SULLA FACCIATA DI PALAZZO TURSI, DIMORA ANNOVERATA TRA I ROLLI ED OGGI SEDE DEL COMUNE DI GENOVA.




Il commento di un anonimo genovese… al quale ci uniamo con simpatia!
MAGNIFICO….questo tuo post dove noi zeneisi siamo colpiti e affondati! azzeccatissimo…..ammia câa Miss semmou coscí còmme ti dixi ti…i discórsci
che gian insciú mogògno soun cæi e scetti “mogògno libberou” o ”levæme tùtto ma lasciæme ou mogògno ”, o ascí ” pe’ fâ andâ e cose drite ghé veu ‘na bella lite, niatri inte ‘na manea o natra douvemmou mogògnâ.
Ciâo grandiscimma, un grande abràsso e gràçie!
CARLO GATTI
Rapallo, 10 Aprile 2018
UN IMBARCO ISTRUTTIVO... GIUAN DI CARUGGI
UN IMBARCO ISTRUTTIVO…
Giuan di caruggi…


La NESSY FRIEND era una moderna petroliera dei primi Anni ’60.
Buona strumentazione, locali spaziosi all’americana, una palestra da ginnastica (rimasta sempre chiusa per ordine del Comandante) ed altri comfort che, al momento dell’imbarco, ci avevano fatto dimenticare i disagi raccontati da tanti marittimi imbarcati su carrette tirate su dal fondo nel dopoguerra. La nave aveva una potente turbina che ci spingeva a quasi 20 nodi ci velocità e i viaggi ci sembravano più corti, ma era solo un’impressione. La sala macchina era sempre pulita e gli ufficiali indossavano la tuta bianca come gli ingegneri di terra. Il loro “sano” ambiente sembrava appartenesse ad un’altra nave, o quanto meno ad un’altra famiglia, saggia e di buoni principi.
L’equipaggio era sottoposto alla universale legge del mare:
- - fare la guardia con scrupolo per partire, navigare e arrivare in sicurezza;
- - controllare la posizione della nave tre volte al giorno;
- - raschiare e pitturare in continuazione, anche in Golfo Persico in estate con 50°-60° di calore, non escluso i gavoni di prora e di poppa;
- - il radar era un ottimo Raytheon ma apparteneva ad una sola persona: il Comandante che non era uno stupido, tutt’altro! Ma per capire il suo modo di pensare e di agire occorreva aggiungere circa 130 anni ai suoi 45, e andare indietro nel tempo: al trasporto dei Coolies cinesi nelle stive da Macao al Perù… (Vedi su questo sito: NAPOLEONE CANEVARO, i COOLIES cinesi si ammuntinano).
Per lui la parola DEMOCRAZIA era svuotata di ogni significato in tutti i suoi pensieri, atti ed atteggiamenti.
L’equipaggio proveniva dalle due riviere, solo il Comandante, naturalizzato genovese, era di una città vicino a Napoli.
Quella nave aveva un solo difetto: batteva bandiera ombra - liberiana e l’unica legge vigente a bordo era quella del Comandante che, come avete capito era uno “padre - padrone psicopatico”.
La parte burocratica del viaggio: registrazione arrivi e partenze dai porti, le avarie della nave, del carico, sbarchi-imbarchi equipaggio, eventuali problemi di qualsiasi tipo (assicurazioni, perizie ecc…) erano “risolti” presso il Consolato Liberiano del porto scalato, il quale era del tutto disinteressato alle “beghe da frati” che accadevano tra i rissosi equipaggi latini…
A dire il vero il Comandante era un uomo di mare che conosceva alla perfezione il numero dei bulloni della “sua” nave, era un “tappo” che faceva coppia con il 1° Uff.le di coperta; avevano la stessa età ma tra loro c’era un abisso nell’intendere il concetto di normalità da applicare in un ambiente di lavoro difficile, insano e dislocato in mezzo al mare.
I due soggetti entrarono in conflitto fin dalla partenza da Palermo dove la nave aveva fatto lavori importanti sia in macchina che in coperta.
Quell’imbarco “sui generis” iniziò quando fu anche troppo evidente che i Sottufficiali di coperta prendevano ordini soltanto dal Comandante, in barba all’antica consuetudine di bordo che vede tuttora il 1° ufficiale assegnare ogni mattina i lavori giornalieri al nostromo, tankista, carpentiere e cuoco. Il 1° ufficiale del ponente ligure non accettò mai di essere messo da parte in quel modo scorretto e prepotente e da quel momento condusse una battaglia psicologica che caratterizzò e classificò quell’imbarco come il peggiore in assoluto vissuto da quell’equipaggio nella loro vita da naviganti.
Alla mafia dei “torresi”, così era configurata quella particolare situazione di bordo, si aggiungevano altre figure direi “intimidatorie” che seguivano fedelmente il Comandante ad ogni imbarco: uno era un gigantesco lericino, cameriere della mensa Ufficiali, quarantenne che pochi anni primi era stato campione di pugilato nella categoria dei mediomassimi. Poi c’era il suo cameriere personale, una specie di “rasputin” che aveva il compito di riportargli tutti i “ceti” che origliava tra le “sonorizzate” paratie della nave.
Comandante e 1° ufficiale si parlavano per interposte persone ed era ormai percezione comune che prima o poi ci sarebbe scappato il morto… Per fortuna non andò così, ma non mancarono le risse e le beccate tra questi due “pesi gallo”, qualche occhio nero, minacce di denunce che poi vennero sempre archiviate a causa della “disinteressata” bandiera liberiana…
Le disavventure di quell’imbarco durarono a lungo e peggiorarono quando la parte “normale” dell’equipaggio si accorse che le provviste “buone” della cambusa venivano sbarcate e contrabbandate nei porti dalla “famiglia caina”, e per l’equipaggio rimaneva soltanto da consumare il cibo in scatola.
Questa fu l’atmosfera che respirai al mio primo imbarco da Allievo Ufficiale di coperta che mi vide subito schierato, direi “appiccicato” al 1° ufficiale perché da lui dovevo imparare il mestiere, sia durante le guardie in navigazione, sia in segreteria, sia nella gestione del carico.
Un imbarco sfortunato e scioccante che per fortuna si concluse dopo 7 mesi e 24 giorni quando il santo protettore dei marittimi s’impietosì al punto da dire: “ora basta”!

Il Golfo Persico


Il monte Fuji detto anche Fujiyama
La nave, dopo sei viaggi consecutivi Golfo Persico - Giappone, ne fece un altro per Luanda (Angola) e poi finalmente si verificò il miracolo che nessuno aveva osato immaginare: il viaggio per Genova, dove ¾ dell’equipaggio sbarcò per motivi personali… senza doversi pagare il viaggio di rientro, per esempio dal Giappone, e neppure quello del rimpiazzo subentrante.
Solo in questo modo il nostro “dimagrito” equipaggio ebbe il suo giorno della liberazione!
Un imbarco così disastroso avrebbe meritato di essere analizzato da una commissione di psichiatri e non solo… anche perché non poteva che concludersi con un finale altrettanto “psicopatico”; vi anticipo che non fu tragico come l’immaginazione di ognuno potrebbe suggerire, ma fu di tutt’altro tipo che definirei comico… giudicate voi stessi!
Direi quindi che lo scopo di questo memory non é quello di coinvolgere il lettore nella storia “pietistica” del mio primo imbarco che potrebbe interessare solo una piccola parte dei miei conoscenti; ma piuttosto l’esperienza che ne derivò dall’aver scoperto quanto la solitudine del marittimo sia la causa di tanti malesseri che sono difficili da spiegare alla gente di terra che ogni sera, nella propria oasi famigliare, scarica le tensioni e poi “risorge” per affrontare lo stress del giorno dopo nell’ambiente che gli dà le risorse per vivere.
Vi devo subito presentare l’elemento “chiave” di quell’avventuroso arrivo a Genova.
Giuan di caruggi, imbarcato sulla Nessy Friend con la qualifica di “giovanotto di coperta”, era la sagoma di bordo, ovvero il “giullare” di quei pochi momenti di relax che erano rimasti tra un programma e l’altro di RADIO CUCINA che annunciava solo casini…

Giuan nel suo regno
Giuan era una leggera da angiporto, una specie di saltimbanco, di scimmia ammaestrata, che prendeva tutti per il culo senza offendere nessuno, rispettava i graduati ma con loro scherzava sempre tra ironia e satira e non andava mai sopra le righe. Il suo pensiero era uno soltanto… “prima o poi ve lo metterò in quel in posto…”.
Aveva ragione! Il suo momento di gloria non tardò ad arrivare, l’home-voyage per i Porto Petroli di Multedo-Genova era stato annunciato giusto in tempo per fargli organizzare un “progetto di rapina ad hoc”.

In quegli anni il Giappone viveva il suo magic moment tecnologico ed aveva imposto sui mercati internazionali il primato di qualità e quantità di macchine fotografiche, walky-talkie, radio di ogni tipo, altoparlanti, binocoli e registratori. I marchi Minolta, Canon, Yashica, Fuji ed altri che non ricordo, erano sulla cresta dell’onda ed i lettori con i capelli grigi li ricorderanno per aver caratterizzato i mitici anni ’60, un decennio reso famoso per il boom economico che rappresentò il più importante rinnovamento, anche generazionale, del secolo scorso.
L’Estremo Oriente, tra cui le città-stato: Hong Kong e Singapore, aveva il monopolio della costruzione e della vendita di questi richiestissimi prodotti altamente sofisticati che si trovavano sparsi nelle vetrine di tutti i mercati del mondo. Tuttavia, a questo enorme “laboratorio” ufficiale, si associava un altro mercato parallelo che viveva sottobanco ed alimentava il contrabbando internazionale specialmente negli angiporti europei.
Tra i marittimi c’era una specie di malattia da competizione tra chi riusciva a farne incetta con il miglior rapporto prezzo/qualità, ma quegli apparati avevano il fascino della modernità orientale: antenne lunghe e tante minuscole manopole che miglioravano i suoni e le musiche secondo parametri a noi sconosciuti. Le “voci dall’Italia” giungevano chiare di notte sulle onde corte “e il naufragar (dello spirito) m’era dolce in questo mare”.
Anche il look era particolare: prevaleva il colore nero lucido con strisce metalliche lucenti che davano eleganza e mistero all’oggetto.
In Giappone i loro prezzi erano di gran lunga convenienti, circa un terzo del valore pattuito di contrabbando in Italia, insomma si trattava di un business molto ambito da tutti i marittimi in circolazione in quel periodo! Guadagnarsi un extra stipendio era il sogno che spesso faceva dimenticare le disavventure di bordo, la nostalgia e la lontananza dall’Italia.
Forse avrete già capito il senso del contendere: sei viaggi per il Giappone in quel periodo potevano valere una fortuna per i contrabbandieri di alto bordo, ma anche per i marittimi di un certo tipo…

Purtroppo l’ingenuità dei marittimi più abbelinati stava per scontrarsi con la strategia dell’astuto Giuan di caruggi!
Arrivammo a Genova nel tardo pomeriggio. I piloti del porto ci avvisarono che l’ormeggio al porto Petroli di Multedo si sarebbe liberato soltanto dopo qualche giorno e il Comandante fu invitato a dare fondo l’ancora garantendo l’ascolto continuo per eventuali istruzioni.
Il Comandante abitava a Genova-Sturla per cui decise di dare fondo in quella zona per poter salutare sua moglie con il fischio di bordo.
Non essendo la nave in “libera pratica” (sanitaria) era tassativamente proibito all’equipaggio trasferirsi a terra con qualsiasi mezzo si fosse presentato sottobordo.
“Fatta la legge trovato l’inganno” !
Giuan di caruggi conosceva il Codice della Navigazione più di tanti esperti ufficiali di bordo e trovò il modo e la maniera di “portare in porto…” il suo sogno!
Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni di bordo, verso le due di notte un motoscafo o qualcosa del genere, si affiancò a luci spente dal lato di sottovento dov’era pronta una biscaglina pronta ad essere calata in mare al segnale pattuito.
In pochi minuti 20 valige piene di prodotti giapponesi, furono calate sulla lancia tramite due heaving-line, con la PROMESSA che sarebbero state occultate in un magazzino costiero nella vicina Sturla, nell’attesa di essere ritirate, previa compensa, dai proprietari che mai sarebbero passati da un varco doganale del porto di Genova per pagare le dovute tasse allo Stato italiano.
Il cliente più diffidente dell’equipaggio, all’ultimo momento ebbe qualche dubbio e chiese a Giuan di caruggi delle garanzie sull’intera operazione: costi e recupero della merce. Evidentemente non era tutto chiaro! Ma a quel punto venne fuori la prontezza di spirito e la genialità di Giuan il funambolo il quale, messo un po’ alle strette, dichiarò solennemente:
“Io sono la vostra garanzia. Seguirò la merce fino a destinazione. Sparirò dalla nave per qualche ora, vi lascio i miei documenti e i miei averi in consegna, ecco le chiavi della cabina e del mio armadietto. Se nel frattempo mi cercassero, voi non sapete nulla e non avete visto nulla! Rientrerò in tempo per fare la mia guardia in coperta. State tranquilli! Sistemerò io le vostre valige e al momento giusto festeggeremo il business nel miglior ristorante di via Pré!”
La merce lasciò la Nessy Friend scivolando via tra le acque amiche velate di tramontana e di tanto mistero!
A questo punto anche il lettore meno smaliziato avrà capito che quella notte Giuan di caruggi passò al comando di quel motoscafo-fantasma e sparì per sempre… chissà dove… chissà con chi… e di lui non si seppe più nulla, for ever!
A bordo, il giorno dopo, in tanti piansero rendendosi conto di non poter mai più rivendicare la loro merce di contrabbando… altri se la risero di nascosto ma con l’amaro in bocca per non aver sconsigliato con più veemenza quella pazza idea al loro compagno di bordo e di sventura.
Chi scrive ebbe un’altra storia: quella di sentirsi totalmente “abbelinato” per circa sette mesi! Poi, quando ormai si era convinto d’aver sbagliato tutto, improvvisamente, si vide consegnare presso le FFSS di Rapallo un gran bel pacco con tutto quello che aveva comprato e spedito da Yokohama seguendo il consiglio di un anziano giapponese in kimono che lo aveva intenerito con i suoi numerosi inchini di rispetto e per l’antica saggezza che emanava sotto i baffi e la barba bianca, lunga e appuntita.
Il pacco, imbarcato chissà su quale misterioso treno, attraversò tutta l’Asia imballato a regola d’arte, al punto che nulla fu danneggiato, neppure il servizio da tè, con le belle geishe in trasparenza sul fondo, che ancora oggi “sorridono” nel mio salotto buono…

In seguito si seppe che il Comandante cambiò velocemente Compagnia, forse trovò imbarco su una riedizione del Vascello Fantasma in compagnia dei suoi fedeli pirati… Il suo intimo motto era: Dopo di me il nulla! O forse “despues me Dios!”
Ma ne aveva anche un altro meno aulico e di più recente memoria:
“O con me o contro di me!”
Per ¾ dell’equipaggio sbarcante, quel diavolo di Comandante scrisse peste e corna, tra cui: “l’allievo di coperta non é navigabile”.
Quell’uomo mi aveva profondamente deluso: era un buon marinaio che conosceva tutti i segreti della nave… ma non era un conoscitore di uomini. Dote che in seguito ravvisai in Comandanti, in Direttori di Macchina e in tanti Ufficiali delle tre sezioni con i quali feci lunghissimi imbarchi. Di tutti loro conservo intatto il ricordo della loro umanità e qualità professionali che mi aiutarono a crescere!
Ma la domanda finale é questa: Quanti giovani allievi di coperta avranno rinunciato a battere le VIE DEL MARE per colpa sua?
Carlo GATTI
Rapallo, 25 Febbraio 2018
VITTORIO G. ROSSI GIORNALISTA, SCRITTORE E UOMO DI MARE
VITTORIO G. ROSSI
GIORNALISTA, SCRITTORE E UOMO DI MARE
Caduto nell'oblio?

Vittorio G. Rossi nel 1965

Quest’anno ricorre il 120° anniversario della nascita dello scrittore ed il 40° della sua morte.
« Si può amare una nave come si ama una donna, anche di più. Certo, una nave non si ama tutti i giorni, tutt'altro: vengono giornate in cui si maledice lei e chi l'ha fatta. Ma neanche una donna amata si ama tutti i giorni.»
(Vittorio Giovanni Rossi, "Pelle d'uomo", 1943 )
Un grande filosofo ha scritto:
“Gli avvenimenti della nostra vita sono come le immagini del caleidoscopio nel quale ad ogni giro vediamo una cosa diversa, mentre in fondo abbiamo davanti agli occhi sempre la stessa.“
Noi crediamo che la vita di Vittorio G.Rossi, “giramondo innamorato del mare”, si presti ad essere sbirciata attraverso il tubo magico del caleidoscopio. Ed ora ci proviamo…
Vittorio Giovanni Rossi (Santa Margherita Ligure, 8 gennaio 1898 – Roma, 4 gennaio 1978) è stato un giornalista e scrittore italiano.
Nato da padre lombardo e madre ligure, dopo il diploma di capitano di lungo corso ottenuto al'Istituto tecnico Nautico di Camogli, venne ammesso all’Accademia navale di Livorno come allievo ufficiale di complemento. Subito dopo la Prima guerra mondiale fu inviato - a vent'anni – a Trieste col compito di riorganizzare la flotta abbandonata dalla Guardia di finanza austroungarica; promosso comandante e docente della scuola nautica da lui fondata per la Guardia di Finanza italiana in Istria, vi rimase otto anni. Nel 1925 firmò il Manifesto degli intellettuali fascisti.
Trascorse lunghe licenze viaggiando per tutto il mondo su navi mercantili e scrivendo instancabilmente.
È stato inviato speciale del Corriere della Sera ed Epoca, ma nel corso di quel viaggio raramente interrotto che fu la sua vita fu anche occasionalmente marinaio e timoniere, palombaro e pescatore, carovaniere e minatore. Nel 1944 gli fu assegnato il Premio Mussolini dall’Accademia d’Italia, ma Mussolini d'imperio lo cancellò per darlo all'antifascista Marino Moretti.
È stato anche il primo giornalista italiano non comunista ad entrare nella Russia sovietica, dopo la seconda guerra mondiale. Fu lo stesso Governo italiano dell'epoca a mediare per l'ottenimento del visto. Di questo viaggio è testimone il libro Soviet, del 1952.
È sepolto nel cimitero di Santa Margherita Ligure, dove ha sede anche il museo a lui dedicato, situato all'interno di Villa Durazzo-Centurione.
“Siamo nuovamente in guerra, una serie di conflitti diffusi che si richiamano alle religioni e alle civiltà e in questo pentolone i parlatori di mestiere hanno buon gioco.
C'è una differenza fondamentale tra la nostra e le altre religioni: la confidenza, come la chiamo io. Nelle altre religioni non c'è questo rapporto di quasi familiarità.
Te lo spiego.
Noi, quando assumiamo l'ostia sacra, il Corpo di Cristo, cioè Dio, stiamo generalmente dritti in piedi come se fosse pane.
Noi ci rivolgiamo a Dio, e lo chiamiamo Padre Nostro che sei nei cieli.
Nelle religioni che ho conosciuto non ho mai sentito chiamare Dio con tanta confidenza e dolcezza come Padre Nostro.
E questo Padre l'ho sentito tante volte in mare, nei momenti più difficili, e le decisioni le prendeva lui”.
Vittorio G. Rossi
( Da Colloqui con VGR di Decio Lucano )
I libri Oceano, Maestrale, Il granchio gioca con il mare, Il cane abbaia alla luna, La pelle dei marinai crude oil in Golfo Persico; il mio abbigliamento preferito era un cofanetto con i libri di Vittorio G.Rossi. ed altri sono stati i miei più cari compagni di viaggio sulle petroliere e in seguito sulle navi passeggeri. Sulle prime imbarcavo con il sacco da marinaio sapendo che sarei andato incontro alla reclusione tra quattro lamiere per oltre un anno in mezzo al mare e non dovevo indossare divise ed abiti eleganti per andare a caricare il crude oil in Golfo Persico; il mio abbigliamento preferito era un cofanetto con i libri di Vittorio G.Rossi.

Istituto Tecnico nautico Cristoforo Colombo - Camogli

Da sinistra: Vittorio Massone, Ernani Andreatta, Bruno Gazzale, Pro Schiaffino, Carlo Gatti, Mario Peccerini.
Lo conobbi a Camogli in visita al suo Vecchio Istituto Nautico di Camogli, era già anziano, ma capii subito che lui era un professore, non tanto di navigazione ed astronomia, ma dello spirito, della coscienza e della conoscenza del MARE che lui emanava come fosse il mare e noi gli studenti marinai…
Emanava esperienze “salate” che già mi portavano al largo verso il mio primo imbarco, tra gente con le ossa rotte dalla guerra che era ancora in guerra contro il mondo, uomini di mare accigliati, diffidenti, sospettosi in cerca di mine vaganti… ma era gente dal cuore tenero!
Erano le sue parole anche quando diceva: “ragazzi non vi preoccupate più di tanto, non siete voi a scegliere la carriera del mare, ma é il mare che sceglie i suoi “amanti” e poi li sposa per sempre! Non mancategli di rispetto. Temetelo ed amatelo!”
Avevo letto di recente il suo libro OCEANO
Oceano raccontava la navigazione del mercantile norvegese Galatea, partito da Bergen e diretto all'Avana, e vi cuciva intorno storie di marinai e di guerre, la Prima guerra mondiale, di pesca al merluzzo e di pesca alla balena, riflessioni sulla natura umana, descrizioni di paesaggi, con quello stile scabro che in parte gli era proprio e in parte gli veniva dalla frequentazione della letteratura realista anglo-americana. Il tutto era al servizio dell'entità sovrana e mobile che era l'Atlantico, mare freddo e scuro, affascinante e minaccioso su cui Vittorio G. Rossi, capitano di lungo corso, si muoveva con attenta naturalezza:
Mentre il Mediterraneo è un mare intensamente popolato, e quindi il suo attraversamento è una storia di porti, incontri, vita, l'Atlantico sta su quella nave che lo attraversa, o altrimenti è una realtà costiera, da un capo all'altro dell'immensa distesa di mare che la separa. L'Atlantico, insomma, è l'imbarcazione che lo naviga, ovvero gli uomini che vi stanno sopra, le loro reazioni, le loro paure, o gioie.
Grazie ad altri sappiamo tutto sull'Oceano, ma non cosa significhi navigarci dentro. Vittorio G. Rossi ci fa accomodare a bordo.
In seguito ebbi la fortuna d’imbarcare su tre navi passeggeri e tra le migliaia di libri di bordo, scritti in tutte le lingue, c’erano anche i romanzi “vissuti” di Vittorio G.Rossi e non conobbi mai la solitudine del marinaio.
Ancora oggi sfoglio i suoi libri con infinita nostalgia riscoprendo la sua intatta forza narrativa: asciutta, precisa, diretta e in essa scopro tanta poesia nascosta… lontana dalle frasi ad effetto.
Qualcuno ha scritto:
Il suo rammarico per chi non comprende la bellezza del mare, né il valore di coloro che, uomini veri, ne affrontano i pericoli, è palese nella maggior parte dei suoi scritti. E che questo, per certi versi, accada anche oggi, ci porta a condividere il suo rammarico.
Il giornalista scrittore Francesco Amendola é andato giù duro…:
La cultura italiana ha la memoria corta; lo sappiamo.
Hanno la memoria corta, sovente per invidia e meschina gelosia, la critica e il mondo degli intellettuali «affermati» (e progressisti, si capisce: i veri intellettuali sono tutti progressisti; o no?); e ha la memoria corta, per superficialità e conformismo, il pubblico, sempre smanioso di novità e sempre pronto ad applaudire qualche nuovo idolo, nell'ambito letterario così come in quello sportivo, musicale e dello spettacolo.
Tuttavia, vi è qualche cosa di più, e di peggio, nell'oblio in cui è stata relegata l'opera di Vittorio Giovanni Rossi; qualche cosa che oltrepassa l'ambito della semplice ingratitudine, e che sembra evocare altre ragioni e altri scenari; quasi una calcolata vendetta postuma.
Sarà perché Vittorio G. Rossi, i suoi libri, li vendeva a tiratura altissime, anche se non aveva frequentato i canonici studi letterari e non aveva mai avuto a che fare con l'ambiente accademico, tanto meno si era trovato nella necessità (si fa per dire) di leccare le scarpe ai soliti baroni del palazzo.
Sarà perché i signori critici non lo avevano mai veramente apprezzato, avevano sempre mantenuto, nei suoi confronti un atteggiamento sussiegoso e supercilioso: tanto è vero che, in tutta la sua lunga carriera di scrittore, una sola volta si erano scomodati a concedergli un importante riconoscimento letterario: ed era stato il Premio Viareggio, per il romanzo «Oceano»; e questo quasi all'inizio di essa, nel lontano 1938.
Già, nel 1938: vale a dire, ai tempi del Fascio. E allora - tanto vale dirlo subito - una terza possibile ragione di questo oblio, che somiglia maledettamente a un complotto, potrebbe avere a che fare con quella firma di Vittorio G. Rossi, messa lì nero su bianco e più che mai politicamente scorretta (almeno dopo il ribaltone del 1943…) in calce al Manifesto degli intellettuali fascisti, redatto nel 1925 da Giovanni Gentile.
Vuoi vedere che abbiamo messo il dito sulla piaga giusta?
……………………..
Sta di fatto che si è trattato di una presenza decisamente atipica, nel panorama delle patrie lettere: uno scrittore che non viene fuori dal mondo dei libri e dell'università, ma dal mare: un capitano di lungo corso, uscito dall'Accademia Navale di Livorno, che ha passato tutta la sua vita sul mare e in lontani continenti; un uomo che, quando non navigava (ed è sua la frase che si può amare una nave esattamente come si ama una donna, e sia pure con momenti di stanchezza e di rifiuto), faceva il manovale o qualche altro strano mestiere «en plen air». Uno che - figuriamoci il dispetto dei nostri intellettuali, tutti topi da biblioteca: spalle strette e puzzetta sotto il naso - aveva la sfrontatezza di affermare che «bisogna scrivere con la propria pelle: cioè prima vivere, e poi scrivere».
Certo che aveva tutte le carte in regola per attirarsi l'eterna inimicizia di quella consorteria di eunuchi autoreferenziali che non perdonano a un «outsider», a un cane sciolto, tutto quel successo scandaloso, tutti quei libri venduti, tutto quel pubblico che andava pazzo per lui.

Ho riportato quasi interamente l’articolo di Francesco Amendola perché nella sua analisi tocca “nervi scoperti” che meritano attente riflessioni; tuttavia dopo aver riletto un ingiallito libro di V. G. Rossi: LA GUERRA DEI MARINAI edito da Bompiani nel 1941, quando il fascismo toccava l’apice del suo “rovinoso” successo, l’autore non dedica alcuna parola al regime. Mussolini non viene mai nominato. La politica non emerge in alcun modo, neppure di striscio…
La Marina Militare e quella Mercantile, si sa, erano orientate verso la monarchia, ma lo scrittore amava soprattutto il mare ed i suoi operosi marinai, al di sopra di ogni ideologia.
Ciò che invece affiora in ogni riga é lo stupore per l’abnegazione degli uomini di mare imbarcati sulle navi da guerra e sulle “carrette” mercantili.
Vittorio G.Rossi a pag.92 scrive:
“Quelli che fanno il Mare del Nord, mare dannato anche quando non c’é la guerra; nebbie, tempeste che strizzano il cuore come uno straccio, banchi e secche, e se c’é nebbia, sono ore tremende, paura di sentir d’attimo in attimo la prora dare nel banco, e col gran mare che fa laggiù, una nave incagliata é una nave persa, ondate paurose che schiodano la nave e la fanno a pezzi; nebbie e tempeste, e ora c’è la guerra, mare che la guerra ha fatto il più duro di tutti, mine dappertutto, mine a urto, mine magnetiche, mine in deriva; e i segnali della costa sono spenti, navigare a fiuto, ogni miglio rischiare
Cento volte di rimetterci la pelle; e poi ci sono i sommergibili e gli aerei, ci vuol poco a prendere nella nebbia, una bandiera per un’altra,
e un siluro fa presto a correre, una bomba, una spazzata di pallottole di mitragliera fa presto a piovere: e il “mercantile”, che ancora non é in guerra, “fa” il Mare del Nord, che é il mare più duro di tutti……
Un vero artista si vede dalla bocca; se la sua bocca ha pratica di masticare il ferro; nessuno può diventare un vero artista, se non ha provato a masticare il ferro…
La sua narrazione é un susseguirsi di fermo-immagini di un modo sconosciuto ai più, un film sempre attuale di una razza che sposa il mare e ne segue le sorti come un fatale destino che si perpetua da sempre: dagli Argonauti, a C. Colombo, dal Titanic all’Andrea Doria, fino a farci intravvedere il mare come una gigantesca tomba di famiglia dove tutto giace nelle profondità abissali in quel mondo di anime che solo il mare si é scelto.

Lo scrittore Vittorio G. Rossi conversa con Giuseppe Saragat
Colloquio immaginario con Vittorio G. Rossi
Se potessi incontrare lo scrittore di mare Vittorio G.Rossi gli direi:
Maestro, indipendentemente dalla bandiera, lingua, religione ed etnia, i marittimi provano gli stessi sentimenti di solidarietà e amicizia soprattutto quando – INSIEME – hanno superato grandi pericoli per la loro esistenza terrena.
Il mare unisce sempre, anche quando il destino umano corre sbandando sulla cresta di una gigantesca onda che divide la vita dalla morte. Il marittimo é sempre il più vicino a questa ineffabile frontiera che lui stesso ha scelto di sfidare tra un tramonto memorabile vicino a Dio e una tempesta di venti infernali. Il paradiso e l’inferno del marittimo si alternano e girano insieme sulla ruota del timone e della fortuna. Chi naviga lo sa e vive la sua religiosa solitudine specchiandosi nel mare blu dove vagano tanti spiriti che lo consolano sussurrandogli: “non sei solo!”
E lui mi risponderebbe:
Già! I vivi, i morti, i naviganti, gli spiriti, i gabbiani… tutti sotto lo stesso cielo che abbraccia sempre lo stesso mare! A volte per amore, a volte per morire insieme e poi risorgere.
Ma ora ritorniamo in questo contesto scolastico che mi riporta alla perduta gioventù… Tu hai letto il mio OCEANO e saprai che ci sono popoli che si svegliano ogni mattina con lo sguardo sull’oceano. Nel Nord Europa si usa andare a battere il mare molto presto, con qualsiasi tipo di nave, grande o piccola. Da quelle parti la mentalità marinara é un fattore antropico, figlio di un ambiente duro da affrontare e domare per via delle alte montagne che spingono i norvegesi ad avventurarsi verso l’Atlantico a cercare la sopravvivenza, un tempo solo per pescare, oggi anche per altri motivi legati alla ricerca del petrolio ed hai commerci marittimi di ogni tipo.
La Norvegia, per fare un semplice esempio, dispone oggi di una flotta di navi tra le maggiori al mondo ed ogni norvegese é consapevole d’avere nelle proprie vene sangue vikingo. Tutta la nazione ha, per questi motivi, una caratura marinara molto accentuata e, soprattutto, la Scuola Nautica é in linea con questo principio comportamentale, che impone all’allievo l’alternanza dello studio teorico nelle aule scolastiche con periodi d’imbarco sulle navi al fianco di marinai e ufficiali professionisti con i quali approfondire la loro preparazione.
Anche l’Italia ha una storia di “grandi navigatori medievali” ad alto livello marinaro, ma la mentalità che dilagò nei secoli successivi, tradì quel mondo delle scoperte dell’oltremare per non aver saputo gestire politicamente le nuove terre. Si può anche dire che abbiamo avuto dei grandi navigatori senza una politica alle spalle che sapesse mettere a frutto i loro sforzi ed il loro coraggio.
La nemesi storica… si ripete anche oggi! I migliori cervelli allevati in Italia scappano all’estero, a loro vengono preferiti i VOTI della mediocrità politica!
Questo distacco dal mare oggi é definito da una piccola cifra: soltanto il 5% degli Allievi Nautici del nostro Paese prende la Via del Mare per intraprendere la carriera da ufficiale.
Infatti, fin dalla tenera età, un giovane deve sapere a cosa va incontro attraverso esperienze progressive che lo fanno maturare, oppure lo fanno desistere dal continuare la vita di mare per la quale non é tagliato.
La Scuola Nautica del Nord Europa si é da tempo adattata al mondo globale del mare dove esistono poche regole da seguire, semplici ma ferree:
- Chi frequenta questa Scuola deve essere preparato a diventare un uomo di mare universale, globalizzato che si sposta in continuazione senza sosta, senza farsi problemi politici, religiosi e di ogni altro tipo.
- La lingua del mare é l’inglese, la Seaspeak. Questa lingua gli permette di navigare e lavorare senza problemi, ma la deve conoscere alla perfezione perché una cosa é certa: nella sua vita di marittimo parlerà di più la lingua inglese che quella di casa.
- Possiamo concludere con una osservazione di carattere generale:
- L’Italia non regge il confronto con la scienza museale marinara del mondo cosiddetto civile.
- Non solo il nostro Paese ha pochissimi Musei Navali, ma non riesce a conservare reperti e ricordi di navi famose che possano infiammare l’entusiasmo dei giovani.
- La cultura marinara dell’Italia é affidata agli ultimi Mohicani che dedicano tempo e denaro con un impegno personale che ha prodotto ricerche e “chicche storiche” ogni giorno, ma questi frutti, per quel che si vede, non sono destinate a dare germogli.
- Lo Stato, la TV e i mass-media in generale ignorano del tutto le nostre origini ed i fasti del passato di una antichissima civiltà marinara che si sviluppò lungo 8.000 km di costa e poi prese il largo verso gli Oceani.
- C’é ancora da sottolineare con amarezza il vuoto su cui “galleggiano” gli Istituti Nautici Italiani nei quali non si studia più la geografia, dove non si prende più in mano un sestante, dove nessuno ha ancora capito che la caratteristica principale di una scuola Nautica é la sua peculiarità internazionale, quindi l’uso di una sola lingua, quella del MARE, LA SEA-SPEAK !!!
- Io ero già in cielo quando ho sentito rimbombare l’ultima bestemmia contro il mare… l’abolizione del Ministero della Marina Mercantile avvenuto nel 1994. Ecco, io penso che l’inesorabile declino sia iniziato con la rinuncia a governare un mondo che solo chi ha navigato conosce i segreti per affrontarlo…
La ringrazio Maestro! Da lei ho capito tante cose, ma su tutte una : "Il Mare va temuto perché dietro quel fascino irresistibile che ci attrae, c'é un'immensa superbia che non perdona!
Joseph Conrad e Vittorio G.Rossi

Joseph Conrad
Figlio unico di Apollo Korzeniowski e della sua consorte Ewa Bobrowska, entrambi appartenenti a nobili famiglie polacche, Conrad nacque il 3 dicembre del 1857 a Berdyciv, in Podolia, attualmente sita in Ucraina, una regione parte del Regno di polonia fino al 1793 quando, con la seconda spartizione della polonia, venne annessa alla Russia zarista. Morì a Bishopsbourne il 3 agosto 1924.

Museo Marinaro di Camogli - Quadro di G. Roberto. Un quadro a tempera rappresenta la nave "Narcissus", di proprietà di un armatore Camogliese, sulla quale lo scrittore Polacco naturalizzato inglese, Joseph Conrad navigò come ufficiale e alla quale si ispirò per scrivere "The Nigger of the Narcissus". Successivamente lo scrittore passò al comando della “Otago”, che rimase famosa poichè fu l'unica unità ad essere comandata dallo scrittore-capitano.
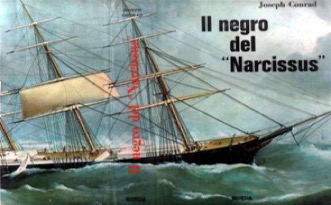
In Joseph Conrad c’é la ricerca interiore dell’anima del marittimo del suo tempo, il quale si agita tra le tante difficoltà razziali, religiose e politiche. Lo scrittore ne analizza gli aspetti psichiatrici come un professionista che é presente a bordo pur essendo nella posizione privilegiata di Primo Ufficiale oppure Comandante del “NARCISSUS”.
Vittorio G. Rossi racconta il marinaio che va incontro al mare consapevole di essere un predestinato alla sofferenza, alla solitudine ad un matrimonio difficile ma inevitabile, un rapporto che può finire da un momento all’altro, ma che sa dare giorni alterni di felicità e dolore. Il marinaio ha una sola risorsa da sfruttare: entrare in empatia con il mare-oceano per imparare a cavalcarlo, a domarlo.
A mio avviso tra i due grandi scrittori esiste un fattore di complementarietà che li unisce nel percepire questa vecchia, anzi antica razza come la più matura per esercitare una sorta di convivenza che li rende anonimi come quei reclusi di terra che nessuno conosce e vuol conoscere. Chi può dire di conoscere un marittimo se non é stato con lui tra quattro lamiere battute dall’oceano? Chi può dire di conoscere la paura del mare se solo pochi compagni di viaggio gli sono testimoni avendo ancora negli occhi gli stessi terribili colpi di mare?
In Conrad c’é una specie di pudore nel descrivere la sofferenza del marittimo; in Vittorio G.Rossi c’é la gioia di sopportare il peso della CROCE, un rito sacrificale mistico, molto religioso: qualcuno lo deve pur fare anche per chi non conosce oppure crede di conoscere come la famiglia che lo aspetta sulla costa ma che poi l’onda di riflusso se lo riporta via, ogni volta diverso, che parla lingue diverse, che chiama cambusa la cucina di casa, che chiama corridoio il cortile, che chiama gabbiani tutti gli uccelli che vede, che chiama mozzo il figlio più piccolo e così via.
In Conrad c’é la visione aristocratica di un mare che domina la scena. In Vittorio G. Rossi il marinaio ha capito che può essere salvato soltanto dalla conoscenza, dalla tecnica, dalla capacità di rinnovarsi nello scontro col mare che non é il male, ma come lo stesso nome un po’ si assomiglia…
Crediamo di fare cose utile al lettore segnalando i libri di Vittorio G. Rossi, ormai non facilmente reperibili, pur essendo passati pochi anni da quando venivano stampati a decine di migliaia di copie, e tradotti in tutto il mondo.
«Le streghe di mare» Milano, Alpes, 1930. «Tassoni», Milano, Alpes, 1931. «Tropici», Milano, Bompiani, 1934. «Via degli Spagnoli», Milano, Bompiani, 1936. «Oceano», Milano, Bompiani, 1938. «Sabbia», Milano, Bompiani, 1940.» «La pelle dei marinai», Milano, Bompiani, 1941. «Cobra», Milano, Bompiani, 1941. «Pelle d'uomo», Milano, Bompiani, 1943. «Alga», Milano, Bompiani, 1945. «Preludio alla notte», Milano, Bompiani, 1948. «Soviet», Milano, Garzanti, 1952. «Fauna», Milano, Bompiani, 1953. «Il granchio gioca col mare», Milano, Mondadori, 1957. «Cristina e lo Spirito Santo», Milano, Mondadori, 1958. «Festa delle lanterne», Milano, Mondadori, 1960. «La Terra è un'arancia dolce», Milano, Mondadori, 1961. «Nudi o vestiti», Milano, Mondadori, 1963. «Miserere coi fichi», Milano, Mondadori, 1963. «Il silenzio di Cassiopea», Milano, Mondadori, 1965. «Però il mare è ancora quello», Milano, Mondadori, 1966. «Teschio e tibia», Milano, Mondadori, 1968. «L'orso sogna le pere», Milano, Mondadori, 1971. «Calme di luglio», Milano, Mondadori, 1973. «Il cane abbaia alla luna», Milano, Mondadori, 1975. «Maestrale», Milano, Mondadori, 1976. «Terra e acqua», Milano, Mursia, 1988.
Vittorio G. Rossi era amico dei marinai anche a tavola
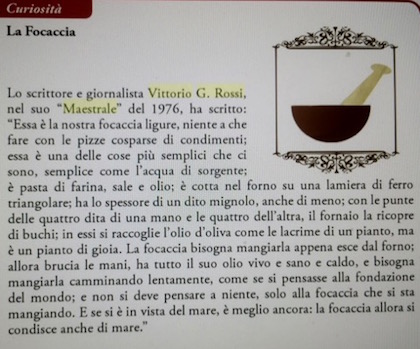

San Rocco di Camogli
Le gallette del MARINAIO

Le lettere di un affezionato cliente, il celebre Vittorio G. Rossi

Qui le Gallette del Marinaio sono una vera istituzione, al punto da aver fatto il giro del mondo e da essere state apprezzate da personalità illustri come Vittorio G. Rossi che ha riservato allo storico negozio dei Maccarini numerose dediche e riconoscimenti scritti.
CARLO GATTI
Rapallo, Venerdì 16 febbraio 2018