CANCARONE E VINO NAVIGATO
CANCARONE E VINO NAVIGATO

Quando nel 1956 feci il mio primo imbarco da mozzo su una piccola vinacciera, sentii che l’equipaggio chiamava sia il vino di bordo sia quello trasportato, con un nome curioso e suggestivo: CANCARONE. Ma nessuno a bordo conosceva l’origine di quel nome che mi ricordava i profumi della darsena e dell’angiporto di Genova. Ero un ragazzo, ma con un ramo di parentela nel basso Piemonte… per cui mi accorsi subito quanto fosse imbevibile quel liquido che non sembrava ricavato dalla fermentazione del mosto d’uva.
Mio cugino Francesco Fidanza dal Venezuela mi telefona: "alcuni gorni fa mi e’ venuto in mente: la parola CANCARONE che a bordo veniva servito nella classica caraffa di vetro, la raffinatezza era che veniva servito ‘freddo di frigorífero'. Nonostante tutto, si svuotava... e si poteva vedere la macchia rosso scura che lasciava quel liquido chiamato Cancarone. Poi, gli armatori meno spilorci, il giovedi e la domenica ci donavano il vino in bottiglia (con il tappo di sughero ) che era la versione di LUSSO dello stesso cancarone, in effetti se ne bevevi due gotti, ti veniva il mal di testa..."
L'amico Nunzio C. ricorda che alla fine degli anni '40, prima dell'avvento in Italia della Penna a sfera (la famosa biro), molti marittimi usavano il CANCARONE come inchiostro per scrivere a casa...
“La colpa é del mare mosso e delle vibrazioni del motore – mi spiegavano – che non permettono il deposito delle 300 sostanze di cui é composto il vino”.
Per una volta tanto la famiglia caino di bordo: “il cambusiere”, veniva assolto insieme ai suoi collaboratori della sezione cucina.
Tempo addietro trovai persino la definizione di questo strano nome: VINO CANCARONE
CANCARONE
Non è un tipo di vino né un nome. Si usa soprattutto in Liguria, la dizione si rifà ad un brano del celebre scrittore sanremese Italo Calvino per indicare un vino scadente, che costa poco e vale meno.
In certi ambienti viene usato anche un altro nome:
TRAGLIA
Qualcosa di scarsa qualità, generalmente riferita a vino o alcolici in generale. In un impeto di internazionalizzazione è stato anche sostituito con l’inglesismo "cancaron".
Espressioni collegate: "E’ una traglia" - "Che vino molto “cancaroni!"
Sono proposte di Max (Kroy), area genovese in particolare di Rapallo.
Nel novembre del 1932, entrò il linea il CONTE DI SAVOIA che fu il primo piroscafo a essere dotato di enormi giroscopi stabilizzatori per diminuire il rollio ed il beccheggio in caso di maltempo. Da quel giorno anche i SOMMELIER DA CANCARUN fecero un salto di qualità...
LA NOVITA’
Dopo tanti anni di oblio, é ritornata di moda un’altra definizione che però certifica un’altra tipologia di vini, questa volta di buona qualità:
VINO NAVIGATO

Albenga: La sezione di archeologia sottomarina, ospitata nel Palazzo Peloso Cepolla, pregevole edificio del primo Seicento, è sorta nel 1950 in seguito al ritrovamento, sui fondali dell'isola Gallinara, di una nave oneraria degli inizi del 1 sec. a.C. Nel Museo, in corso di risistemazione, sono esposti resti dello scafo, e materiali recuperati durante le varie campagne di scavo, e soprattutto un gran numero di anfore vinarie, collocate secondo la disposizione originaria del carico.
L’interno dell’anfora da vino era impermeabilizzato con pece e resine, da cui il termine "vino resinato", mentre l’imboccatura veniva chiusa con un tappo di sughero spalmato di pece ma anche da appositi tappi di ceramica sigillati con calce o pozzolana.

Portofino/Santa Margherita Ligure. Quelle anfore pescate il 27 maggio 2016, alla fine hanno condotto al vero tesoro: una nave da carico romana del II – I secolo a. C., affondata al largo di Portofino. Le anfore, riportanti i bolli del generale Lucio Domizio Enobarbo indicano con esattezza la loro provenienza, la fornace e lo schiavo che le aveva realizzate. Vista la loro grandezza, da subito si era ipotizzato che facessero parte di un grosso carico di vino di una nave di notevoli dimensioni.
Questi reperti archeologici della nostra regione, dimostrano che la storia del Vino Navigato si perde nella notte dei tempi e ci raccontano di quel vino ligure che viaggiava tra le sponde del Mediterraneo sulle navi onerarie romane e non solo, quando una su tre affondava a causa del Mistral, e le sopravvissute naufragavano prima o poi sulle coste della Riviera a causa del libeccio. Non é quindi un caso, che in seguito a questi naufragi esistano tante anfore recuperate che oggi rivivono nei nostri musei.
Non solo anfore potremmo dire, ma anche qualche segreto che oggi riemerge in forma direi turistica e commerciale.
Ma di cosa si tratta?
Si dice che furono i “marangoni genovesi” (sommozzatori e palombari, provetti nuotatori di superficie e in apnea, famosi fin dal 1300) a localizzare numerosi relitti romani recuperando le anfore che erano rimaste indenni dalle mareggiate. I nostri avi che erano più interessati al contenuto che alle anfore-container dell’epoca, fecero una interessante scoperta: quel vino navigato e invecchiato per un destino avverso… era migliore di quello di terra. Ma come spesso succede in questa terra ligure un po’ arcigna e impregnata dei “si dice…manaman”, certi segreti rimasero sepolti sul bagnasciuga dei porticcioli, forse all’interno di qualche calata privata e protetta, tana e patrimonio di pochi fortunati intenditori! Tuttavia qualche fuga di notizie ci fu nella lunga e variegata storia locale che poi si é tramandata attraverso piccoli cunicoli fino ai giorni nostri!
Ecco, improvvisamente rispuntare i primi esperimenti di vino, (anche champagne pregiato, si dice…), che viene affondato ad oltre 50 metri di profondità per essere conservato, anche un anno intero, in gabbie opportunamente ancorate e accarezzate dall’acqua di mare pulita e mai mossa, con poca luce e tanti profumi sconosciuti tra i mortali che vivono in superficie.

E’ inutile girarci intorno… Oggi il termine Vino Navigato, é abusato e copiato per ovvi scopi pubblicitari e turistici, ma non vanno dimenticati i secoli di fatica, sudore e rischi di navigazione: unici elementi che conferivano, in maniera naturale, un gusto davvero speciale al vino. Sulla scia di quanto detto, il nostro pensiero corre innanzitutto al RICORDO dei nostri Leudi, ai quali abbiamo già dedicato un’ampia rassegna di saggi e articoli sul Sito di Mare Nostrum Rapallo.

L’ultimo Leudo di Sestri Levante: Nuovo Aiuto di Dio
RICORDI di quando il vino era una specie di santo “pellegrino” che viaggiava via mare in botti di rovere sui Leudi, una tipologia di imbarcazioni in uso in tutto il Mediterraneo fino alla fine del Novecento.
Il LEUDO fa parte della nostra storia e della nostra tradizione. Quest'imbarcazione aveva il compito di trasportare tutti i generi di prima necessità, a partire soprattutto dal vino.
Tradizionali erano gli scambi con l'Isola d'Elba, ma anche con la Sicilia e la Corsica.

L’ultimo Leudo rimasto è il "Nuovo aiuto di Dio" di proprietà del dottor Gian Renzo Traversaro presidente dell'Associazione "Amici del Leudo" che è stato restaurato e ha potuto riprendere il mare nel 2011.
Sul "Nuovo aiuto di Dio" imbarcò Agostino Ghio "Giustinin" (Ancora d'Oro nel 1961) che fu anche timoniere di Guglielmo Marconi sulla celebre Elettra.
“Nel 2012 – racconta il dott. Traversaro - in una delle riunioni invernali per le opere da eseguire, mi è balenata un'idea, forse pazza, ma interessante: riprendere i commerci con il Leudo ed in particolare quello del vino con l'Isola d'Elba e l'isola del Giglio”.
Una bella notizia di questi ultimi anni riguarda quindi il ritorno al passato… Da questa antica tradizione, il vino Navigato riprende le vie del mare nostrum a bordo della bombata coperta del primo LEUDO restaurato da appassionati privati. Ascoltiamone il racconto di un anonimo testimone:
“Quel vino rischiava di non essere prodotto a causa del mancato varo del Leudo Nuovo Aiuto di Dio determinato da problemi tecnici, ma un gesto di solidarietà ed amicizia, tipica delle buone tradizioni marinare, ha salvato la situazione! È stato il Leudo Zigoela, capitanato dal patron della Compagnia delle Vele Latine, Roberto Bertonati, a trasportare il prezioso nettare degli dei. Il ricavato della vendita del vino, apprezzato da consumatori ed esperti, servirà per rimettere in sesto il Nuovo Aiuto di Dio.
Così il 29 settembre 2014 il benemerito Leudo Zigoela è salpato dal golfo di La Spezia alla volta di Vernazza, nelle Cinque Terre, custodendo nel suo ventre il vino della Cantina Sassarini.
Dopo aver preso contatti con alcune cantine produttrici dell’Isola d’Elba, abbiamo trovato due bottifici ancora attivi a Marsala che ci hanno fornito le botti per il trasporto. Ad attendere l’arrivo delle botti, non solo presenziava il sindaco Vincenzo Resasco, ma anche i ‘vinacceri’ Andrea e Daniele Ballarini e i rappresentanti dell’ Associazione Amici del Leudo Ugo Rocca e Giordano Veroni. Nel Settembre del 2012, quarantaquattro anni dopo l’ultimo viaggio commerciale che fu appannaggio proprio del Nuovo Aiuto di Dio, è stata riaperta “La Via Dei Leudi”.

Andrea Ballarini, imprenditore, ristoratore e socio degli amici del Leudo ci informa che: i progetti per il Vino Navigato di quest’anno sono ambiziosi. Alla “Stella Maris”, che farà affinamento in botte immersa nelle acque del nostro mare, si affiancheranno due nuovi prodotti che vedranno la luce grazie ad una collaborazione con il Museo di Sestri nella persona del direttore Fabrizio Benente.
STELLA MARIS IL VINO DEL LEUDO “NUOVO AIUTO DI DIO”
L’armatore Gian Renzo Traversaro parlandoci del naufragio del Leudo predecessore il "Nuovo Aiuto di Dio", avvenuto all’altezza delle secche di Vada, ci disse che durante quel triste epilogo, si seppe di anfore e botti di imbarcazioni affondate che avevano perfettamente mantenuto, se non addirittura migliorato il gusto de loro prezioso carico. Nacque un’idea. Ce la può raccontare?
“Certamente! Con un attento studio sulle botti e sui tempi abbiamo voluto creare una cosa unica immergendo in mare per sei mesi una serie di botti in una località segreta a Sestri Levante.
Il legno agendo da membrana osmotica ha poi regalato al vino altre note preziose facendolo acquistare in struttura e sapidità.
Fu scelto un nome speciale: “Stella Maris” un punto cardinale della devozione dei nostri marinai fin dall'antichità; in ebraico antico significa anche “goccia di mare”.
Ma per avere contezza del tempo che passa, andiamo ancora un po’ indietro e leggiamo che nel 1876 Bartolomeo Bregante iniziò a commercializzare il cosiddetto "vino navigato" lungo le rotte del Mediterraneo con una piccola flotta di Leudi.


Il Maestro d’Ascia Antonio Muzio detto anche “Tunin Capetta”
Di nuovo messo in secco nel 2013 per lavori all'albero maestro il leudo, costruito dai maestri d'ascia sestresi nel 1923, e' tornato a veleggiare. 'Il nuovo aiuto di Dio' che trasportava vino tra la Sardegna e l’Elba fino alla fine degli anni '50, in estate raggiungerà il porto di Marciana Marina (Elba) seguendo l'antica rotta dei vinacceri.
Dimensioni principali del “NUOVO AIUTO DI DIO”
| Lunghezza fra le Pp. ................................................................ | mt. 14,670 |
| Lunghezza fuori tutto ............................................................. | mt. 15,320 |
| Larghezza massima fuori Fasciame Ponte Coperta ............ | mt. 4,680 |
| Larghezza massima fuori Ossatura Ponte Coperta ............. | mt. 4,550 |
| Larghezza massima fuori Fasciame Orlo Impavesata......... | mt. 5,300 |
| Altezza P. Coperta dalla L.C. alla Retta Baglio .................. | mt. 1,050 |
| Bolzone ..................................................................................... | mt. 0,750 |
| Immersione massima dalla L.C. sulla Pp. AV. .................... | mt. 0,850 |
| Immersione massima dalla L.C. sulla Pp. AD. .................... | mt. 0,930 |
Di ritorno a Sestri, il vino veniva trasportato in botti di legno della capacità di 600/800 litri e veniva caricato sia nelle stive che in coperta.

Prima delle mareggiate invernali i Leudi venivano tirati a riva. Oltre all’equipaggio partecipavano a questa manovra anche i passanti ed i turisti.

Unico esemplare esistente di ‘Argano a mano’ per virare il Leudo a riva.
(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta. Foto C.Gatti)

I Leudi normalmente trasportavano fino ad un massimo di 300/500 botti che venivano gettate in mare con la stessa tecnica di sempre: spinte verso terra, tra lo stupore dei turisti festanti, da qui venivano rotolate sulla spiaggia per essere caricate e destinate all’imbottigliamento.
Il vino così prodotto e maneggiato in questo microcosmo costiero delle nostre parti, prese il nome di NAVIGATO in quanto assunse caratteristiche importanti nei gusti, dovute alla salsedine ed al "legno" della botte che, assieme ai continui movimenti durante il trasporto, ne definiscono in maniera unica ed antica il sapore. Un prodotto difficile, ma sicuramente unico in tutto.

Quando un Leudo era carico, la linea di galleggiamento era molto bassa.
Il Leudo era una imbarcazione molto stabile ma non era veloce. Era preferibile navigare con il vento a favore perché cambiare il bordo della vela era una manovra complicata.
CARLO GATTI
Rapallo, 7 Settembre 2017
IL GIGLIO DI MARE
IL GIGLIO DI MARE
IL RE DELLE DUNE
Sulle spiagge crescono e sbocciano i fiori??

La spiaggia, non è solo una distesa di sabbia o ciottoli, ma un complesso ecosistema, in cui vive una vegetazione testimone di raffinate strategie adottate dalla vita per occupare tutti gli spazi possibili anche i più ostili. A questo tipo di vegetazione appartiene il Giglio di mare (nome scientifico Pancratium maritimum) tra le piante più ornamentali e belle da ammirare sui litorali sabbiosi. Il suo areale di distribuzione è esteso a tutte le regioni del mediterraneo ma in Italia è una specie rara, o è divenuta tale, a causa della rarefazione continua del suo habitat. In Liguria, la fascia di terra che progressivamente portava alla fine della spiaggia chiamata duna non esiste più, ora ci sono gli stabilimenti balneari, la passeggiata, le strade, le case e i parcheggi.
All’incirca sino al dopoguerra su quasi tutte le spiagge della costa ligure si poteva ancora ammirare la fioritura dei gigli di mare, una testimonianza la possiamo trovare negli scritti di Camillo Sbarbaro risalenti al maggio del 1945 a Spotorno: “E’ fiorito sulla spiaggia il giglio di mare; scendo a coglierne; dalla strada un passante mi grida lì tutto è minato”.
Alcuni esemplari hanno tentato o sono riusciti a rifugiarsi in zone più protette o dove per alcuni fattori le caratteristiche di naturalità necessarie alla loro sopravvivenza si sono mantenute.
Il giglio di mare il cui nome in greco significa tutta forza, faticosamente cerca di resistere come dimostrato da studi condotti dall’Università di Genova, in tre siti in Liguria: a Cavi di Lavagna (sembrerebbe piantato da Lord George C. Byron) a Varigotti e tra Ceriale e Albenga.

IL GIGLIO DI MARE
Il giglio della sabbia, lo conosci?
fragile più di ogni altro,
s'alza solo dove il tempo s'arresta,
lì, presso la scogliera immensa,
più d'un giorno non dura,
breve come il miraggio
della maga anche lei sola,
le bestie la cerchiano e le rupi,
brune ancelle nella sosta
tra il gioco della palla e i panni stesi
del fiore e di parole riempirono i canestri,
anche al naufrago appare
e lo consola.
Umberto Piersanti
L'albero delle Nebbie
Credevo di essere un uomo di mare a tutto campo per l’interesse che ho sempre sentito per tutto ciò che si muove in mare e sulla costa, ma la mia presunzione ha subito un duro colpo quando ho ricevuto questa fotografia dal mio amico Nunzio Catena di Ortona.

Giglio di mare (Pancratium maritimum)
Pancratium maritimum è una pianta profumatissima, perenne bulbosa, con fusto alto sino a 40 cm e ampie foglie lineari. I fiori, da 3 a 15, bianchi e lunghi fino a 15 cm, sono riuniti in infiorescenze ad ombrella; si aprono tra luglio e ottobre. I fiori hanno un profumo intenso e persistente di giglio, che diventa percepibile principalmente durante le notti d'estate senza vento. E’ facilmente coltivabile, ma richiede una posizione molto soleggiata e un terreno sabbioso molto ben drenato. Ha bisogno di estati calde per indurre la fioritura, mentre una fioritura timida può avvenire in climi più freschi. Tollera temperature fino a circa -5°. La propagazione avviene per seme o divisione dopo la fioritura. Piantine possono fiorire nel loro terzo o quarto anno di vita.

Il frutto é una capsula contenente semi neri lucidi di forma irregolare. I semi galleggiano, cosicché la disseminazione avviene anche tramite le correnti marine!
Cresce sui litorali sabbiosi del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, dal Portogallo, Marocco e lee Isole Canarie fino a est in Turchia, Siria, Israele e Caucaso. Può essere osservato anche nella Bulgaria meridionale e nel nord della Turchia e sulle coste della Georgia nel Mar Nero, dove la specie è minacciata di estinzione
In Italia lo si può osservare sulle dune costiere di Veneto, Liguria di Ponente, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Progetto Giglio di Mare

Il suo habitat ideale è sulle dune sabbiose, in posizione retrodunale. Pianta protetta a rischio di estinzione per la scomparsa dei siti idonei per il suo ciclo vitale, per il calpestio estivo dovuto al turismo, per la recisione del fiore. Dichiarata specie vegetale protetta ai sensi della Legge Regionale n°56/2000 che ne vieta il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.
UN PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE DEL GIGLIO MARINO.
Il giorno 19 Ottobre 2012 tra il CRISBA (Centro Ricerche Strumenti Biotecnici nel settore Agricolo-forestale) dell’ISIS “Leopoldo II di Lorena” e l’Associazione “Terramare”, è stato firmato un protocollo d’intesa fra i due soggetti per la raccolta di alcuni campioni di seme di Pancratium maritimum finalizzata alla propagazione della specie in modo tale da produrre un numero sempre più consistente di piante da destinare alla messa a dimora nelle aree dunali maremmane.
Il CRISBA ha attivo ormai da alcuni anni un programma di propagazione da seme autoctono di questa specie, finalizzato alla reintroduzione in ambiente delle piante ottenute; ad oggi sono state effettuate molteplici piantumazioni nelle dune del territorio provinciale con alte percentuali di attecchimento delle piante messe a dimora. L’Associazione Terramare collabora a queste progetto e ne ha ampliato le finalità attivando con il CRISBA un piano di monitoraggio e mappatura del Giglio di mare nel nostro territorio.
Si tratta di un’iniziativa, svolta in collaborazione anche con Treart Srl, ISIS “Leopoldo II di Lorena” e Provincia di Grosseto, alla quale ciascuno di voi può partecipare segnalando l’avvistamento di uno o più esemplari di Giglio di mare nelle nostre dune!
I dati raccolti, una volta verificati, arricchiranno una mappa satellitare interattiva che consente di monitorare la diffusione della specie vegetale in Maremma e di conoscere lo stato di salute delle nostre dune.
Riporto una interessante spunto dal web:
Caro……
il Pancratium maritimum produce centinaia di semi, molto ben visibili perché grandi come un fagiolo. Se sei talmente preoccupato per la possibile scomparsa di questa specie, puoi attivarti andando a raccoglierne in buona quantità, prima che si secchino al sole inutilmente, e cominci a sotterrarli nella sabbia nei punti chiave come da tempo faccio anch'io. Ci sarà quindi chi ruba le piante e chi la andrà a ripiantare.....
E' molto semplice quindi poter fare qualcosa per aiutare la natura nel suo difficile cammino di sopravvivenza, basta muovere le gambine e spremersi un po' di sudore....
Una rimarchevole inziativa:
21 Apr 2017
Chiavari: la colonizzazione del Giglio Marino
Questa mattina ha preso l’avvio il progetto di colonizzazione del giglio marino, con la piantumazione delle specie in via di estinzione sul litorale chiavarese.
Il Comune di Chiavari, in attuazione del “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime”, approvato nel 2015, in accordo con le previsioni del Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero e secondo le indicazioni della D.G.R. 129/2011 del Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria, sta favorendo la rinascita della vegetazione spontanea costituita da psammo-alofile (da psammos e alos che significano sabbia e sale), cioè di quelle piante esclusive o quasi degli ambienti marini, ormai estinte sui nostri litorali (tra le quali il bellissimo Giglio Marino (Pancratium Maritimun), nella spiaggia posta in aderenza al Porto Turistico, e sottostante la passeggiata a mare Lungo Porto Don Giussani, in particolare nella fascia più prossima al mare del sistema dunale.

A tale fine, l’Amministrazione Comunale ha realizzato due aiuole (di mq. 300 e mq. 375 ciascuna) che hanno uno scopo dimostrativo, teso a diffondere la conoscenza della biodiversità e il rispetto per la natura.
In particolare, le aree riservate alla vegetazione psammofila spontanea sono state realizzate con materiale prelevato dalla spiaggia originaria o proveniente dalle operazioni di dragaggio per la realizzazione della nuova darsena, comunque evitando ghiaie e materiale grossolano.
Sono state leggermente rialzate rispetto al piano spiaggia e compartimentate mediante fascinature in modo che favoriscano la stabilizzazione del materiale, e creino artificialmente una duna embrionale nella quale possa insediarsi la vegetazione pioniera, e al contempo delimitino e segnalino l’area.

Verranno posti, per ciascuna aree, dei cartelloni esplicativi indicanti gli obbiettivi di salvaguardia e i divieti vigenti.
Una volta realizzate le aree verranno individuate graficamente su cartografia almeno in scala 1:2000 e detto inquadramento cartografico, ed ogni successivo aggiornamento, verrà inviato al Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria.
L’area verrà costantemente mantenuta attraverso interventi di ripristino della delimitazione in fascinatura e della cartellonistica e soprattutto attraverso un costante servizio di pulizia manuale da eventuali rifiuti e vegetazione infestante.
Il Comune eseguirà un monitoraggio delle aree, consistente almeno in un reportage fotografico da realizzarsi una volta l’anno nel periodo da maggio a settembre.
Collaborazione con l’Università di Genova
Volendo accelerare il processo di colonizzazione della vegetazione in maniera attiva, il Comune di Chiavari ha instaurato una collaborazione di tipo scientifico per il monitoraggio botanico dell’area con il DISTAV, (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita), presso l’Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Prof. Mauro Mariotti, per la conservazione dei fiori di spiaggia, per la specifica consulenza scientifica, il supporto al reperimento del materiale e la predisposizione di specifici indirizzi per la gestione.
Progetto con le scuole
Questa mattina, il progetto ha preso avvio mediante la piantumazione delle prime specie da parte di Studio Gardenstudio e dei giardinieri comunali, con la partecipazione degli studenti delle scuole di Chiavari.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Il Laboratorio Territoriale Tigullio (gestito dalla Cooperativa Terramare), che ha realizzato un percorso didattico sviluppato con le Scuole secondarie di primo grado del Comune di Chiavari, con il coinvolgimento di due classi.
Presenti alle operazioni di piantumazione l’Assessore all’Ambiente Nicola Orecchia, la Dott.ssa Isabella De Benedetti e Nicolò Mora dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Chiavari, il Prof. Mauro Mariotti dell’Università degli Studi di Genova (DISTAV) la Dott.ssa Elena Montepagano del Settore Ecosistema Costiero e Acque, Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, nonché gli studenti e le insegnati delle classi IE della Scuola Secondaria di Primo Grado Ilaria Alpi Istituto Comprensivo Chiavari II e la IIB della Scuola Secondaria di Primo Grado “Della Torre” Istituto Comprensivo Chiavari I, ed il Dott. Giacomo Goria, dello Studio Sciandra & Associati.
Così dichiara l’Assessore Orecchia: “Siamo molto soddisfatti di questo progetto ambientale che si prefigge di diffondere la conoscenza della biodiversità ed il rispetto per la natura, con una particolare attenzione alle specie di vegetazione marina spontanea delle psammofile, ormai estinte sul nostro litorale, cui appartiene, ad esempio, il bellissimo Giglio Marino, che vorremmo potesse tornare ad abbellire le nostre coste. Ringraziamo per la preziosa collaborazione tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa…
- La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva.
(Albert Einstein)
Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.
(Andy Warhol)
Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la terra.
(Henry David Thoreau)

Su questa spiaggia di Ortona (Abruzzo) oggi, 31 luglio 2019, é stata scattata la fotografia che tutta Italia e, forse tutto il mondo, sogna di poter avere sotto i propri occhi: una prateria di profumatissimi e rari GIGLI DI MARE.
Si dà il caso, che proprio in questo periodo, e proprio per questa spiaggia, verrà decisa la sorte di questo magnifico RE DELLE DUNE. Sul suo destino incombono richieste d’impianti balneari che ne decreterebbero l’estinzione.
La ridente località abbruzzese ha una grande responsabilità:
vincere una guerra di civiltà!
Tutta Italia é con voi!
Carlo GATTI
Rapallo, 11 Agosto 2017
GIUSEPPE PETTAZZI UN RAPALLESE DA RICORDARE!
Ing. GIUSEPPE PETTAZZI

Un rapallese da ricordare
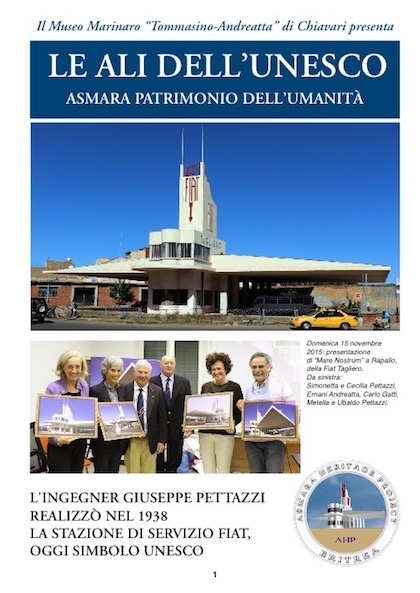



L'INGEGNER GIUSEPPE PETTAZZI REALIZZO’ NEL 1938 LA STAZIONE DI SERVIZIO FIAT, OGGI SIMBOLO UNESCO

Sopra: l’inaugurazione della Fiat Tagliero ad Asmara il 28 Ottobre 1938. Presenti le massime autorità gerarchiche del tempo. A sinistra, in completo scuro, si riconosce il Duca Amedeo di Savoia-Aosta, l’Eroe dell’Amba Alagi, che il 3 Marzo 1942 morirà a Nairobi, prigioniero degli Inglesi. Medaglia al Valor Militare.
La Rai nazionale si è interessata alla Fiat Tagliero di Giuseppe Pettazzi con due filmati tratti da due trasmissioni della Grande Storia di Paolo Mieli e Massimo Bernardini. Altri edifici di quel tempo, sempre in Eritrea sono fotografati in altre località come “Dire-Daua”, “Dessiè”, “Gondar”, “Mogadiscio”, “Adis Abeba”. Sono altresì rappresentate tramite fotografie panoramiche, le “Torri Balilla al mare e sulle Alpi” che vengono proposte come colonie Fiat per bambini con slogan come: “attraverso le miriadi e miriadi dei vostri figli si ha la certezza assoluta della continuità nei secoli della nostra “Patria”.
Per quest’ultimo edificio, la rassomiglianza con la nostra Colonia Fara di Chiavari è straordinaria, non solo nella struttura centrale ma anche nelle due terrazze laterali. L'accostamento tra la Ex Colonia Fara e le nuove costruzioni nell'Ex Cantiere Navale, è giustificato dalle architetture razionaliste e variegate della zona Preli, e anche molto criticate, come riportato dalla stampa locale.

Sopra: da ”Il Corriere della Sera” del 12 Luglio 2017, articolo di Guido Santevecchi

Progettazione della Fiat Tagliero, con i timbri originali degli uffici asmarini

Luigi Frugone

... e parte della sua libreria
Sono sotto gli occhi di tutti gli arrotondamenti dei terrazzi per creare una architettura "razionalista" simi- lare a quella della “Torre Fara”, e avendo conosciuto una persona che ha moltissimi libri di Futurismo, Art Decò e Razionalismo cioè il Signor Luigi Frugone chiederemo a lui un suo giudizio ed un commento da profondo e appassionato conoscitore dell'argomento.
Questa nuova conoscenza è straordinariamente significativa ed emozionante per aver riportato di attualità l'opera della Fiat Tagliero di Giuseppe Pettazzi. Pensate .... due persone che in parallelo si interessano della stessa cosa per anni e si appassionano all'argomento ma che non si conoscono affatto, anche se uno sapeva che l'altro esisteva e viceversa. Ma l'incontro ad una cena degli "Amici del Monte" ha creato il contatto. Ecco che Frugone, con una immagine straordinaria presenta subito una inedita Colonia Fara e uno ZEPPELIN che gli sorvola intorno!!! Naturalmente lo Zeppelin non è mai passato a Chiavari, ma “Photo-shop” sì.
Dopo questa emozionante presentazione, nel totale disinteresse, si sono scambiati subito i propri “ritrovamenti”. Frugone aveva disegni inediti con timbri colorati originali che ha ottenuto dal Municipio di Asmara .... e dall'Ufficio Storico del Museo Fiat di Torino, senza sapere, per anni, che i figli di Pettazzi erano a 50 metri dai suoi innumerevoli libri di futurismo. Chissà cosa ne avrebbe pensato Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del Futurismo che fu la prima avanguardia storica italiana del Novecento.
Filippo Tommaso Marinetti


Una foto da lui proposta della Colonia Fara
Inoltre Andreatta aveva una serie di foto avute dalla famiglia Pettazzi che Frugone non possedeva. E' stato uno scambio disinteressato e assolutamente culturale! E' storia recente che, gli autorevoli quotidiani nazionali e locali hanno finalmente portato alla luce lo straordinario lavoro degli Architetti e degli Ingegneri Italiani che progettarono un’urbanistica citata come “esempio mondiale di architettura modernista”. Si viene altresì a sapere che il Politecnico di Milano formerà tecnici eritrei per il restauro del patrimonio culturale e architettonico di Asmara, nell’ambito di un progetto finanziato con quasi 300.000 euro dall’Unione Europea. Lo ha precisato l’architetta Susanna Bortolotto dell’ateneo milanese, contattata da askanews dopo che l’Unione Europea ha riferito del coinvolgimento del Politecnico nel progetto intitolato “Capacity building for safeguarding Asmara’s historic urban environment”. Bruxelles ha infatti annunciato di recente il via libera a un finanziamento di 297.721,87 euro per le attività di valorizzazione e tutela del patrimonio di Asmara, “unico al mondo”, che fa della capitale eritrea la “città modernista del continente africano” candidata a diventare patrimonio Unesco. Ed infatti l'Unesco, nella sua sessione annuale in corso a Cracovia nel Giugno 2017, ha dichiarato Asmara Patrimonio dell'Umanità, inserendola nella lista World Heritage. La capitale dell'Eritrea è il primo sito del Paese africano a entrare nel Patrimonio, come "città modernista d'Africa", in riferimento alla sua struttura urbanistica, che porta la firma degli architetti italiani della fine dell'Ottocento e soprattutto del Ventennio.

Il progetto, presentato dall’Asmara Heritage Project e dalla municipalità di Asmara, prevede il completamento del “Con- servation Master Plan” della città e un corso per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio e attività che incentivino la consapevolezza e il coinvolgimento dell’opinione pubblica. L’Asmara Heritage Project implementerà parte del progetto in collaborazione con il Politecnico di Milano”, si legge nella nota diffusa dall’Unione Europea. “L’affascinante capitale dell’Eritrea – ha concluso Bruxelles – con un perimetro storico di circa 4.300 edifici censiti all’interno di un’area di 480 ettari, potrebbe anche diventare presto il primo sito Unesco Patrimonio dell’umanità dell’Eritrea”. E naturalmente quale sarà il simbolo di questo progetto, senza dubbio la Fiat Tagliero dell’Ingegner Giuseppe Pettazzi.
Ed ancora.... ricevo un Email da Luigi Frugone in cui ci parla di una mostra a Parigi presso l'Ambasciata Eritrea per perorare la causa di Asmara e delle sue architetture come “patrimonio dell'Umanità” con la Stazione di Servizio Fiat Tagliero, naturalmente, come simbolo più significativo. L'esposizione art deco di Asmara è stata inaugurata a Parigi all'ambasciata dell'Eritrea. Sua Eccellenza Hanna Simon, ambasciatrice dell'Eritrea in Francia, ha aperto l'esposizione. L' Ambasciata ha dichiarato che l'esposizione si svolge con il tema "Asmara: la città dei sogni". Questa mostra vuole attirare l'attenzione internazionale e le persone di cultura per visitare questa città e aiutarla a preservarne l'eredità. L' esposizione vuole contribuire al dibattito sulla valutazione del modernismo classico, la globalizzazione dell'architettura moderna, il suo valore storico e gli effetti sull'urbanistica.
Tuttavia, Asmara è l'unica grande città al mondo dove tutta una varietà di movimenti architettonici sono riuniti insieme. Pertanto, Fiat Tagliero, ideata e costruita da Giuseppe Pettazzi è diventata un pò il simbolo di Asmara e di tutta l'Eritrea, e vediamo la sua immagine riportata sulle magliette e sulle borse per farla conoscere al mondo. L'immagine di questa modella è stata fornita da Lugi Frugone, così come una serie di Magliette che arriveranno al più presto dall'Asmara con corriere internazionale. Riportiamo qui di seguito gli articoli dei quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giornale, Il Secolo XIX e il Nuovo Levante.
La famiglia Pettazzi è certamente grata a questi quotidiani che hanno voluto portare alla luce una storia ormai dimenticata, ma che andava certamente ricordata anche in memoria di chi ha perso la vita e di chi, al di la di ogni convinzione politica ha così tanto sofferto in certi periodi della propria esistenza. Perchè sono principalmente quelle ali di cemento che hanno fatto volare Asmara, capitale dell'Eritrea, fino al riconoscimento più alto, quello del patrimonio dell'UNESCO.
E se non fosse stato per questa improvvisa notorietà globale che ha travolto Asmara, di certo pochi si ricorderebbero di Giuseppe Pettazzi, Ingegnere di origine piemontese che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, scelse Rapallo in Liguria come rifugio in cui custodire e conservare il passato, nel tentativo, dopo cinque anni di prigionia in India, di ricostruirsi un futuro.

S.E. Hanna Simon, ambasciatrice eritrea in Francia, che ha aperto l’esposizione Art Decò di Asmara, inaugurata a Parigi all’ambasciata eritrea.

Progetto World Heritage. Asmara “città modernista d’Africa


Alcuni gadget per l’evento Unesco

Nella zona dove stanno sorgendo le nuove costruzioni della Società “Gli Scogli Srl”, il cantiere navale Gotuzzo vi costruì e varò oltre 125 velieri oceanici. Per comprendere come appariva il litorale all’epoca eroica della vela possiamo guardare il dipinto di Amedeo Devoto riportato qui sotto, raffigurante la stessa zona, nel 1919, quando ben cinque velieri erano contemporaneamente in costruzione. Sulla destra, il Cantiere Navale dei Gotuzzo, edificato nel 1912, dopo oltre cinquant’anni di lungaggini burocratiche, con uno stile assolutamente armonico rispetto al territorio.
Sotto: da “La Repubblica” del 17 Luglio, articolo di Massimo Minnella.

VITA E COERENZA DI GIUSEPPE PETTAZZI
“FORTUNATO SOPRAVVISSUTO” - “RAPALLINO DI ADOZIONE”
PARTECIPÒ NEL 1941 ALL'EROICA DIFESA DI CHEREN IN A.O.I. NEL BATTAGLIONE "UORK AMBA"

Giovanna Calissano, nata ad Alba conobbe Giuseppe Pettazzi a Rocchetta Tanaro. Soltanto dopo la guerra, nel 1947 si unirono in matrimonio. Rapallo diventò la loro residenza.

Giuseppe Pettazzi, ingegnere civile, nato a Milano, era di origine piemontese.
Durante la guerra in Africa Orientale (A.O.I.) era Sottotenente degli Alpini.
Le origini piemontesi
Giuseppe Pettazzi, di professione ingegnere civile, allo scoppio della seconda guerra mondiale si trovava in Africa Orientale Italiana e fu uno dei pochi sopravvissuti del Battaglione Alpino “UORK AMBA” durante la presa di Cheren in Eritrea da parte degli Inglesi.
Proveniente da una famiglia medio borghese di origine piemontese, era nato a Milano il 3 Maggio 1907. Dopo la guerra, nel 1947, diventa Rapallino di adozione. E’ uno dei tanti che, negli anni 30, ha dovuto fare delle scelte fondamentali e spesso si è trovato coinvolto in avvenimenti o battaglie sanguinose o situazioni di prigionia faticosamente vissute e sopportate, a volte assurde, specie se viste con gli occhi di oggi. Pettazzi, nonostante tutto, può ritenersi un “fortunato sopravvissuto”.
Aveva un carattere estremamente equilibrato, di grande livello etico e morale e certamente pacifico e sicuramente era un uomo coerente. Ma si trovò, dai trenta ai quarant’anni, a vivere un decennio di spaventosi cambiamenti e tragedie, e così, nell’età in cui un uomo è nel pieno delle sue capacità fisiche e professionali, venne coinvolto in quel momento che viene ora definito come il “Colonialismo Italiano”.
Dopo la maturità classica che consegue nel 1925, Pettazzi si iscrive alla facoltà di ingegneria di Torino dove ne esce laureato nel 1931 dopo aver interrotto gli studi per il servizio militare nel ‘28 a Bra dove frequenta il Corso Allievi Ufficiali per Alpini e ne esce Sottotenente, in caso di richiamo.
Il primo impiego, come ingegnere civile, è presso l’impresa ing. Sapelli di Ciriè, specializzata nei calcoli del cemento armato, con lavori in loco in industrie locali, e per il genio militare, alla frontiera Francese, Cesana, Sestriere, e galleria di Monte Rotta presso Bardonecchia. Nel 1935 lavora con l’impresa Zolla di Milano che ha depositi di carburanti a Gozzano e quindi con l’impresa Carlo Grasso di Torino sempre nel settore per il quale si era laureato e cioè ingegneria e progettazione civile.
Sotto: Giuseppe Pettazzi all’Asmara, con la sua “Balilla” quando era titolare dell’impresa di costruzione omonima. In pochi anni, ad Asmara, prima della tragedia scatenata da Mussolini con la perdita dell'A.O.I., aveva già progettato e costruito molti importanti edifici e strade.
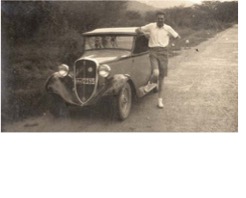
Africa Orientale Italiana – L’Italia Decò
A questo punto nella vita di Pettazzi c’è una svolta che condizionerà molta parte del suo futuro. Come Ingegnere civile verso la fine del 1936 va a lavorare in Africa Orientale, in Eritrea, per cercare di avere un miglior futuro professionale sull’onda del grande esodo verso questi possedimenti del regime di allora. In quegli anni le colonie Italiane rappresentano per molti professionisti e non solo, uno sbocco importante di lavoro. Per molti giovani sono una strada aperta verso nuovi orizzonti di grandi speranze che si concretizzano presto con il grande bisogno di infrastrutture, come vengono ora chiamate, le strade, i ponti, gli acquedotti, le fognature ecc. in un paese dove non c’era nulla di tutto questo.
Un Esempio dell’archittetura “decò” di Asmara


Da un giornale del dopoguerra del 2007: la Fiat Tagliero progettata da Pettazzi é ancora in piedi.
Sotto: Una sfilata delle Giovani Italiane a Rapallo. Con la camicia bianca si nota Giovanna Calissano che prima della guerra era già residente a Rapallo.

Sotto: Una immagine del 1952 dei coniugi Pettazzi ormai Rapallini di adozione e non più “furesti”

In Eritrea, all’Asmara, esercita la libera professione proprio nel settore dell’ingegneria civile e le sue doti di progettista anticipano e interpretano perfettamente quella tendenza che potremmo chiamare “l’Italia Decò” in terra d’Africa. E’ giovane e lo spirito imprenditoriale come le capacità professionali non gli mancano e così attraverso una propria impresa di costruzioni si tiene al passo con il grande sviluppo urbanistico della città coloniale probabilmente anche favorito dall’impulso imposto dal regime di allora. Tra i progetti da lui portati a termine, uno di questi, la stazione di Servizio della Fiat Tagliero lascerà un’impronta particolare sia per la sua architettura innovativa e moderna che per una leggenda ancora adesso tramandata di generazione in generazione dagli Eritrei dell’Asmara.
Una rivista d’arte e cultura del 2007, “Luoghi dell’infinito” parlando di un viaggio all’Asmara nel 1991 in un articolo riporta testualmente: La guerra trentennale era finita. (proprio in quell’anno infatti era caduto il potere dittatoriale comunista di Menghistù). Il paese era libero e Asmara si risvegliava nella sua tranquilla e sorprendente bellezza. Fuori dall’aeroporo i Taxi in attesa di quei primi viaggiatori erano ancora Fiat 1100 dal colore azzurro arrugginito. Per strada vedevi circolare improbabili Balilla grigie che andavano a passo d’uomo. Ci fermammo al primo bar aperto: si chiamava Duca d’Aosta e il tassista mi offrì un cappuccino e una pasta. Il barista aveva i capelli bianchi: “Benvenuto”, disse in Italiano. La macchina scivolò poi davanti ad un distributore di benzina che assomigliava ad un ae- roplano. “Fiat-Tagliero” annunciava con orgoglio la scritta rosso sbiadita che sovrastava la torretta centrale.
Fiat Tagliero all’Asmara Autostazione Aeroplano
Mi raccontarono, è Andrea Semplici che scrive autore di queste righe, che l’ingegnere che aveva avuto l’ardire di progettare nel 1938, quel garage futurista dovette puntare una pistola alla testa del capomastro per convincerlo a togliere le impalcature che sorreggevano gli oltre 16 metri delle “ali”. Chissà se Giuseppe Pettazzi, il progettista, lo fece davvero! Quel che è certo che “l’Autostazione-Aeroplano” sembra, dopo oltre settant’anni dall’inaugurazione, ancora pronta al decollo. E continuando: l’Italia fascista aveva cancellato dalla geografia politica l’Etiopia, unico paese libero dell’Africa, e Mussolini voleva trasformare il volto di quelle terre. Asmara, fino al 1935 era una tranquilla città di una lontana provincia coloniale sulle coste del Mar Rosso. Ma alla vigilia dell’invasione dell’Etiopia conobbe un sussulto. Vi arrivò di tutto, “oltre che a bravi professionisti come Pettazzi” approdarono anche migliaia di soldati, coloni, avventurieri, braccianti, operai, poveri d’Italia. Era la retrovia della guerra che Mussolini avrebbe scatenato alla fine del 1935.
Sotto: Dal libro “Gli Alpini” – Storia –Reparti – Adunate- Eroi – 2014 e 2015- Edizione Gribaudo. Proprio per la sua breve vita il Battaglione UORK AMBA é poco conosciuto. Dal numero dei caduti, come leggiamo, é certamente uno tra i più eroici proprio per la straordinaria difesa di Cheren. Giuseppe Pettazzi, col grado di Sottotenente si può definire un “fortunato sopravvissuto” perché pochi giorni prima della resa di Cheren era stato ricoverato in ospedale ad Addis Abeba per una ferita alla mano che si era infettata. Durante la battaglia fu anche lievemente ferito alla testa.
“Divina geometria”
In meno di sei anni divenne il teatro di ogni possibile e radicale sperimentazione architettonica e urbanistica. Divenne la palestra in libertà dell’”Art Decò” delle linee futuriste, del modernismo. Il risultato? “Una divina geometria” azzardò anni fa Eugenio Lo Sardo, ispettore del Ministero dei beni culturali e ricercatore pignolo di quella stagione urbanistica. “Gli Italiani crearono un capolavoro dell’Art Decò. Asmara possiede la maggior concentrazione al mondo di architetture anni trenta. Gli Italiani hanno costruito con eleganza e stile. Hanno modellato una capitale abbagliante, moderna, internazionale. Sono più di quattrocento gli edifici asmarini censiti come piccoli capolavori del Decò. (foto sotto)

Negli anni a seguire, dopo la seconda guerra mondiale, l’edificio della Fiat Tagliero è stato più volte sulle pagine di giornali specializzati o settimanali o quotidiani. E’ interessante citarne alcuni per capire l’ambiente “urbanistico” in cui si viveva in questa colonia Italiana. Ma è il supplemento “Venerdi”, del quotidiano “La Repubblica” del 5 Dicembre 2003, in un articolo di Marc Lacey, che, è proprio il caso di dirlo, scatena le “ire” di Giovanna Pettazzi, ora scomparsa, con una lettera indirizzata al direttore Dott. Ezio Mauro dove si definisce, in questa accorata precisazione, “ottantaquattrenne, vedova dell’Ingegner Giuseppe Pettazzi deceduto nel 2001 all’età di novantaquattro anni”. Ne riportiamo volentieri alcuni commoventi “frammenti”: “la prigionia per sei lunghi anni in India, scrive, riferendosi al marito, posero temine alla sua attività svolta per troppo breve tempo in Asmara dove tuttavia rimane la Stazione di Servizio FIAT TAGLIERO che fu inaugurata nel 1938 dal Duca Amedeo D’Aosta, chiamata e conosciuta come “l’aeroplano” per la struttura a sbalzo con due ali tese di un’apertura di sedici metri (NON di tre metri, come legge inorridita sull’inserto) nuovo particolare questo, “tanto pietoso, quanto assurdo”!
Mio marito mai dovette ricorrere alla minaccia delle armi!
E continua rimarcando che da altri giornali come il Touring è stata definita come una costruzione “unica al mondo”! ma dice anche che: “mio marito mai dovette ricorrere alla minaccia delle armi (!!!) per persuadere gli operai a togliere le impalcature fatte per sostenere la massa di cemento in attesa che si solidificasse.... ............Poi parla del rapporto di affezione che c’era tra suo marito anche con la manovalanza indigena ... concludendo: quindi la citazione della minaccia delle armi (pistola o quant’altro) è falsa e pretestuosa!
Mio marito continua era “un puro, un onesto, mite, ma fiero”, che mai avrebbe commesso una azione così riprovevole nei con- fronti di chicchessia, tanto meno di una manovalanza che stimava, a cui era sinceramente affezionato. E quando lesse questa affermazione rimase profondamente indignata.
Firmato Giovanna Calissano vedova Ingegner Pettazzi.

Sotto: Le torri Balilla al mare e sulle Alpi. Per quest’ultimo edificio, la rassomiglianza con la nostra Colonia Fara di Chiavari é straordinaria, non solo nella struttura centrale ma anche nelle terrazze laterali.

Le opere del giovane Ingegner Pettazzi all’Asmara sono naturalmente riprodotte sui giornali del regime di allora come nel “Bianco e Rosso”, giornale del dopolavoro aziendale n. 5 del Maggio 1939, dove nella pagina ”La Fiat nell’Impero” in un disegno stilizzato viene rappresentata la Stazione Fiat dei Fratelli Tagliero in veduta prospettica da due differenti lati. In entrambi i casi è chiaramente indicato: “progetto e direzione lavori Dr. Ing. Giuseppe Pettazzi, Impresa Costruzioni Asmara”.
Altri edifici di quel tempo, sempre in Eritrea sono fotografati in altre località come “Dire-Daua”, “Dessiè”, “Gondar”, “Mogadiscio”, “Adis Abeba”. Sono altresì rappresentate tramite fotografie panoramiche, le “Torri Balilla al mare e sulle Alpi” che vengono proposte come colonie Fiat per bambini con slogan come: “attraverso le miriadi e miriadi dei vostri figli si ha la certezza assoluta della continuità nei secoli della nostra “Patria”.
Per quest’ultimo edificio, la rassomiglianza con la nostra Colonia Fara di Chiavari è straordinaria, non solo nella struttura centrale ma anche nelle due terrazze laterali. Dopo l’8 Settembre 1943 continua e si aggrava la tragedia italiana per mancanza totale di ordini e disposizioni con il conseguente sfascio del già debole apparato difensivo e offensivo. Nel dopoguerra, con la loro scellerata amministrazione, ci pensano gli Inglesi a portare via tutto. Selassiè trasferisce in Etiopia quanto rimasto e Menghistù (che era Etiope) con la nazionalizzazione dà il colpo mortale. E l’articolista aggiunge: in questo ultimo mezzo secolo l’Eritrea è stata la cenerentola del mondo, dimenticata da tutti anche da quegli Italiani che si gloriavano della loro “colonia primogenita”.
Forse dimentica che proprio gli Italiani sono tornati da quei posti o da altre Colonie come anche la Libia, spogliati di tutto o scusando la licenza, “con una mano davanti e una di dietro” ! Non parliamo poi di quelli che anche se “fortunosamente sopravvissuti” sono tornati a casa dopo 5 anni di prigionia come l’Ing. Pettazzi catturato dagli Inglese a Cheren nel 1941 e rimpatriato nel Dicembre del 1946 dopo che la guerra per l’Italia era finita il 25 Aprile del 1945. Nel 1997 l’Italia è stato il primo paese a riconoscere lo stato Eritreo con l’unico ministro degli esteri presente il giorno della dichiarazione di indipendenza il quale dichiara: “al di là delle sofferenze del colonialismo, l’Italia ha lasciato una grande impronta del suo lavoro, della sua presenza, della sua civiltà”.
Sotto: Giuseppe Pettazzi all’Asmara in divisa da Sottotenente degli Alpini appena richiamato dopo l’inizio del conflitto della Seconda guerra mondiale. Da lì a poco, in Africa Orientale Italiana, verrà scatenata una cruenta battaglia con la perdita totale di questa colonia. Cheren e l’Amba Alagi furono gli ultimi baluardi della resistenza italiana.
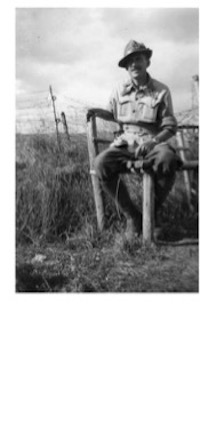
Altre opere dell’Ing. Pettazzi all’Asmara
Giuseppe Pettazzi, nei suoi pochi anni di permanenza all’Asmara partecipa, per quello che è dato di sapere, anche ad altri importanti lavori come progettista. Ne citiamo alcuni: oltre all’edificio già descritto della Stazione di Servizio Fiat dei Fratelli Tagliero, con le “sue ali da airone”, progetta e costruisce l’officina riparazione e magazzino ricambi sempre Fiat e si occupa anche di importanti lavori stradali come la strada di arroccamento di “Adigrat”, nel primo tronco “Adigrat-Passo Alequà”.
Quindi progetta e porta a termine per la ditta Berti la Tagliero alimentari e per Leopoldo Belli i saloni di vendita della Upim-Rinascente. Da notare che la stazione di servizio Fiat-Tagliero viene inaugurata alla presenza del Duca Amedeo D’Aosta, l’eroe, di lì a pochi anni dell’Amba Alagi.
Si arriva così al 15 Agosto 1939 quando Pettazzi si concede una licenza in Italia e parte da Asmara con viaggio in aereo e tappe a Kartoum – Tripoli – Bengasi – Roma per giungere a Rocchetta Tanaro (AT) che era la casa dei suoi genitori, Ubaldo e Maria.
Giusto per sedersi al tavolo della vittoria Mussolini porta l’Italia allo sfascio totale. Di lì a pochi giorni, il 3 Settembre 1939, Hitler scatena, con l’invasione della Polonia quella che sarà una tra le più sanguinose e spietate guerre della storia che, sulla terra, sui mari e nei cieli, coinvolgerà tutto il mondo. L’Italia, per decisione di un solo uomo, nell’affannosa e assurda rincorsa di gloria, e “per sedersi al tavolo della vittoria” come più volte raccontato a giustificazione di quella disastrosa guerra, per sua parte, pagherà un prezzo altissimo trascinandosi anche in una cruenta guerra civile con il grande dilemma di ogni Italiano che era quello, dopo l’8 Settembre 43, da quale parte schierarsi, o meglio se rimanere coerenti cioè fedeli al regime oppure tradire, cioè “badogliare”. Giuseppe Pettazzi, proprio nel settembre del 1939, viene richiamato dalla sorella Franca che era giunta in Asmara pochi mesi prima, non pensando che la guerra avrebbe avuto poi quegli sviluppi disastrosi anche per le colonie Italiane. Ma proprio nel Settembre del 39, mentre sta per ripartire dall’Italia diretto in Eritrea, accade un altro fatto che avrà una influenza importante per la sua futura esistenza.

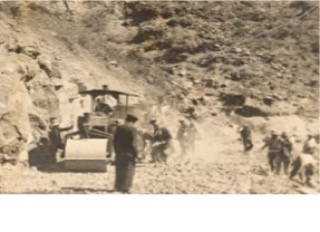
I lavori di costruzione per la strada di collegamento tra “Adigrat e Passo Alequà” in Africa Orientale italiana diretti dall’Ing. Pettazzi. Durante i 56 giorni di combattimenti per la conquista di Cheren da parte degli Inglesi, questa strada, nella gola di Dongolas fu ostruita da pesanti massi fatti crollare dall’esercito italiano per impedire l’ingresso a Cheren.

Una cartina della zona di Cheren tenuta sin quasi all’annientamento da parte del Battaglione UORK AMBA che scrisse una delle ultime e più tormentate pagine della nostra storia coloniale. La maggior parte dei caduti sono sepolti, spesso senza nome, nel bianco cimitero di Cheren che conserva anche le spoglie di molti amici di Pettazzi caduti in battaglia.


La bussola originale usata dall’Ing. Pettazzi che faceva parte della sua attrezzatura in Asmara che é ancora utilizzata da suo figlio Ubaldo per le gite in montagna. E l’orologio che Guido Rovaro Brizzi, suo compagno di prigionia, gli donò in punto di morte pregandolo di portarlo ai suoi genitori. Cosa che fece al suo ritorno in patria, ma i genitori di Brizzi vollero che Pettazzi lo conservasse in ricordo del loro figlio. Alla morte di suo marito, Giovanna Calissano disse ai figli: “ed io continuo a caricarlo… fatelo anche voi…”.
Sotto: L’ingresso del Paese di Rocchetta Tanaro dove Giuseppe Pettazzi si conobbe con Giovanna Calissano. Le loro tombe sono uno vicino all’altra nel riposo eterno.

L’incontro sulla diligenza con Giovanna Calissano
Sulla diligenza chiamata del “Giaun” davanti alla casa della “Rita”, proprio a Rocchetta Tanaro, incontra con lo sguardo ... una persona. Uno di quegli sguardi che rimangono impressi per sempre. Occhi che si incontrano e che in qualche modo si promettono! Sono diretti entrambi alla stazione, lui per prendere a Torino il biglietto dell’aereo che lo avrebbe riportato all’Asmara dalla sorella, e lei per andare a Rapallo. Gli occhi che incontra, splendenti, chiari, verdi, sono di Giovanna Calissano, quella che poi nel 1947 diventerà sua moglie che era originaria di Alba. Ma i suoi genitori avevano delle terre a Rocchetta Tanaro per questo il destino fu complice! E li fece incontare. Nelle sue memorie scritte a mano in un piccolo diario, con quella meravigliosa calligrafia di un tempo, lei, racconta così quell’incontro: Vedo tutto Papà, bello, sorridente col suo spolverino color sabbia, saltare sul predellino della diligenza già al completo. Da allora si accese nel cielo la stella del nostro destino che ci riservava silenziosamente l’una per l’altro, per sette lunghi anni di tacite speranze e di sogni che apparivano irrealizzabili..... Non è dato di sapere se in quell’incontro si “dichiarano”, ma sicuramente si parlano e soprattutto si penseranno l’un l’altra per “sette lunghi anni”. Non è approccio retorico, a quel tempo si usava così!
Nel Maggio del 1940, Pettazzi, che si trova in Eritrea, viene richiamato in servizio militare come Sergente allievo e poi Ufficiale al ventunesimo battaglione fanteria di Asmara. Deve abbandonare tutto, sogni, progetti e azienda di costruzioni. Più tardi lascerà la procura dell’azienda a sua sorella Franca. Verso la fine di Maggio il suo gruppo viene trasferito ad Adis Abeba e prende posizione sulla prima linea difensiva del Campo di Aviazione di Adis Abeba.
Viene incaricato dal Comando Difesa di rilevare questa prima linea difensiva. Lavoro che viene eseguito con i pochi strumenti tecnici di allora, principalmente con una bussola graduata gonio- metricamente, ancora conservata e usata dal figlio Ubaldo per le sue gite col CAI–Club Alpino Italiano e una rolletta decametro. Suoi aiutanti sono tre soldati del suo stesso gruppo.
Sottotenente degli alpini per la difesa di Cheren – Una pallottola gli attraversa il cappello Nel Dicembre 1940 viene nominato Sottotenente e così, acquista, cioè compra con i suoi soldi, il suo cappello da Alpino all’Unione Militare di Adis Abeba. Lo stesso cappello di Alpino che orgogliosamente riuscirà a portare a casa anche dopo la prigionia in India, attraversato, durante i combattimenti, da una pallottola che gli provocò una leggera ferita. Il buco, rammendato, con “ago e spago” è ancora visibile nella parte alta del cappello. Lo stesso cappello, che non abbandonerà mai, altrettanto orgogliosamente, con dignitosa fierezza, lo indosserà nei raduni degli Alpini ai quali non mancava mai, dopo la guerra, per tanti anni, sino alla sua scomparsa che, ricordiamo, è avvenuta all’età di 94 anni nel 2001. Non solo, organizzerà, all’interno di questi raduni, il 24 e il 25 Maggio 1967 in quella che è ormai diventata ormai la “sua Rapallo” una grande adunata dei Reduci di Cheren riportata dai giornali dell’epoca.
Sotto: Dopo l’8 settembre 1943 per la scissione tra “collaboratori e non cooperatori” Pettazzi viene trasferito al campo 25 riservato ai “non cooperatori”. Sul suo cappello di alpino sono cucite le targhette metalliche di appartenenza al campo 25 e una medaglietta coniata dopo la prigionia con la seguente scritta: “L’ONORE HA PER TESTIMONIO LA PROPRIA COSCIENZA E PER DIFENSORE IL CORAGGIO” – SALO’ 1952 – CAMPO 25 – NON COOPERATORI. La sua coscienza, evidentemente non venne mai meno né durante la prigionia, né dopo.

Sotto: Il cappello daAlpino del Sottotenente Giuseppe Pettazzi. Lo indossava in Africa Orientale Italiana per la difesa di Cheren. E’ ancora evidente (particolare in alto a destra) la cucitura fatta con lo spago in seguito ad una pallottola che gli provocò una lieve ferita alla testa. Fino alla sua scomparsa lo indossò sempre con orgoglio specialmente nei raduni del dopoguerra.

Sotto: Il villaggio di Cheren teatro, nel 1941, di una sanguinosa battaglia con intorno tutti i morti dove era attestato il battaglione UORK AMBA. Fu l’ultimo baluardo prima della perdita dell’A.O.I. Giuseppe Pettazzi, dopo i cinque anni di prigionia in India mal volentieri ricordava quei momenti terribili specie subito dopo la liberazione. Nomi inconsueti come Cima Forcuta, Dologorodoc, Dekameré, Adi Ugri, Omo Bottego, Nolisò, Gimma e infine Cheren e Amba Alagi…

Il battaglione Uork Amba (montagna d’oro)
Col grado di sottotenente, Giuseppe Pettazzi, viene assegnato al Battaglione UORK AMBA schierato sull’Omo Bottego con il comando a Nolisò sulla strada per Gimma. Gimma, sarà l’ultimissimo caposaldo Italiano a cadere in mano agli Inglesi addirittura anche dopo l’Amba Alagi. Ma è anche giusto ricordare che quei “poveri soldati Italiani”, già male equipaggiati con armi antiquate della prima guerra mondiale, e senza mezzi, erano dei dimenticati da Dio e dalla Patria, senza appoggio aereo, senza rifornimenti, non solo di armi e munizioni, ma anche di viveri, acqua, medicinali e quant’altro poteva servire in una guerra senza tregua.
Il 26 marzo del 41, il Comando Supremo Italiano è costretto a porre fine alla resistenza nella zona di Cheren. Tre medaglie d’oro, 500 morti e centinaia di feriti attestano il sacrificio del battaglione sulla cima Forcuta e sul Dologorodoc. I resti del “Uork Amba”, un centinaio di uomini e due ufficiali, per sottrarsi alla cattura percorsero 100 Kilometri di zona montana per arrivare ad Asmara. Da qui proseguirono su Massaua dove combattono ..... l’ultima battaglia.
È il primo di Aprile 1941. Su una forza complessiva di 1000 uomini, dopo due mesi di combattimenti ne rimasero incolumi solo 130 mentre oltre 300 furono i caduti.
Giovanna Calissano ricorda... gli amici di Papŕ Citiamo alcuni valorosi Alpini dell’ “Uork Amba” per ricordarne la memoria, come leggiamo nelle note di Giovanna Calissano che è un po’ la nostra guida storica e cronologica: Tenente Colonnello Peluselli, ......... . il Capitano Romeo, .......... il Tenente Luciano Orlando, .......... il Tenente Marcello Bressan, .......... Smaniotto, .......... poi aggiunge.......... le diapositive da noi viste in casa di Romeo a Belgirate sono ora in mano di Bressan, ricorda.
Ci è sembrato giusto ricordare alcuni pezzi di storia di quella eroica e sanguinosa, “ultima battaglia”, per la difesa dell’Africa Orientale Italiana con postazioni strategiche prima perdute, poi riconquistate e poi perdute definitivamente.
Tra il 24 febbraio e il 4 marzo gli alpini dell’Uork Amba tennero sia le Cime Biforcute che il monte Panettone. Il 28 febbraio Cheren, Dekameré e Adi Ugri vennero sconvolte dal terrificante bombardamento di tre successive ondate di aerei, e il 4 marzo le truppe d’assalto inglesi occuparono il monte Tetri di dove, nel corso della successiva notte, vennero ricacciati dai carabinieri e dal battaglione Uork Amba che vi era stato prontamente inviato. E il 15 marzo iniziò la nuova terrificante battaglia che vide il sacrificio e l’eroismo degli alpini dell’Uork Amba come pure dei bersaglieri, dei carabinieri, degli artiglieri, granatieri e cavalleggeri, dei genieri e dei fedelissimi ascari. Sui nostri reparti piovvero, in poche ore, oltre 32 mila granate; il combattimento che seguì durò quindici ore, ininterrottamente. Il successivo giorno, 16 marzo, la lotta continuò furibonda e tutti i nostri reparti furono superiori ad ogni elogio. L’Uork Amba, attestato sul Samanna, fu ancora ammirevole. Il sottotenente Bortolo Castellani, da Belluno, cadde meritandosi la medaglia d’oro al valore militare. Anche Pettazzi è nel mezzo di questa bolgia infernale e partecipa a questa impari lotta! Le condizioni di vita durante queste battaglie erano inumane, specialmente per il tanfo e la puzza emanata dai cadaveri dei soldati caduti e dagli animali putrefatti. Il terreno roccioso e il caldo insopportabile non consentivano di scavare delle fosse per seppellirli.

L’articolo del Secolo XIX con la foto del Labaro della sezione di Rapallo dei reduci di Cheren. Era presente tra gli altri la vedova della medaglia d’oro Bruno Brusco. Un telegramma della duchessa Anna d’Aosta, vedova di Amedeo, l’eroe dell’Amba Alagi ricordava la loro inalterata fedeltà e riconoscenza alla memoria del marito.
Sotto: Il sacrario dei Caduti della divisione Cunense al Colle di Nava con la targa dedicata a Pio Viale ucciso in prigionia dagli Inglesi. Uno dei tanti amici che Giuseppe Pettazzi ha perduto durante la guerra in A.O.I. per la difesa di Cheren.

Una ferita alla mano che si infetta salva la vita a Giuseppe Pettazzi
Chissà, viene da domandarsi, se a questo punto prese in mano... “quella pistola” !!! Giuseppe Pettazzi, intorno al 20 Marzo, pochi giorni prima della perdita di Cheren, riporta una ferita alla mano che, invece di guarire, per le disastrose condizioni igieniche, si trasforma in una dolorosa piaga tropicale. Viene trasferito agli ospedali di Elabereth e assistito dal dott. Vandelli e da Zio Miro, che era il Dott. Casimiro Simonetti,
suo cognato avendo sposato la sorella Franca, già in Asmara e a quel tempo crocerossina. all’ospedale di Asmara. Il 17 marzo era caduto il generale Orlando Lorenzini mentre, col cappello
d’alpino in testa, dirigeva l’azione contro il Dologorodoc; alla sua memoria venne conferita la medaglia d’oro. Gli eroismi furono innumerevoli e sovrumani, ma all’alba del 27 marzo i reparti italiani, con l’Uork Amba in retroguardia, lasciarono Cheren:
Cheren era perduta .... per sempre ... . era l’inizio della fine! Dopo 56 giorni di combattimenti i no- stri soldati tra Italiani ed Ascari Eritrei a Cheren erano 45 mila e ne morirono 12.147;
21.700 riportarono ferite e mutilazioni; non vi fu un solo disertore italiano né eritreo. Gli alpini dell’Uork Amba erano 916. Dei 21 ufficiali, 5 sono morti e 14 gli spedalizzati; tra i 55 sottufficiali i morti furono 18 e i feriti spedalizzati 26; degli 840 uomini di truppa ne morirono 300; ne vennero ricoverati per ferite 420.
In totale le perdite furono di 783 su 916: l’86 per cento! Dopo essersi attestati ad Ad Teclesan, i pochi alpini rimasti validi raggiunsero Zàzega e, il 31 marzo, l’Asmara; il primo di Aprile passarono per Nefasit e Ghinda e infine a Massaua dove combatterono fino all’8 aprile per la disperata difesa di quella città; i sopravvissuti proseguirono per Decameré ed Agordat per concludere sull’Amba Alagi a fianco degli altri magnifici soldati del Duca d’Aosta.
La vita del Battaglione alpino «Uork Amba», era durata soltanto cinque anni ma rimarrà indelebile nella storia d’Italia. il battaglione aveva lasciato sul terreno, tra morti e feriti, 783 uomini su 916; questo gli valse due medaglie d’oro al valor mi- litare. Con la fine del conflitto in Africa il battaglione fu sciolto.
Per l’esercito inglese fu un grande successo. Nei tre mesi di guerra fece prigionieri oltre 230.000 uomini, anche se in alcune zone la resistenza italiana continuò nei mesi seguenti. In Italia, il bollettino di guerra n.348 del 19 maggio diede la notizia della caduta dell’Amba Alagi e della cattura del Duca d’Aosta e del suo seguito dopo “una resistenza oltre ogni limite”.
Ancora caduti, tutti amici di Pettazzi
Nell’ultima decade di Marzo cadono sulla linea di difesa di Cheren, quota Forcuta, i Sottotenenti Brusco, medaglia d’oro, ..... Bortolo Castellani, medaglia d’oro, ...... De Maria, ...... Giuseppe Masocco di Agliano d’Asti, ...... ..Trealdi, tutti amici di Pettazzi ricordati dalla moglie nel suo piccolo diario che continua, raccontandoci altri preziosi momenti di quelle tragedie.
Dei sei Sottotenenti in linea di combattimento Pettazzi è stato l’unico superstite e si salvò perché ricoverato in ospedale. Il 1 Aprile 1941 cade l’Asmara e il Sottotenente Pettazzi viene fatto prigioniero dagli inglesi nella stessa data. Nonostante tutto, come ripetiamo potè rite- nersi “un fortunato sopravvissuto”.
La guerra per lui è finita e forse dovrà ringraziare quella ferita alla mano, addirittura quella piaga tropicale e il successivo ricovero in ospedale, se ha potuto uscire vivo da quell’inferno!
Sotto: Il cimitero di Cheren dove é sepolto e identificato Bruno Brusco anche lui sottotenente degli Alpini come Pettazzi. Nelladifesa di Cheren, Pettazzi fu l’unico a salvarsi dei sei sottotenenti del Battaglione UORK AMBA.

Sotto: I poco veritieri giornali del Regime Fascista, riportavano spesso notizie del tutto infondate sulla reale situazione in Africa Orientale e non solo. Ma in realtà la difesa di Cheren fu un capitolo di straordinario eroismo da parte del Battaglione UORK AMBA. Il battaglione aveva lasciato sul terreno tra morti e feriti 738 uomini su 916. Questo gli valse due medaglie d’oro al valor militare.
Cinque anni di prigionia in India
I primi quattro o cinque mesi da prigioniero degli Inglesi li passa a Kartoum, località Ondurman sul Nilo. Poi viene trasportato in India a Bophal, località bassopiano di Bairahar: campo di stoppie con pioggia, fango, poca acqua. Gli alloggi sono poche tende malconce e strappate piene di buchi. La località di Bophal nel 1984 sarà teatro di una spaventosa tragedia provocata dall’Union Carbide India Ltd filiale indiana dei giganti della chimica americana per una accidentale fuoriuscita di gas altamente tossico. I morti furono tra otto- mila e diecimila secondo il Centro di ricerca medica indiana, oltre venticinquemila, secondo Amnesty International.
L’uccisione di Pio Viale ricordato nel Sacrario di Nava
Quella sera in particolare, nel campo 28, mentre cantavano in gruppo nei pressi dei reticolati, le guardie Inglesi spararono, uccidendo, il Capitano Pio Viale. Nel sacrario dei caduti a Nava, vicino a Pieve di Teco, c’è anche il suo nome, e del Capitano Cesare Rossi. Pettazzi nell’attiguo campo 25 sentì le fucilate e il mattino seguente seppe la notizia. Il cimitero dei campi era a Darham-Salam una località poco lontano.
Fino a tutto il 1943 il sottotenente Pettazzi rimane prigioniero nel campo 28; i campi erano quattro: 25, 26, 27. 28 di 2500 prigionieri ciascuno.
La malaria curata con “pork & soia”
Cinque anni di prigionia in India
I primi quattro o cinque mesi da prigioniero degli Inglesi li passa a Kartoum, località Ondurman sul Nilo. Poi viene trasportato in India a Bophal, località bassopiano di Bairaghar: campo di stoppie con pioggia, fango, poca acqua. Gli alloggi sono poche tende malconce e strappate piene di buchi. La località di Bophal nel 1984 sarà teatro di una spaventosa tragedia provocata dall’Union Carbide India Ltd filiale indiana dei giganti della chimica americana per una accidentale fuoriuscita di gas altamente tossico. I morti furono tra otto- mila e diecimila secondo il Centro di ricerca medica indiana, oltre venticinquemila, secondo Amnesty International.
L’uccisione di Pio Viale ricordato nel Sacrario di Nava
Quella sera in particolare, nel campo 28, mentre cantavano in gruppo nei pressi dei reticolati, le guardie Inglesi spararono, uccidendo, il Capitano Pio Viale. Nel sacrario dei caduti a Nava, vicino a Pieve di Teco, c’è anche il suo nome, e del Capitano Cesare Rossi. Pettazzi nell’attiguo campo 25 sentì le fucilate e il mattino seguente seppe la notizia. Il cimitero dei campi era a Darham-Salam una località poco lontano.
Fino a tutto il 1943 il sottotenente Pettazzi rimane prigioniero nel campo 28; i campi erano quattro: 25, 26, 27. 28 di 2500 prigionieri ciascuno.
La malaria curata con “pork & soia”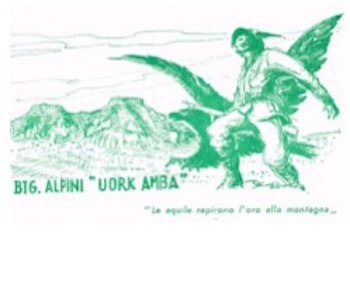
Un’altra immagine del Battaglione UORK AMBA al quale l’alpino Pettazzi era molto legato. UORK AMBA in lingua eritrea significa “Montagna d’oro”
L’8 Settembre 43 Pettazzi è a letto con la febbre per la malaria, e conseguente dissenteria bacillare curata con “pork and soia”. Dopo l’otto settembre 1943 per la scissione tra “collaboratori e non cooperatori” Pettazzi viene trasferito al campo 25 riservato ai “non cooperatori”. Sul suo cappello di alpino sono cucite le targhette metalliche di appartenenza al campo 25 e una medaglietta coniata dopo la prigionia con la seguente scritta: “L’ONORE HA PER TESTIMONIO LA PROPRIA COSCIENZA E PER DIFENSORE IL CORAGGIO” - SALO’ 1952 – CAMPO 25 – NON COOPERATORI”. La sua coerenza, evidentemente non venne mai meno né durante la prigionia, né dopo.
La vita è molto dura in India, non ultima l’inedia del prigioniero che vive soltanto nella speranza della fine della guerra e della conseguente liberazione. E’ una debilitazione morale spa- ventosa oltre che fisica per la scarsità di cibo, di acqua, di confort e non meno importante di affetti.
La guerra finisce in Europa il 25 aprile 1945 ma per quei prigionieri di liberazione non se ne parla. Eppure con una radio clandestina, ascoltata di nascosto, i prigionieri lo sanno che la guerra è finita. Ma le proteste sono inutili. Nel 1946, Pettazzi e le altre migliaia di Italiani sono ancora prigionieri anche se le restrizioni vengono un po’ allentate. Evidentemente quei prigionieri sono dimenticati dal governo italiano che stenta a riprendere le fila della normalità anche in patria. Il 25 Aprile 1946, ad un anno esatto della fine della guerra, per un’ultima volta gli viene ancora ostinatamente richiesta la firma se confermava “fedeltà alla monarchia o ai badogliani o alla Repubblica Sociale”.
Tutto il campo 25 restò fedele alla Repubblica Sociale Italiana mentre chi non le confermava fedeltà, le cosidette “maddalene”, passarono nei campi “badogliani”, in una parola, nel campo dei traditori. Gli americani, dopo l’otto Settembre del 43 coniarono addirittura un nuovo verbo: “to badogliate” col significato di “tradire e tergiversare, in una parola essere inaffidabile”. Il riferimento ai comportamenti del Maresciallo Badoglio era più che evidente.
25 Dicembre 1946 – Il prigioniero di guerra n. 87.418 torna a casa
Finalmente, ai primi di Dicembre del 1946 viene comunicato che il rimpatrio sarà effettuato tra pochi giorni. Il 13 Di- cembre 1946, finalmente, trasferimento a Bombay dove avvenne la partenza su una nave trasporto truppa il “Tamaroa”. Navigazione da Bombay a Napoli con vitto di broda e gallette; qualche cipolla elargita dagli indiani, alloggiamenti qualche amaca, brande a castello, per i più il nudo pavimento.
Tutti vengono sbarcati a Napoli il 22 Dicembre 1946. Poi trasferiti a Roma il 23 in pantaloni di tela e cappotto verde- violento con una toppa romboidale nera sulla schiena per indicare la posizione dell’individuo che la portava, cioè il “prigioniero di guerra”. Il “darry”, parola indiana che era il nome di un piccolo stuoino, dove venivano raccolti anche gli effetti personali, più una piccola cassetta di legno con nome, cognome e “P.O.W.” cioè:
Prisoner of war “prigioniero di guerra numero 87.418” - Altezza 1,87 - Peso 50 Kg.
A Roma subisce poi l’interrogatorio per le generalità di appartenenza al reparto e altre notizie sulle circostanze della cattura da parte degli Inglesi e conseguente prigionia. Viaggio da Roma a Rocchetta Tanaro nei disastrati treni di quel tempo. Finalmente, il 25 dicembre 1946 arriva a casa. Era alto un metro e ottantacinque cm. e pesava soltanto 50 Kilogrammi!
Dopo un po’ di giorni di ambientamento e di buona cucina piemontese, sotto lo stretto controllo alimentare del dottor Casimiro Simonetti, di Zio Miro, quel sogno che lo aveva accompagnato per tanti anni finalmente si realizza. Giovanna Calissano, già viveva a Rapallo dove insegnava lettere al Collegio delle suore Orsoline, che era lo stesso istituto che aveva frequentato da bambina.
Il coronamento di un sogno
Sabato 25 Gennaio 1947, Giuseppe Pettazzi “finalmente”, si incontra con Giovanna Calissano proprio a Rapallo, che diventerà la loro città di adozione. ...dopo avermi scritto una lettera ai primi dello stesso mese... annota lei! Il 3 Settembre 1947 Giuseppe Pettazzi e Giovanna Calissano si sposano a Rapallo nella stessa Chiesa delle Suore Orsoline. Il matrimonio viene celebrato dal Cardinale Siri di Genova che era stato professore di Religione e preparatore spirituale di Giovanna durante tutti gli anni dell’Università. Il cardinale fu ben lieto di celebrare il matrimonio, ma come unica condizione aveva richiesto che fosse officiato in forma strettamente privata alle ore sette del mattino. Sempre dal piccolo diario leggiamo .....raggiungimento di un sogno lungamente e segretamente accarezzato...
Un orologio .... da caricare sempre .....
E’ sempre Giovanna Calissano che scrive: Guido Rovaro Brizzi, geometra che lavorò con Papà, prima di morire in ospedale durante la prigionia volle consegnare a Papà il suo orologio pregandolo di portarlo ai suoi genitori. Appena tornato in patria Papà li cercò e andò a consegnare l’orologio: ma essi vollero che lo conservasse lui. E Papà lo portò sempre al polso.... Ed io continuo a caricarlo....fatelo anche voi....rivolgendosi ovviamente ai figli.....
Rapallini di adozione .... Non più “foresti”
Giuseppe Pettazzi e Giovanna Calissano riprendono faticosamente la vita normale e diventano entrambi Rapallini di adozione. A Nava vicino a Pieve di Teco, hanno la loro casa di campagna che sarà la meta estiva, per tanti anni, di felicissime e indimenticabili vacanze con i figli piccoli ai quali cerca di insegnare certi valori e soprattutto l’amore per la montagna perché dentro, è rimasto un .... “Alpino”, Un alpino del Battaglione UORK AMBA.
Rimangono sposati per ben 54 anni. Nel dopoguerra, col suo cappello da Alpino acquistato in Adis Abeba, lacerato da una pallottola il cui strappo è stato malamente rammendato, Giuseppe Pettazzi non manca mai alle adunate annuali del suo corpo. Anzi nel 1965 organizza a Rapallo una riunione dei “Reduci di Cheren” e così continuerà a portare rispetto alla sua Bandiera e al corpo degli Alpini. Con orgoglio sfila per le vie delle città nei raduni che si susseguono in tutta Italia, ogni anno. A Vicenza nel 1991 durante il 64mo raduno il Battaglione UORK AMBA sfila per la città con un suo striscione in ricordo soprattutto dei caduti e di quei valori di Patria che lui non ha mai dimenticato. Pettazzi è là, nel mezzo, il più alto tra tutti, a reggere questo ultimo lembo di storia, di valori, di eroismo.
Sotto: la casa di campagna al Colle di Nava, a circa 1000 metri di altitudine, sarà per molti anni meta di felici e indimenticabili vacanze dei coniugi Pettazzi con i quattro figli piccoli. Il secondogenito Ubaldo ne continua la cura e la manutenzione, molto impegnativa, data anche la notevole estensione del terreno circostante.

I reduci di Cheren sfilano a Vicenza nel Maggio del 1991. Giuseppe Pettazzi é al centro, il quinto da destra che con orgoglio indossa ancora il suo cappello da Alpino.
BATTAGLIONE ALPINI UORK AMBA: Avendo in programma la guerra d'Etiopia, il 31 dicembre del 1935 il Comando Generale dell'esercito costituì la 5a Divisione Alpina Pusteria, formata da due reggimenti alpini, uno di artiglieria e due battaglioni strutturati, oltre a una compagnia mista genio. L'anno dopo, nel corso della battaglia del Tembien, il 7° Battaglione, guidato dal tenente colonnello Ferdinando Casa, ebbe un ruolo di primordine nella conquista del massiccio dell'Uork Amba ("Montagna d’oro") e da allora fu chiamato “Battaglione Alpini Uork Amba”. Alla fine delle ostilità, i componenti del battaglione prolungarono la ferma e furono integrati con altri complementi provenienti dall'ltalia: fu l’unica unità alpina in Africa Orientale. Con la fine del conflitto in Africa il battaglione fu sciolto.
Dal matrimonio sono nati 4 Figli: Cecilia (nata nel 1948), Ubaldo (nel 1950), Simonetta (nel 1954) e Metella (nel 1959). Poi nasceranno anche ben 8 nipoti: Francesco e Matteo, Chiara e Federica, Alessandro, Letizia, Raffaele e Laura. Giuseppe Pettazzi scompare a Rapallo l’8 di Ottobre 2001. La moglie, Giovanna Calissano lo segue l’8 di gennaio 2007. Entrambi sono sepolti a Rocchetta Tanaro; sono tornati là dove si erano in contrati tanto tempo prima, nel 1939, là dove era nato, in pochi attimi, un sentimento che durò tutta una vita. Era bastato uno sguardo! Per tanti anni si erano scritti e moltissime lettere non arrivarono mai a destinazione ma molte recuperate furono sempre conservate e custodite come un prezioso tesoro: sulla busta che le conteneva c’era scritto ...“nostro lungo quotidiano epistolario che sarà con noi e solo per noi per sempre”!... Giovanna Calissano in Pettazzi è stata sepolta con le “sue lettere” raccolte in una “bustina rossa” .... Entrambi ora, riposano in pace .... uniti per sempre... Nella documentazione, il cui contenuto, mal destramente cerchiamo di consegnare a chi gli ha voluto bene e perché no, alla storia, troviamo spesso dei bigliettini scritti dalla signora Giovanna Calissano in Pettazzi .... perchè i miei figli ricordino!
Sotto: La famiglia di Giuseppe Pettazzi e Giovanna Calissano, al completo con i quattro figli, nel giorno della prima comunione di Simonetta. Da sinistra Ubaldo, Simonetta, Giovanna Calissano, il vescovo di Chiavari Francesco Marchesani con davanti Metella, Franca Pettazzi, Giuseppe Pettazzi, Cecilia e un comunicando compagno di Simonetta. Franca Pettazzi, sorella di Giuseppe, 1939 si recò come crocerossina, dove conobbe e sposò il dottore Casimiro Simonetti (zio Miro), medico radiologo.

In punta di piedi, con rispetto, speriamo di avere esaudito il suo desiderio.

Ernani Andreatta con la consulenza di Simonetta Pettazzi Immagini di Famiglia Pettazzi, Ernani Andreatta e Luigi Frugone Bibliografia: Documentazione fornita dalla Famiglia Pettazzi
Sulla vita di Giuseppe Pettazzi sono disponibili anche due DVD del Museo Marinaro “Tommasino-Andreatta” di Chiavari con filmati storici dell’epoca e le voci narranti di: Stefano Schiappacasse, Barbara Bernabò e Nicola De Gregorio.
DAL VOLUME DI ARRIGO PETACCO
“QUELLI CHE DISSERO NO” (Ed. Mondadori)
Per informazioni: andreattaernani@libero.it - tel. 335 392.601
L'8 settembre 1943, quando dopo 1201 giorni di guerra il maresciallo Pietro Badoglio annunciò la firma dell'armistizio con gli Alleati, circa seicentomila soldati italiani si trovavano rinchiusi nei campi di prigionia che inglesi e americani avevano allestito in varie nazioni del mondo, dall'Egitto all'Algeria, dalla Palestina al Kenya, dal Sudafrica all'India, e persino alle Hawaii.
"Ma tu con chi stai, con il duce o con il re?" Fu il dilemma di fronte al quale si trovarono i nostri soldati, colti di sorpresa dall'annuncio della resa senza condizioni accettata dall'Italia e dalla conseguente fuga di Vittorio Emanuele III a Brindisi: dopo avere combattuto per anni contro un nemico preciso e riconosciuto, bisognava scegliere, all'improvviso, se passare o no dall'altra parte della trincea. Di questa massa enorme di giovani una cospicua minoranza scelse di non "tradire", ma gli storici, sia per la scarsità delle fonti ufficiali sia per la "delicatezza" politica dell'argomento, non se ne sono occupati che in maniera superficiale: ancora oggi, gran parte delle notizie utili a una ricostruzione di quegli anni ci giungono da pagine autobiografiche o dai resoconti memorialistici dei protagonisti. Molti dei quali, avendo risposto di no al- l'appello di Badoglio a rientrare in patria, anche per non subire odiose discriminazioni, preferirono il silenzio.
Pochissimi libri restituiscono voce e memoria ad alcuni di loro. Uno di questi uomini che dissero "no" fu Giuseppe Pettazzi che noi abbiamo voluto ricordare raccontandone la storia e le circostanze in cui si trovò coinvolto.
ERNANI ANDREATTA - Simonetta Pettazzi e famiglia
Rapallo, 4 Agosto 2017
webmaster Carlo Gatti
1494 - LA GUERRA DI RAPALLO
Settembre 1494 – LA GUERRA DI RAPALLO
L’ANTEFATTO
Papa Innocenzo VIII, in conflitto con Ferdinando I di Napoli a causa del mancato pagamento di quest'ultimo delle “decime ecclesiastiche”, aveva scomunicato il Re di Napoli con una Bolla dell’11 settembre 1489, offrendo il regno al sovrano francese Carlo VIII; nonostante nel 1492 Innocenzo, in punto di morte, avesse assolto Ferdinando, il regno rimase un “pomo della discordia” lanciato nelle politiche italiane. A questo si aggiunse la morte, quello stesso anno, di Lorenzo de’ Medici, Signore di Firenze e perno della stabilità politica tra gli stati regionali. Pacificati i rapporti con le potenze europee, Carlo VIII, che vantava attraverso la nonna paterna, Maria d’Angiò, un lontano diritto ereditario alla corona del Regno di Napoli, indirizzò le risorse della Francia verso la conquista di quel reame, incoraggiato da Ludovico Sforza, detto Il Moro (che ancora non era duca di Milano, ma ne era solo reggente).
QUADRO STORICO
Con la Prima guerra italiana (1494-1495) di Carlo VIII ebbe inizio la fase di apertura delle Guerre d’Italia del XVI secolo. Il conflitto vide da una parte Carlo VIII (Re di Francia dal 1483 al 1498)
ALLEATI:
Ducato di Milano
Repubblica di Genova
AVVERSARI:
Sacro Romano Impero
Spagna
- Alleanza dei maggiori stati italiani guidata da Papa Alessandro I, Repubblica di Venezia, lo Stato Pontificio, il Regno di Napoli ed il Ducato di Milano.
La riconquista del Sud della Penisola, già governato dalla Casata degli Angioini durante il secolo XIII, non comprendeva, nei progetti, anche la Sicilia. Quest'ultimo fatto depone a favore della tesi secondo la quale Carlo VIII non intendeva accrescere semplicemente i domini della sua Casata, ambizione comune a molte case regnanti di area mitteleuropea o anglosassone, ma farne piuttosto la base di partenza per quelle Crociate la cui eco era rinvigorita dalla cacciata degli arabi dall'ultimo possedimento spagnolo, il Regno di Granada (1492), avvenuta proprio in quegli anni. Il progetto politico della Res Publica Christiana Pro Recuperanda Terra Sancta aveva ancora presa nelle classi dirigenti europee nonostante la fine rovinosa cui andarono incontro sia la maggior parte di quel progetto stesso, sia coloro che intesero realizzarlo ben prima, intorno alla metà del Duecento.
LA BATTAGLIA DI RAPALLO
PIANA DI VALLE CRISTI
5 settembre 1494
Un evento poco conosciuto
Nell'ambito della Guerra d’Italia del 1494-1498, Carlo VIII discese in Italia il 3 settembre 1494 con un esercito di circa 30.000 effettivi dei quali 5.000 erano mercenari svizzeri, dotato di un'artiglieria moderna.
La battaglia di Rapallo fu combattuta:
- fra mercenari svizzeri, coi loro alleati genovesi e milanesi guidati da Luigi d’Orleans
- contro forze napoletane-aragonesi guidate da Giulio Orsini
In quel giorno la città di Rapallo venne invasa dalla flotta navale aragonese che sbarcò con 4.000 soldati comandati da Giulio Orsini, Obietto Fieschi e Fregosino Campofregoso per sollevare la popolazione rapallese contro Genova che era dedita alla signoria sforzesca. Tre giorni dopo (8 settembre) in città giunsero inoltre circa 2.500 soldati svizzeri che diedero vita ad uno scontro armato contro gli aragonesi presso il ponte sulle saline: tra le violenze generali e i saccheggi, si assistette all'uccisione di cinquanta malati ricoverati all'ospedale di Sant'Antonio (attuale sede del municipio) da parte degli elvetici.
MILANO, FRANCIA,NAPOLI - FUORIUSCITI GENOVA
|
Gaspare da San Severino Carlo di Brillac
|
Obietto Fieschi
|
|
Antonio Maria da San Severino Guido di Louviers
|
Giulio Orsini P
|
|
Galeazzo da San Severino Bravo
|
Fregosino Fregoso FP
|
|
Giovanni Adorno Onofrio Calabrese
|
Orlandino Fregoso P
|
|
Luigi d’Orléans Tommaso da Fermo
|
|
|
Gianluigi Fieschi Avanzino Cassiana
|
Francesco Fregoso P
|
|
Riccardo Bevilacqua
|
Paolo Battista Fregoso P
|
|
Antonio di Baissay
|
|
|
Angelo da Potenza
|
|
|
Francesco Nardo
|
|
|
Piennes
|
|
|
Giovanni di Lagrange
|
|
Francesi/sforzeschi:
1000 fanti svizzeri, fanti italiani;
Aragonesi: 40 uomini d’arme, balestrieri a cavallo, 3000 fanti. Attacco ad una testa di ponte aragonese portato da terra e dal mare; fallimento del contrattacco aragonese.
- I napoletani perdono circa 200 uomini, mentre altri 250 sono feriti. Gli svizzeri uccidono 60 fanti rifugiatisi nell’ospedale di San Lazzaro. Per il Floro nel combattimento restano uccisi d’ambo le parti 500 uomini.
-

Porta delle Saline. All'estremità occidentale del Lungomare Vittorio Veneto si trova la "Porta delle Saline", che delimita e divide dal mare la zona pedonale del centro storico. E' l'unica sopravvissuta delle cinque porte dell'antico "borgo murato", e deve il suo nome alla vicinanza con le Saline, di cui la famiglia genovese dei Doria aveva il monopolio, che furono in attività per molti secoli nella zona pianeggiante presso la spiaggia al centro del golfo. Nella parte che si affaccia verso il centro storico, è abbellita da un altare barocco che accoglie una riproduzione della celebre icona della Madonna di Montallegro. Ha evitato la demolizione grazie a successivi restauri, al contrario delle altre porte del vecchio borgo che, nel tempo, sono state demolite.

Flotta Navale d’Aragona
La flotta franco-genovese aveva stabilito una base a Rapallo, in Liguria, per assicurare gli approvvigionamenti all'esercito di Carlo VIII e soprattutto il trasporto delle pesantissime artiglierie. In quell'occasione i mercenari svizzeri al soldo del re di Francia avevano dato prova di una brutalità inusitata quanto inutile, saccheggiando la cittadina subito dopo uno scontro con le forze aragonesi. I francesi avevano avuto quindi modo di suscitare le ire dei rapallesi e con loro dei genovesi stessi, che si sarebbero vendicati l'anno seguente.
Resisi conto, nel giro di pochi mesi, di aver fatto un pessimo affare, i principi italiani decisero di coalizzarsi, il Moro incluso, ma disponevano, tra tutti, di un esercito inadeguato quanto a dimensioni e a organizzazione. Per fortuna le Marine italiane, costantemente impegnate in duri pattugliamenti nel corso della propria lotta plurisecolare contro i pirati barbareschi, erano di ben altra pasta.
Infatti, il 2 maggio 1495, la flotta francese (sette galere, due fuste e due galeoni), comandata dal Sire de Molans si scontrò con la squadra genovese di Francesco Spinola e di Fabrizio Giustiniani, (otto galere, due saettie e una caracca).

Lo scontro avvenne all'alba, e fu una sconfitta totale per i francesi: tutte le navi vennero catturate, e, contemporaneamente, a terra, un contingente di truppe sbarcate dalla flotta genovese al comando di Gian Ludovico Fieschi e Giovanni Adorno, aiutati dai Rapallini, sbaragliarono i transalpini rimasti a terra prendendo il controllo dell'abitato. Furono così liberate trecento donne, rapite in Campania a titolo di ostaggi, mettendo altresì le mani su un fantastico bottino utilizzato, in seguito, per costruire la sontuosa chiesa dell’Annunziata, a Genova.
Il successo ottenuto venne incrementato pochi giorni dopo quando un convoglio di dodici velieri venne catturato nelle acque di Sestri Levante.
Nel bilancio della battaglia si devono considerare poi le ingenti ricchezze trasportate dalle navi dei transalpini, che comprendevano, tra l'altro, diverse donne e monache partenopee, e le porte bronzee di Castel Nuovo di Napoli. Porte che poco dopo vennero restituite, e che recano ancora, sul retro, i segni della battaglia di RAPALLO. Il resto del bottino fu distribuito tra i marinai, i soldati e i comandanti, e in parte venne usato per erigere la chiesa di Santa Maria Annunziata a Genova.
Dopo questa sconfitta la flotta francese cessò virtualmente di esistere per molti e molti anni. Ciò inoltre rese molto più precaria la situazione di Carlo VIII, che si vide costretto a ritirarsi dal momento che non poteva più contare né su vie di terra, (ora che non aveva più appoggi negli stati italiani), né su rotte di mare per i contatti con la Francia, l'approvvigionamento e la spedizione del bottino fatto in Italia, senza contare l'assenza di navi per trasportare la sua tanto poderosa quanto pesante e lenta artiglieria.
Per pura curiosità segnaliamo che in quei giorni di grande tensione nella sua Liguria, Cristoforo Colombo impegnato nel suo Secondo Viaggio nel NUOVO MONDO, si convinse che Cuba fosse un continente. Il 12 giugno 1494 si trovò di fronte all'isola di San Giovanni evangelista, a 100 miglia dalla fine dell'isola. Colombo fece firmare ad ognuno dei componenti delle caravelle un giuramento con il quale si affermava che si era giunti nelle Indie, nel continente. Nei giorni della Battaglia di Rapallo il grande Ammiraglio si ammalò e tornò a Isabela il 29 settembre 1494.
Carlo GATTI
Rapallo 20 luglio 2017
STELLA MARIS - CAMOGLI
STELLA MARIS
LA FESTA DELLA GENTE DI MARE E DELLA COSTA
La prima domenica d’agosto, ogni anno si celebra a Camogli la Festa della

Madonna Stella Maris
Le cerimonie religiose che ancora oggi si praticano in tanti porti del Mediterraneo sono incantesimi, perennemente reiterati contro il capriccio delle bufere e delle tempeste. Gli ex voto di marinai scampati al pericolo parlano di quella paura annidata nel cuore degli uomini, che mai si abbandonano a cuor leggero alla perfidia delle onde. E' alla Vergine Maria, "Stella Maris", Stella del Mare, che i marinai dell'occidente raccomandano i loro carichi, e soprattutto i loro corpi e le loro anime.
Fernand Braudel

Punta Chiappa - Camogli. Opera di F. Dal Pozzo dedicata alla Madonna Stella Maris (Stella del Mare)- Il mosaico s’ispira all’antichissimo affresco ritrovato nella chiesa di S.Nicolò.
La ricorrenza fu ideata nel 1924 da Don Nicolò Lavarello, Rettore della Chiesa di San Nicolò di Capodimonte e da allora ogni anno la prima domenica di agosto si ripete.
L’intera giornata è dedicata alla Madonna protettrice di chi va per mare.

Isola di Tinetto – La statua della Stella Maris

Camogli - STELLA MARIS; Giuseppe Bozzo, 2003
olio su tela cm 120 x 80
Maria, come recita un'antico inno, è, specialmente nel mese di Maggio, invocata come "Stella Maris". Perchè la Madonna viene chiamata "Stella del Mare"? Le stelle si presentano come un segnale luminoso e posseggono un loro fascino simpatico e misterioso per tutti noi, ma per quanti operano in mare esse sono sempre state fondamentali per la sicurezza della navigazione.
Quando il cielo era limpido e la notte serena, la loro fiammella era il richiamo rassicurante per il procedere in mare ed in vista della meta desiderata. Ed anche quando il firmamento restava oscurato dalle nuvole, era motivo di fiducia il pensiero che comunque le stelle al di là continuavano ad esistere e non cessavano di mandare la loro flebile luce, anche se momentaneamente non veniva percepita.
Nel mare della vita tutti abbiamo bisogno di avere qualche stella, che ci mandi la sua luce, ci indichi il cammino, ci doni sicurezza. Quando siamo sinceri con noi stessi sentiamo che non si può vivere in una continua oscurità e senza almeno qualche certezza. La notte della mente e del cuore fa paura, suscita ansia, blocca la vita e nessuno può essere talmente masochista da voler vivere in una situazione di perenne confusione e di vuoto interiore.
Abbiamo bisogno di luce spirituale per vivere sereni, vogliamo vedere davanti a noi il cammino da percorrere, desideriamo conoscere la strada del nostro destino e la meta della nostra vita.
Maria può essere quella guida materna che la nostra vita ricerca, si presenta come la stella luminosa del mattino delle nostre giornate, è la voce di quel navigatore spirituale che indica la strada da percorrere.
“Fate quello che Gesù vi dirà”. Ecco la voce della stella, ecco l’indicazione del navigatore. Ha un nome, Maria, e dice una cosa: “Fate quello che Gesù vi dirà”.
Maria è la stella del mare della vita, che manda la sua luce solo a quanti alzano gli occhi verso di lei e sanno mettersi nel silenzio, come quando vogliamo ascoltare il silenzio delle stelle.
Solo chi sa stare in silenzio può percepire la voce dell’altro che parla, riesce ad ascoltare i propri sentimenti, ha la capacità di rispondere agli interrogativi del suo cuore e quindi riesce a dare luce al cammino della propria vita.
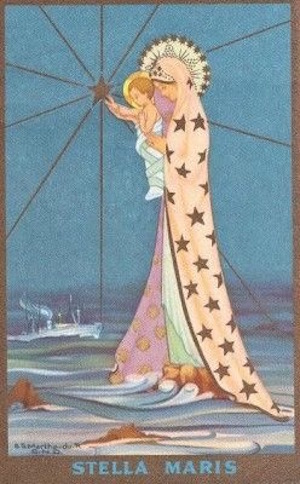
La Stella Maris si festeggia la prima domenica di agosto. Questa festa risale al '400 ed è dedicata alla "Stella di Mare", titolo con il quale i marinai e pescatori venerano la Madonna.

La sera in chiusura della festa vengono lasciati in mare da imbarcazioni o a nuoto dai bagnanti migliaia di lumini accesi, che donano uno spettacolo suggestivo e imperdibile.

Ü Dragun incendiato
Durante la festa della Stella Maris, una processione di barche ornate a festa parte dal porticciolo di Camogli per raggiungere Punta Chiappa dove si trova l'altare della Madonna "Stella di Mare".
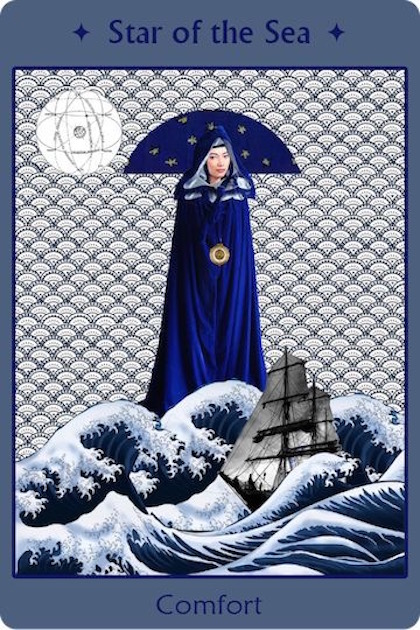
“Vi è un incanto nei boschi senza sentiero ed è un’estasi sulla spiaggia solitaria vi è un rifugio dove nessun importuno penetra. Accanto alla profondità del mare ed alla musica del suo frangersi riesco ad amare più la natura di quanto ami l’uomo. In questi colloqui riesco a liberarmi da quanto sono o credo di essere stato per essere un’unica cosa con l’universo e sentire quanto non riesco ancora ad esprimere e che non so neppure nascondere.“
Scritto da Lord George Gordon Byron allo Stella Maris nell’anno 1821

Ü Dragun – Sciabecco-Galea simbolo della città di Camogli
Alla processione tra le varie barche partecipa anche Ü Dragun. Una volta raggiunto lo scoglio di Punta Chiappa viene celebrata la Santa Messa.
Significato
Nome composto da Maria e Stella. Maria deriva dall'ebraico Maryàm e vuol dire "principessa, signora", mentre Stella ha origine latina ed il suo significato è "luminosa come un astro". Può comparire anche nelle forme Maria Stella o Maristella. Stella Maris ossia Stella del mare è un antico titolo utilizzato per Maria Vergine, madre di Gesù. L'onomastico può essere festeggiato il 12 settembre giorno dedicato al Santissimo Nome di Maria oppure l'11 maggio in memoria di Santa Stella martire.
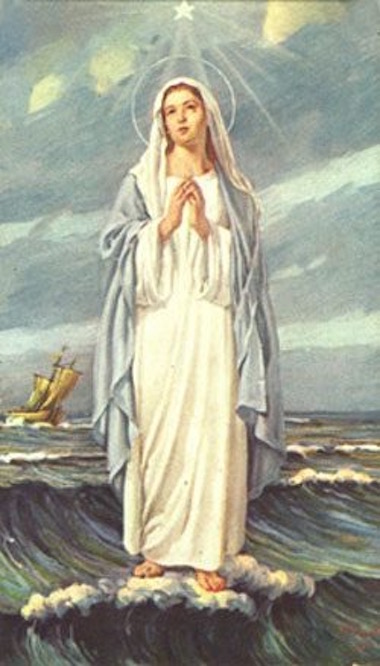
L’immagine della STELLA MARIS qui raffigurata è forse la più conosciuta a bordo delle navi
MAESTRA E SIGNORA DEL MARE
Secondo questa interpretazione il nome di Maria deriverebbe da MOREH (ebr. Maestra-Signora) + YAM (=mare): come Maria, la sorella di Mosè, fu maestra delle donne ebree nel passaggio del Mar Rosso e Maestra nel canto di Vittoria (Es 15,20), così "Maria è la Maestra e la Signora del mare di questo secolo, che Ella ci fa attraversare conducendoci al cielo" (S.Ambrogio, Exhort. ad Virgines).
Altri autori antichi che suggeriscono questa interpretazione: Filone, S. Girolamo, S. Epifanio. Questo parallelo tipologico tra Maria sorella di Mosè e Maria, madre di Dio, è ripreso da S. Agostino, che chiama Maria "tympanistria nostra" (Maria sorella di Mosè e la suonatrice di timpano degli Ebrei, Maria SS. è la tympanistria nostra, cioé dei Cristiani: il cantico di Mosè del Nuovo Testamento sarebbe il Magnificat, cantato appunto da Maria: questa interpretazione è sostenuta oggi dal P. Le Deaut, uno dei più grandi conoscitori delle letteratura tergumica ed ebraica in genere: secondo questo autore, S. Luca avrebbe fatto volontariamente questo parallelismo.
LA STELLA MARIS
NELLA POESIA
Quando nel volto di Maria il poeta Giorgio Caproni ricordava con nostalgia inquieta la fede della sua infanzia: "Nel vago della notte, io disperso mi sorprendevo a pregare. Era la stella del mare".
Oggi festeggiamo il nostro destino, che è di vita e non di morte. Maria, assunta in cielo, dice che il miracolo della Resurrezione non è privilegio divino, ma meta per tutti. La Vergine ci precede, e ci mostra la via.
Non a caso una delle metafore più usate dai poeti di ogni tempo è proprio quella di Maria stella del cielo, che indica la rotta ai naviganti.
È un'immagine che usa anche Giorgio Caproni, uno dei massimi lirici del '900. Nella sua poesia Alla Foce, la sera (Frammento su un ricordo d'infanzia), tratto dalla raccolta Il conte di Kevenhuller, si trova una Maria luminosa, che abita il cielo:
La vedevo alta sul mare.
Altissima.
Bella.
All'infinito bella
più d'ogni altra stella.
Bianchissima, mi perforava
l'occhio:
la mente.
Viva.
Più viva della viva punta -
acciaiata - d'un ago.
Ne ignoravo il nome.
Il mare
mi suggeriva Maria.
Era ormai la mia
sola stella.
È, come dice il titolo, un ricordo d'infanzia: Caproni (1912-1990) è stato un poeta in perenne conflitto con il tema di Dio, che non si è risolto in una fede positiva. Eppure la misteriosa assenza di Dio non lo ha mai lasciato tranquillo. Ma da bambino aveva fede, con un particolare affetto per la Madonna:
Nel vago
della notte, io disperso
mi sorprendevo a pregare.
Era la stella del mare.
Caproni stesso racconta della sua devozione mariana in pagine bellissime, raccolte in Il mondo ha bisogno dei poeti. Intervista e autocommenti (1948-1990):
Da bambino, volevo tanto bene alla Madonna che, quando me ne regalarono una - tutta bianca, di gesso, forse una statuina della biancoceleste Madonna di Lourdes- mi venne addirittura voglia di costruirle una chiesuola.
La madonna cantata nella poesia è frutto del pennello di un pittore francese che Caproni bambino conosceva e frequentava: Jean Bourillon, a cui sono dedicati i versi. Un giorno il poeta vide un quadro preparato dall'artista per una festa di mare, con Maria sulle onde. E gli rimase profondamente impresso. Poi la vita gli fece perdere la fede, ma rimase il ricordo di quell'immagine e del suo autore:
La tua stella, Jean,
così remotamente morto
con la mia infanzia, e in una
con tutta la tua opera...
Jean
senza fortuna...
Amico
(in gioia e in disperazione)
dei miei sussulti...
Di me:
della mia diffrazione
nel tempo che ormai mi allontana -
sempre più mi allontana -
dalla nascita e - forse -
(oh Jean!) dalla mia stessa morte...
È esperienza comune: anche in chi ha perso la fede rimane un ricordo, una nostalgia forse, almeno della materna figura della Vergine. È un'eco che non abbandona il cuore dell'uomo.
Non si può guardare a Maria che con affetto e gratitudine:
«Ciao stella del mare» mi sorprendo a dire con voce sommessa. «Ciao mio povero Bourillon, che grazie al tuo quadro, e per virtù del tuo quadro, mi costringi ancora (e te ne sono grato) a salutare Maria, come la salutavo nella mia cameretta di fantolino fidente - bella e protettrice - a capo del mio lettuccio».
LA STELLA MARIS COME EFFIGE DI DEVOZIONE DEI MARINAI NACQUE IN QUESTO EREMO di S. NICOL0’ DI CAPODIMONTE - (foto sotto)




La Chiesa di San Nicolò di Capodimonte del XII secolo è situata a 97 metri sul mare lungo il sentiero che conduce dalla chiesa parrocchiale di San Rocco, 221 metri sul mare alla celebre Punta Chiappa. Qui la vegetazione mediterranea e di macchia raggiunge la sua più intensa espressione: pino silvestre, d’Aleppo, lecci centenari, querce, castagni, ulivi e poi la fragranza dei mirti, corbezzoli, eriche giganti, ginepri, ulivi selvatici, lecci nani, cactus, ginestre, caprifogli, pistacchi, alaterni, citisi, carrubi nani, melograni selvatici, timo, capperi e dovunque spunta la Isca con la quale gli abitanti del luogo fanno corde resistentissime all’acqua salata.
La chiesa romanica fu fondata, secondo la tradizione, nel XII secolo dai monaci di San Rufo nei pressi di una già presente cappella intitolata a san Romolo del 345. Abbandonata dal XV secolo per le frequenti incursioni dei pirati e trasformata in abitazione civile dopo l'editto napoleonico, fu nuovamente riaperta al culto religioso dal 1870. Tra le tracce di affreschi vi è la raffigurazione di una Madonna che protegge un'imbarcazione, la Stella Maris, ripresa nel mosaico di Punta Chiappa e oggetto di venerazione durante le omonime festività religiose.
Tutto il complesso è stato abbandonato nel XV secolo a causa delle ricorrenti invasioni dei pirati saraceni, e trasformato in abitazioni civili durante il periodo napoleonico. Gli interventi di restauro effettuati tra il 1925 e il 1926 hanno restituito alla chiesa l'originale aspetto romanico con facciata in pietra viva e portale strombato con colonnine marmoree.
L'interno è caratterizzato da una pianta a T con tre absidi e unica navata in pietra nera sulla quale sono ancora visibili tracce di affreschi. Tra questi si nota la Madonna che protegge una barca durante una tempesta: è il tema della Stella Maris ripreso sulla stele a mosaico di Punta Chiappa.
Inizio modulo
Per il mio nuovo viaggio lungo le rotte della memoria, non cerco porti idonei alla partenza o ai ritorni; non cerco nave od equipaggio. La terra, la mia, farà da porto e da riparo; e magicamente sarà nave ed equipaggio. Insieme veleggeremo, fatalisticamente sospinti da ataviche maledizioni, da fallaci certezze, da vecchie e nuove paure, alla ricerca di serene spiagge, di gioiosi lidi. Alla Stella del Mare raccomando questo singolare veliero, insieme ai corpi ed alle anime del nostro equipaggio. A mia madre rivolgo pensiero e gratitudine e a lei dedico gli esiti incerti e le possibili conquiste del viaggio; a mia moglie, come ad ogni partenza, la promessa del primo abbraccio del ritorno.
Il comandante
ALBUM FOTOGRAFICO


Uno scorcio suggestivo di Punta Chiappa

Punta Chiappa - Camogli. Opera di F. Dal Pozzo dedicata alla Madonna Stella Maris (Stella del Mare).

Madonna del Tinetto


La statua della Madonna del Tinetto mi ha fatto ricordare un episodio molto vicino al cuore anche per ricordi familiari.
La statua era stata abbattuta da una mareggiata e prima della sua ricostruzione mio figlio, che è un video artista con il nome Masbedo, aveva girato un filmato e scattato delle foto che avevano portato ad aggiudicare a Masbedo il premio nazionale Gairo di fotografia. Il filmato, dal titolo:
"Schegge d'incanto in fondo al dubbio"
trattava della donna nella sua dimensione complessa all'interno della coppia. Per la realizzazione del filmato era servito l'appoggio della Capitaneria per posizionare l'artista sul basamento dove prima c'era la statua e la cosa era stata complicata dal fatto che avevano voluto girare anche con inquadrature di mare mosso.
(Marcello Bedogni)

Camogli nella notte della STELLA MARIS
CARLO GATTI
Rapallo, 21 Luglio 2017
IL MARE INNAMORATO
IL MARE INNAMORATO
Alcuni credono che il mare sia una cosa inanimata: un minerale. lnvece no. E un essere vivo, con un caratterino bizzarro e bizzoso con cui bisogna fare i conti. Se i pescatori gli portano via troppo pesce, se gli uomini lo sporcano troppo con i loro rifiuti o lo soffocano con il loro petrolio, allora si altera, incomincia ad ondeggiare, a sbuffare spruzzi d'acqua e, siccome è enorme, ogni suo movimento provoca danni anche a grande distanza. In un paesino poco conosciuto sulla costa della Liguria, viveva una bambina che amava molto il mare. Era ancora piccolina, ma già brava a camminare e a parlare. Il suo posto preferito per giocare era la spiaggia, anche se sassosa e scomoda. D'estate il suo più grande divertimento era fare il bagno. Ogni volta che arrivava vicino al mare, bagnava la manina, si faceva il segno della croce ripetendo una giaculatoria che le aveva insegnato la nonna: "Ciao Gesù, io ti saluto nel più bello del Creato", poi immergeva di nuovo la mano, assaggiava il sapore del mare e diceva sempre: “Com'è buono”. Infine, se era estate, correva dentro e si lasciava afferrare dall'onda senza paura ed esclamava: “Com'è forte!”. Il mare a furia di sentirsi dire: bello, buono e forte si intenerisce, quando arrivava la bambina, regolava l'onda per non farle male, attirava le correnti per spingere al largo rifiuti e meduse, insomma si faceva più bello per lei. I pescatori locali, come tutti, ascoltavano le previsioni del tempo prima di avventurarsi a pesca e, se erano troppo brutte, se ne stavano a casa a dormire per non rischiar la pelle. Ben presto però si accorsero che, nella loro zona, si verificava un fenomeno strano. La radio annunciava: venti da sud, sud-ovest, mare forza sei, burrasche, facendoli correre a rinforzar gli ormeggi e brontolare per la perdita di guadagno. Il giorno dopo invece, dopo un inizio burrascoso, il mare si quietava, non rispondeva al vento e tutto ritornava tranquillo. “Ehi, Dario, ma hai sentito anche tu le previsioni. Non ci azzeccano proprio”. “Io metto la barca in mare" diceva Piero. Ormai è passata l'ora buona, ma andiamo lo stesso. Non si capisce più niente” rispondeva Dario con un'aria sconsolata.
I poveretti mettevano le barche in mare e per qualche ora tutto filava liscio. Finché la bambina stava sulla spiaggia, il mare faceva per lei il bello e il buono e calmava i suoi furori, ma quando lei rientrava a casa, tornava a imbizzarrirsi e ancor più si infuriava contro quei due o tre pescatori, che avevano osato sfidare la sua potenza.
Il mare vuole rispetto e se lo si prende sottogamba, c'è da pagarla cara. Cosi una volta i poveri Dario, Piero e Simone si trovarono di colpo in balia delle onde.
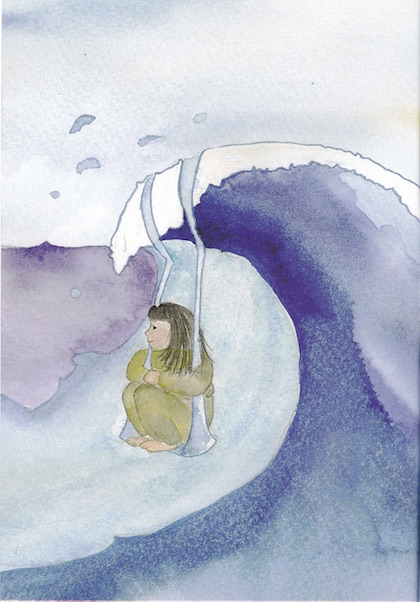
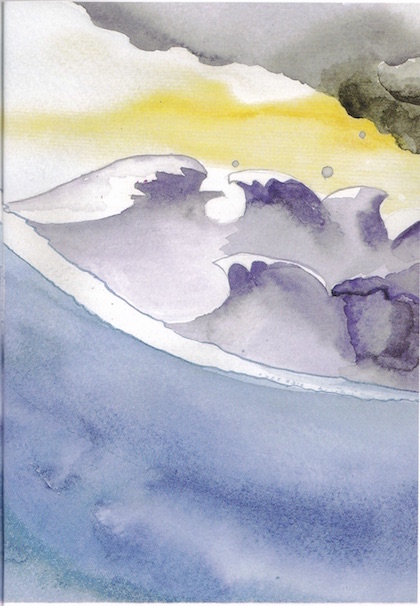
"Maria santissima, cosa succede?" gridava uno nella radio. L'altro a fatica rispondeva: "Presto, tiriamo su le reti. Cerchiamo di tornare in porto". ll terzo, sopraffatto dall'urlo del vento e dal mugghiar del mare, non riusciva a sentirli e, tra una bestemmia e una preghiera, tagliò la rete per affrettare il ritorno. Meglio perdere la rete che la vita, pensava con le lacrime agli occhi, senza capacitarsi di un cambiamento del tempo così repentino. Uno dopo l'altro ammaccati e grondanti rientrarono in porto, accolti con sollievo dai familiari, ma rimbrottati aspramente dalle autorità marittime, che non capivano come dei professionisti fossero usciti in mare con le previsioni catastrofiche annunciate. Inoltre non era la prima volta che lo facevano. Due sere dopo, passata la burrasca, i tre s'interrogavano ancora, davanti a un bicchiere di vino, sulle avventure vissute, anche se l'ultima era stata la peggiore. “In tanti anni non mi era mai capitato, che il mare cambiasse così improvvisamente” disse Dario. “Previsioni sbagliate, ne ho sentite tante”, riprese Piero, ma nelle realtà una cosa del genere non l'avevo mai vissuta, né sentita raccontare”. "A me è venuta voglia di cambiar mestiere” borbottò Simone, che aveva perso anche la rete. “No, dai non ti scoraggiare;” gli rispose Dario, la rete la ricompriamo con il fondo del Circolo; l'abbiamo fondato apposta per venire incontro alle vittime di incidenti che possono capitare a tutti noi, la cosa importante è che dobbiamo capire cosa è successo per non caderci un'altra volta” riprese pensieroso. “Sai, Agostina, quella bambina che sta vicino a me" disse Simone distrattamente, quando ha saputo quello che è successo, mi ha chiesto: "Perché non hai fatto una carezza al mare? Così si calmava". Beata innocenza. Per Piero fu come una rivelazione. “Accidenti, disse anche le altre volte e andata così. Il mare è brutto, poi ad una certa ora si calma, soltanto qui nel nostro golfo e, dopo qualche ora ricomincia il finimondo. "C'è qualcosa sotto!" concluse. “Cosa intendi con "qualcosa sotto"? gli chiese Dario. “Non lo so, ma dobbiamo indagare, vedere cosa succede in paese, quando il mare si calma. Non è normale”, rispose Piero. Dopo una settimana la situazione si ripeté identica. Previsioni cattive, tutti in porto, ma invece di starsene a casa a dormire, i nostri tre pescatori di divisero i compiti dell'indagine. “Tu Dario vai in chiesa a vedere se fanno qualche funzione Particolare”, disse Piero.” Tu Simone, controlla Agostina, la tua vicina di casa. Io intanto giro un po' per il paese e per il porto e sento cosa si dice” decise Piero. Dario non era un frequentatore abituale della chiesa e ci entrò con un certo imbarazzo. La chiesa era deserta, la luce scarsa penetrava dai vetri colorati in modo uniforme. A tratti però, durante qualche schiarita, la luce si intensificava e si raccoglieva in raggi obliqui, che andavano ad illuminare, come fari, un altare laterale tappezzato di ex-voto, dove era esposta una Madonna. Dario guardò incuriosito le pareti, che circondavano l'altare: i quadretti esposti rappresentavano per lo più scene di mare in burrasca, battelli inclinati con le vele ammainate e marinai imploranti. Sì, i suoi avi ne avevano passato delle belle in mare e nei momenti più bui si erano rivolti alla Madonna per aiuto. Lui non ci credeva molto, ma capiva come potesse essere successo. Così un po' vergognoso accese una candela, accompagnando il gesto con questo pensiero: "Fa' che non succeda più»" Poi se ne uscì senza aver ottenuto le informazioni che cercava. In chiesa non c'era nessuna funzione, anzi non c'era anima viva. Simone era affacciato alla finestra della cucina, quando vide Agostina uscire di casa con secchiello e paletta, accompagnata dalla mamma. “Ma dove andate con questo tempo?” chiese. “Alla spiaggia" rispose Agostina sorridendo. “Non scherzare. Quando il mare è grosso se la mangia la tua spiaggia" insistette Simone. Dove andiamo noi è riparato, intervenne la madre, e poi ad una cert'ora si calma sempre". Simone rimase interdetto. Lì per lì non sapeva se controbattere, se seguire le due vicine o se correre dagli amici araccontare quello che aveva sentito. L'indecisione gli fu fatale, perché nel frattempo le due si erano allontanate e lui non riuscì a ritrovarle. Uscì comunque di casa e si diresse verso il porto, dove incontrò Piero, intento a chiacchierare animatamente con due vecchi pescatori in pensione. Essi sfidavano il brutto tempo pur di non mancare all'abituale appuntamento sul porto, dove erano soliti trascorrere le mattinate rievocando le avventure passate e brontolando sul presente. “Ma come ve lo spiegate voi questo tempo matto?' stava chiedendo Piero al più anziano dei due. “Quando ero giovane io, le mareggiate c'erano solo d'autunno. Quelle sì, che erano mareggiate. L'onda arrivava contro le pareti della chiesa e gli spruzzi bagnavano le vetrate. Così, quando eravamo in chiesa, ci sembrava di essere in barca. Più sicuri, però. Poi hanno costruito questa barriera di scogli per proteggere le fondamenta della chiesa e il mare ha preso un altro giro. Non ci capisco più niente” rispose quello. “lo so” riprese con pazienza Piero "vi ricordate se il mare era così variabile? Agitato, poi quasi calmo e poi di nuovo in burrasca nello stesso giorno?” “No, no, rispose l'altro "se era scirocco durava tre giorni, se era libeccio un giorno e una notte, poi piano piano si calmava. Il maestrale non ci dava tanto fastidio. Bastava stare all'interno del golfo, ma allora si pescava lo stesso. Non come adesso che se non andate al largo, non prendete niente". “E secondo voi, cosa può essere a rendere il mare così matto?”. Chiese ancora Piero. “Eh lo so io, lo so io, rispose il primo. La bomba atomica, gli esperimenti. Ecco cos'è. Dopo la guerra niente è stato più come prima”... concluse scrollando il capo. Intervenne Simone dando di gomito a Piero.
“Vieni al bar" disse "che ti devo raccontare una cosa". Lì, al riparo da orecchie indiscrete, gli disse in quattro e quattr'otto cosa gli avevano detto Agostina e sua madre. A Piero pareva una scemenza e mentre stavano discutendo arrivò anche Dario, che non aveva scoperto niente. Uscirono insieme e guardarono il mare: pareva un agnellino innocente con le sue piccole onde a ricciolo bianco. Uno scherzo. “Un imbroglione" gli urlò Piero vedrai che scopriremo il tuo trucco. Insieme si incamminarono verso le spiagge di levante e lì, in una piccola insenatura protetta dagli scogli, videro Agostina che giocava beatamente con i piedi nell'acqua e sua madre, che faceva la maglia. "Avete un bel coraggio voi due, incominciò Piero "a star sulla spiaggia con questo tempo”. “Vede che il mare si è calmato?" rispose la signora guardando Simone "siamo fortunate. Noi veniamo quasi tutti i giorni alla spiaggia. Quando Agostina andrà a scuola sarà diverso, ma per adesso ce la godiamo". “Buon divertimento allora» risposero i tre allontanandosi, con la testa confusa da pensieri contrastanti. Non ne parlarono più tra loro, per timore di essere presi per creduloni, però, come per un tacito accordo si misero a turno sulle tracce di Agostina. Il fenomeno del mare, che si calmava, quando Agostina era sulla spiaggia, si verificava sempre. Non sapevano che spiegazione dare, non intendevano parlarne ad altri, ma tra loro presero alcune decisioni. “Senti”, disse Piero rivolto a Simone "devi invitare Agostina sulla barca a pescare". Ma mi è d'impiccio, sei matto. Una bambina di quattro anni in barca a pescare, si ribellò Simone. “Cos'hai in mente?, chiese Dario. “Ho pensato che Agostina potrebbe essere il nostro portafortuna”, rispose Piero. Simone, che la conosce meglio, la porta in barca due o tre volte col mare buono, per farle prendere confidenza. Un giorno, quando ci sarà burrasca usciremo tutti e tre sulla barca di Simone con Agostina e magari non ci succede niente. Peschiamo quando tutti gli altri sono in porto. Possiamo vendere al prezzo che vogliamo, se siamo gli unici ad averlo" concluse. “Mi pare un'idea disonesta e pericolosa”, disse Dario. “E anche sciocca, esclamò Simone io non ci sto. Lasciatemi in pace! “Ohi te, che fai il cavaliere” lo rimbrottò Piero. "Ti devi ricomprar la rete. Vorrai mantenere la tua famiglia in qualche modo? Non facciamo niente di male, sfruttiamo solo un segreto, che gli altri non conoscono». In breve Piero vinse la resistenza degli altri due e Agostina fu invitata a pesca. La prima volta la mamma rifiutò, poi cedette alle insistenze del pescatore e della bambina. "Dai mamma, lasciami andare. Deve essere bellissimo stare in mezzo al mare. Anch'io da grande farò la pescatrice" insistette Agostina. “Si, la rana pescatrice" rise la madre. Per due volte Agostina uscì in barca con Simone. Il mare era calmo, i pericoli lontani e la piccolina tornò a casa orgogliosa con qualche pesce in mano. Una sera dopo aver ascoltato alla radio le previsioni del tempo, che annunciavano vento forte e mare agitato i tre si telefonarono. Piero, che era la mente del gruppo, organizzò il lavoro per il giorno dopo. Si accordarono per uscire in mare tutti e tre sulla barca di Simone con Agostina come protezione contro la furia del mare. Naturalmente dovevano ricorrere ad uno stratagemma per ingannare la mamma di Agostina. Questa parte antipatica toccò a Simone. “Buongiorno signora. Oggi è brutto tempo e non si va. Se vuole porto Agostina a fare un giretto, tanto sono disoccupato”. “Perché no?”, rispose la madre, che era indaffarata ad impastar ravioli. “La copra bene, che tira vento”, suggerì il pescatore. Una volta fuori di casa Simone disse ad Agostina: ti confido un segreto, che deve restare tra noi, per non spaventare la mamma. Ti porto in barca anche oggi. Non aver paura. Vedrai che emozione, disse sorridendo, quasi sicuro che il mare si sarebbe calmato, vedendo la barca con Agostina sopra. La bambina non rispose. Gli camminava a fianco in silenzio, preoccupata per la bugia, ma curiosa di vedere il mare in burrasca. Appena la barca con i quattro doppiò il molo del porto, si trovò in difficoltà. il mare era davvero spaventoso: era impossibile calar le reti e difficilissimo timonare. Piero e Dario, a fatica, presero Agostina sotto le ascelle e alzarono le braccia la cielo come per offrirla in voto urlando: ”Mare, mare, calmati. Guarda chi c'è a bordo!”. A quel punto scoppiò il finimondo. Il mare, vedendo che quei pazzi avevano osato sfidarlo usando Agostina come scudo, perse del tutto la ragione e si scagliò con forza contro la barca sballottandola come fosse stata una foglia secca. Agostina era sicura che se avesse potuto mettere la mano in acqua e accarezzare il mare, quello si sarebbe placato, ma lì a prua, tenuta come una polena dai due pescatori, era davvero spaventata. Incominciò a pianger e a invocare la mamma. Piero urlava a Simone: “Vira, vira. Rientriamo”. L'amico aveva difficoltà di manovra, mentre era di fianco, un'ondata più vigorosa delle altre, si abbatté sul battello spaccandolo in due. Era il naufragio, altro che pesca miracolosa. In un attimo, mentre la barca colava a picco, i tre avevano capito il loro errore. Preoccupati per la bambina, cercavano di afferrarla e salvarla, ma il mare aveva già deciso. Un'onda orlata di spuma bianca la rapì dalle loro mani, che annaspavano e la fece sparire alla loro vista. Agostina si trovò a cavallo di quest'onda anomala, che, senza mai infrangersi, galoppava veloce verso la solita spiaggetta dove amorosamente la posò a terra fradicia e piangente. I tre aggrappati ai rottami del battello intanto cercavano di galleggiare, mentre il mare s'infuriava contro di loro. Passarono un quarto d'ora lungo un secolo tra pianti, insulti e preghiere. Agostina a terra si chiedeva che fine avesse fatto il suo amico Simone e gli altri due pazzi, che l'avevano presa e sollevata e chiedeva al mare di salvarli, di avere pietà di loro. Il mare sembrava sordo quel giorno, ma dopo un po' si calmò. Adagio, adagio i tre pescatori avevano raggiunto la riva terrorizzati e ammaccati. Naturalmente non la passarono liscia. Oltre alla perdita della barca, dovettero subire un processo e furono condannati a tre anni di prigione. In prigione ebbero modo di riflettere e decisero di cambiar mestiere, perché avevano intuito che il mare non avrebbe perdonato un'altra mancanza di rispetto. Era già andata bene così.
ADA BOTTINI
17 Luglio 2017
{jcomments on}
LA GALLETTA DEL MARINAIO
LA GALLETTA DEL MARINAIO

UN PO’ DI STORIA
Le leggende dei lupi di mare raccontano che la razione giornaliera di acqua era prevista in tre litri a persona. Il cibo era costituito principalmente da patate, legumi secchi, carne salata e stoccafisso. Per anni piatto dei poveri anche sulla terra ferma ed oggi pietanza costosissima dove ti servono scagliette di stoccafisso con una marea di patate, polenta bianca, gialla e birulò e il tutto pepato a più non posso. Come nel “Cundigiun” erano sempre presenti le gallette che venivano conservate in cassoni foderati di zinco per mantenerle lontane dall’umidità, dagli scarafaggi e dai topi ma, ciò nonostante, dopo un paio di mesi di navigazione, spesso le gallette venivano “abitate” da vermi biancastri ma guai a buttarle. Si prendevano e si adagiavano, o meglio, si sbattevano più volte sul tavolo, se non sulla coperta, per esserne liberate dai vermetti e renderle così mangiabili. A bordo erano conservati anche: fagioli, ceci, fave, patate. Non mancavano l’aglio, le cipolle e il lardo che serviva necessari per fare il minestrone.
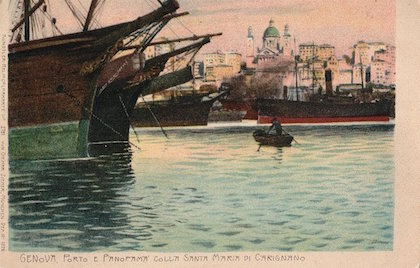
Velieri e CADRAI nel porto di Genova
Certo che non mancava il pesce pescato fresco sul posto. Cioè in mare. I marinai riuscivano facilmente ad arpionare un delfino; la carne veniva tagliata a strisce ed accatastata in un mastello coperto da dei pesi per far defluire il sangue. Dopo qualche giorno venivano messe in salamoia e poi venivano appese al sole ad essiccare. Dicono si trattasse di una squisitezza. Poi denominata “mosciame” e oggi proibitissimo. Alcuni fanno derivare il termine dal genovese “muscio” ossia persona di gusti difficili o comunque difficile da accontentare, tanto era considerato succulento.
E ora parliamo delle gallette e, nello specifico, delle gallette del marinaio.
La galletta era un prodotto a chilometro zero ma a “miglia” infinite. Era nata, come focaccina secca, quasi immangiabile se non bagnata, ideale sostituto del pane da mettere nelle zuppe e nelle insalate.
Le prime notizie risalgono al 1500 e riguardano l’uso delle gallette sui velieri, sciabecchi, galeoni ecc.
A bordo la galletta era l'unico “pane” per i marinai e si conservava per lunghi periodi. Per prepararla si usava una ricetta semplice: farina, acqua, malto, lievito di birra e sale.
Venivano infornate e cotte e la consistenza finale, era quella di una ciambellotta dura come il marmo. Le gallette a chilometro zero, venivano poi imbarcate per i lunghi viaggi. Prima dell’uso, venivano bagnate con l'acqua di mare, olio d'oliva e acciughe salate e ne veniva fuori una pietanza povera che non richiedeva cottura, non sempre possibile sulle barche dell’epoca e su quelle da pesca.
La galletta si sposava bene anche con il cibo che in contadini consumavano spesso quando si recavano nell’entroterra per falciare e fare provvista di fieno per l’invero. Non vi era casa di ogni frazione che non avesse almeno una bella mucca e il fogliame (fugiacu) e il fieno non poteva mancare in inverno.
LE GALLETTE DEL MARINAIO – OGGI


Panificio Maccarini – San Rocco di Camogli

Le famose gallette “Maccarini” servite calde
Tra gli scenari mozzafiato del Parco Naturale Regionale di Portofino e gli scorci incantevoli di località come Camogli e le sue frazioni, si respira aria di mare, di storia e di tradizione, tutte racchiuse in un unico prodotto della gastronomia locale che evoca l’antica vita di bordo dei naviganti liguri: la Galletta del Marinaio.
Incastonata tra mare e monti lungo la Rivera Ligure di Levante, Camogli sorge in riva al mare in una zona della costa compresa nel Parco Naturale Regionale di Portofino. Lo storico porticciolo e l’antica tradizione marinara contribuiscono ad ammantare di fascino le atmosfere incantate della cittadina ricca di suggestioni e di testimonianze del suo passato glorioso. Gli scorci mozzafiato e la posizione strategica rendono Camogli il punto di partenza ideale per visitare la Riviera di Levante ed i dintorni ricchi di paesaggi incontaminati che spaziano dalle cime innevate alle acque limpide del mar Ligure, e le numerose frazioni pittoresche e ricche di storia. Tra di esse merita una particolare menzione quella di San Rocco, facilmente raggiungibile percorrendo uno dei numerosi sentieri che si snodano dall’abitato di Camogli. Questo piccolo borgo vanta una posizione mozzafiato e si mostra come una splendida terrazza a picco sul mare dominata dalla bellissima chiesa di San Rocco edificata nella seconda metà del XIX secolo dai naviganti di San Rocco al posto della Cappella Campestre, ormai insufficiente ad accogliere tutti gli abitanti della frazione. Proprio lungo la strada per la chiesa, sorge lo storico panificio Maccarini dove si prepara ancora oggi la Galletta del Marinaio, una delle specialità più rappresentative della tradizione locale. Oltre a dedicarsi ai piaceri del palato, vale, però, la pena proseguire anche nell’esplorazione del territorio intraprendendo splendidi itinerari lungo i sentieri che raggiungono le più interessanti località del Monte di Portofino. Proseguendo, infine, verso il Golfo del Tigullio, una delle zone più apprezzate dai turisti di tutto il mondo, si raggiunge un’area caratterizzata dalla natura incontaminata dell’area protetta che lascia immediatamente il posto a località vibranti e vivaci come Portofino, meta prediletta del jet set internazionale, Lavagna, che custodisce uno dei principali porti turistici del Mediterraneo, Rapallo dove storia, arte e scenari da sogno si fondono in tutt’uno dalle suggestioni uniche, e Santa Margherita Ligure che, assieme a Sestri Levante, offre numerose incantevoli insenature in cui immergersi.
L’INGREDIENTE: Sono passati due secoli da quando sulle navi che salpavano dai porti liguri fecero la loro comparsa le Gallette del Marinaio. Erano tempi in cui le imbarcazioni a vela e i loro equipaggi rimanevano in mare per lunghissimi periodi, senza toccare porti, potendo contare soltanto sulle provviste imbarcate alla partenza che dovevano avere, dunque, la prerogativa di mantenersi a lungo. Proprio in quest’ottica nacque la croccante Galletta che a lungo accompagnò i marinai di leudi e pescherecci e che, soprattutto, si manteneva a lungo, anche per diversi mesi. Non è un caso, dunque, che questa croccante specialità sia diventata in breve tempo uno degli alimenti più diffusi tra gli equipaggi che potevano consumarla dopo averla fatta semplicemente rinvenire in acqua, accompagnata generalmente con le acciughe e condita con un poco di olio. Era questo il pasto tipico dei marinai. Una ricetta semplice chiamata Capponadda. Nonostante le necessità a bordo delle navi siano oggi profondamente cambiate e le comodità introdotte consentano una maggiore libertà nella scelta delle provviste da imbarcare, la Galletta non è mai scomparsa ed anzi è diventata un prodotto tipico estremamente rappresentativo della tradizione marinara che può essere gustato nella sua versione originale recandosi nello storico panificio della famiglia Maccarini, probabilmente l’unico che ancora la prepara secondo l’antica ricetta rimasta identica a quella di due secoli fa.
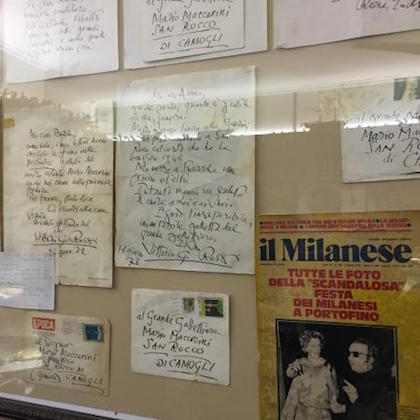
Le lettere di un affezionato cliente, il celebre Vittorio G. Rossi
Qui le Gallette del Marinaio sono una vera istituzione, al punto da aver fatto il giro del mondo e da essere state apprezzate da personalità illustri come Vittorio G. Rossi che ha riservato allo storico negozio dei Maccarini una dedica speciale.
Ricetta e varianti:
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, strofinandoci sopra uno spicchio d’aglio e imbevendole di acqua e aceto per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto con una generosa dose di olio d’oliva. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l’uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell’insalata.
Nome e nascita incerti:

Antica CAMBUSA
Sull’origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C’è chi sostiene che il termine derivi dal latino caupona (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un’ipotesi più sofisticata: “capón de galea” era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d’identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di Camogli andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l’idea di allestire una sagra della capponadda.
Una famiglia allargata?
Nonostante il nome, la capponadda non c’entra niente con la caponata di melanzane tipica della Sicilia. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l’origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la panzanella toscana, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
Capponadda d’oltremare
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponadda ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti un piatto tipico anche di Carloforte, città fondata sull’isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale. Il motivo? All’inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull’isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l’isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c’è da scommettere, non mancava la capponadda.
GATTI CARLO
Sabato 8 luglio 2017
MAESTRI D'ASCIA RAPALLINI SUL LAGO DI GINEVRA
MAESTRI D’ASCIA RAPALLINI SUL LAGO DI GINEVRA
(LEMAN-GRAN LAC)
Altitudine 372 s.l.m, Lunghezza 72 km, larghezza 13 km, profondità max 309,7 mt

Lo sapevate che sul lago di Ginevra (lago Lemano) vi fu una presenza di navi da guerra? Nel XIII sec. i Savoia avevano una flotta di galee ormeggiate nei porti di Villeneuve (VD) e di Ripaille (Thonon, F). E’ accertata anche la presenza di Cantieri Navali che le costruivano servendosi di personale altamente specializzato. Le galee genovesi erano, ovviamente, il modello preferito dei Savoia che scelsero, per la loro supremazia navale, maestranze provenienti dai cantieri navali genovesi, non solo, ma é pure accertato che persino Rapallo inviò sulle rive del Lemano numerosi suoi figli tra cui due grandi specialisti: i maestri d’ascia Sacolosi ed Andreani.

Gli attrezzi del Maestro d’Ascia
Il maestro d’ascia é una professionista le cui origini affondano nell’antichità. Purtroppo di questi mitici personaggi, a metà tra l’artigiano e l’artista, ne rimangono pochi e sono introvabili. Costruire uno scafo preciso al millimetro presuppone anni di fatica e tanto amore per la costruzione navale. Esperienza, perizia e competenza sono tutti elementi che maturano nel corso del tempo, sotto la guida di maestri d’ascia più anziani, spesso nonni e padri che tramandano l’abilità nell’adoperare l’ascia da una generazione all’altra.

Vicino a Montreux troneggia il Castello di Chillon (XI Sec) il più visitato della Svizzera: 340.000 turisti/anno. La sua bellezza straordinaria, la sua suggestiva posizione sulla riva del Lago di Ginevra con le montagne a fargli da sfondo e il suo indiscutibile valore artistico affascinano proprio tutti, e non sono rimasti immuni dal suo fascino grandi poeti, letterati e artisti come Rousseau, Delacroix, Lord Byron e Victor Hugo.
Il suo ponte levatoio, i camminamenti che attraversano i bastioni e le torri di avvistamento sul Lago di Ginevra, fanno di Chillon un classico castello in stile medioevale che fu di proprietà prima dei Savoia nel 1200, poi dei Bernesi ed infine dei Vodesi. Costruito su un isolotto roccioso, la facciata rivolta verso il lago era la residenza principesca, mentre quella rivolta verso l’interno era la fortezza. Attraversando le mura del Castello, si ammirano i suoi affreschi risalenti al XIV secolo, le volte sotterranee in stile gotico, le sale di rappresentanza e la stanza da letto conservata al tempo della dominazione bernese decorate con stemmi gentilizi, le cappelle private, le armi antiche, i meravigliosi cortili e l’incredibile vista che si gode dalle torri e dai camminamenti di guardia sul Lago di Ginevra e Montreux.
Nell’archivio del castello di Chillon (nella foto) esistono i libri contabili che riportano molte notizie di questa migrazione specializzata dei nostri avi. Un’autentica sorpresa per noi rapallini un po’ curiosi... alla ricerca di qualche traccia di vecchia memoria, dove il nostro “vecchio amico” archivista descrisse la vita quotidiana militare del Medio-Evo su un lago alpino con le parole e i termini marinari storpiati dal genovese. Infatti, fin dall’inizio, molti termini tecnici utilizzati sui battelli del Lemano venivano usati dalle maestranze genovesi che lavoravano nei cantieri savoiardi. Con il passare degli anni il dialetto “marinaro” ligure prende curiosamente un accento valdese addolcendosi. I matafioni (cordame utilizzato per diminuire la superficie delle vele con vento forte) diventano “metafions” e poi “metafis”.
“Peguola”, il barile del catrame dei calafati (rendevano impermiabile lo scafo) sul Lemano diventa “pègue” e poi nel valdese pèdze.
Nel Castello di Chillon si ammirano molti dipinti di galee che, di primo acchito, destano qualche perplessità nel vederle veleggiare ai piedi di cime altissime ed innevate. Sale quindi la curiosità e si scopre che la prima galea fu varata nel 1287, era del tutto simile a quelle nostrane che combattevano i corsari nel Mediterraneo. La galea aveva lo scafo affusolato, e quando veniva lanciata a “tutti remi” (alla gran puta) mostrava la prora minacciosa come una spada “rostrata” pronta a penetrare nella fiancata del battello nemico per squarciarlo.
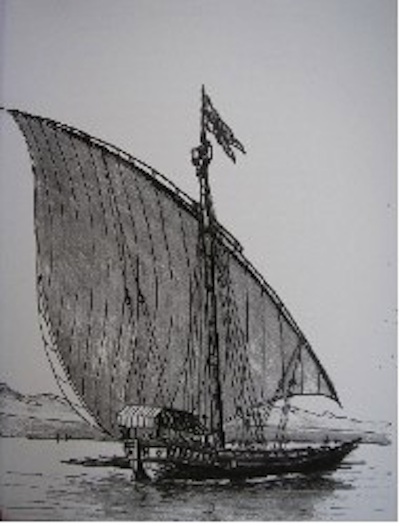
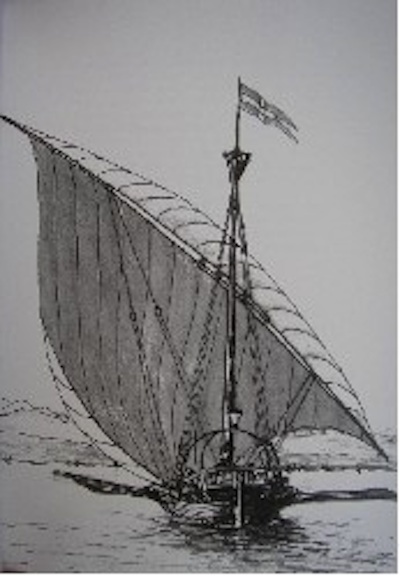
Questa meravigliosa galea del Lemano fu la prima di una serie di navi ancora più straordinarie. Fu annotato dal contabile del Castello di Chillon: “quando il vento era favorevole, si issavano le vele latine: due grandi triangoli fregiati delle armi dei Savoia, la mezzana ed il trinchetto e ci volevano ben duecento “aulnes” di stoffa per confezionare queste ali. (quasi trecento metri quadrati)”.
Viene ancora annotato: I costruttori navali, venuti da Genova per dirigere il cantiere, furono probabilmente spaventati dai rigori dell’inverno del Lemano per cui istallarono dei caminetti per scaldare le cabine del battello. I soldati stavano a prua. Dietro loro, una lunga passerella separava le file di rematori: il ritmo della frusta degli aguzzini stimolava lo zelo della ciurma.
La più grande galea della storia del Lemano fu varata intorno al 1300. Poteva imbarcare 380 uomini d’equipaggio: non solo rematori, ma anche arcieri, soldati e ufficiali che vivevano a bordo con tutti i loro domestici. Questa enorme imbarcazione s’allontanava dal porto alla testa di un convoglio di battelli più piccoli che avevano il compito di caricare il frutto del saccheggio di villaggi e di pacifici battelli mercantili.
Nel 1343 un devastante incendio partì dal centro di Villeneuve e il vento caldo (foehn) lo spinse verso la rada investendo la totalità delle navi. In pochissimo tempo avvenne la distruzione di una storica flotta che decretò anche la fine di un periodo storico che vide protagonista la genovesità marinara di quel tempo.
Purtroppo quei meravigliosi libri di contabilità del Castello di Chillon si fermano al 1352. I volumi più recenti sono scomparsi e, a partire da quella data, l’oblio avvolge più o meno la vita dei marinai d’acqua dolce ed i loro superbi battelli. Un oblio che durò fino all’invasione bernese “del Pais de Vaud” a metà del secolo XVI esimo.
Carlo GATTI
Martedì 17 novembre 2015
{jcomments on}
L'ULTIMO "PRIGIONIERO" DI RAPALLO
L’ULTIMO “PRIGIONIERO” DI RAPALLO


Qualche giorno fa ho avuto l’occasione di visitare le segrete del castello cinquecentesco di Rapallo che fino ai primi anni ’50 erano adibite a carcere: sei celle in tutto. Improvvisamente, dopo tanti anni di amnesia, mi è venuto in mente quel tragico episodio che mise fine a quel luogo di detenzione umido e triste, una specie di “isola dei reclusi” dal sapore medievale, che ancora oggi emana un’atmosfera di orrore e paura pensando alle fragorose mareggiate invernali che colpiscono la vecchia struttura come colpi di cannoni. Ne parlai con gli amici della mia età e mi accorsi che nessuno di loro ricordava quel tentativo di evasione dell’ultimo prigioniero recluso che diede luogo al ferimento del guardiano. Pare che anche altri anziani rapallini abbiano rimosso quel brutto ricordo, veramente da dimenticare, tuttavia, la mia memoria ha continuato a galoppare fino a quando ho “inquadrato” visivamente un caro amico, la persona giusta e qualificata per riesumare quell’episodio da “Far west” che, a malincuore, fa parte della nostra storia cittadina.
Italo, noto commerciante di Rapallo, è il figlio di Giuseppe Pocorobba, collega del guardiano Rocco Canacari che fu ferito da un detenuto...
Prima di entrare nel vivo della vicenda, come ti spieghi che in quei primi anni ‘50 era ancora in funzione una prigione costruita nel XVI secolo?
L’istituto penitenziale di Rapallo era un “Carcere Mandamentale” ossia quasi dismesso, nel quale erano detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi, oppure condannate a pene fino a sei mesi.
Italo, sono passati tanti anni, so che eri un ragazzino come me, ma che di quell’avvenimento ricordi tutti i dettagli, per ragioni famigliari a te molto vicine. In questo momento penso che tutti i rapallini e rapallesi ti stiano ascoltando. Come si svolsero i fatti? Ce ne vuoi parlare?
Il detenuto usava farsi la barba con un rasoio di sicurezza che Rocco gli concedeva di usare. Fu proprio mentre riponeva il rasoio nella valigetta contenente i suoi effetti personali che si rese conto che, celata sotto la biancheria c’era ancora la sua pistola automatica. Da qui nacque l’idea della fuga… e la sua gravissima messa in opera. Giunse il giorno, in piena estate, in cui il detenuto impugnò l’arma e fece fuoco contro il guardiano con più colpi di pistola automatica. Per fortuna soltanto uno dei tre proiettili andò a segno nella nuca di Rocco Canacari fuoriuscendo dall’occhio destro devastandolo ma risparmiandogli miracolosamente la vita. Rocco, vecchia tempra di ex carabiniere resistette all’aggressore e lo respinse mentre questo lo colpiva alla testa, ancora una volta, ma con il calcio della pistola. Alla fine Rocco, sebbene fosse ferito gravemente, riuscì coraggiosamente a barricarsi nel suo ufficio.

Credeva di morire e con il dito intinto nel proprio sangue, scrisse sul grande registro giornale del carcere un messaggio alla moglie raccomandandole i numerosi figli.
Ancora oggi credo che solo la Madonna di Montallegro abbia potuto mettere la sua mano protettiva sul povero Canacari. Infatti, dopo il terzo sparo del detenuto, la pistola s’inceppò.
Il racconto della seconda parte di questa brutta storia riguarda il “salvataggio” di Rocco. La vicenda é molto meno cruda, ma forse più avvincente perché coinvolse più persone e per fortuna molto in gamba...

L’operazione di salvataggio di Rocco Canacari avvenne grazie alla reazione dei due detenuti che si trovavano nelle rispettive celle che danno sulla passeggiata. Vista la scena e capita la situazione, i due cominciarono a urlare gridando attraverso le finestre a “bocca di lupo” per attirare l’attenzione dei passanti. Fu proprio grazie a queste richieste di aiuto che fu possibile allertare le forze dell’ordine. Fu mandato in bicicletta il vigile Gabbiati a casa nostra per avvertire mio padre che subito si precipitò ad aprire le carceri, fu cos’ possibile soccorrere il povero Canacari.
Ed anche qui la Madonna lo aiutò, perché eravamo in procinto di salire sulla carrozza di “Badin” che ci doveva portare in stazione a prendere il treno per Piazza Armerina (Sicilia), paese natale di mio padre. Eravamo in piena estate ed il viaggio era stato programmato da tempo.
Lo sparatore che aveva sognato la fuga, presto si rese conto che non sarebbe più potuto evadere senza le chiavi (dei tre accessi) alla prigione e, in preda al panico, ritornò quasi subito nella sua segreta lato mare, e cadde nella disperazione più totale. Era consapevole del guaio che aveva combinato, ma ormai era troppo tardi.
A quel punto si doveva salvare Rocco che perdeva sangue copiosamente.
Rocco Canacari fu prelevato senza altri danni. Il coraggioso guardiano si riprese e, nonostante la grave invalidità, continuò il suo lavoro nelle nuove carceri costruite nel frattempo nella ex Casa del Fascio. Lavorò fino alla pensione e visse ancora per molti anni.
Un ricordo personale dell'articolista: quando lo sparatore fu prelevato dal carcere per essere trasferito altrove, dovette fare i conti con una folla inferocita che tentò di linciarlo.
Alcuni cenni storici
La costruzione del castello cinquecentesco
Chi non ha mai sentito ricordare, con un certo brivido, l'assalto di Dragut al nostro borgo? Ebbene, dietro a questo nome, che nei documenti dell'epoca è storpiato in Droguth, Draguto, Dragute, Dorghutto ed in tante altre forme, si delinea la minacciosa figura di quel Torghud che, catturato nel giugno del 1540 da Giannettino Doria nella baia di Giralata presso Aiaccio, era finito incatenato al banco dei rematori a bordo d'una delle galee genovesi del grande ammiraglio Andrea Doria.
Ed in questa miserevole condizione avrebbe certamente terminato le sue avventure se Khair-Ad-Din, il più potente corsaro barbaresco, tristemente noto col nome di 'Barbarossa', non avesse posto fine, dopo qualche anno alla sua prigionia provvedendo al pagamento del cospicuo riscatto.
Così Torghud poté ben presto riprendere ancora più spavaldo a correre il mare sotto il vessillo della mezzaluna, gettando ovunque il terrore, in una travolgente ascesa che, di successo in successo, lo porterà prima ad essere il più temuto pirata tra gli 'infedeli' e poi al governo della città di Tripoli. Una palla di cannone, infine, lo ucciderà il 25 giugno 1565 sotto le mura di Malta da lui assediata.
L'assalto al borgo
Nella primavera del 1549 Torghud "Dragut", tornato libero dalla prigionia per mano di Andrea Doria, è pronto ad iniziare una nuova serie di scorrerie. Alle prime luci dell'alba del 4 luglio 1549, le navi turche, che col favore delle tenebre si erano avvicinate alla costa, puntano rapide al cuore della baia rapallese. Gli uomini, su veloci imbarcazioni, prendono terra in tre punti: presso la Porta Saline, alla Marina delle Barche, al centro del litorale, e nel quartiere della Stella, in Avenaggi. Brandendo le armi, i pirati si gettano assetati di preda sulle abitazioni, dilagando in ogni direzione. La sorpresa è assoluta e non si riesce ad organizzare un tentativo di resistenza in qualche modo efficace. Agli abitanti, quindi, non resta che cercare la salvezza con una fuga disperata. Dai documenti si ha notizia della cattura di oltre ventidue rapallesi che, nell'agosto seguente, verranno sbarcati ad Algeri, iniziando per loro indicibili sofferenze e per i parenti il tormento di tentarne il riscatto a prezzo di enormi sacrifici. Ingenti anche i danni materiali subiti dal nostro borgo per la devastazione delle botteghe, dei laboratori artigianali, delle case.
L'assalto subìto il 4 luglio 1549 da parte del pirata saraceno, determinò i rapallesi a perorare presso il Senato genovese l'erezione di un forte a protezione della spiaggia; una delegazione, guidata da Fruttuoso Vassallo, sottopose la richiesta che, sollecitamente, ottenne l'assenso desiderato. Da quel momento, il Castello costituì, con le fortificazioni di San Michele di Pagana, Santa Margherita Ligure, Paraggi e Portofino, il sistema difensivo del golfo Tigullio.
All'inizio del XIX secolo, il castello, armato di cannoni e presidiato da una decina di soldati, mantiene la sua doppia funzione di carcere-baluardo. Dopo l'unità d'Italia, però, iniziano i grandi cambiamenti: il primo ed il secondo piano vengono trasformati per divenire sede della Guardia di Finanza, mentre il piano celle continua a svolgere il suo compito con pochi rimaneggiamenti. Nel 1958, il Comune di Rapallo diviene proprietario del forte e nel 1963 verrà avviato un primo restauro che porterà il castello ad assumere la funzione di sede espositiva.
Il castello di Rapallo, più che un castello vero e proprio, è un fortino di forma rettangolare, con una massiccia parete curva a Sud Ovest, circondato dal mare ed unito alla costa da una sottile striscia di terra. La struttura è composta da un piano destinato alle carceri, due piani superiori, una torre di coronamento ed una garitta aggrappata alla parete Nord Est. Il paramento esterno è quasi completamente in ciottoli e blocchi di pietra a spacco. Alla base, una scogliera frangiflutti artificiale difende il forte dai colpi di mare. La copertura del corpo principale è in sottili lastre di ardesia, mentre la torre termina con una copertura praticabile piana protetta da un parapetto. L'unico accesso attuale consente di accedere direttamente al primo piano attraverso una scala in muratura.
Carlo GATTI
9 Giugno 2017
A VOI UOMINI DI MARE (Poesia)

A VOI UOMINI DI MARE

A voi coraggiosi
che avete disancorato
le certezze
per indagare
oltre l’orizzonte
in quell’essere
mutevole
minaccioso e accogliente
che riempie gli occhi e il cuore
di meraviglia grata
al Creatore
per un dono così travolgente.
A voi il nostro grazie
la nostra ammirazione
la nostra lieve invidia
per tutte le esperienze
che hanno arricchito
la vostra vita.
ADA BOTTINI
Rapallo, Mercoledì 10 Maggio 2017
{jcomments on}



