BENEDIZIONE DEL LABARO MARE NOSTRUM-RAPALLO

BENEDIZIONE DEL LABARO
ASSOCIAZIONE MARE NOSTRUM RAPALLO

Tempio del perpetuo Suffragio
Preghiera pro caduti, dispersi e vittime di tutte le guerra
Signore Gesù Cristo che nella Tua vita nel tempo hai voluto
una patria terrena che fosse segno e immagine della patria
celeste, benedici questo vessillo, simbolo visibile dell’Italia
nostra; fa che esso sia anche il segno concreto della Tua protezione.
Assisti e proteggi tutti coloro che sotto questa bandiera
compiono il servizio per l’osservanza delle patrie leggi, per la
custodia dell’ordine, a garanzia della tranquilla convivenza di
tutti i cittadini.
Fa che la Patria nostra, anche perla concordia operosa dei suoi
Figli, viva lunghi giorni di serenità e di pace.
Per Cristo nostro Signore.

La Chiesa di San Francesco d’Assisi - Rapallo

Interno – Navata centrale
La sua costruzione è risalente al 1519 grazie alla donazione del terreno ai Minori Osservanti che, insieme alla podestà rapallese, iniziarono l'opera di edificazione. Il convento, adiacente alla chiesa, viene restaurato e ceduto ai Frati Minori nel 1601 per ordine pontificio di Papa Clemente VIII.
Ecco le fasi del rituale religioso che si é svolto alle 10.15 dell’8 novembre 2015 Chiesa di San Francesco, Rapallo.
- Celebrazione della SS.Messa
- PREGHIERA DEL MARINAIO recitata a memoria dal Com.te Luciano BRIGHENTI, socio di Mare Nostrum.
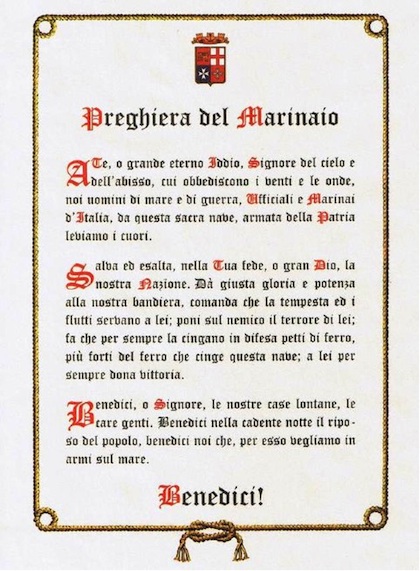
Autore della "Preghiera del marinaio" fu lo scrittore Antonio Fogazzaro, nato a Vicenza il 25 Marzo 1842. Fogazzaro la scrisse nel 1901, sollecitato dal vescovo di Cremona, Bonomelli, cui stava a cuore lo spirito religioso dei marinai.
Il comandante del “Giuseppe Garibaldi” Capitano di Vascello Cesari Agnelli, colpito dalle parole della preghiera del Fogazzaro, chiese e ottenne nel Marzo di quell’anno, dall'allora ministro della Marina, Ammiraglio Costantino Morin, l’autorizzazione a recitarla in navigazione prima dell’ammaina bandiera, quando l’equipaggio è schierato a poppa. Da allora tale consuetudine si diffuse rapidamente su tutte le navi della flotta, tanto che nel 1909 la “Preghiera Vespertina” era già comunemente conosciuta come “Preghiera del marinaio italiano” e ne era stata resa obbligatoria la lettura a bordo.
La “Preghiera del marinaio” viene attualmente letta, oltre che prima dell’ammaina bandiera in navigazione, anche al termine delle messe a bordo, nelle caserme e negli stabilimenti della marina e alla conclusione delle funzioni religiose celebrate in suffragio di marinai deceduti.
Rito della BENEDIZIONE del Labaro della nostra Associazione
Don Aldo, sacerdote della Chiesa di S.Francesco di Rapallo, ha recitato la formula di rito:
<< Preghiamo: O Dio, grande nell’amore e fedele per chi ti invoca con cuore sincero, benedici questa bandiera segno di uomini e di donne che si impegnano nel custodire la bellezza del creato. Per Cristo nostro Signore >>.
Seguono due testimonianze:
Che senso ha una benedizione "sacramentale" ad un vessillo non militare? Non certo per conferirgli poteri magici o addirittura "superpoteri". Semplicemente da oggi il nostro vessillo non è più un insignificante drappo estetico ma è divenuto "oggetto sacro" perché asperso con Acqua Santa. Servirà ad unire attorno ad esso tutti gli Associati a Mare Nostrum e a poterli appieno e legittimamente rappresentare in qualsiasi cerimonia civile, militare, religiosa o funebre a cui parteciperà, con pari dignità delle altre bandiere che saranno presenti. Quando c'è, in lei ci riconosciamo tutti e tutti ci rappresenta. E' stato un patto giurato davanti a Dio non per fare guerra ma, come ha anche detto giustamente il Celebrante che l'ha benedetta, per collaborare anche noi a diffondere la pace e a lavorare per la salvaguardia della natura, oggi in pericolo. Più uomini si uniscono con questi scopi e meglio andrà il mondo. Lo abbiamo fatto anche nella speranza faccia ricadere su di noi la misericordia di Dio e ci aiuti a non commettere malvagità ma, anzi, ci sproni sempre più ad ascoltare e ad agire per il bene dei fratelli. Al momento della Benedizione effettuata con l'aspersione dell'Acqua Benedetta, quindi Santa a tutti gli effetti, l'Ufficiante ha invocato Dio perché guardi con amore quell'oggetto specifico, riversando sugli Associati il bene a che ne facciano un uso corretto, ogni qual volta sotto di essa si riuniranno.
Renzo BAGNASCO - scrittore
Socio di MARE NOSTRUM
La Celebrazione della Benedizione del Labaro di Mare Nostrum rappresenta una tappa importante nel cammino dell'Appartenenza.
Appartenenza ad una Comunità spirituale, Condivisione di esperienze, di lavoro, di sacrifici, di privazioni, nella lontananza, del calore della Famiglia, delle responsabilità di svolgere al meglio il compito affidato e della stessa vita dei compagni d'equipaggio, guidati soltanto, per dirla con Kant, dalla "Legge morale dentro di noi e dal Cielo stellato sopra di noi". Per i Credenti (e chi partecipa ad una Benedizione è credente) si tratta della Terza Persona della Santissima Trinità: lo Spirito Santo. Il Vangelo ce lo descrive sotto forma di lingue di fuoco, i pittori l'hanno rappresentato sotto forma di colomba, ma chi prega sa che Kant ci ha aiutato molto a capire il suo significato. Renzo Bagnasco ha colto in pieno il significato della Benedizione: l'invocazione della misericordia di Dio e la guida dello Spirito Santo nell'operato dell'Umanità. Riscoprire i valori o meglio togliere da Essi la "polvere del tempo" aiuta a trasmettere alle nuove generazioni una Testimonianza di vita da far valere sui messaggi di morte.
Questa è la forza di Mare Nostrum, una forza che unisce nella condivisione delle varie esperienze, nel rispetto delle opinioni e nella crescita culturale e spirituale.
Prof. Gabriele MORO
Socio di MARE NOSTRUM
A cura di
Carlo GATTI
Rapallo, 23 Novembre 2015
IL RAPALLESE PINO SORIO IN IRLANDA DEL NORD
IL RAPALLESE PINO SORIO
PARTECIPO' ALLA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA IN IRLANDA DEL NORD

Carta geografica dell'Irlanda del Nord. Le frecce indicano il sito della Centrale di Ballylumford
Il lavoro in Irlanda del Nord è durato un po' meno di nove mesi, però diviso in due fasi: la prima di 4 e la seconda di 5. Il mio compito era di seguire i montaggi dei condensatori e delle turbine a vapore per conto dell'Enel Power mentre l'Ansaldo aveva i suoi tecnici e gli Inglesi della Premier Power Ltd, i loro.
Allego una mappa della località dove è stata costruita la centrale, che poi è stata un ampliamento e ammodernamento di quella già esistente.
La località si chiama Ballylumford e si trova nella contea di Larne sulla punta della penisola di Islandmagee e che divide il Larne Lough dal Mare d'Irlanda. La città più vicina alla centrale è Larne mentre Carrickfergus, dove abitavo io, dista da Belfast circa 20 miglia.
TURBINA A GAS
BALLYLUMFORD CCGT PLANT – UNITED KINGDOM1.
La Premier Power Ltd ha costruito una centrale elettrica da 600 MW a ciclo combinato (CCGT) a turbine a gas a Ballylumford, una località dell’Irlanda del Nord, sulla punta della penisola Islandmagee che separa il Lame Lough dal Mare d'Irlanda. La nuova stazione si trova vicino ad un’altra preesistente e sfrutta le esistenti infrastrutture inclusa la fornitura di gas naturale ed i sistemi elettrici di distribuzione. L’efficienza termica del nuovo impianto è superiore al 50% e la corrente è prodotta a 15 e 18 kV per facilitare la trasmissione sottoterra. Quando il nuovo impianto sarà completato, le tre turbine a vapore da 200 MW del’impianto esistente verranno decommissionate e i tre rimanenti gruppi nell’impianto esistente resteranno operativi.
La Centrale é la più grande dell'Irlanda del Nord e con il suo impianto principale produce la metà di tutta la corrente consumata nel Paese. A pieno regime la Centrale può produrre 1316 MW.
CICLO COMBINATO TURBINE A GAS
Il ciclo combinato delle turbine a gas può ora dare un’efficienza del ciclo termale superiore al 50% e molto più altadell’attuale 33% del vecchio impianto. Se le turbine a vapore dovessero essere fermate per manutenzione o avaria, ilnuovoimpiantopotrebbe continuare ad operare in condizioni ridotte fornendo il 35% della produzione. In questo caso il calore delle turbine a gas verrebbe scaricato all’atmosfera attraverso una ciminiera by pass.
TRE TURBINE SIEMENS A GAS
L’impianto comprende due turbine a gas Siemens V94.2 e una V64.3A a ciclo combinato.
TENSIONE A 15/18 kV TRASFORMATI A 275/110 kV
La corrente viene prodotta a media tensione (15/18 kV) e convertita a 275/110 kV a mezzo di trasformatori per soddisfare le esigenze della rete di distribuzione dell’Irlanda del Nord (NIE). La corrente ad alta tensione viene trasferita amezzocavisotterranei ad una sottostazione della NIE e da qui distribuita alle utenze. All’interno della centrale la media tensione viene ridotta per soddisfare le esigenze interne operative rendendo la centrale autosufficiente.
GAS NATURALE CON BASSO CONTENUTO DI ZOLFO
Il combustibile principale dell’impianto è il gas naturale a basso contenuto di zolfo proveniente dal Mare del Nord. Il gas viene inviato alla centrale di Ballylumford attraverso la rete di distribuzione BG National Transmission System ed il gasdotto sottomarino Premier Transco dalla Scozia all’Irlanda del Nord ad una pressione da 15 a 75 bar. Arrivato alla centrale viene ridotto alle pressioni per l’utilizzo nei bruciatori delle caldaie. Le turbine a gas possono operare anche con combustibile liquido a basso contenuto di zolfo nel caso che la fornitura di gas venga interrotta. Quando le turbine lavorano con combustibile liquido le emissioni NOx vengono controllateper lenorme antinquinamento previste dalla legislazione locale. Questa operazione viene fatta iniettando acquaovapore nel fuel per mantenere più bassa la temperatura di combustione. Nessuna iniezione di acqua è richiesta per controllare il NOx quando si usa il gas naturale. Lo scarico delle turbine a vapore viene inviato al condensatore e il condensato viene reinviato alle caldaie a mezzopompe. rispettare
WATER RETURNED TO LARNE LOUGH
L’acqua di raffreddamento per il condensatore viene presa e reinviata dopo l’utilizzo nel Larne Lough a mezzo pompe di circolazionead immersione. Anche l’acqua di raffreddamento, al ritorno in mare, non deve superare i limiti di temperatura e di purezza previsti dalle leggi locali.
La disposizione e la progettazione dell’impianto viene fatta con sistemi tecnologici approvati che rispettano i livelli di impatto ambientale ed in particolare inquinamento, rumorosità, sicurezza ed emissioni.
ALBMUM FOTOGRAFICO DELL'IMPIANTO DI BALLYLUMFORD

Assemblaggio del condensatore

Condensatore Ausiliario

Gruppo turbina a Gas SIEMENS

Montaggio tubazioni cool water

Pompe del condensatore ausiliario

Tubi e Bulloneria in Titanio nel Condensatore

Tubi e piastre, tubi in Titanio del Condensatore

Alternatore

Dual-fuel boilers (Fileminimizer)

Palette

Palette viste da un'altra posizione

Palette-Rotore

Perni bloccaggio

Rotore

Rotore installato
ALBUM FOTOGRAFICO DI BALLYLUMFORD

Premier Power CCGT power station (FILEminimezer)

City Hall - Carrickfergus

Dopo il temporale

Giardini di Carrickfergus

Porto di Carrickfergus

TO COMMEMORATE THE LANDING OF HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II AND HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF EDINBURGH AT THIS PIER ON 8TH AUGUST 1961

Tipico Pub di Carrickfergus

Restauro di una imbarcazione
Durante la mia permanenza, nei giorni in cui non si lavorava, avendo l'auto a disposizione, facevo il turista. A Belfast, che è una bella città, ho visitato il museo del Titanic ed i cantieri H & W dove è stato costruito, i quartieri dove si sono svolti gli scontri tra l'IRA e gli Inglesi (vedi foto "murales"), il museo delle ferrovie, e tanti altri posti. Fra l'altro ho visitato, con assaggi vari, le antiche distillerie Bushmills (vedi foto), nella contea di Antrim, dove producono ottimo whiskey (comunque preferisco sempre una bella grappa nostrana). A Belfast andavo spesso a vedere gli storici e famosi pubs: the Crown Liquor Saloon del 1855 è il più famoso e si trova nella zona della città chiamata "il Golden Mile".
ALBUM FOTOGRAFICO DI BELFAST ED ALTRE LOCALITA' DELLA ZONA


"Seacat" nel porto di Larne

Il SEACAT che collega Belfast e Larne
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MURALES DI BELFAST




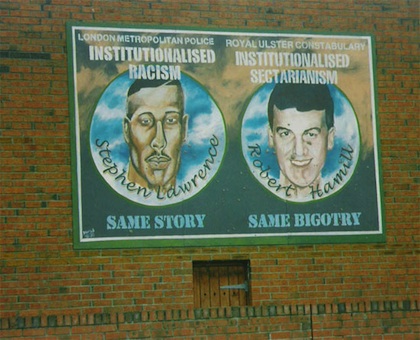











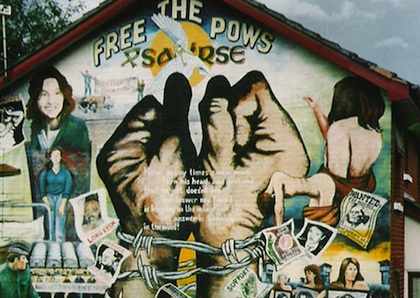
CARRICKFERGUS
IRLANDA DEL NORD

Castello

Il Centro città



Esterno della Distilleria Old Bushmills
Pino SORIO
A cura di Carlo Gatti
Rapallo, Giovedì 22 ottobre 2015
S.FRUTTUOSO DI CAMOGLI-MARIA E CATERINA AVEGNO. Un dramma da ricordare
MARIA E CATERINA AVEGNO
Un dramma da ricordare
La mattina del 24 aprile 1855, Cavour e Rattazzi assistevano nel porto di Genova agli intensi preparativi per l’imbarco di un reparto di circa 270 uomini dell’esercito piemontese sul piroscafo inglese Croesus, destinato alla guerra di Crimea. Stavano imbarcando 37 Ufficiali del Genio e 239 soldati di sussistenza, medici e infermieri, oltre a medicinali (specialmente preparati anticolerici) e le attrezzature di un ospedale da campo di oltre 100 letti. E ancora muli, cavalli, fieno, acquavite, 1.400.000 razioni di viveri e una notevole quantità di munizioni ed esplosivi. Il Croesus doveva inoltre rimorchiare il Pedestrian, un veliero carico di viveri, ma soprattutto di munizioni e una batteria di campagna. La partenza avvenne intorno alle 09. Dopo circa due ore di navigazione, il Piroscafo Croesus, avvolto da un incendio, naufragò nella baia di San Fruttuoso il 24 aprile del 1855.

Il p.fo Croesus in fiamme davanti a San Fruttuoso

La casa natale delle sorelle Maria e Caterina Avegno a San Fruttuoso di Camogli
Erano tempi in cui per sopravvivere si batteva il mare... e di uomini a San Fruttuoso se ne vedevano pochi, in gran parte erano imbarcati sui velieri di Camogli, altri erano dediti al commercio dei prodotti della collina: olio, uva, miele, ortaggi, legna, lisca e fascine. Gli altri, quei pochi pescatori del borgo, quel giorno “bottezzâvan” lontani dalla baia. Nel villaggio facevano la guardia poche donne, qualche anziano intento a riparare le reti e molti bambini. Sul bagnasciuga c’erano solo due gozzi, quelli di riserva destinati all’emergenza e al rimessaggio; il primo venne utilizzato dalle sorelle Maria e Caterina Avegno, il secondo dal marito di Maria, Giovanni Oneto.

Maria Avegno, per quanto ne sappiamo dalle cronache dell’epoca, era madre di molti figli, c’é chi scrive quattro, altri sei, altri addirittura otto. Non é difficile immaginarla “figgeua” con la sorella Caterina, cavalcare le onde da libeccio, tuffarsi dagli scogli e poi sparire fino a riva, emergere e scrollarsi l’acqua di dosso nella loro piscina naturale, privata. Il palcoscenico é il mare, un sottile fiordo a picco sul mare: il loro paradiso. Dietro al verde pendio accanto all’Abbazia c’é il loggione da cui sognare prima della rincorsa per l’ultimo tuffo della giornata. Queste figlie del mare sono cresciute sfidando le onde, le uniche amiche di cui potersi fidare, compagne con cui dividere quel che resta di un mondo che é chiuso in una conchiglia magica che ha un solo suono: l’eco del mare. Maria e Caterina sono due delfini che saltano di gioia aiutandosi a crescere senza paure. Le “uscite” con qualsiasi tempo, sono sfide quotidiane per sentirsi padrone del borgo e non prigioniere della solitudine. Sanno nuotare, remare e manovrare la vela, conoscono le insidie di certi scogli e i giri di corrente, la paura non fa parte dei loro pensieri.
Ma allora cosa accadde quel giorno? Purtroppo chi va per mare lo sa, ogni tanto lo spirito del maligno, approfittando di chissà quale distrazione del cielo..., interviene con tutto il suo potere nefasto e si vendica di tanta beatidudine e bellezza che non gli appartengono.
Dirotta il Croesus sotto incendio all’interno della baia, lo spinge contro gli scogli e reclama con successo 24 vittime sacrificali.
La cronaca é un lampo di cattiveria, di sfortuna, d’immensa tristezza.
Quasi tutti i soldati non sanno nuotare e presi dal panico si gettano in mare con la speranza di toccare il fondale, di rimbalzare e d’essere spinti verso la riva, su quella striscia bianca che si chiama ‘salvezza’.
Maria e Caterina sanno che il baluardo di scogli che ha bloccato il Croesus tra le due ultime anse della rada, scende a picco su un alto fondale e, intuita la scena successiva del “naufragio sotto casa”, spingono i gozzi in mare e con poche remate si trovano circondate dai naufraghi. Ne raccolgono parecchi e ritornano a riva. Ripetono la spola salvandone altri. Poi, all’improvviso, alcuni soldati stanchi e impauriti s’aggrappano alla falchetta del gozzo, tutti dalla stessa parte. La disperazione e l’inesperienza fanno il resto: l’imbarcazione si capovolge. Le due ragazze rotolano in mare e i soldati si aggrappano alle loro vesti trascinandole sott’acqua. Neppure il tempo di gridare AIUTO!! Al loro pezzetto di cielo. Vittime del loro coraggio, le ragazze vengono inghiottite dal mare traditore che si riprende tutto ciò che aveva dato loro in prestito: la confidenza e una felice gioventù.
Caterina viene tratta in salvo più morta che viva. Il corpo di Maria é restituito ai suoi cari dopo quattro lunghi giorni di ricerche e di pianti.
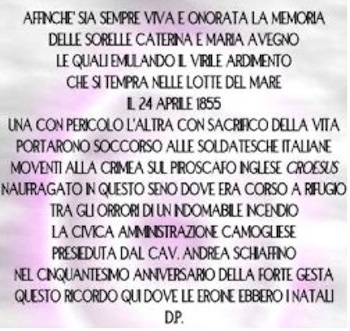
Maria Avegno fu sepolta nell’abbazia di San Fruttuoso, per concessione dei Principi Doria Pamphilj, un privilegio unico per gli abitanti del borgo.
Le Autorità cittadine conferirono alla sua memoria onorificenze e sostegno per gli orfani. Il governo del Regno di Sardegna, nel giugno 1855 deliberò di concederle la medaglia d’oro al valor civile (prima donna italiana a ricevere l’alta onorificenza) e un vitalizio ai suoi otto orfani.
La Regina Vittoria conferì alla memoria di Maria la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il Console inglese Brown consegnò 10 sterline alla superstite Caterina e 50 sterline alla famiglia di Maria Avegno.
Il nome di Maria Avegno è scritto persino nel libro d’oro della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, per mano do monsieur Cormenin, fondatore di un’associazione che ha lo scopo di celebrare una messa quotidiana, in una cappella della Cattedrale, in suffragio di tutti coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo.
A Camogli il belvedere panoramico noto come la “Rotonda”, è intitolato alle due eroiche sorelle.
Carlo GATTI
Rapallo, 18 Settembre 2015
SANT’ERASMO (SANT’ELMO) - Devozione e Tradizione
In molti ORATORI dei nostri borghi sono visibili le tracce della nostra tradizione marinara che sanguina devozione e ricordi. C.G.
SANT’ERASMO - (SANT’ELMO)


Santino raffigurante Statua di Sant'Erasmo - S.M. Capua Vetere
Liguria
Il Cambiaso ci riferisce che il culto di questo Santo, Vescovo e Martire, vissuto intorno al 300 d.C. fu portato nella nostra città (Genova), dai marinai di Gaeta, nel sec. X. Da Gaeta la venerazione verso di Lui si diffuse in Italia durante i sec. XIII e XIV. E’ invocato come protettore dei marinai unitamente a S. Firmina. In seguito il culto del Santo acquistò popolarità e dal 1263 Egli fu festeggiato annualmente. La Franchini-Guelfi deduce sia specifico “patrono dei marinai” anche dal fatto che non esistono Chiese od Oratori dell’entroterra dedicati a tale Santo mentre invece sono numerosi lungo le coste della riviera ligure. Ad esempio, nella riviera di levante, oltre a quello di Quinto, ne esistono tutt’ora a Capolungo, a Sori (edificato nel 1495) ed a S. Margherita mentre nel ponente ne sono attive ancora due: l’Arciconfraternita di Voltri e la Compagnia di Pegli. Diversi sono i santi protettori a cui si rivolgeva la gente di mare. Il più affascinante è senz’altro Sant’Erasmo o Sant’Elmo. La sua luce - i fuochi di S.Elmo - ha certamente un’origine pagana: i Greci infatti credevano che fossero i Dioscuri Castore e Polluce, figli di Zeus, a soccorrere le imbarcazioni in difficoltà, splendendo come due stelle ai lati dell’albero maestro... A Savona esiste un molo di Sant’Elmo, il ricordo di una chiesetta cinquecentesca nella darsena a lui dedicata: ma l’elenco dei suoi templi in riva al mare è infinito, e citandoli si farebbe il giro delle coste italiane. La leggenda dice che... ...naufrago, Sant’Elmo fu raccolto da una nave, salvato e condotto a terra. Il capitano non volle altra ricompensa che una prova della potenza che in quanto santo egli doveva possedere: Sant’Elmo gli promise così di avvertirlo con un fuoco dell’imminenza della burrasca, affinché egli potesse farvi fronte. Il santo mantenne la promessa, e cominciò a far apparire i suoi fuochi per salvare anche altre navi. Dei prodigi di Sant’Elmo raccontano nei loro diari Fernando Colombo (nell’ottobre 1493), figlio dell’Ammiraglio, e Antonio Pigafetta (da Primo Viaggio al globo terraqueo, I) che con Magellano circumnavigò la Terra; Pigafetta vede sugli alberi della sua nave durante la tempesta ben tre santi in un colpo solo, Erasmo, Niccolò e Chiara.
SANT’ERASMO A SANTA MARGHERITA LIGURE
L'oratorio di Sant'Erasmo


di Alfredo Bertollo e don Gerolamo Devoto
Presentazione del parroco di San Giacomo di Corte: Don Luigi Egiziano
La Confraternita di Sant'Erasmo, con l'annesso Oratorio, s'inserisce nell'ampio movimento associativo laicale sorto nella storia della Chiesa per rispondere alle esigenze culturali, sociali e caritative delle comunità cristiane. La diligente, seppur breve, ricostruzione storica del dottor Alfredo Bertollo, ha il merito di riassumere le date importanti del cammino dell'Oratorio di Sant'Erasmo e di evidenziare le caratteristiche peculiari dell'omonima Confraternita, che sono state e rimangono di tipo liturgico, caritativo e culturale. L'Oratorio di Sant'Erasmo rimane tutt'oggi un piccolo tempio aperto e invitante per la preghiera della popolazione, dei turisti e della comunità che si raccoglie ogni domenica per la Santa Messa, aperta ad accogliere i defunti di Corte e al suffragio per essi, puntuale per la celebrazione delle liturgie e delle feste con particolare solennità. Auspichiamo di cuore che questo notiziario storico raggiunga lo scopo non solo d'informare, ma anche quello di creare un clima d'apprezzamento e di simpatia per i confratelli, e un'occasione, questa del 650° di fondazione, per rinnovare lo spirito originario di fervore, di fedeltà e di zelo in tutti gli aderenti e i simpatizzanti della Confraternita.
Prefazione
Nell'anno in corso 1997 ricorre il seicentocinquantesimo della costruzione della chiesa che marinai e pescatori della parrocchia di San Giacomo dedicarono nel 1347 a Sant'Erasmo. La Confraternita dell'Oratorio di Sant'Erasmo di Corte, da me sollecitata, ha ritenuto dare risalto a questo anniversario, oltre che con le feste che saranno celebrate nel prossimo giugno, anche con questa breve pubblicazione che si ripromette di rievocare e lasciare una piccola traccia per le generazioni future delle vicende più importanti della storia dell'Oratorio e delle sue proprie, strettamente legate a quest'ultimo. Ringrazio, insieme con la Confraternita, l'amico dottor Alfredo Bertollo che ha aderito prontamente all'invito di coordinare e redigere tutte le notizie che, sull'argomento, abbiamo potuto raccogliere.

La Statua in legno di Sant'Erasmo attribuita ad Anton Maria Maragliano (1664-1741)

Funzione religiosa nell’Oratorio di Sant’Erasmo a Santa Margherita Ligure
L'Oratorio di Sant'Erasmo ha una particolare importanza per avere svolto un'intensa opera di pietà, di carità e di culto a pro' di tutti gli iscritti ma specialmente dei bisognosi, dei malati, dei defunti e per essere stata una specie di società di mutuo soccorso, sia materiale che spirituale. La chiesina di Sant'Erasmo, che ha anche un certo valore artistico, è stata costruita su uno scoglio che sorgeva ai piedi della collina su cui è costruita la chiesa di San Giacomo. Non esisteva allora né la strada carrozzabile sotto la chiesa, né l'ampia calata, né il molo che cinge il porto. L'Oratorio aveva davanti a sé il mare che si frangeva violento nelle tempeste contro i muri della chiesa. Esso rappresenta, con il solenne ammonitore linguaggio dei secoli sullo svolgersi delle vicende umane di cui è stata, ed è tuttora, testimone e attrice, un simbolo di fortezza e di fede. L'Oratorio di Sant'Erasmo godette, nei secoli, di grande prestigio non soltanto locale, in quanto sede della Confraternita che comprendeva anche molti pescatori del prezioso corallo che veniva raccolto in lontani mari e commerciato in tutta l'Europa. Quest'opuscolo vuole essere per gli attuali abitanti di Corte, memori della meravigliosa attività svolta sempre a vantaggio dei loro conterranei in tanti secoli d'esistenza, oltre che un glorioso ricordo, anche un invito a rinnovare affetto e stima per l'Oratorio e per la sua benemerita Confraternita. Sono certo che queste pagine saranno lette con interesse perché fanno riscoprire l'umiltà e la bellezza della fede degli antenati e anche di molti nostri contemporanei, la grandezza della Carità e l'attrattiva e l'insegnamento della storia e dell'arte.
Sac. Gerolamo Devoto
Introduzione
L'Oratorio di Sant'Erasmo, che appartiene alla Confraternita omonima, fa parte di Corte, quartiere di Santa Margherita Ligure. Corte (la Curtis romana), posta nella parte meridionale dell'antica Pescino, nome che il territorio posto fra Rapallo e Portofino mantenne fino al tardo Medioevo, è una località marinara che fu sempre dotata di un comodo approdo. Il piccolo edificio sacro con minuscolo campanile, posto ai piedi della maestosa scalinata che porta alla chiesa di San Giacomo di Corte, parrocchia dalla quale dipende, è ubicato in uno dei luoghi più adatti per essere dedicata a Sant'Erasmo, Patrono della gente di mare: prospiciente al porto, il cui molo fu costruito nell'ottocento per la pertinacia della gente di Corte, e sopra la spianata dove ac-costano le barche con le cassette di pesce appena scaricate dai pescherecci. Santa Margherita ha ricche e splendide parrocchie (La Basilica di Margherita d'Antiochia, San Giacomo, San Siro, San Lorenzo della Costa e Nozarego) e alcuni oratori che potrebbero, da soli, essere il vanto di parecchie cittadine delle dimensioni di Santa Margherita. Fra questi l'Oratorio di Sant'Erasmo di cui ci occuperemo parlando del santo titolare, della chiesa e della sua Confraternita.
Sant'Erasmo
Per poter conoscere meglio la figura di Sant'Erasmo, che fu un martire del IV secolo, è necessario fare una panoramica di quel tempo prima di entrare nei dettagli, affatto facili da ricostruire, dato che la storia della sua vita, non supportata da sufficienti testimonianze e documentazioni, è in gran parte avvolta nella leggenda. Erasmo era un nome tipico, comune anche ad altri santi della Siria, latinizzato dal nome greco Orao che significa piacevole, gradevole. Il Nostro nacque ad Antiochia (l'attuale Antykia in Turchia nel Mediterraneo orientale ai confini della Siria), da una semplice famiglia di lavoratori del mare, verso la metà del IV secolo quando Aureliano, che voleva ristabilire l'unità dell'Impero, turbata dalle forze centrifughe - fra le quali il Cristianesimo - aveva iniziato un'ennesima persecuzione. Erasmo fu cristiano, sacerdote e persino vescovo in quella città che diventò il centro più importante dell'esegesi letterale della Bibbia. Egli subì la persecuzione di Diocleziano, l'imperatore di origine dalmata, che assunse titoli divini e voleva perfino essere adorato. Fu proprio lui che, dopo avere diviso in quattro l'impero e riservato per sé la Siria, l'Egitto e l'Asia Minore, risiedendo a Nicomedia, poco lontana da Antiochia, gli fece subire nel 303 d.C. un primo crudele martirio. L'esempio d'intrepido coraggio da lui dimostrato valse a moltiplicare il numero di persone che si convertirono al Cristianesimo. Stando a quanto afferma il Martirologio Romano, l'Arcangelo Gabriele avrebbe miracolosamente liberato Erasmo dal carcere, dov'era stato rinchiuso, per portarlo in salvamento, prima nell'Illirico (la costa dalmata), poi in Italia, che, nella sopraricordata divisione, era passata a Massiminiano. Un miracolo particolare è quello del fulmine che, nel corso di una traversata, sarebbe stato, per mezzo di lui, venerabile parafulmine, deviato e avrebbe risparmiato la navicella su cui si trovava. Il santo, che da molti è chiamato anche Elmo, ha dato il nome ai cosiddetti fuochi di Sant'Elmo che sono quel velo incandescente, dovuto a elettricità atmosferica, cha appare talvolta di notte sulla estremità degli alberi delle navi. In Italia Erasmo non ebbe vita facile ma operò anche qui, come prima nell'Illirico, moltissime conversioni. Si parla di centinaia di migliaia (ottocentomila!!). Non diamo limiti alla Provvidenza ma è probabile che la tradizione abbia dato luogo all'iperbole. Perseguitato, dovette lasciare le Puglie (la città di Lucera) e, attraversati gli Appennini, passare a Formia dove i cristiani locali, considerati i suoi molti prodigi, lo elessero a loro vescovo. Formia, la bella località nel golfo di Gaeta a sud di Roma, fu anche il luogo dove Erasmo venne martirizzato. Condotto davanti a Massimiano Augusto, non rinnegò Gesù Cristo e fu sottoposto al più atroce supplizio, terribile perfino da descrivere, quello dell'estrazione dall'ombelico degli intestini, tramite un argano. La leggenda racconta che, prima che spirasse, una voce che scendeva dal Cielo dicesse: «Erasmo, mio servo fedele, poiché come buon soldato hai combattuto per me, vieni a ricevere la corona della gloria» e che, mentre il martire pronunciava le parole: «Ricevi, o Signore, in pace il mio spirito», una corona splendente circondasse a mo' di aureola il suo capo. Fin qui la storia e la leggenda. Sappiamo tuttavia per certo che il suo corpo fu sepolto nella cattedrale di Formia e che, poi, quando nell'842 i Saraceni assaltarono le città di Formia e Fondi e le distrussero, i suoi resti furono traslati in quella di Gaeta, città della quale divenne patrono. Quale protettore dei marinai e dei pescatori, Sant'Erasmo ha ricevuto in moltissime chiese a lui dedicate ex-voto rappresentanti salvataggi miracolosi ma le grazie da lui ottenute sono anche quelle relative al salvamento nelle tempeste della vita alle quali tutti siamo soggetti. Ma Sant'Erasmo è anche protettore dei tornitori. Il motivo è forse che gli furono estratti gli intestini con uno strumento di tortura che ricorda il tornio. Essendo stato dunque martirizzato in questo modo, è considerato anche il protettore delle malattie viscerali e delle partorienti. Rasmo o Mal di Sant'Erasmo è designato infatti nell'antico italiano il mal di ventre. Il santo fu anche invocato specialmente contro le epidemie. Il culto di Sant'Erasmo, oggi generalizzato in molte parti d'Italia, sta a dimostrare quanti miracoli egli abbia ottenuto da Dio a chi, per suo tramite, lo ha devotamente implorato. La figura del santo e il suo martirio sono stati ricordati sia nel Rinascimento che nell'Età Barocca in tutta l'Europa cristiana (Lucas Cranach, Mathias Neithard, Gothardt, soprannominato Gruenewald, Michael Pacher). In Italia è stato magistralmente rappresentato nella splendida tela che si trova nella Pinacoteca Vaticana "Il Martirio di Sant'Erasmo" del pittore Nicola Poussin, maestro del Classicismo francese. Il santo, di cui abbiamo nell'Oratorio la bella statua lignea, attribuita ad Antonio Maria Maragliano, è anche ricordato in parecchie pale d'altare del Tigullio: in cattedrale a Chiavari, nella Basilica di Rapallo e nella chiesa di San Giacomo di Corte. Inoltre a Rapallo, nel posto, dietro il chiosco della musica, dove si trovava la sede della locale Confraternita di Sant'Erasmo, vi è un altro dipinto del santo.
La Chiesa e i suoi tesori
Desta meraviglia constatare quante e come sono belle le chiese che si trovano in ogni angolo della Liguria. Sono barocche ma non mancano alcune romaniche, gotiche e neo-classiche. Nella Riviera di Levante, e in particolare nel Tigullio, l'architettura barocca, fino a poco tempo fa ingiustamente denigrata perché, in certi casi, portava all'esagerazione, è quella predominante e ammiriamo splendidi esterni non soltanto nelle grandi chiese dei centri maggiori, ma anche in quelle piccole dell'entroterra e in diversi oratori. Quando poi si entra nelle chiese si resta meravigliati dalla magnificenza, anche qui barocca, dei loro interni e sorgono spontanee due domande: «Come si può essere arrivati a tale ricchezza e come essa è stata mantenuta, nonostante le innumerevoli vicissitudini di tanti secoli?». Non ci si può sottrarre a esse neppure nella chiesa di San Giacomo di Corte e nel piccolo Oratorio di Sant'Erasmo a Santa Margherita. Le risposte sono queste: «Anche qui, come in quasi tutte le chiese della costa, marinai e pescatori hanno accantonato una parte dei loro redditi, la famosa "decima", per arricchire la chiesa» e «In ogni tempo della storia essi hanno sempre contribuito con i loro mezzi a ricostituire quanto corsari, ladri sacrileghi o governi antireligiosi hanno depredato nel corso dei secoli». Non parliamo della chiesa di San Giacomo, che non è l'oggetto di questa breve esposizione, se non per ricordare che una bella pubblicazione del dottor Davide Roscelli, edita nel 1983 da un Comitato di Corte in occasione del secondo centenario del Ritrovamento e del primo della Incoronazione della Madonna della Lettera, ne spiega, in maniera approfondita e con splendide illustrazioni, storia e arte. La chiesa di San Giacomo, dominante il mare, posta in alto vicina allo splendido palazzo che fu dei Durazzo, sembra quasi proteggere l'abitato di Corte.
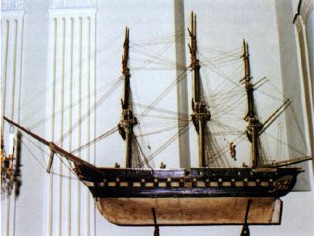

Due ex voto di eccellente fattura
Il sottostante Oratorio fu costruito come cappella dai marinai di Corte su uno scoglio, detto di Sant'Elmo, lambito dal mare che dominava la loro rada quando ancora non esisteva la strada litoranea. Per arrivare da Corte alla chiesina, si passava da un sentiero sopraelevato, l'attuale via che conduce al Convento dei Cappuccini. L'Oratorio di Sant'Erasmo, Monumento Nazionale, costruito a una sola navata, per la prima volta nel 1347, ha oggi una facciata barocca, recentemente restaurata, piccola abside e sacristia ed è un gioiello fra i tanti che la religiosità del popolo - nel nostro caso marinai e pescatori - ha donato a Santa Margherita. La Confraternita si occupò, come in seguito vedremo, di mantenere l'Oratorio e di arricchirlo di monumenti di gran valore e suppellettili ricchissime che qui elenchiamo. Fra le opere più notevoli abbiamo:
• la già ricordata bella statua di Sant'Erasmo, attribuita al noto scultore in legno Antonio Maria Maragliano che, secondo alcuni, era originario di Corte;
• modelli di velieri in legno costruiti a mano dai naviganti nei lunghi viaggi di mare e donati ex voto;
• pitture artistiche del quattrocento.
Crocifisso Nero
Fra gli arredi:
• ostensori, turiboli e navicelle per l'incenso, candelieri in argento di Torretta e in legno dorato;
• mazze artistiche per guidare le processioni;
• paramenti di broccato secenteschi;
• tovaglie, camici e cotte fatte a mano con pizzi, a produrre i quali erano maestre le donne di Corte;
tabarri di velluto rosso, ricamati in filigrana d'oro, per i confratelli
L'Arciconfraternita di Sant'Erasmo Le confraternite, che proliferarono in molte parti d'Europa sia prima che dopo la riforma luterana, erano delle associazioni di laici che avevano un proprio statuto, titolo, foggia speciale di abiti, insegna, e dipendevano dalle autorità ecclesiastiche per quanto concerneva il culto. Ve n'erano molte anche in Liguria e nella stessa Santa Margherita possiamo ricordare quelle di San Bernardo, che risale al 1503, della Buona Morte al 1523, della N.S. dei Sette Dolori del 1687 nonché quella di N.S. del Carmine di Nozarego nel 1724.
Queste associazioni, che non avevano solo scopi di culto ma anche di assistenza reciproca, erano sorte per iniziativa di appartenenti ai diversi mestieri praticati e prendevano normalmente il nome da un soggetto religioso. I relativi oratori, nel corso dei secoli, furono amministrati dalle rispettive pie confraternite. Nel passato vi erano molte chiese, oratori e società di mutuo soccorso intitolate a Sant'Erasmo. Ricordiamo in Liguria la parrocchia di Sant'Erasmo di Voltri e le chiesette di Nervi, Quinto al Mare, Sori e Lerici. La Confraternita di Sant'Erasmo di Corte raggruppava marinai, pescatori e validi costruttori di barche, maestri d'ascia fra i migliori del Mediterraneo. Gli scopi della Confraternita erano quelli di tutelare i suoi membri (e le loro famiglie), sottoposti ai gravi rischi del lavoro, sia in terra che in mare. Va ricordato che molti pescatori, oltre che al pesce, si dedicavano al corallo e si recavano lontano fino a raggiungere l'arcipelago greco, la Corsica, la Sicilia e l'isola di Tabarka in Tunisia, rischiando molto spesso di morire o di essere catturati dai corsari per essere ridotti in schiavitù. La Confraternita si occupava anche dei relativi riscatti e poi delle diverse manifestazioni liete e tristi dei soci, provvedeva alle vedove e agli orfani, assisteva i malati, seppelliva i morti, faceva recitare Messe di suffragio a favore di confratelli e consorelle defunti. Tutto questo in una primordiale forma di assicurazione. Essa aveva anche scopi caritativi. Prima che venisse costruita la pescheria, vi era in quel luogo un magazzino dove tenevano a mantà, una misura di rame il cui contenuto di grano veniva, in occasione di carestie, distribuito ai più poveri. La Confraternita di Sant'Erasmo risale al 1638.


Interni dell’Oratorio di Sant’Erasmo-Santa Margherita Ligure
L'Oratorio, costruito, come già abbiamo scritto, nel 1347, fu lasciato in seguito andare in rovina dalla Confraternita della Trinità di Roma, alla quale era stato aggregato.
Attilio Regolo Scarsella, lo storico di Santa Margherita che si occupò approfonditamente delle vicende di tutte le attività civili e religiose della città, ne ricorda la ricostruzione nel 1674, per merito della Confraternita. "In nome di Gesù e Maria. Questa fabbrica l'hanno fatta Fra Bernardino Rodele e, Fra Beneto da Pompilio… poveri eremiti." Nel 1682 s'iniziò a celebrarvi la prima Santa Messa festiva. Cent'anni dopo (1782), il Simulacro della Madonna della Lettera, trasportato al largo di Corte dalle correnti marine da Messina, dove era crollata la chiesa in seguito a un terremoto, fu conservato per parecchio tempo nell'Oratorio prima di venir solennemente posto nell'Altar Maggiore della chiesa di San Giacomo.
Alla fine del XVII e nel XVIII secolo, la Confraternita svolgeva anche il compito di Capitaneria di Porto della Repubblica Genovese e riscuoteva i diritti portuali; si occupava della manutenzione dell'Oratorio e dell'acquisto di oggetti sacri necessari al culto. Organizzava le processioni che rappresentavano l'orgoglio dei confratelli. Purtroppo con la Rivoluzione Francese queste tradizioni si affievolirono e l'ottocento e la prima metà del novecento furono tempi bui per l'Oratorio in quanto esso rimase chiuso, sia a causa delle rivoluzioni che delle guerre. Un personaggio benemerito nella vita dell'Oratorio è stata la signorina Angela Grosso, vulgo Angiulinna che, avendo rilevato la chiave dal canonico di san Giacomo, don Luigi Maria Carbone, morto nel 1948, nonostante avesse i suoi impegni di lavoro, si prodigò per tutta la sua vita fino al 1979 per la conservazione dei beni dell'Oratorio: arredi sacri e strutture essenziali della chiesa, che negli anni della guerra avevano subito notevoli danni. Il suo gran merito fu quello di aver lasciato, alla sua morte, spazio al gruppo giovanile che si occupò dell'Oratorio per mantenere le tradizioni religiose della Confraternita e svilupparne l'attività.
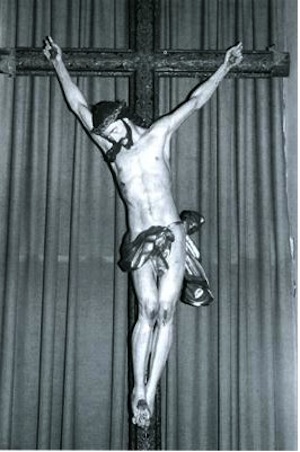
La Arciconfraternita, oggi La Confraternita di Sant'Erasmo, costituita oggi come ente morale avente scopo umanitario, caritativo e di culto, è stata rifondata nel 1968 ed è composta da un Collegio di Priori e da un Consiglio di Massari con l'assistenza spirituale del parroco di San Giacomo di Corte, don Luigi Egiziano. Essa è oggi Arciconfraternita avendo facoltà di aggregarsi altri sodalizi dello stesso titolo e scopo. Questo ente, negli ultimi trent'anni di attività, oltre ad aver ripristinato l'Oratorio dal punto di vista architettonico esterno (facciata, abside e sacristia), e interno (con il restauro degli armadi e del coro in legno, nonché dei preziosi lampadari), ha anche ricostruito l'organo nella sua sede originale, cioè sull'orchestra.

Il sagrato dell'Oratorio (Risseu)

L’organo dell’Oratorio
Inoltre ha dotato la piccola chiesa di importanti attrezzature moderne quali l'impianto elettrico generale, la soneria dell'orologio e delle campane a distesa, l'allarme contro i furti e l'apertura automatica delle finestre laterali. Ha provveduto poi, per le processioni, ad acquistare un nuovo grande crocifisso in bronzo e una nuova bandiera con l'effigie di Sant'Erasmo e ha restaurato l'arca processionale. Inoltre, nell'interno, ha rimesso a nuovo le barche antiche, ora mirabilmente esposte, e ha restaurato il Crocefisso Bianco. La Confraternita allestisce ogni Natale - opera pregevolissima - un Presepio, spesso con ambientazioni tipiche del quartiere di Corte. In gran parte, le figure in terracotta sono state artisticamente costruite e vestite dai ragazzi delle scuole e da membri della Confraternita stessa. Anche il Sepolcro del Giovedì Santo è uno fra i più belli e suggestivi della città. Un altro merito della Confraternita è stato quello di avere riordinato e sistemato l'archivio dell'Oratorio. E' chiaro che nei suoi obiettivi sono comprese anche manifestazioni culturali e musicali, realizzate anche in collaborazione con il Comune, a scopo caritativo fra le quali i concerti, utilizzando il nuovo organo di cui abbiamo poc'anzi ricordato l'installazione. La Confraternita ha inoltre organizzato un concorso canoro per le bambine della scuola elementare e uno di disegno per gli allievi delle Scuole Medie. Quest'ultimo al fine di realizzare la nuova bandiera. La presenza di ben novantaquattro bozzetti, esposti nell'Oratorio, sta a dimostrare la grande partecipazione riservata a questo genere di attività culturale.
Le attività religiose, quali organizzare le Sante Messe festive e di suffragio per i defunti ascritti e novene, sono parte integrante delle finalità dell'ente. La Novena dei Morti, per esempio, che inizia alle cinque di mattino, notte fonda alla fine d'ottobre, viene recitata con un Ufficio notturno seguendo l'antica tradizione latina dei pescatori. La Confraternita organizza anche con pompa magna, la festività del Santo Patrono e di N.S. della Pace, la cui immagine è stata donata all'Oratorio dagli emigranti di Corte nelle Americhe. Negli ultimi anni è stata ripristinata la processione in mare in occasione dell'anniversario dell'arrivo del Simulacro della Madonna della Lettera nel mare di Corte. Conclusione Con questa breve pubblicazione ci eravamo prefissi:
• di fornire qualche notizia su Sant'Erasmo del quale pochissimi conoscono la vita;
• di rendere più nota la sua piccola chiesa di Corte e le opere d'arte in essa contenute;
• di ricostruire, a sommi capi, la storia dell'Oratorio e della Confraternita di Sant'Erasmo e di evidenziarne le tradizioni.
Ci auguriamo essa possa servire particolarmente agli abitanti di Corte affinché mantengano salde quelle tradizioni che rappresentano la forza e la vitalità di un popolo e anche ai forestieri, italiani e stranieri, che, sfogliando questo opuscolo, fra le tante impressioni procurate loro dalla bellezza di Santa Margherita, possano conservarne anche alcune di Sant'Erasmo di Corte.
Riassunto Questo opuscolo riguarda una delle innumerevoli chiesine, che si trovano sparse in ogni parte della Liguria, sia marittima che montana. In questo caso si tratta di un antico Oratorio, quello di Erasmo, il santo dei marinai e dei pescatori a Corte di Santa Margherita Ligure. Erasmo, proveniente da Antiochia, città della Siria, oggi in Turchia, da una famiglia di marinai, fu un vescovo cristiano del IV secolo, martirizzato a Formia, a sud di Roma, con un tremendo supplizio, quello dell'estrazione degl'intestini con un argano. La devozione a Sant'Erasmo è diffusa soprattutto sulla costa, (a Nervi, a Quinto al Mare, a Sori, Voltri etc.) e a Santa Margherita Ligure. L'Oratorio fu qui costruito nel 1347 su uno scoglio che sorgeva sulla spiaggia e diventò la sede della omonima Confraternita che esiste da secoli. Le confraternite sono enti morali, sorti già ai tempi del Medioevo, composti da laici che hanno fini di mutua assistenza, sia materiale che spirituale. Esse hanno sempre rappresentato una forma di assicurazione per i loro membri, provvedendo alle loro necessità in caso di bisogno e occupandosi anche del culto (funzioni religiose sia in vita che in morte). Una caratteristica dell'Oratorio di Sant'Erasmo è quella di essere stata sede per molto tempo dei pescatori, oltre che tradizionali del pesce, anche del prezioso corallo che essi, insieme ai pescatori della Campania e della Sicilia, raccoglievano in lontani mari (di Corsica, della Sardegna e del nord-Africa) e commerciavano poi in Europa. Per questo motivo la piccola chiesa, dotata di campanile e sacristia, è ricca di artistiche suppellettili, (modellini di barche in legno, candelieri in argento di Torretta), sculture, quadri (quattrocenteschi) e arredi sacri di gran valore (turiboli, pissidi, navicelle per l'incenso). Si deve ai membri attuali dell'Arciconfraternita se tutto quello che riguarda l'Oratorio è tenuto nel perfetto stato in cui si trova.
Sant'Erasmo di Formia, vescovo e martire, viene festeggiato il 2 giugno.
I marinai lo venerano come patrono con il nome di Sant'Elmo.
Non deve essere confuso con San Telmo, il domenicano spagnolo San Pietro Gonzales, anch'egli invocato come protettore dei marinai.
Infatti, dopo il periodo d'oro dei pescatori di corallo che giunse fino alla Rivoluzione Francese, l'Oratorio fu nel secolo scorso trascurato. Fu merito di una brava donna di Corte, Angela Grosso, chiamata volgarmente Angiolinna se le tradizioni dell'Oratorio vennero mantenute per una buona metà del nostro secolo. Dal 1968, con l'intervento di giovani che si dedicarono anima e corpo al ripristino sia dell'esterno che dell'interno, l'Oratorio è tornato agli antichi splendori. La Confraternita allestisce per Natale uno splendido presepio che riproduce l'abitato di Corte, per il Giovedì Santo il Sepolcro che è fra i più belli delle chiese di Santa Margherita e organizza processioni in occasione delle feste. Ci auguriamo che uno sguardo su questo libricino, possa ricordare al lettore forestiero che Santa Margherita, oltre ad avere il porto turistico pieno di barche a vela e motoscafi moderni, ha ancora dei pescatori, molto legati alle tradizioni che hanno un loro bell'Oratorio, quello di Sant'Erasmo, posto proprio sopra la calata dove essi attraccano alla sera.
© La Gazzetta di Santa
L'iconografia di Sant'Erasmo in Italia
Fonti sicure attestano l’esistenza di un sant’Erasmo vescovo di Formia, martire al tempo di Diocleziano e Massimiano (303) e sepolto nella località costiera del Lazio meridionale (Formia poi Gaeta).
Di storico su di lui si sa, però, poco. La «Passio» che lo riguarda, compilata nel VI secolo, è leggendaria. Venerato nel Lazio e in Campania, è menzionato, oltre che negli antichi martirologi, anche nel Calendario marmoreo di Napoli. Nell’842, dopo che
Formia era stata distrutta dai Saraceni, le reliquie furono nascoste nella vicina Gaeta. Quando furono ritrovate, nel 917, il martire venne proclamato patrono della diocesi del Golfo. Nel 1106 Pasquale II consacrò la cattedrale di Gaeta, dedicandola alla Vergine e a sant’Erasmo. È invocato contro le epidemie e le malattie dell’intestino per il fatto che, nel martirio, gli sarebbero state strappate le viscere. I marinai lo venerano con il nome di Elmo. (Avvenire)
Di seguito riportate alcune delle immagini sacre di Sant'erasmo e statue che lo ritraggono venerate in diverse città italiane

Statua di Sant’Erasmo di Porto Ercole

Sant'Erasmo flagellato al cospetto dell'Imperatore Diocleziano

Suplizio di Sant'Erasmo

Sebastiano Ricci, Martirio di S.Erasmo, pinacoteca di Brera, Milano

Cristoforo Serra, Immacolata Concezione ed i SS.Giacomo apostolo ed Erasmo da Formia, 1670, Chiesa di S.Agostino, Cesena

Statua di Sant’Erasmo Capaci (Palermo)

Nicholas Poussin. Martirio di S.Erasmo. XVII sec.
Città del Vaticano
Alfredo BERTOLLO
Don Gerolamo DEVOTO
C.l.c. Carlo GATTI
Rapallo, Sabato 1 Agosto 2015
Ezio STARNINI, 99 ANNI, ULTIMO SUPERSTITE REX-C.SAVOIA
EZIO STARNINI
L'ultimo superstite degli equipaggi del
REX e DEL CONTE DI SAVOIA
Martedi 22 Luglio compirà 99 anni
Ezio Starnini è nato a Genova, il 22 Luglio 1916, pertanto il 22 Luglio compirà ben 99 anni. Da moltissimi anni abita a Chiavari e può ritenersi Chiavarese di adozione.
E' sicuramente l'ultimo superstite di quel tempo straordinario che fu l'era dei Transatlantici. Ha conosciuto sul REX sia il Comandante Francesco Tarabotto di Lerici che il Comandante del Conte di Savoia Antonio Lena di Riva Trigoso.
A soli 16 anni, nel 1931 imbarcò sul Giulio Cesare e quindi sul prestigioso REX il 26 settembre del 1932.


Ezio Starnini nell’ovale, dietro di lui il gigante Primo CARNERA e la squadra di pallacanestro di bordo
Il 9 Novembre del 1932 imbarca come "Piccolo di Camera" sul conte di Savoia dove vi resta ben 16 mesi. Le sue mansioni a bordo erano quelle di "ascensorista" e accompagnava i passeggeri su e giù nei meravigliosi saloni progettati dagli architetti Gino, e Mariano Coppedè. Per manovrare quegli stupendi ascensori o salottini in miniatura, come ricorda sempre Starnini, non c'erano bottoni, ma soltanto una maniglia dorata che a seconda delle posizioni portava l'ascensore ai vari piani della nave.
7 anni di militare di cui 4 anni di guerra. A Genova si diplomò ragioniere e a guerra finita svolse tale mansione per quasi quattro anni, segretario dell’Associazione “Vittime Civili di Guerra” da lui stesso fondata e altri 26 anni in una nota società petrolifera americana.
Sessantenne, rifiutando incarichi di grande responsabilità che l’azienda gli aveva proposto, va in pensione per dedicarsi decisamente alla scrittura, sua passione da sempre. Dopo alcune esperienze, all’inizio del 1979 scrive e pubblica il suo primo libro, l’autobiografico “Un Ventennio“ Editore Eil Milano. Seguono nel 1987 il romanzo storico “Fuggiasco in Valcedra”, edizioni Lanterna, ambientato nel Parmense del 1800; il 1991 il romanzo “Genova dentro” Edizioni Ecig, vincendo rispettivamente il premio letterario a Santa Margherita Ligure, decima e quindicesima edizione.
Nel 1992 il volume “Era il tempo” ottiene il primo posto nel concorso letterario “Trichiana Paese del Libro”. Nel 1998 col romanzo “l’Ingegnere utilizzato” si cimenta nel giallo ottenendo consensi. Pubblica quindi la prima edizione di “Il tassello mancante” seguito da “Il tassello giallo” e la seconda edizione di “Il tassello mancante” Edizioni Gammarò.
Ha al suo attivo una trentina di racconti e saggi sui Quaderni dell’”Agave“, Centro di Cultura in Chiavari, di cui è socio fondatore.
Quale appassionato narratore e saggista è noto, ma ora è veramente un inedito romanzo ritrovare Starnini nonostante qualche "acciacco", ancora in buona salute, perchè a 99 primavere pensiamo sia senza alcun dubbio l'unico superstite degli equipaggi delle navi di quell’epoca irripetibile. Vive a Chiavari, in un bell'appartamento di Corso Italia appunto insieme alla sua gentile Signora Flora dove hanno trascorso ben oltre 40 degli oltre 70 anni di felicissima unione matrimoniale.
A Ezio Starnini gli Auguri più sinceri del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta dove è ricordato accanto ai modelli del Rex e del Conte di Savoia dove lui .... c'era !
" VISSUTO D'EPOCA SUL CONTE DI SAVOIA"
DOPO OLTRE 80 ANNI SVELATO IL MISTERO DELLA FALLA NEL SUO VIAGGIO INAUGURALE.
Un giorno Ezio Starnini scrive una lettera al sottoscritto.
Chiavari, 17.11.2012
Carissimo Ernani, Mentre ti ringrazio per avermi menzionato durante l'interessante e riuscitissima manifestazione al Caffè Defilla sull'affondamento della ROMA, mi permetto passare dal fattore Marinaresco Militare a quello Mercantile, inviandoti, per la lettura, il racconto di un mio, "vissuto d'epoca" sul CONTE DI SAVOIA.
Ti saluto cordialmente.
Ezio Starnini

Starnini mentre contempla i modelli del REX e del CONTE DI SAVOIA conservati al Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari. In entrambi vi effettuò il viaggio inaugurale.
Nel Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, osservo interessato i modelli in scala di due grandi transatlantici: il REX e il CONTE DI SAVOIA. Noto in essi la perfetta riproduzione dei particolari: l'armamento, Ie verande, il sun-deck, gli arredi esterni nella loro stupenda minuziosità, gli ampi oblò a finestra del Ponte A ... il Salone Colonna! Ed eccomi, a novantasei anni, avulso dalla realtà e riprovare, con emozione crescente, un episodio nel mio "vissuto d'epoca": groom sedicenne, ascensorista a bordo del Conte di Savoia in rotta verso New York. Vengo svegliato a notte fonda dal Capitan d'Arme che, sbrigativo, con due marinai di coperta mi sloggia dal letto, mi allontana in malo modo e si appropria del materasso.
Al mio sbalordito e ritroso : "Ehi.., che fate?.,, Perche?", risponde brusco: "Una falla nella murata di babordo; imbarca acqua e bisogna tamponarla. Tu porta l'ascensore del Ponte A, su, al Salone Colonna. Stai pronto e zitto." Burbero come quando era entrato, seguendo i marinai con l'ingombro esce dalla cabina senz'altro aggiungere. Sconcentrato, mi domando perche proprio il mio materasso, e non ..... la risposta mi viene spontanea: occorre, subito, un ascensorista e un materasso? Eccoli pronti, l'uno e l'altro contemporaneamente; nel bisogno la praticità è preziosa! Mi vesto in fretta, mentre nel cervello in subbuglio i pensieri si accalcano: una falla? Quanto sotto: se imbarca ?... e in pieno Gulf Stream ! II silenzio delle macchine mi dice che la nave è ferma. Ragiono. Per niente impaurito, salgo agile per conosciute scale e corridoi, raggiungo presto l'ascensore del Ponte A e lo porto su, al Salone Colonna, meraviglia d'arte e vanto della Classe di lusso della nave.
Entro ed osservo stranito la scena nella luce abbassata del vasto locale, il Comandante Lena, il Primo Ufficiale e un Terzo, il capo allogi - mio diretto superiore - due garzoni di sala, sono sporti dalla finestre sulla murata, gli splendidi tendaggi arrotolati, poltrone dorate spinte altrove, il prezioso tappeto parzialmente ripiegato .... disordine.
Trovo spazio, mi sporgo sull'immensità buia e corro con gli occhi nella
luce incrociata di due fari puntati sulla murata, in basso, all'altezza del Ponte C in corrispondenza verticale con Ie finestre dove si trovano il Comandante e il Primo Ufficiale.
Dal portello aperto sul bagagliaio in quella precaria luminosità, esce
lento un tavolone grezzamente squadrato, col mio materasso inchiavardato: il tampone. legato a dei cavi, scorre in basso a piccoli strappi accompagnato dalla luce dei fari; scende giu fino al pelo dell'acqua: acqua per fortuna non molto agitata, ma sempre mare dell'Oceano Atlantico, nel pieno della corrente ascensionale del Golfo, non lontano dalla punta Nord del famigerato "triangolo delle Bermude". Nella chiazza di luce, calato con una robusta cima al petto, appare un uomo. Egli si agguanta al tampone, ad ampi gesti verso l'alto ne coordina la posizione, quindi, saldamente aggrappato al pesante aggeggio, affonda, scompare.
I fari battono il mare, ma la luce non mostra l'uomo faticare, privo del respiro, nell''opera viva della nave; non penetra I'agitata compattezza marina. Un paio di metri sotto il livello, in apnea, nell'acqua gelida e irrequieta, I'uomo farà una cosa straordinaria:
profittando del vorticare del gorgo, ma pure temendone la forza attrattiva, fara scorrere sul corpo grinzoso della nave, il grosso, riluttante e mobile "tampone sulla falla"; col residuo delle forze fisiche e del respiro, cercherà di sistemarlo al meglio sullo squarcio dai margini sghembi e taglienti, fra gli impeti del gorgo, quindi risalirà all'aria, stremato, ma conscio che nell'interno della nave, cessatoil pericoloso afflusso, la falla verrà chiusa, con travi e cemento a presa rapida mentre il tampone si staccherà portando il materassino galleggiante fra le correnti del Gulf Stream.
Teso quasi allo spasimo, fisso con gli occhi sbarrati la macchia di luce sul mare che copre I'uomo da troppo tempo: minuti, ma quanti? II tempo scorre lento e I'ansia .... Un improvviso rigurgito su quella superficie agitata, è il segno che la falla e finalmente otturata; ma il breve sollievo non sminuisce l'ansia: l'uomo ??.... Egli affiora nel
ribollio dell'acqua, la testa ..... respira; la corda al petto si tende ed egli è issato velocemente nel ventre della nave, giusto da dove ne era uscito per I'arduo compito.
II Comandante si erge lento, sul suo volto un sorriso fugace lascia il posto al consueto tono di fermezza; dalle labbra semiserrate, un "bravo" appena si ode.
Affiancato dal Primo Ufficiale sollecito e sorridente e da tutti seguito, s'avvia spedito all'uscita - che io ho appena oltrepassato - senza fermarsi, con voce chiara scandisce:
"Domattina, quassù deve essere tutto in perfetto ordine. Ora scendiamo nel bagagliaio del Ponte C. Stringero' la mano ad un mio eroico marinaio."
Di quell'uomo, del marinaio Gennaro Amatruda divenni amico allorchè, stringendogli anch'io la mano, ebbi modo di raccontargli Ie mie ansie. Modestamente, come semplice e modesto egli stesso era, sorridendo mi disse: "Embè... guagliò, quando c'e da fare si fa. Non te lo scordare". Ed io, come questo racconto verità lo dimostra, ancora ricordo.
Ezio Starnini
Nota: La perfetta corrispondenza dell'episodio raccontato da Starnini si trova su internet "su Wikipedia - Enciclopedia libera" - CONTE DI SAVOIA (TRANSATLANTICO).
Nei vari capitoli della sua storia ad un certo punto troviamo queste frasi.
CONTE DI SAVOIA (TRANSATLANTICO)
STORIA
Varato il 28 ottobre 1931 dalla principessa Maria José del Belgio, in seguito regina d'Italia, il Conte di Savoia fece il suo viaggio inaugurale da Genova a New York il 30 novembre 1932.
Il viaggio divenne quasi un disastro quando una valvola di sicurezza nella sala macchine esplose, squarciando lo scafo nell'opera viva. Per evitare l'affondamento un eroico e audace marinaio, Gennaro Amatruda di 45 anni si fece calare fuori bordo e tamponò la falla con travi e cemento a presa rapida in modo da poter arrivare a New York per provvedere in cantiere alle riparazioni.
Nota dell'Autore:
EZIO STARNINI ha descritto ciò che ha visto e ciò che lo riguardava, cioè la sottrazione del suo materasso che è servito, così si chiama in termine marinaresco da "PAGLIETTO TURAFALLE".
Naturalmente, per chi ha navigato o conosce le navi, può solo sorridere, quando si afferma che l'eroico marinaio GENNARO AMATRUDA, tamponò la falla con travi e cemento a presa rapida.
Sarebbe stato impossibile, da fuori bordo, immergersi nell'acqua dell'Oceano e tamponare la falla in quel modo.
Sicuramente le cose si svolsero così:
Il materasso di Starnini e le tavole, trasformate in un "Paglietto" di notevoli dimensioni furono calate "ESTERNAMENTE" allo scafo della nave in corrispondenza della falla.
In pratica si costruì un grande "PAGLIETTO" e il materasso era certamente legato con delle tavole e a sua volta, il tutto, era legato con delle cime per facilitarne la guida e la messa in posizione del "paglietto".
All'interno, in corrispondenza della falla quando l'acqua in entrata è stata quasi eliminata o notevolmente diminuita di intensità, si è provveduto a "TAMPONARE LA FALLA CON CEMENTO E TAVOLE". Al cemento, sicuramente sarà stato aggiunta della soda per accelerarne l'indurimento. Questa è stata la vera operazione credibile e completa altrimenti non può aver senso "infagottare" di cemento l'esterno dello scafo con "cemento e tavole". Con la successiva ripresa della navigazione a 25/27 nodi di velocità, sarebbe stato impossibile mantenere la riparazione se effettuata dall'esterno (come afferma Vikipedia) il che, era tecnicamente impossibile da eseguire.
E comunque per terminare citiamo il "Muzemal", che spiega che cosa è il "Paglietto Turafalle" di una volta.
A bordo dei vecchi bastimenti veniva preparato anche il paglietto turafalle. Questo era costituito da un pezzo di grossa tela olona lardata o da un fitto intreccio di filacce di vecchio cavo, che veniva anch'esso lardato. Ai quattro angoli del paglietto venivano assicurati dei lunghi cavi, che servivano a guidarlo e assicurarlo fuoribordo perché ostruisse una falla, riducendo notevolmente la quantità d'acqua imbarcata e consentendo l'intervento di riparazione dall'interno dello scafo. Il Muzemal.



Cristina Anastasi e Carlo Gatti sul palco di Lerici

Fine di Luglio del 2013 - Ciassa di Barchi o Piazza dei Pescatori. Ezio Starnini ha appena compiuto 97 anni. Eppure sta aiutando ad alzare il gran pavese ! Lascio a voi lettori ogni commento su questa straordinaria persona.
Ernani ANDREATTA
Rapallo, 20 Luglio 2015
LE BELLEZZE E LA STORIA DEL NOSTRO MARE
LE BELLEZZE E LA STORIA DEL NOSTRO MARE

In quel lontano periodo il sub Giancarlo Boaretto (a destra nella foto) si trovava impegnato nei fondali della nordica Tromsø (Norvegia)
Quando si parla di mare, che si sia stati dei naviganti, pescatori, sub dilettanti o professionisti, apneisti, insomma chi ha vissuto il mare sopra o sotto, si ricorda immediatamente le cose che hanno colpito e affascinato maggiormente come se fosse passato solo un giorno; anche se in realtà possono esser passati degli anni.
Quando si mette la testa sotto quel fluido bagnato e molto più denso dell’aria ci si rende conto che si è entrati nel regno di Nettuno; si ha la sensazione di volare in un altro mondo, una flora e una fauna inaspettata, un mondo inatteso e affascinante dove fino a una decina di metri sotto il livello del mare i colori di ciò che si guarda restano inalterati e iniziano a sfumare in tonalità che vanno dall’azzurro al blu a breve distanza da noi.
Ma attenzione, questo “regno” molto affascinante impone le sue regole e sono ferree; occorrono molte precauzioni, prudenza e conoscenze tecniche approfondite, seguite da uno stile di vita idoneo e soprattutto: va rispettato.
IL CORALLO


Nel Golfo del Tigullio una delle attività più antiche è stata la pesca del corallo e ne parlavano già nel II secolo d.C. e anche nel XIV secolo da Fazio degli Uberti, si utilizzavano le “coralline” barche a vela molto robuste con l’equipaggio composto da 6/8 persone.


Gozzo Ligure "corallino"
Per la pesca si utilizzava un marchingegno composto da due grandi legni incrociati e zavorrati al centro, ai vertici dei bracci che si formavano dall’incrocio dei legni venivano applicate delle reti di un paio di metri ciascuna, venivano fatte sprofondare sul fondale e poi trainate con l’aiuto del vento; le reti del marchingegno strisciando sul fondo incocciavano i rami di corallo e li stappavano tenendoli incastrati nelle maglie.
La tecnica di per sé funzionava, ma con l’andare degli anni , o meglio, dei secoli di razzia dai fondali del Tigullio il corallo è praticamente sparito; da li i “corallari” hanno dovuto spostarsi verso la Corsica, la Sardegna, fino alle coste della Tunisia e Algeria e famosa è l’isola di Tabarca che divenne il punto d’approdo dei pescatori di corallo.

I coralli rossi, tipici del Mediterraneo sono colonie di microscopici polpi che si nutrono di plancton allungando i tentacoli estroflettendoli dallo scheletro che è ricoperto da una sottile pellicina che quando è raschiata via scopre il colore rosso sangue della struttura vera e propria del corallo; questo ha una crescita lentissima, si parla di decine di anni per raggiungere l’altezza di un centimetro e perciò quello fotografato sul palmo della mano non dovrebbe aver vissuto meno di cinquant’anni.

Nello stemma di Santa Margherita Ligure è raffigurato un ramo di corallo e alcuni fortunati ne trovano ancora in qualche anfratto ma ad una profondità di almeno settanta metri, e si limitano ad osservare gli esemplari rimasti, qualche volta fotografandoli ma non dicendo mai dove li hanno trovati.
Giancarlo BOARETTO
Rapallo, Sabato 18 luglio 2015
LE AVVENTURE DI BENEDETTO DONATI
LE AVVENTURE DI BENEDETTO DONATI
“... Tutte le passioni tempestose dell'umanità quando era giovane, l'amore della rapina e l'amore della gloria, l'amore dell'avventura e l'amore del pericolo, insieme con il grande amore dell'ignoto e i vasti sogni di dominio e di potenza, sono passati come immagini riflesse in uno specchio, senza lasciare alcun segno sulla faccia misteriosa del mare. Impenetrabile e senza cuore, il mare non ha dato nulla di se stesso a coloro che ne hanno corteggiato i precari favori ...” - JOSEPH CONRAD

Benedetto Donati, (nelle foto) nato a S. Ambrogio di Zoagli e rapallese per il tempo che visse, nacque sugli scogli della Riviera di Levante nel 1916, durante la Prima guerra mondiale. Il mondo d’allora offriva solo doni di natura e fin da piccolo aveva l’unica visione del mondo che il Tigullio poteva offrirgli: una cornice di colline verdi che si chiudevano ad anfiteatro alle sue spalle. Ma al di là di quella cresta sinuosa per lui c’era il nulla. Si girava a guardarla soltanto quando neri nuvoloni carichi di pioggia salivano da scirocco per darle una lavata...
Il mare che aveva davanti agli occhi lo attraeva e lo ammaliava come il canto di una sirena. Benedetto era e si sentiva libero come un delfino che giocava con le onde sotto il tagliamare delle navi, nuotava veloce, volteggiava per aria e poi spariva per sfidare il mare aperto verso l’ignoto ad inseguire i suoi sogni oltre l’orizzonte. Figlio di una divinità marina irrazionale era dominato dall’istinto puro, da quella forza che sentiva dentro e che cercò invano di trattenere per tutta la vita.
Benedetto ignorava Conrad, ma il grande scrittore polacco conosceva bene questi rari figli del mare, duri ma generosi, ansiosi e romantici dal carattere talvolta aspro ma sincero. Spesso diceva a suo figlio Roberto, Comandante di navi, “per essere dei buoni marinai non serve essere letterati, ma umili e timorati del dio-mare, occorre piegarsi alle tempeste senza rinunciare alla propria dignità; indietreggiare o “puggiare” per poi avanzare, non significa vigliaccheria, ma saggezza”.
Benedetto cresceva in fretta. Abbronzato tutto l’anno, era diventato un bel ragazzo, alto e atletico. In inverno studiava aspettando l’estate. Le automobili straniere lo attraevano per la raffinata eleganza e le ragazze d’oltralpe per l’emancipazione senza ipocrisie. Si sentiva un “europeo” ante litteram. Amava usare alcune infallibili frasi in francese e inglese per scardinare quei cuori che lui sapeva conquistare con le canzoni italiane e gli scorci panoramici della Riviera. Cresceva ed imparava i trucchi dello “squalo del Tigullio”, amava ed era amato senza pregiudizi e senza frontiere.
Benedetto aveva i piedi per terra e sapeva fin da ragazzo come guadagnarsi da vivere. Aveva il mare “dentro”, molti sogni nel cassetto, ma anche un’autentica passione: i motori. Li smontava e li rimontava accuratamente ridandogli vita per sentirli rombare in tutta la loro potenza.
Era il suo pane, un pane duro che portò nello zaino durante il suo pellegrinaggio di uomo di mondo. L’officina era diventata il suo regno e ben presto cilindri, pistoni, cinghie e candele non ebbero più segreti per lui. La sua specialità erano i motori marini, sia quelli veloci dei motoscafi dei ricchi sia quelli dei pescherecci, più lenti nelle mani di quei poveri cristi che partivano di notte e dovevano sempre girare per poter tornare a casa quando la stiva era piena. A poco a poco si fece largo nel vortice della vita quotidiana ed il suo nome era sempre più richiesto sui moli della Riviera. Acquistava vecchi motori, li rigenerava e li rimontava su imbarcazioni per chi di meglio non poteva permettersi.
La sua storia personale sta per voltar pagina. A 20 anni compiuti é arruolato presso il C.R.E.M. di Spezia e 15 giorni dopo imbarca sulla R.Nave CAMPANIA per il corso M.A.

L’incrociatore leggero RN Campania in movimento
Il 15 Luglio 1937 viene trasferito a Pola per imbarcare sul Ct. “QUINTINO SELLA” ed é inviato a Portolago in Egeo. Visti i suoi requisiti di valente meccanico, viene promosso Motorista A. Scelto.

Il Quintino Sella fotografato all’ancora negli anni ‘30
Il 5 marzo 1938 Benedetto sbarca a Brindisi e lo stesso giorno viene trasferito alla “Difesa” – Brindisi, Comando Militare Marittimo "Brindisi" (Brindisi) - 5^ Legione Milizia Artiglieria Marittima Territoriale (Bari) - Il 20 marzo 1938 viene trasferito all’Ufficio Circondariale di Molfetta. Il 2 maggio 1938 viene trasferito al Compamare di Bari, dove l’1 ottobre viene promosso Sottocapo M.A.
A Bari, storica e importante città portuale del basso Adriatico, Benedetto conosce Apollonia. Un colpo di fulmine, complici l’ansia e la paura di perdersi nei venti di guerra, decidono di sposarsi. Il loro primo frutto si chiama Roberto che nasce il 22 aprile 1942.
In seguito ai bombardamenti del 17.11.1940 Benedetto Donati viene decorato con la Croce di Guerra al V.M. su Azione di Guerra.
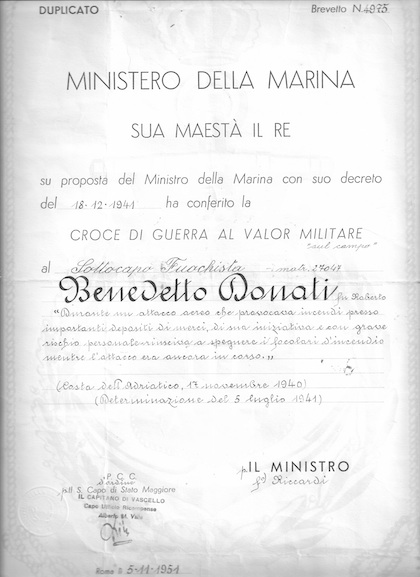
Tuttavia, per un puro gioco del destino, Benedetto si ritrovò come “prigioniero di guerra” degli inglesi anche durante il secondo, ancor più disastroso, bombardamento di Bari il 2 dicembre 1943.
A questo punto della storia inseriamo la rievocazione del “BOMBARDAMENTO DI BARI” curato dallo storico Francesco Bucca. La lettura del brano ci dà la reale consapevolezza sia dell’immane tragedia che costò migliaia tra morti e feriti per opera di bombe molto particolari, sia per comprendere lo strascico che tali esalazioni ebbero in seguito sul fisico di tanti innocenti, tra cui Benedetto.
UN PO' DI STORIA
A cura di Francesco BUCCA
BOMBARDAMENTO DI BARI : 2 Dicembre 1943
Il bombardamento del porto di Bari avvenne il 2 Dicembre 1943, a circa 3 mesi dalla resa dell’Italia agli Alleati (8 Settembre 1943) e poco tempo dopo la successiva dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania (13 Ottobre 1943).
Per le sue conseguenze e il numero delle navi alleate affondate da parte dei bombardieri tedeschi fu il maggior incidente di guerra chimica avvenuto durante la II Guerra Mondiale e fu soprannominato a ragione la “Pearl Habour del Mediterraneo” o “seconda Pearl Harbour”, in quanto, a fronte della perdita di solamente 2 bombardieri tedeschi, complessivamente 17 navi da carico alleate con più di 38.000 tonnellate di merci furono affondate e altre 8 seriamente danneggiate e il porto di Bari rimase chiuso per 3 settimane a causa dei relitti , ritardando non poco l’offensiva degli Alleati verso il Centro Italia a causa della mancanza di rifornimenti e consentendo ai tedeschi di attestarsi lungo la linea Gustav.
Il porto di Bari fu ripristinato alla piena operatività soltanto nel Febbraio 1944.
In effetti fu l’attacco aereo più distruttivo subito dagli Alleati dopo quello giapponese del 7 Dicembre 1941.
Ciò senza citare i gravissimi danni derivati alla città dai bombardamenti in se e soprattutto dallo scoppio delle bombe all’iprite trasportate dalla nave da carico americana tipo Liberty JOHN HARVEY (2000 bombe tipo M 47 per 91 tonnellate) e relativa fuoriuscita di sostanze tossiche, che causarono più di 1000 vittime tra militari e civili .
Il 2 Dicembre più di 40 navi da carico battenti bandiera americana, inglese, polacca, norvegese, olandese e italiana si trovavano nel porto di Bari.
Il porto di Bari era stato intenzionalmente risparmiato dai bombardamenti americani in quanto considerato strategico ai fini dell’approvvigionamento dei rifornimenti per le armate alleate che avrebbero dovuto risalire l’Italia e minacciare i confini meridionali della Germania ed a Bari erano tra l’altro anche stati creati diversi ospedali per la cura dei feriti al fronte.
Nella notte del 2 Dicembre il porto di Bari era completamente illuminato e stava lavorando a piena capacità per accelerare lo scarico dei rifornimenti destinati ad alimentare il fronte.
Gli Alleati infatti non si attendevano un attacco aereo e non nutrivano alcun dubbio sulla sicurezza del porto, tanto che l’avvistamento nei giorni precedenti di ricognitori tedeschi, il bombardamento di Napoli di fine Novembre e quello successivo di Manfredonia non avevano suggerito alcun provvedimento, neppure quello di decidere l’oscuramento delle luci del porto e di almeno una parte delle luci della città contigua al porto stesso.
Lo stesso 2 Dicembre era appena arrivato un convoglio proveniente dal Nord Africa e dagli Stati Uniti, senza però che esistesse la possibilità di scaricare le navi se non dopo molti giorni di attesa.

La nave tipo Liberty John Harvey
Tra le unità in porto, vi era anche, come detto, la Liberty americana JOHN HARVEY al comando del capitano Elwin Knowles, che trasportava segretissimamente 2000 bombe all’iprite, oltre ad altro materiale esplosivo, principalmente bombe d’aereo destinate alla 15.ma Air Force statunitense stanziata a Manfredonia incaricata dei bombardamenti strategici sulla Germania del sud, ed era attraccata vicino all’estremità del molo di Levante del porto.
Era arrivata il 28 Novembre e attendeva da 5 giorni di essere scaricata del suo pericolosissimo contenuto, che non era stata rapidamente sbarcato anche a causa della sua segretezza, che aveva rallentato il passaggio delle informazioni tra il comandante statunitense e le autorità portuali inglesi.

Bari - Bombe all’IPRITE recuperate
L’iprite, detto anche “gas mostarda”, era stata ampiamente utilizzata durante la Prima GM sul fronte francese e poi bandita dal trattato di Versailles del 1922, era stata trasportata solamente per essere utilizzata come atto di ritorsione ad un eventuale attacco chimico da parte tedesca alle forze alleate e in ultima analisi come deterrente. Fonti di intelligence alleate, infatti, sin dal Luglio 1943 avevano iniziato a inviare rapporti sul suo possibile uso da parte tedesca ed in effetti depositi di armi chimiche furono successivamente ritrovati in Italia.
L’iprite ancora, comunemente denominata gas, è un agente chimico vescicante con forte odore che ricorda l’aglio e si presenta allo stato liquido e non gassoso e costituisce un aggressivo chimico che può essere nebulizzato. Il termine gas è quindi improprio e il suo uso costituisce una concessione al linguaggio comune. Inoltre l’iprite è un liquido oleoso con effetto quindi più persistente rispetto agli aggressivi chimici aeriformi come ad es. il fosgene.
L’iprite risulta dunque molto pericolosa ad essere trattata e gassifica facilmente in quantità tali da produrre pericolosissimi aumenti di pressione nei contenitori delle bombe in cui viene conservata.
La sua conservazione e trattamento è quindi estremamente delicata.
Al tempo della Seconda GM, le bombe erano lunghe poco più di 1,2 metri, con un diametro di 20 cm e contenevano da 30 a 32 kg di iprite, sufficienti a contaminare un’area di 40 m. di diametro.
L’attacco aereo tedesco fu fissato per i primi giorni di Dicembre in quanto la luna crescente avrebbe consentito una sufficiente visibilità ai piloti, ma reso meno individuabili gli aeroplani.
Il giorno propizio si verificò il 2 Dicembre, quando un ricognitore Messerschmitt Me 210 tedesco, volando ad alta quota fotografò nel porto di Bari oltre 40 navi ancorate, molte facenti parte del convoglio appena arrivato.
Fu quindi immediatamente presa la decisione di attaccare.
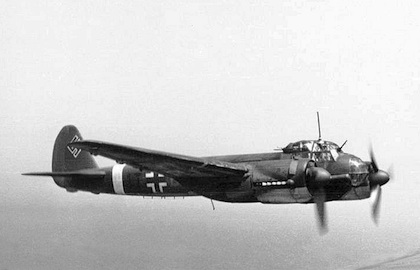
Junker Ju 88
Al comandi del generale Wolfram von Richthfen, parteciparono all’attacco 105 velivoli, per lo più Junkers Ju 88, provenienti dagli aeroporti del Nord Italia e anche dalla Jugoslavia e Grecia.
Erano tutti armati con motobombe FFF ( dall’iniziale dei cognomi dei progettisti italiani tenente colonnello Prospero Ferri, capo disegnatore Filpa e colonnello Amedeo Fiore ), che costituivano una variante del siluro elettrico, ovvero una volta lanciate da quote comprese tra 500 e 4000 m., un paracadute ne frenava la caduta fino all’impatto con l’acqua, poi spinte da un motore elettrico iniziavano a navigare con una traiettoria a spirale a circa 12 nodi fino all’impatto con il bersaglio o al termine dell’autonomia , che era di circa 30 min.
Gli aerei volarono a bassissima quota per non essere intercettati dal radar alleato (che comunque quella notte era fuori servizio).
17 aerei per motivi tecnici dovettero abbandonare la missione, per cui solamente 88 aerei parteciparono all’azione.
Alle 19,30 iniziò il massiccio bombardamento. L’attacco fu una completa sorpresa e ciò fece si che il bombardamento potesse avvenire con grande precisione.
Seguono alcune immagini del Bombardamento di Bari



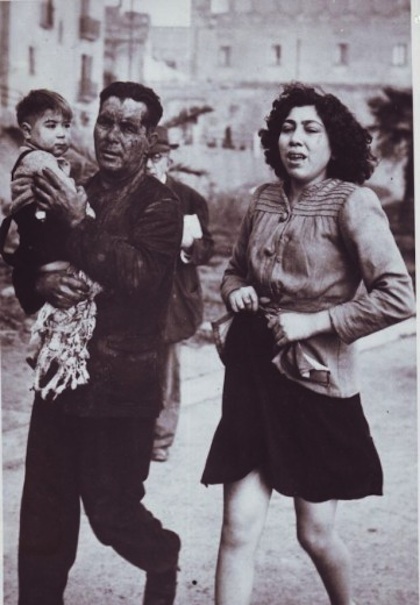
Le bombe caddero sulle navi, che affondarono rapidamente ormeggiate alla banchina, mentre quelle che trasportavano munizioni saltarono in aria, provocando danni ingentissimi. Si incendiarono pure le condutture di benzina sulle banchine, rendendo le acque del porto un mare di fiamme che distruggeva anche le altre navi non danneggiate.
Fu colpita anche la JOHN HARVEY con le sue 91 ton. di bombe all’iprite. Molte esplosero direttamente sul posto, mentre altre furono scagliate lontano in modo tale che il loro contenuto tossico venne disseminato per largo raggio.
Inizialmente il vento soffiava in direzione opposta alla città, in modo tale da agevolare la popolazione, ma successivamente cambiò direzione e i fumi tossici investirono direttamente gli abitanti e i militari.
Poiché il carico di iprite era segretissimo, nessuno ne conosceva l’esistenza e quindi anche i medici degli ospedali a cui man mano affluivano i feriti (solo i militari, in quanto i civili erano rimandati indietro per mancanza di posto), non essendone al corrente, non furono in grado di istituire subito terapie idonee , diagnosticando spesso congiuntiviti o dermatiti.
Solo dopo 3 giorni, quando la presenza dell’iprite fu scoperta, anche se non formalmente resa pubblica, pur con grandissimo riserbo, i feriti iniziarono ad essere trattati adeguatamente con terapia a base di sulfamidici.
Quando la nave scoppiò, inizialmente il vento allontanò verso il largo la nube tossica generata dalle esplosioni. Ciò comunque non impedì all’iprite di disperdersi come miscela oleosa nelle acque del porto, contaminando gli indumenti dei marinai e portuali scampati alle esplosioni e che si trovavano in acqua e che la inalarono inavvertitamente, come pure fecero i soccorritori che si adoperavano per trarre in salvo i superstiti. Le prime conseguenze visibili furono bruciore agli occhi, narici e gola, parziale cecità e vesciche sulla pelle con successivi distacchi di pelle.
In totale si stima che le vittime tra civili e militari furono circa un migliaio. Di questi circa 250 furono i civili baresi. Vi furono oltre 800 militari ricoverati con ustioni o ferite. Gli intossicati all’iprite furono 617.
Va osservato che nel successivo rapporto redatto dal colonnello Alexander della Sanità militare americana inviato sul posto, datato 27 Dicembre 1943, le ustioni riscontrate, per ragioni di segretezza, furono subito classificate per causa Not Yet Diagnosed.
Sembra sia stato lo stesso Churchill a disporre che non si facesse cenno all’iprite nei documenti che riguardavano il disastro di Bari in quanto il porto era controllato dagli inglesi e non si voleva ammettere un simile disastro.
Solo molti anni dopo la fine del conflitto i governi inglese e americano ammisero ufficialmente la presenza dell’iprite.
Infatti i documenti riguardanti l’attacco furono declassificati solamente nel 1959.
Ancora molti decenni seguenti all’attacco furono numerosi i casi di contaminazione di pescatori baresi a causa degli ordigni di iprite inesplosi che, ormai corrosi, rilasciavano il loro contenuto.
Tuttavia negli ultimi anni tali episodi sono completamente spariti.
Va infine citato che la città pugliese fu nuovamente colpita negli ultimi giorni della guerra. Il 9 Aprile 1945, infatti, un’altra nave americana, la CHARLES HENDERSON, esplose accidentalmente mentre stava scaricando un forte quantitativo di armi chimiche, uccidendo ancora militari e civili e danneggiando gravemente le attrezzature portuali della città.
I lavori di bonifica del porto iniziarono nel Marzo 1947 e si protrassero per diversi anni, potando al rinvenimento, oltre al resto, di 2302 bombe d’aereo (più 3714 recuperate dalla CHARLES HENDERSON), 98 bombe all’iprite (94 a Bari, 2 a Barletta, 1 a Trani e 1 a Molfetta) e 157 bombette ad aggressivi chimici, ugualmente pericolose.
Durante i lavori di bonifica, il 30 Maggio 1947, si verificò addirittura lo scoppio accidentale di una bomba all’iprite di grande capacità e fu possibile evitare gravi incidenti alla popolazione e danni alla città vecchia grazie al prontissimo intervento di tutti gli operatori civili e militari, che si prodigarono con slancio, riportando personalmente gravissime lesioni da iprite.
Tutte le armi chimiche recuperate vennero di nuovo buttate a mare al largo di Bari, in fondali molto profondi dove attualmente è vietata la pesca a strascico. Ciò nella convinzione che gli aggressivi chimici sarebbero rapidamente diventati innocui, il che però, a detta delle Associazioni ambientali, è ancora tutta da verificare.Il bilancio totale delle perdite navali è evidenziato nel riquadro 1.Riassumendo furono affondate 6 navi trasporto americane tipo Liberty, 4 unità inglesi, 2 norvegesi, 3 italiane e 2 polacche per un totale di 17 unità. Altre 8 furono seriamente danneggiate, mentre un‘altra decina di unità minori (unità di uso locale, piccoli traghetti, etc) risultarono anch’esse affondate. FINE
Benedetto DONATI cambia destinazione
1 febbraio 1942 Benedetto viene trasferito al Comando Fotoelettriche di Pantelleria e vi rimane sino alla resa dell’isola.
1942 - PANTELLERIA ISOLA DI COMANDO R. MARINA

Veduta parziale isola (Foto dell'Isola prese nel 1936-Public Record Office, Londra ADM/239/463)

Isola di Pantelleria - Benedetto (a destra) appostato con un commilitone sull'AEROFONO

Benedetto amava la musica

... e pensava alla sua Riviera

... magari avesse avuto una Benelli a Rapallo
Comando Marina "Pantelleria" - 9^ Legione Milizia Artiglieria Marittima Territoriale - 13 batterie controaeree da 76/40 - 1 batteria controaerea da 76/40 (Lampedusa) - 22 mitragliatrici da 13,2 - 2 fotoelettriche di tipo moderno - 5 fotoelettriche di tipo antiquato.
Nel 1943, durante la II Guerra Mondiale, la conquista di Pantelleria fu ritenuta d’importanza strategica dalla Truppe Alleate che si preparavano ad invadere la Sicilia, tanto che l'isola fu pesantemente bombardata dal mare e dal cielo, per preparare lo sbarco delle truppe, nell'ambito di un'operazione anfibia chiamata Operazione Corkscrew. L’attacco venne sotto forma di incessanti attacchi aerei ed era già incominciato l’8 maggio. Secondo le intenzioni italiane l’isola doveva essere la nostra Malta, ma l’entrata in guerra ritardò le strutture difensive dell’isola e spesso fermò i lavori. Le principali strutture consistevano in un aeroporto in caverna, da dove però potevano operare aerei da caccia. Le batterie antiaeree erano 14 con 75 cannoni antiquati da 76 mm - 18 mitragliere da 20 mm - 500 quasi inutili mitragliatrici da 8 mm. Le batterie antinave erano 5 con 12 pezzi da 152 mm - 8 da 120 mm. I militari di stanza nell’isola erano 11.420. Le scorte di viveri erano sufficienti per 50 giorni. Sull’isola c’erano 3 radiolocalizzatori di scoperta aerea e 1 di scoperta navale germanici, ma verso la fine di maggio il personale li smontò e abbandonò con essi l’isola. Dall’8 giugno, alla pressione aerea si aggiunsero i bombardamenti navali con 4-6 incrociatori e 8 caccia. Il 10 giugno fu raggiunto il massimo della violenza: 44 attacchi aerei da parte di 1.040 velivoli anglo-americani, 1400 ton. di bombe rovesciate sull’isola. Lo stesso giorno gli alleati intimarono la resa, il Comando Italiano non dette risposta e in serata a, reparti della prima Div. Britannica di fanteria s’imbarcarono (a Susa e Sfax-Tunisia) su 3 navi da trasporto truppe, 15 mezzi LCI, 19 LCT, 4 mezzi da sbarco d’appoggio LCF, 5 vedette ML. In quelle stesse ore, considerata la situazione, il comando dell’isola affidato all’Amm. Pavesi, chiese a Roma l’autorizzazione ad arrendersi.

L'Aeroporto di Pantelleria

Hangar di Pantelleria

Soldati Inglesi occupano l'Isola di Pantelleria
Cronologia degli avvenimenti che hanno coinvolto Benedetto Donati: 10 giugno 1943 Catturato e fatto prigioniero dagli inglesi. 14 giugno 1943 Trasferito a Souse (Tunisia). 5 luglio 1943 Trasferito in un Campo di Concentramento provvisorio a Tunisi. 3 settembre 1943 Trasferito in un Campo di Concentramento provvisorio presso Algeri in attesa d’essere imbarcato per gli Stati Uniti. 7 settembre 1943 Imbarca su una nave alleata. 10 settembre 1943 Sbarca ad Orano (Algeria) in seguito all’Armistizio.11 settembre 1943 Viene riportato in un Campo di Concentramento (gabbia n.7) presso Orano (Algeria). 20 ottobre 1943 E’ destinato al Campo Lavoratori Portuali come ecoperatore. Come abbiamo già visto, il sottocapo fuochista Benedetto Donati, vantava una specializzazione di meccanico navale di cui gli inglesi ben presto si accorsero. Gli Alleati nel frattempo erano sbarcati in Sicilia e risalendo la penisola, occuparono i punti nevralgici e vi stabilirono delle teste di ponte. Gli inglesi s’impossessarono del porto di Bari e, proprio in questo porto strategico per lo sbarco della logistica USA, inviarono un contingente specializzato di P.O.W (Prisoners of war), tra cui Benedetto, per essere utilizzato nel suo ruolo di meccanico in assistenza alle numerose navi da carico militarizzate che giungevano con molte avarie e, soprattutto, con le stive cariche di armi di ogni tipo. Benedetto ne fu felicissimo perché durante quell’insperata missione avrebbe rivisto sua moglie ed il piccolo Roberto nato da pochi mesi. Tutto sembrò andare per il verso giusto, almeno fino al momento del secondo tragico bombardamento di Bari da parte della Luftwaffe il 2 dicembre 1943 che già vi é stato raccontato.
10 gennaio 1944 Benedetto Donati viene liberato dalla prigionia e imbarca sulla cisterna “Posa Rica” al servizio degli americani.
10 marzo 1945 Benedetto viene rimpatriato.
INTERVISTA al figlio maggiore di Benedetto, Com.te Roberto Donati.
I suoi genitori hanno avuto la soddisfazione di mettere al mondo due figli che hanno raggiunto il massimo livello nelle loro rispettive professioni:
Roberto, Capitano di L.C. - Comandante e Capo Pilota del Porto di Augusta
Michele, Avvocato e Generale di Divisione della Guardia di Finanza.
Mio padre avrebbe meritato questa soddisfazione, se non altro per averci indicato, con il suo esempio e i tanti sacrifici, la GIUSTA ROTTA da seguire nella nostra vita.
Mia madre, pur essendo mancata a soli settantacinque anni, riuscì a vedere i suoi figli degnamente sistemati.
Questo saggio è dedicato a suo padre, ultimo nato di undici figli, durante la Grande Guerra. Benedetto fu terribilmente coinvolto, da militare, nella Seconda guerra mondiale.
I bombardamenti di Bari gli furono sicuramente fatali sia per i fumi tossici inalati durante il primo bombardamento per cui fu anche decorato, sia per le esalazioni di gas-Yprite del secondo bombardamento che respirò durante la fase di recupero dei naufraghi nel bacino portuale di Bari per ordine degli inglesi. In queste due tragiche circostanze i suoi polmoni ne furono talmente indeboliti da costargli la vita quando aveva soltanto 47 anni.
Cosa le raccontò di quei tragici avvenimenti?
Mio padre era un simpatico ottimista, socievole, disponibile e caratterialmente molto aperto, ma anche molto determinato e coraggioso, tuttavia, ogni volta che si affrontava l’argomento “guerra”, abbassava la testa e si chiudeva in uno sconcertante silenzio. Evidentemente il film da lui vissuto come attore, era ancora troppo impregnato di ricordi e sofferenze personali che gli bruciavano dentro senza riuscire a esorcizzarli come riusciva, al contrario, con tutti gli altri eventi negativi cui in successione dovette far fronte nella vita.
Gli effetti di quei gas nocivi, fumi e nubi tossiche sparsi a pioggia su Bari nei due bombardamenti, prima di vederli su se stesso a distanza di anni, li vide sulla pelle di quelle migliaia di morti e feriti che vide galleggiare inerti nel porto di Bari e che aiutò a recuperare con le sue stesse mani. Mio padre visse quei tragici momenti come un incubo ricorrente per tutta la sua vita. Capisco quindi il motivo per cui evitava di parlarcene.
A Pantelleria Benedetto fu fatto prigioniero dagli inglesi. Cosa vi raccontò di quel periodo?
Su questo argomento ci raccontò alcuni aneddoti, ne ricordo uno in particolare. I prigionieri italiani erano trattati molto male: scarsissimo nutrimento, condizioni igieniche pessime, punizioni crudeli e disumane.
La fame costringeva i prigionieri italiani a rubare qualsiasi cosa sembrasse commestibile. Un giorno, mi raccontò, un prigioniero del reparto s’impossessò di un barattolo di burro di arachidi, ma fu scoperto e il comando del campo lo costrinse a ingerire tutto il contenuto fino alla nausea, al vomito, alla diarrea.
Mio padre fu molto deluso dagli inglesi perché a Rapallo, in Riviera, li aveva conosciuti come dei veri “gentlemen”. E’ proprio vero che la guerra trasforma e imbruttisce gli uomini.
Anche in America Benedetto Donati andò incontro a delle vicissitudini. Può farcene un cenno?
Dopo l’armistizio e alcuni trasferimenti con l’incarico di P.O.W dalla Tunisia a Orano in Algeria, il 10/01/1944 fu liberato dalla prigionia e imbarcato con la qualifica di motorista sulla petroliera “Posa Rica” nave militarizzata al servizio degli Alleati.
Dopo alcuni viaggi per gli Stati Uniti, mio padre, come tanti italiani che scalavano saltuariamente i porti della mitica America, pensò di trasferirsi in quella terra per poi richiamare la famiglia. Questo era il suo sogno nel cassetto: un sogno che non prevedeva l’importanza del capire la lingua "americana", né le conseguenze della “diserzione” in una terra ospitale e generosa, ma governata dell’US IMMIGRATION SERVICE che applicava leggi severe che lui neppure poteva interpretare.
Naturalmente, appena scoperto, fu rimpatriato in Italia mettendo così la parola FINE a quelle agognate aspettative per una nuova vita con la sua famiglia e con l’incognita della malattia che già sentiva avanzare in maniera subdola per via dei progressivi limiti respiratori.
Tuttavia, mio padre ricordava sempre con piacere il periodo passato a bordo di quella Petroliera USA di cui esaltava la qualità della vita e la mentalità aperta e sincera degli americani, che nulla aveva in comune con quella degli inglesi subita in prigionia.
Raccontava delle comodità di bordo: acqua corrente, frigoriferi, abbondanza di cibo, la pulizia, l’igiene e persino gli innumerevoli svaghi di bordo.
Ricordo sempre la sua ostinata raccomandazione: studiate l’inglese!
Che ricordo ha di suo padre nel dopoguerra?
Il 10 marzo 1943 rimpatriò in Italia, ma di guerre e campi di prigionia ne aveva fin sopra i capelli. Non solo non si schierò, ma dovette iniziare a curarsi dalle conseguenze subite nei campi di prigionia che cominciavano a insidiargli i polmoni. Per alcuni anni dovette curarsi nei sanatori regionali, prima a Bari e poi a Genova ottenendo il riconoscimento di una pensione come Grande Invalido di Guerra. Tornato in Liguria nel 1953, riprese i contatti con gli amici di sempre e nonostante la sua invalidità, per supplire alla misera pensione di guerra, riprese a lavorare come meccanico per la manutenzione dei motori marini in ricovero durante l’inverno, e nei mesi estivi, per un breve periodo, fece il conduttore motorista per la scuola di sci nautico di Hans Nobel, noto campione olimpico di sci invernale, divenuto istruttore di sci nautico presso il Grand Hotel Excelsior di Rapallo. Fu quello il periodo più gratificante per mio padre, sia per l’ambiente che frequentava la Scuola di sci nautico (noti attori, attrici, scrittori ecc.) sia per la considerazione professionale in cui era tenuto.
Anche per me fu un periodo che ricordo con piacere, infatti, lavorando con Lui imparai a guidare i motoscafi della scuola ottenendo, in seguito, il patentino nautico che mi permise di sostituirlo negli anni successivi. Purtroppo le sue condizioni di salute si aggravarono, tanto da essere necessario il suo ultimo ricovero. Fece ancora in tempo ad aiutarmi nella ricerca del mio primo imbarco da allievo nautico di coperta e a vedermi, un anno dopo per l’ultima volta, in ospedale, prima di ripartire da Genova con l’avanzamento ottenuto a 3° Uff.le di coperta. Mio padre mancò il 18 gennaio del 1963 a 46 anni, durante la mia partenza da Genova per il Golfo Persico. Morì serenamente circondato da tutte le persone che lo avevano amato e apprezzato in vita.
ALBUM FOTOGRAFICO
BENEDETTO DONATI




BOMBARDAMENTO BARI (sotto)





PANTELLERIA (sotto)

Militari italiani prigionieri degli inglesi

Carlo GATTI : LA AVVENTURE DI BENEDETTO DONATI
Francesco BUCCA: IL BOMBARDAMENTO DI BARI
Rapallo, Martedì 23 Giugno 2015
RICORDO DI MARCO LOCCI, PITTORE DI MARINA
RICORDO DI MARCO LOCCI
PITTORE DI MARINA

Il 5 maggio 2015 é mancato Marco Locci, grande pittore di marina, amico di molti soci di MARE NOSTRUM RAPALLO, con cui ha collaborato per quasi vent’anni con mostre personali, sempre dedicate alle navi. In questi anni Marco aveva superato momenti difficili a causa della salute un po' ballerina, ma anche quest'anno, come faceva da sempre in questo periodo, ha invitato tutti i suoi amici a S.Massimo per una giornata di ricordi e cibo del suo orto. Marco era una "persona speciale" in tutto ciò che faceva: viveva e lavorava da artista. Aveva le sue regole e per chi non lo conosceva a volte sembrava scomodo e scorbutico, ma era soltanto Marco Locci, un uomo che non sapeva nuotare, ma era un autentico uomo di mare. Parlava di qualsiasi nave del passato e del presente come se ne fosse stato il capitano oppure il nostromo. Aveva un profondo rispetto per le navi e le trattava come persone, con la loro personalità e fisionomia. Donava loro il fascino che si erano meritate in mare e le arricchiva di quella atmosfera fumosa tipica dei porti molto trafficati che lui non aveva mai visto, ma che aveva immaginato da grande lettore e cultore di letteratura e storia marinara. Marco ha illustrato molti libri e ha anche vagato in spazi "non navali" (il mondo dei Patanchi) per poi ritornare sempre al suo vecchio amore "marinaro".
Marco lascerà un vuoto artistico-culturale non solo a Rapallo e in Italia, ma per un ampio raggio che si estende da Dubai a New York dove per anni ha spedito quadri per Mostre a lui dedicate. L'ultima fu quella dedicata ai festeggiamenti del REX del 2013.
Forse qualcuno l’ha detto prima di me, non lo so, ma ci sono persone che mancano più da morte che da vive! Marco appartiene a questo ristretta categoria, ma questo concetto merita forse un chiarimento: fino a poco tempo fa lo immaginavo ritirato nel suo laboratorio ed ero sicuro che fosse lì. Oggi mi manca perché la mia immaginazione é bloccata tra il sapere che se n’é andato per sempre e la delusione che provo nel guardare i suoi quadri che oggi sono velati di tristezza, come se avessero perso significato e persino l’autore. Ma non é così! Marco continuerà a vivere in noi con le sue opere, a navigare con noi, ad approdare in porti fumosi d’oltreoceano in cui il suo spirito si esaltava nel ricordare, a suo modo, i capitoli dell’emigrazione dei nostri avi e la grande evoluzione tecnica navale di cui amava soprattutto l’architettura.
Mi piace ricordare Marco chino a disegnare il suo porto di Genova, trafficato di bettoline, bunkerine, rimorchiatori e pilotine, un mondo tramontato con le sue cornici di navi passeggeri ormeggiate ai piedi delle colline verdi battute dalla tramontana. Ricordo in particolare il periodo in cui Marco amava disegnare con lo sfondo musicale di Andreas Wollenweider. Erano i tempi in cui rifuggiva il mondo e lo guardava dal suo “rifugio” di Sallutio in Toscana.
Marco, pur essendo ben piantato con i piedi per terra, amava veramente la natura, e la viveva nel suo modo “fantastico” da artista vero: navi che navigavano ed altre che volavano, personaggi inventati come i Patanchi e carrette piene di ruggine che esprimevano viaggi duri e sofferenti. Marco poteva essere anche uno scrittore, un poeta oppure un artista in un campo qualsiasi dell'arte.
Marco arrivò alla tesi di architettura rinunciando alla laurea per inseguire i suoi sogni. Ebbe un coraggio enorme! Fece il corniciaio per molti anni e dipingeva navi per passione. Quando fece la prima “esplosiva esposizione" continuò il suo lavoro con la modestia di sempre e, solo dopo una decina di anni divenne (soltanto) pittore di marina, come se altri l'avessero spinto in quella direzione. Marco non era credente ma amava il mondo, consapevole che solo un Supremo Pittore e Architetto (Dio) poteva concepirlo. Sicuramente non era credente verso tutto ciò che fu costruito ABUSIVAMENTE intorno alla Chiesa. Quel rifiuto così ostinato lo ebbe anche verso la società, la politica ed il deterioramento dei rapporti umani inficiati dal materialismo, egoismo e bassezza d'animo in generale. Marco amava la pittura, la musica e i buoni libri. La musica era l'aria che respirava e la sua casa era impregnata di magia. Cuoco eccezionale, conosceva i segreti più intimi della terra e dei suoi frutti. Amava la buona cucina e i vini genuini, ma era l'arte di proporre i suoi piatti e la condivisione con i pochi Amici a dare sacralità agli incontri.
Carlo Gatti
Seguono alcune e-mail dei soci di Mare Nostrum - Rapallo
- Carissimi Amici di Mare Nostrum Rapallo,
Ho appreso stamattina della triste notizia di cui ci ha reso partecipi Carlo e, conoscendo Marco Locci da molti anni, sono davvero dispiaciuto e rattristato.
Non avevamo avuto molte occasioni d'incontro, ma sapere che lui "c'era" (e tantissime volte è stato presente in maniera fattiva nell'organizzazione di "Mare Nostrum") era sicuramente un elemento positivo e rassicurante.
Inoltre, alcuni anni fa, gli avevo commissionato due quadri di navi a me molto care, che aveva dipinto con le sue consuete maestria e precisione, per non parlare di quel "tocco d'artista" unico e irripetibile che continuerà sempre a vivere in tutte le sue opere che abbiamo apprezzato e continueremo ad apprezzare.
Ricordo in particolare quando, nell'ormai lontano 1998, andai a San Massimo per dargli alcune indicazioni per il primo di questi quadri, e rimasi estasiato delle numerose opere terminate o in lavorazione presenti un po' dappertutto nella sua casa.
Come tutti gli artisti di vaglia, Marco Locci continuerà vivere nelle sue opere, e noi - suoi amici "navali" - conserveremo di lui un ricordo che è difficile descrivere a parole.
Grazie, Marco, per quanto di artistico - e di umano - ci hai saputo donare.
Dott. Maurizio Brescia
- Carissimi Carlo ed Amici di Mare Nostrum, la scomparsa di un Artista è come la Luce intermittente di un Faro: indispensabile per guidare la navigazione nelle tenebre. Sentite condoglianze ai Famigliari di Marco Locci da parte di
Comandante Nunzio Catena e Prof. Gabriele Moro
Cari Amici,
- Non ho avuto il piacere di conoscere il povero Marco, ma da come ne parla Carlo, era veramente una “persona speciale”.
Mi sento di porgere alla famiglia le mie sentite condoglianze.
Cari saluti,
Comandante Mario Terenzio Palombo
Caro Carlo,
- Ho appreso con grande tristezza la notizia che ci hai comunicato.
Certamente tu sei la persona che più di tutti noi lo ha conosciuto, frequentato e apprezzato come uomo e artista.
Per questo ti sono vicino e mi dispiace non essere presente per l'ultimo saluto a Marco, che certamente ricorderemo ogni volta che vedremo le sue opere.
Con affetto,
Comandante Roberto Donati e Proff.ssa Aurelita Persi
** Si uniscono a noi nel ricordare Marco: Pino e Gunilla Lebano che erano AMICI molto stretti di Marco e naturalmente John, Manuela, Scipione, Hanna-Karen, Romina, Ettore e tutti gli undici nipoti.
Il contributo di Ernani Andreatta
- Partecipo come tutti al dolore della famiglia per la scomparsa di Marco Locci che ho conosciuto poco ma apprezzato molto. In suo ricordo invio un suo quadro che mi dipinse e che riguardava il varo nel lontano 1906 del Brigantino
Goletta CARLO nel mare degli Scogli a Chiavari. Lo stesso veliero è anche nella foto preso dal Libro Chiavari Marinara.
Non solo, nel 2013 Amedeo Devoto rappresentò i velieri CARLO e il GIGINO mentre salvavano migliaia di "emigranti illegali" salvati dallo sterminio nazista. Questi due grandi artisti: Marco Locci e Amedeo Devoto pertanto sono uniti da un veliero storicamente importante, il CARLO appunto, che rappresentarono entrambi in diversi periodi della loro vita terrena.
Anche il materiale a seguire é stato inviato dal com.te E.Andreatta


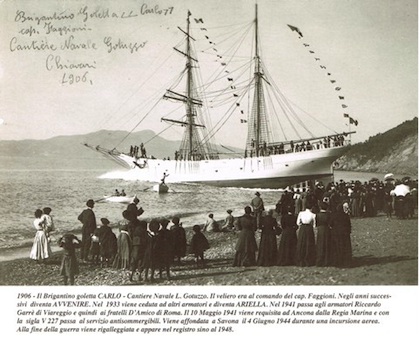
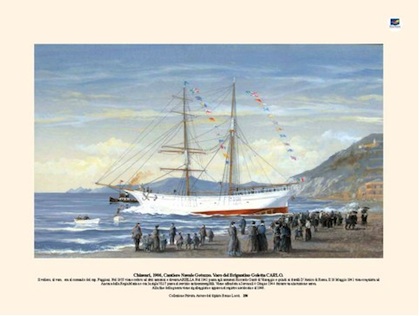
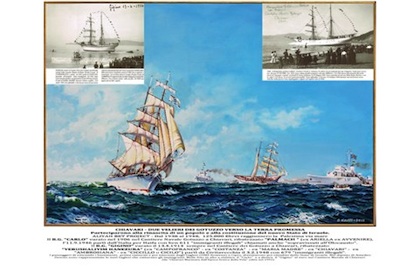
Le tappe terrene di MARCO LOCCI
Nasce a Genova nel 1951
Allievo della facoltà di architettura di Genova, inizia l’attività artistica aderendo ai fermenti della cultura visiva, e non, dei primi anni settanta.
Fonda il gruppo MILOTO, particolarmente interessato ai rapporti tra fotografia e pittura.
Nel 1969 inizia ad esporre a Genova.
PRINCIPALI MOSTRE:
1976 “Ipotesi di volo” al Crippa Art Centre S. Margherita Ligure
1977 “Dalle parole ai fatti” Galleria Civica d’Arte Moderna Castello di Portofino.
1978 Prosegue l’attività con il gruppo della galleria “Cenobio Visualità” Milano
1979 Inizia “Storie dal paese dei Patanchi” creando un mondo che esplora sino ad oggi
1980 Inizia ad esporre annualmente all’antico Castello sul mare di Rapallo
opere a tema marinaro
1994 Interventi alla cava “La piana” a Carrara. Espone “Balenavela” per
“Paraxo” in una mostra su Thor Heyerdahl
1995 “Dipingere l’aria del grande cielo” Chiesa di S. Francesco a Chiavari
1996 “Minotauro, Prometeo Ulisse”, Andora
1998 “Marco Locci anche pittore di navi” Chiavari Galleria Busi
2000 “Storie dal paese dei Patanchi” Gallerie “Il Bostrico” Albissola Marina
2001 “Esercizi di stile” La Spezia Palazzina delle Arti
“Il santuario dei Cetacei” San Fruttuoso di Camogli
“Marco Locci fa il draghetto” Galleria Cristina Busi di Chiavari
2002 “… e del navigar mi è meraviglia” Galleria il Bostrico Albissola
La Via dell’Arte “Il ponte sulle nuvole”
2003 Mostra dedicata ai piloti navali a Genova
Mostra internazionale dei Cartoonist di Rapallo
2004 “Patanchi”, Museo Nazionale dell’Antartide, Genova
2005 “Marco Locci”, L’atelier d’Emmnuelle, Liegi, Belgio
“Il Lungo Orizzonte”, Galleria Cristina Busi, Chiavari
2006 “Mare Nostrum” mostra al Castello sul transatlantico Andrea Doria
2007 “Mare Nostrum” mostra al Castello l’Apparizione della Madonna di Montallegro
2008 “Esposizione presso il museo Luzzati dall’Oblò a Genova
“ Svolge un corso di elaborazione con la carta presso la Comunità Montana Ingauna”
“Presentazione ed istallazione in piazza ad Albenga di un albero eseguito in carta”
.... Sempre in quegli anni prende forma l’epopea dei Patanchi, immaginario popolo lillipuziano che affolla, come un esercito di nere formiche, tavole e tavole di una mitologia personale colma di meraviglia e di sorridente ironia. Locci descrive l’universo dei Patanchi con la minuzia di un etnografo dell’Ottocento sbarcato su un’isola remota oltre l’orizzonte. Questo gusto del viaggio per mare, e attraverso le insidie e l’incanto del mare, a partire dagli anni Ottanta dominerà la pittura di Locci. Le navi diventano protagoniste, anzi, il pittore diventa “ritrattista” di navi, personaggi che con carni di legno e di acciaio solcano il mare oscuro. Spavalde e fragili. Sole come tutti noi.
“Perso per mare” è il titolo che Marco Locci aveva scelto per la Mostra appena inaugurata alla galleria Busi di Chiavari. Cristina Busi conosceva Locci da almeno venticinque anni: «Fummo presentati da Claudio Costa: Marco aveva esposto nell’ex chiesa di San Francesco un’enorme balena di legno. Stava sospesa in mezzo alla navata. Fu così che imparai a conoscere il suo gusto per il fantastico, il suo senso della magia. In galleria, senza contare le mostre collettive cui partecipava sempre, allestimmo almeno cinque personali: una si intitolava: “Locci, pittore non solo di navi”. C’erano tante invenzioni colme di umorismo surreale. Ricordo una cassettina di legno piena di rimasugli di gomma per cancellare: “La polvere degli errori”. Non riesco a credere che lui se ne sia andato». La mostra non chiude, il desiderio della famiglia di Locci è che la rassegna, che raccoglie opere di diverse stagioni creative, continui a essere visitabile. Sandra, moglie dell’artista, ha spiegato a Cristina che lui avrebbe preferito così.
A San Massimo, intanto, non smette di piangere Fausto Oneto, U Giancu, titolare del famoso Ristorante dei Fumetti, amico fraterno di Locci. Quando ha sentito l’ambulanza, Fausto è sceso subito a casa di Marco e Sandra: «Era il mio migliore amico, il più grande, una persona bellissima, un artista straordinario. Le nostre famiglie si frequentano da sempre e con lui ho passato tanti bellissimi momenti e ho condiviso tante passioni, come la musica di Tom Waits, la pittura di Rothko… fu Marco a farmeli conoscere. Qualche giorno fa ero passato da lui, dovevo fotografare alcune sue opere per una pubblicazione, la serie dei transatlantici, ma Marco era tutto preso dal suo giardino, non parlava d’altro. Adorava il suo giardino, che era disordinatissimo, quasi selvaggio. “Guarda la mia rosa bianca”, mi diceva. Era così orgoglioso del suo roseto. Vorrei che le sue ceneri riposassero proprio lì, sotto quella bellissima rosa bianca».
ALBUM FOTOGRAFICO
Il 5 maggio 2015 Marco é salito a bordo per l’ultimo viaggio, il più misterioso, senza nemmeno avere il tempo per preparare il suo baule da marinaio. Così, all’improvviso, tradito da un insulto cardiaco nella sua casa di San Massimo, l’altra notte se ne è andato Marco Locci, pittore di navi e non solo.


Marco Locci nel suo “eremo” di San Massimo (Rapallo)
L’ultima Mostra di Marco Locci
“PERSO PER MARE”: MOSTRA DI MARCO LOCCI ALLA GALLERIA "CRISTINA BUSI"
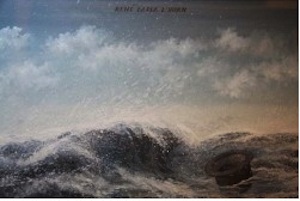
MOSTRA: MARCO LOCCI “perso per mare” LUOGO: Galleria Cristina Busi - Chiavari DATA: Dal 18 Aprile al 17 Maggio 2015 orario di apertura dal martedì al venerdì 16.00/19.30; sabato e domenica 10.00/12.00 e 16.00/19.30; chiuso l'intera giornata del lunedì INAUGURAZIONE: Sabato 18 Aprile ore 17
Marco Locci nasce a Genova nel 1951, vive e lavora a Rapallo. Allievo della facoltà di architettura di Genova, inizia l’attività artistica aderendo ai fermenti della cultura visiva e non, dei primi anni ’70.
Marco Locci perso per mare. Marco Locci non sa nuotare molto bene ma i suoi occhi si. Galleggiando tra le barbe grigie di Capo Horn e i suoi dolci flutti del mediterraneo osservano. Le albe e i tramonti si rincorrono e gli occhi cercano di mettere ordine nella sequenza delle immagini testimonianza dell’eternità del tempo. Sono le onde, gli spruzzi nel loro continuo inseguirsi che scandiscono il sapere che l’acqua ci trasmette. Così come i porti ci fanno riposare finché non riprendiamo il vagabondare e vediamo il sole, la luna, le navi volanti, i mostri, i promontori, le balene, le vele all’orizzonte come bianchi icebergs sino a che il mare torna a stendersi come si stendeva cinquemila anni fa.
Mare, cielo e navi sono i personaggi principali di racconti fantastici, metafore di una memoria storica personale.
Questa mostra è una raccolta di immagini che vanno dal 1992 ad oggi. Vari periodi e vari modi di affrontare la narrazione, varie idee collegate dal filo blu del mare, che diventa interprete e testimone silenzioso delle nostre azioni e col suo ipnotico movimento ci riflette e fa riflettere.
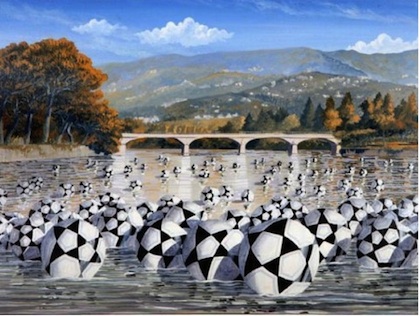
Marco Locci, Cento, acrilico su tela.
Il 14 Marzo 2014 ricorre il Centenario dalla fondazione della Società di Calcio AC Entella Chiavari.
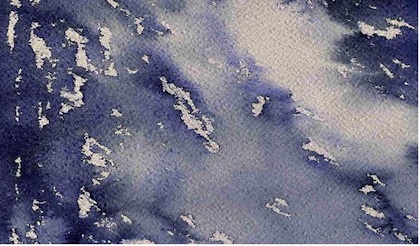

La MAURETANIA a New York

Genova – Transatlantici della N.G.I – a Ponte dei Mille

REX a New York – Manovra sotto la spinta dei rimorchiatori MORAN

NORMANDIE in evoluzione
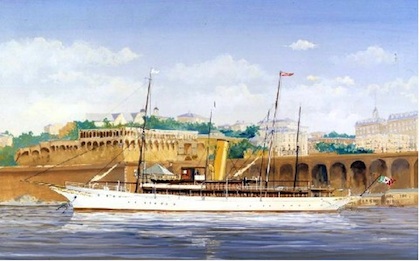
L’ ELETTRA di Guglielmo Marconi all’ancora a Genova
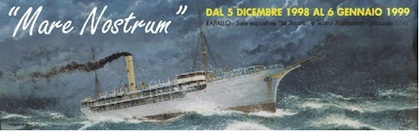
Le navi degli emigranti

Il Porto Vecchio di Genova negli Anni ‘50

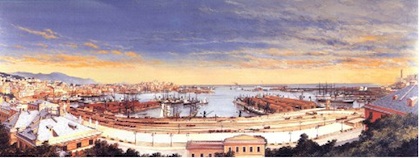
Genova Vecchia - Le Terrazze di marmo - 1875
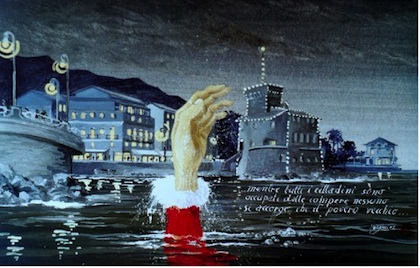
... mentre tutti i cittadini sono occupati dalle compere nessuno si accorge che il povero vecchio....
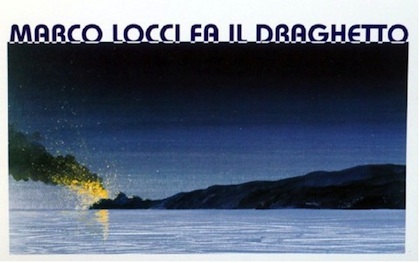
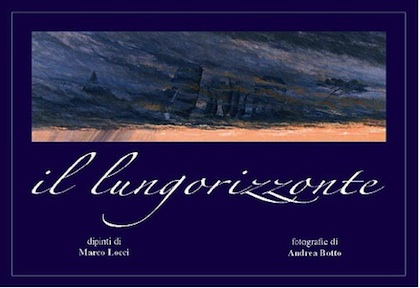
“Il lungorizzonte" con le opere del pittore Marco Locci, artista attento e poliedrico che da anni porta avanti una profonda riflessione sul paesaggio marino.
Locci costruisce una storia fatta di miraggi e visioni fantastiche, oniriche ed a volte ironiche. Saranno presenti anche altri lavori di Locci, dalle famose navi alle fantastiche “Storie dal Paese dei Patanchi", fino alle recenti sculture, che fanno di Marco Locci un artista completo, dalle innumerevoli ed inaspettate sfaccettature.

La nave invisibile (dipinto acrilico su carta)
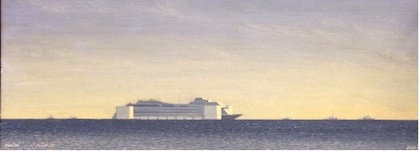
La Costa Concordia, ultimo “sguardo” al Tigullio
MARCO LOCCI e i Piloti



Nella copertina di questo volume, il pittore Marco LOCCI ha raffigurato il gesto eroico del pilota genovese Giancarlo Cerruti durante l’incendio, l’esplosione e l’affondamento della petroliera cipriota HAVEN, avvenuto l’11 aprile 1991 davanti ad Arenzano.
“...In un attimo pezzi di lamiera incandescente vennero scagliati come palle di fuoco, con traiettorie orizzontali e velocissime a pochi metri dalla pilotina e siamo riusciti a raccogliere diciotto naugraghi.”
Marco Locci aveva dedicato anni di collaborazione ai Piloti del Porto di Genova con bozzetti, quadri, disegni di crest, medaglie, mostre ecc... conosceva molto bene l’ambiente ed il lavoro di ormeggio e disormeggio delle navi. Quando fui incaricato dalla Federazione dei Piloti Porti Italiani di scrivere il libro: GENOVA: STORIE DI NAVI E DI SALVATAGGI
(Edizione bilingue: Italiano-Inglese) - Nuova Editrice Genovese
Marco Locci decise di seguirmi in quell’avventura ed illustrò con molti suoi dipinti quel libro che fu subito scelto per la diffusione in Europa di “Genova Città della Cultura-2004”.
La pubblicazione di questo volume avvenne in occasione del 37° GENERAL MEETING EMPA (European Maritime Pilot Association), durante il quale fu celebrato, allo STAR HOTEL di Genova, il 40° di vita dell’Associazione dei Piloti Europei. Proprio in quell’occasione, io allestii una mostra fotografica sugli ultimi 200 anni di storia dei piloti e, sullo stesso argomento, Marco allestì una Mostra di quadri dedicati alla storia delle Pilotine genovesi, britanniche e americane. Marco ebbe un successo strepitoso e insieme fummo invitati a proporre la stessa Mostra in una successiva importante occasione a Roma presso l’Hotel Parco dei Principi.
Su quel libro scrissi nei Ringraziamenti:
MARCO LOCCI, strano a dirsi, non é uomo di mare, ma un autore che ha navigato in tutti gli oceani dell’arte figurativa. Tuttavia chi lo conosce ed ora sono in molti, non riesce idealmente a separarlo dallo scenario popolato di velieri, transatlantici, gabbiani e “patanchi” che si muovono con tanta eleganza tra i suoi cieli accesi e onde cariche di vita ed energia.
MARCO LOCCI vive sul mare e pensa in modo marinaro, inconsapevole forse, della gioia che ci dà ogni volta che ci caliamo nella scia delle sue navi, o quando ci perdiamo tra le luci e le ombre di quei vellacci gonfi di vento in un tramonto intensamente ligustico. Dello stereotipo marinaro, a quest’originale artista manca soltanto la manualità del vecchio nostromo che riesce, con una cima in mano, a risolvere tutti i problemi in una coperta in manovra, ma di contro, egli sa cogliere, con poche pennellate, la spiritualità, la sacralità e l’immensità di quel vecchio mondo nel quale i vivi ed i morti sono così vicini da sembrare già uniti nell’eternità. A questo grande artista porgiamo un particolare ringraziamento per essersi unito a noi in questo lavoro ed averlo illustrato e tratteggiato con una parte emblematica delle sue opere.
Ciao MARCO, grazie per quel che ci hai donato!
Carlo GATTI
Rapallo, 28 Maggio 2015
SANTUARIO DEI CETACEI IN LIGURIA
SANTUARIO DEI CETACEI IN LIGURIA
Chi non conosce "Flipper" il più noto tra i delfini? Qualche anno fa una serie tv lo aveva reso celebre a mezzo mondo, facendolo diventare una specie di "Lassie del mare". Il suo successo era tuttavia scontato. Da sempre infatti i mammiferi marini sono oggetto di studio da parte degli specialisti e molta curiosità da parte del pubblico. Inoltre, tra gli animali marini i delfini sono i più amati dai bambini. Basta vedere l'età media di chi frequenta i delfinari. Ecco dunque che l'interesse scientifico si coniuga con l'amore per il mare e la sua fauna.
In natura un delfino vive intorno ai 30-40 anni, mentre la metà dei delfini catturati in mare muoiono entro 2 anni e la restante parte non sopravvive oltre i 5 a causa di varie malattie strettamente correlate con la vita in vasca.
Oggi in quasi tutti i paesi occidentali, la cattura dei delfini è vietata e possono essere mantenuti nei delfinari solo animali nati in cattività. Per avere un tasso di nascita sufficiente e prevenire gli incroci, viene utilizzata l'inseminazione artificiale.
MARE NOSTRUM - RAPALLO é stata ospite del LIONS CLUB RAPALLO come da locandina che riportiamo integralmente. AMA IL TUO MARE ci ha coinvolto soprattutto per l’entusiasmo dei suoi RELATORI, preparatissimi nell’argomentare le tematiche del proprio settore di appartenenza.
In modo particolare siamo stati affascinati dalla relazione del Dott. Guido Gnone, (Responsabile della gestione del Santuario dei Cetacei), il quale ha saputo guidarci evitando le difficoltà della terminologia scientifica che normalmente “blocca” il profano.
SANTUARIO DEI CETACEI
Il Settore viola della carta sotto riportata mostra IL SANTUARIO DEI CETACEI nel Mar Mediterraneo che bagna le coste della Toscana, Liguria, Provenza e Corsica. L’ampia zona nord occidentale a Ovest di Genova è caratterizzata da una piattaforma continentale molto ristretta, che precede una scarpata incisa da numerosi piccoli canyon sottomarini. La sua profondità massima si aggira intorno ai 2600 m.
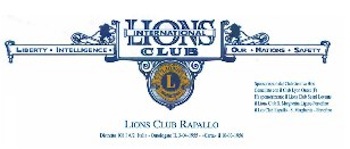


Nella sua introduzione, il dott. Guido Gnone ci ha spiegato che il Torrente Polcevera (tra Ge-Sampierdarena e Ge-Sestri Ponente) segna il confine tra le due Riviere della Liguria, almeno per quanto riguarda il Santuario dei Cetacei.
A Levante la piattaforma continentale, che comprende metà Liguria e buona parte della Toscana (Fosso Chiarone), é ampia e degrada lentamente verso il mare aperto. In questo habitat sabbioso si sono adattati i delfini Tursiopi che sono presenti in gran numero e si possono ritenere stanziali.
A Ponente del Polcevera, la piattaforma continentale é molto stretta e precipita subito verso fondali che raggiungono e superano talvolta i 2.000 metri. Questo habitat, caratterizzato da fiordi abissali, costituisce il polo d’attrazione per molti mammiferi marini che dispongono di grande capacità polmonare e sono adatti alla caccia in apnea.
Una serie di fattori caratterizzano l’area del SANTUARIO DEI CETACEI:
- l’azione dei venti di maestrale e di tramontana
- del gioco delle correnti
- la condizione di omeotermia invernale consentono il rimescolamento delle acque e la conseguente risalita in superficie dei sali nutritivi, che in altri mari rimangono in gran parte confinati nelle acque profonde.
L'apporto di tali sostanze permette lo sviluppo del fitoplancton, che si trova alla base della rete alimentare e costituisce il nutrimento dello zooplancton, a sua volta preda di pesci, cefalopodi e mammiferi marini. Il gamberetto Eufasiaceo Meganyctiphanes norvegica, infatti è l'alimento principale della Balenottera comune (Balaenoptera physalus), la quale, insieme ad altre sei specie di cetacei, frequenta regolarmente le acque del Mar Ligure.
L'abbondanza di nutrimento fa sì che, nell'ambito del Mar Mediterraneo, le acque alto tirreniche rappresentino una delle aree a maggior concentrazione di cetacei. Ognuna delle specie presenti è caratterizzata da un habitat preferenziale, strettamente correlato alla profondità del fondale; possiamo così distinguere specie costiere, di scarpata, pelagiche. Tuttavia, non esistendo in mare confini precisi, i mammiferi marini possono spostarsi liberamente ed essere talvolta avvistati in zone inusuali.
In altre parole si può dire che le particolari caratteristiche chimico-fisiche indotte dalla morfologia e dalla circolazione delle acque, rendono il tratto di mare tra Sardegna, Toscana, Liguria, Principato di Monaco e Francia una delle zone più ricche di vita del Mediterraneo. Si tratta di un’altissima concentrazione di mammiferi marini.
Una serie di studi ha rilevato che in questa zona del Mar Mediterraneo vi è una massiccia concentrazione di cetacei, grazie soprattutto alla ricchezza di cibo, come abbiamo visto. I mammiferi marini sono rappresentati da dodici specie : la balenottera comune (Balaenoptera physalus) il secondo animale più grande al mondo (secondo solo alla balenottera azzurra), il capodoglio (Physerter macrocephalus), il delfino comune (Delphinus delphis), il tursiope (Tursiops truncatus), la stenella striata (Stenella coeruleoalba) , il globicefalo (Globicephalua melas), il grampo (Grampus griseus), lo zifio (Ziphius cavirostris). Più rari, la balenottera minore (Balaenoptera acutorostrata), lo steno (Steno bredanensis) , l’orca (Orcinus Orca) e la pseudorca (Pseudorca crassidens.
Ci sono voluti dieci lunghi anni, ci hanno spiegato, affinché si giungesse alla creazione del Santuario Internazionale dei Cetacei del Mediterraneo. Sono stati anni di lavoro e impegno per molte persone che hanno creduto in un progetto e insieme sono riuscite a realizzarlo.
ALCUNE DATE IMPORTANTI
1978-1985 - Il "Progetto Cetacei"
Il primo progetto di monitoraggio a livello nazionale, denominato "Progetto Cetacei", viene coordinato dal Dr. Antonio Di Natale, con la partecipazione dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Messina, dei Musei Civici di Storia Naturale di Milano e di Venezia, dello Stato Maggiore della Marina Militare ed il WWF-Italia.
1989-1991 - Il "Progetto Pelagos"
L’Istituto Tethys propone il "Progetto Pelagos", per la creazione di una Riserva della Biosfera nel bacino Corso-Liguro-Provenzale, che mostra la più alta concentrazione di cetacei tra tutti i mari italiani e probabilmente rappresenta l’area faunisticamente più ricca dell’intero Mediterraneo. Nel bacino si trova inoltre il principale sito di alimentazione per la balenottera comune in Mediterraneo.
In territorio italiano, il Santuario per i mammiferi marini è stato istituito nel 1991 come Area Naturale Marina Protetta di interesse internazionale, e occupa una superficie a mare di 2.557.258 ha (circa 25.573 km2) nelle regioni Liguria, Sardegna, e Toscana.
1993 - Primo passo ufficiale
Il giorno 22 marzo i rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente di Francia e Italia e il Ministro di Stato del Principato di Monaco firmano a Bruxelles una Dichiarazione relativa all'istituzione di un Santuario Internazionale dei Cetacei del Mar Ligure.
1999 - Il Santuario diventa realtà
L’Area marina protetta internazionale fu invece istituita IL 25 novembre 1999, con il contributo scientifico dell'Istituto Tethys, grazie all'iniziativa del Rotary Club Milano Porta Vercellina, all'intervento del Rotary International e al sostanziale contributo di AERA (Associazione Europea Rotary per l'Ambiente). Importantissima é stata la collaborazione dei tre paesi nel quale il Santuario è compreso. L’area di circa 100.000 Km2 comprende le acque tra Tolone (costa francese), Capo Falcone (Sardegna occidentale), Capo Ferro (Sardegna orientale) e Fosso Chiarone (Toscana). L'accordo verrà ratificato dal Governo Italiano nel 2001 con la L.391.
1999 - Progetto SOLMAR
Nel 1999 prende avvio il Progetto Solmar (Sound, Ocean and Living Marine Resources), la più grande ricerca sui Cetacei esistente al mondo, svolta dal Nato Undersea Research Centre in collaborazione con numerosi Istituti di varie Paesi. Il progetto, che prevede uno studio dettagliato dei cetacei e delle condizioni oceanografiche e biologiche dell'ecosistema pelagico nell'area del Santuario Pelagos, è previsto sino al 2008 ed utilizza tutte le più avanzate tecniche esistenti.
Nel 1992 venne effettuato un censimento sulla superficie di quello che sarebbe divenuto il Santuario dei cetacei da parte dell'Istituto Tethys, da Greenpeace e dall'Università di Barcellona , che consentì la stima numerica delle stenelle (32.800 esemplari) e delle balenottere comuni (830 esemplari) presenti nella zona nel periodo estivo.
Un recente rapporto di Greenpeace ha però documentato un drammatico calo delle popolazioni di cetacei presenti ed una inadeguatezza delle misure di tutela messe in atto. I dati raccolti da Greenpeace ad agosto 2008 riportano la presenza solo di un quarto delle balenottere e meno di metà delle stenelle rilevate negli anni novanta.

L'obiettivo principale del progetto è il miglioramento dello stato di conservazione del delfino tursiope (Tursiops Truncatus), essendo questa la specie costiera tra cetacei del Mediterraneo più esposta alle minacce causate dall'attività umana e dallo sfruttamento delle risorse. Il Consorzio Liguria Via Mare è l'unica compagnia di whale watching in Italia ad essere partner sostenitore del progetto.
Il progetto Arion propone la realizzazione di un sistema di prevenzione di interferenze in grado di rilevare e monitorare i delfini, di identificare le minacce e di prevenire le collisioni e altri rischi tramite la diffusione di messaggi di avvertimento presenza in tempo reale a tutte le categorie interessate (turisti, pescatori professionisti e sportivi, Area Marina Protetta). Il protocollo di comportamento per ridurre i rischi per la specie è stato sviluppato e concordato con i soggetti coinvolti, in collaborazione con la sezione locale della Guardia Costiera.
L'area selezionata per la dimostrazione del sistema può essere considerata come un "Case Study", in quanto vi si trova una popolazione residente di tursiopi, frazione importante della popolazione nord-occidentale del Mediterraneo, e la maggior parte delle attività antropiche di cui sopra sono presenti nella zona.
Il progetto intende dimostrare l'efficacia dello strumento proposto per la riduzione delle minacce ed il miglioramento della conservazione, per appurare la possibilità di essere ripetuto e portato avanti con facilità in altre aree del Mediterraneo.
Gli obiettivi specifici sono quelli di evitare il declino del numero di individui, riducendo le minacce e monitorando l'uso dell'habitat da parte dei delfini e la loro abbondanza, di minimizzare i rischi agendo tempestivamente ogni qualvolta la presenza di delfini viene rilevata nei pressi di una attività antropica in corso, 24 ore su 24 per tutto l'anno, e di fornire tutta una serie di informazioni circa la presenza e il comportamento della specie nella zona, nonché delle attività antropiche concorrenti.
Il sito del progetto Arion è www.arionlife.eu

Il progetto nasce nel 2001 con l’obiettivo principale di valutare la presenza e le abitudini dei Cetacei lungo le acque della Liguria. Particolare interesse è rivolto al tursiope (Tursiops Truncatus), un delfino dalle abitudini prevalentemente costiere e dunque più soggetto all’impatto delle attività dell’uomo.
Le ricerche vengono condotte solitamente a bordo di gommoni e l'area di studio è costituita dalle acque costiere comprese tra Genova e La Spezia. I dati raccolti durante le uscite del Consorzio Liguria Via Mare, prima compagnia di whale watching in Italia ad aver aderito, sin dal 2001, allo studio Delfini Metropolitani, vengono inseriti nel database del progetto.
Lo studio procede attraverso la raccolta di immagini fotografiche che permettono ai ricercatori di identificare gli animali avvistati (foto-identificazione). Tale metodologia permette di stimare l’abbondanza delle popolazioni, seguire gli spostamenti degli individui e valutare la loro fedeltà all’area di studio. I dati vengono inoltre periodicamente confrontati con quelli raccolti da altri gruppi di studio che operano in regioni limitrofe, partner scientifici del progetto Delfini Metropolitani. L’aumento delle conoscenze sulla biologia delle specie costiere e la valutazione dell’interazione con le attività umane, come la pesca ed il traffico marittimo, potranno fornire informazioni essenziali per lo sviluppo di programmi di conservazione e gestione dell’ambiente marino costiero.
Il sito del progetto Delfini Metropolitani è www.delfinimetropolitani.it
Delfino Comune
Delphinus delphinus
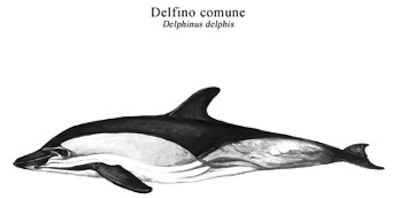

Nonostante il nome Delfino comune indichi una grande distribuzione ed abbondanza, questa specie ha subito una grave riduzione della popolazione negli ultimi anni. Nel bacino mediterraneo la causa principale di questa diminuzione è stata la caccia per scopi alimentari. Il mosciame di delfino o filetto di delfino, era servito nei ristoranti sino agli inizi degli anni ‘50. Oggi la popolazione sembra dare segni di ripresa, in particolare nell’area occidentale del Mediterraneo. La tipica colorazione ed il disegno a clessidra sui fianchi sono caratteri distintivi della specie. Il dorso è grigio-nero, la zona anteriore della clessidra è giallo vivace, mentre il ventre è bianco candido. Una ben evidente striatura nera congiunge il rostro alle pinne pettorali. Gli occhi sono contornati da una mascherina nera. Il corpo esile ed agile di questi delfini li rende degli abili nuotatori, capaci di raggiungere velocità pari a 35 nodi (70 Km/h). I delfini comuni sono particolarmente attivi nel gioco, eseguono spesso il porpoising (tuffo a testa in giù) ed il lobtailing (schiaffeggio dell'acqua con le pinne).
Caratteristiche: Lunghezza 2 - 2,5 m / Peso adulto 70 - 100 kg / Peso nascita 10 kg / Dieta calamari, pesci / Gruppo 10 - 30 individui
Morfologia e dimensioni: Il delfino comune ha le dimensioni e morfologia simili a quelle della stenella striata eccetto che per il rostro, leggermente più sottile ed allungato. Alla nascita misura 80-90 cm, mentre gli adulti hanno una lunghezza attorno ai 2 metri ed un peso di circa 90 Kg.
Colorazione: Il dorso è grigio scuro, il ventre di colore bianco. Sui fianchi è presente un peculiare disegno a clessidra,la cui parte anteriore è di color crema.
Nuoto e ritmo respiratorio: Simile a quella della stenella striata: anch’esso è in grado di compiere salti ed acrobazie e di raggiungere elevate velocità.
Alimentazione: Anche il delfino comune, come la stenella striata, basa la sua dieta su pesci, cefalopodi e crostacei. Comportamento sociale: E' un cetaceo altamente gregario, che può occasionalmente riunirsi in branchidi centinaia di esemplari. E’ facile vederlo nuotare in compagnia di stenelle o tursiopi. Anche per il delfino comune, come per la stenella striata, le informazioni su composizione e struttura sociale dei branchi sono scarse. Ciclo vitale: Non esistono dati per quanto riguarda il Mar Ligure; in altre zone del Mediterraneo, la maturità sessuale è raggiunta nei maschi fra i 5 ed i 12 anni, nelle femmine tra i 6 ed i 7 anni. La gestazione dura 10 – 11 mesi. Sembra che la specie arrivi ad almeno 20 anni di età. Riconoscimento in mare: Può essere distinto dalla stenella striata per la diversa colorazione dei fianchi. Negli ultimi decenni la sua presenza in Mar Ligure è sensibilmente diminuita, pertanto gli avvistamenti sono divenuti molto rari.
Tursiope
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
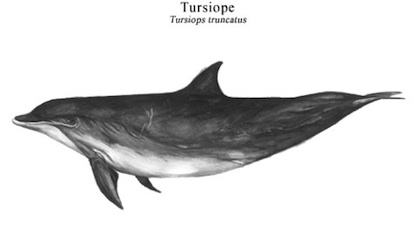

Il Tursiope è la specie di delfino più conosciuta. La sua grande capacità di
adattamento e quindi di sopravvivere in cattività, lo rende spesso protagonista di molti film e star di tanti spettacoli. Il corpo è particolarmente slanciato e dalle forme idrodinamiche. Il capo è caratterizzato dalla presenza del “melone”. Questo rigonfiamento ospita un biosonar (analogo a quello dei pipistrelli) utilizzato per l’eco-localizzazione, che permette ai delfini di vedere e orientarsi anche al buio. Grazie all’ecolocalizzazione un Tursiope è in grado di vedere nel buio completo una pallina di 2 cm di diametro fino a 70 metri di distanza. Il Tursiope è un delfino caratterizzato da un’elaborata struttura sociale, una grande capacità di apprendimento ed un elevato senso dell’altruismo. La sua capacità di osservazione e collaborazione è molto avanzata ed è oggetto di studio da parte degli uomini. È una specie che mostra una grande curiosità nei confronti delle imbarcazioni e spesso instaura rapporti di amicizia anche con gli esseri umani.
Caratteristiche: Lunghezza 2 - 4 m / Peso adulto 150 - 600 kg /Peso nascita 15 kg / Dieta calamari, pesci / Gruppo 1 - 10 individui
Centinaia se non migliaia di tursiopi vivono in cattività in tutto il mondo, sebbene sia difficile stimare un numero preciso.
Morfologia e dimensioni: Di corporatura possente e muscolosa, è una specie in cui il maschio è leggermente più grande della femmina; La lunghezza media negli esemplari adulti è di circa 3m, il peso mediamente di 320 Kg. Il piccolo, alla nascita, misura circa un metro. Il capo presenta un melone pronunciato ed un rostro relativamente corto e tozzo.
Colorazione: grigia con varie tonalità e sfumature: il grigio del dorso diviene più chiaro sui fianchi, il ventre appare di colore bianco.
Nuoto e ritmo respiratorio: il tursiope ha un nuoto possente ed è in grado di raggiungere velocità che superano i 30 Km/h; possiede notevoli capacità acrobatiche e spesso si porta nei pressi delle imbarcazioni facendosi spingere dall’onda di prua. Può immergersi fino a qualche centinaio di metri restando in apnea per un massimo di circa 8 minuti.
Alimentazione: si nutre prevalentemente di pesce (cefali, acciughe, sardine, sgombri, etc.), completando la sua dieta con molluschi cefalopodi (calamari, seppie e polpi) ed all’occorrenza crostacei. Comportamento sociale: vive in piccoli branchi (di 5–10 individui) caratterizzati da forti legami sociali. Esistono gruppi di sole femmine con i cuccioli ed altri composti da solo maschi, che si uniscono alle femmine nel periodo riproduttivo. Ciclo vitale: Le femmine raggiungono la maturità sessuale intorno ai dieci anni di vita, i maschi tra i dieci ed i tredici anni. L’accoppiamento e le nascite avvengono generalmente in estate. Dopo la gestazione, di circa dodici mesi, i piccoli restano con la madre per circa due anni,fino al termine dello svezzamento. I tursiopi possono raggiungere l’età massima di circa 40 anni. Riconoscimento in mare: segnali della sua presenza possono essere la comparsa in superficie della pinna dorsale e del dorso, nel momento in cui l’animale emerge per respirare, o gli spruzzi provocati dal suo movimento nell’acqua (salti e nuoto veloce). Il tursiope è un cetaceo poco frequente in Mar Ligure, specialmente nella porzione occidentale; infatti, risulta essere una delle specie meno avvistate durante le escursioni di whale watching.
Stenella Striata
La Stenella striata è il delfino più abbondante del Mediterraneo. È assai facile avvistare gruppi molto numerosi di Stenelle durante la navigazione perfino a bordo di traghetti e navi. Questi delfini, agili e vivaci, vivono lontano dalle coste in acque piuttosto profonde, ed accettano di buon grado gli incontri con le imbarcazioni. Spesso sfruttano le onde create dalle barche per giocare, esibendosi in tuffi e straordinari salti sopra la superficie dell’acqua. I salti più spettacolari raggiungono l’altezza di 7 metri. Questo delfino è esile e slanciato, il capo appare sottile, con il rostro (muso) molto allungato. La colorazione è caratterizzata da un’evidente sfumatura chiara, a forma di fiamma, sui fianchi del corpo. Il dorso è scuro mentre il ventre appare più chiaro. Una mascherina scura contorna entrambi gli occhi, prolungandosi in una sottile striscia che arriva fino alle pinne. La colorazione particolare del capo dona un aspetto furbo e simpatico agli esemplari di questa specie.


La Stenella striata è il delfino più abbondante del Mediterraneo. È assai facile avvistare gruppi molto numerosi di Stenelle durante la navigazione perfino a bordo di traghetti e navi. Questi delfini, agili e vivaci, vivono lontano dalle coste in acque piuttosto profonde, ed accettano di buon grado gli incontri con le imbarcazioni. Spesso sfruttano le onde create dalle barche per giocare, esibendosi in tuffi e straordinari salti sopra la superficie dell’acqua. I salti più spettacolari raggiungono l’altezza di 7 metri. Questo delfino è esile e slanciato, il capo appare sottile, con il rostro (muso) molto allungato. La colorazione è caratterizzata da un’evidente sfumatura chiara, a forma di fiamma, sui fianchi del corpo. Il dorso è scuro mentre il ventre appare più chiaro. Una mascherina scura contorna entrambi gli occhi, prolungandosi in una sottile striscia che arriva fino alle pinne. La colorazione particolare del capo dona un aspetto furbo e simpatico agli esemplari di questa specie.
Caratteristiche: Lunghezza 2 - 2,5 m / Peso adulto 90 - 150 kg / Peso nascita 10 kg /Dieta calamari, pesci / Gruppo 10 - 30 individui / Status comune





Morfologia e dimensioni: è un piccolo delfino dalla forma slanciata e dalla lunghezza massima di un paio di metri, con un peso intorno ai 100 Kg. Rispetto al tursiope, presenta un rostro più snello ed allungato. Il neonato pesa circa 11Kg. E misura quasi un metro.
Colorazione: sui fianchi sono ben evidenti le striature che danno il nome alla specie. Caratteristica è anche una “fiamma” biancastra, variabile per intensità e lunghezza, che, partendo dai lati del capo, si protende verso la base della pinna dorsale. Il dorso è di colore grigio scuro, il ventre è bianco talvolta rosato.
Nuoto e ritmo respiratorio: è uno dei cetacei più agili e veloci, in grado di raggiungere i 40 Km/he di compiere spettacolari acrobazie. Spesso si avvicinano alle imbarcazioni nuotando nell’onda di prua; non è raro vederlo in un simile comportamento anche nei pressi delle balenottere comuni. Le sue apnee possono durare qualche minuto e si ritiene che durante le immersioni raggiunga anche qualche centinaio di metri di profondità.
Alimentazione: specie “generalistica”, che può cibarsi di varie specie di pesci, calamari e crostacei a seconda delle disponibilità. La dentatura è ben sviluppata su entrambe le mascelle. Alcuni studi hanno evidenziato che, per procacciarsi il cibo, durante la notte la stenella striata tende ad avvicinarsi alla costa. Comportamento sociale: in Mar Ligure, la stenella striata vive in gruppi costituiti in media da una ventina di esemplari, la cui struttura sociale è attualmente studiata dai ricercatori del Tethys Research Institute. Ciclo vitale: probabilmente, come in altre zone del mondo, maschi e femmine raggiungono la maturità sessuale all’età di 9 anni. La gestazione dura 12 mesi, mentre le nascite sono concentrate nel periodo estivo. L’intervallo tra un parto e l’altro varia da 1,5 a 3 anni;la longevità suoera i 30 anni. Riconoscimento in mare: spesso è avvistabile anche da una certa distanza, grazie agli spruzzi provocati dai suoi salti sulla superficie dell’acqua. Le ridotte dimensioni e la colorazione dei fianchi permettono di distinguerla dalle altre specie. E’ il cetaceo più diffuso ed avvistato nel Mar Ligure; si stima che, nel periodo estivo, la sua popolazione nell’area ammonti ad oltre 30.000 esemplari.

Questo delfino è comunemente chiamato “delfino serpente”. Il capo privo della piega che separa il “muso” dalla fronte, appare molto appuntito e sottile e gli occhi decisamente grandi lo rendono simile ad un rettile. L’aspetto particolare e poco rassicurante lo rendono una specie poco amata dal pubblico. Inoltre il carattere schivo e la rarità degli avvistamenti non aiutano i ricercatori a scoprire i molti misteri che ancora circondano questo strano animale. Le sue apnee si prolungano per oltre 15 minuti e per tale motivo è assai difficile da seguire in mare aperto. Le poche osservazioni effettuate fanno tuttavia presupporre l’esistenza di gruppi numerosi, composti da individui di entrambi i sessi. Inoltre gli avvistamenti testimoniano una grande abilità nel nuoto, ed una elevata acrobaticità.
Caratteristiche: Lunghezza 2 - 3 m / Peso adulto 100 - 150 kg / Peso nascita non conosciuto / Dieta calamari, pesci / Gruppo 10 - 15 individui / Status non conosciuto
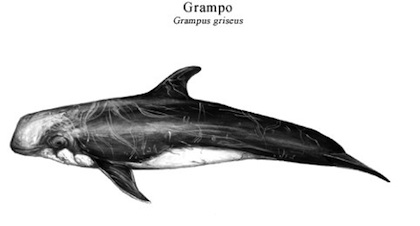
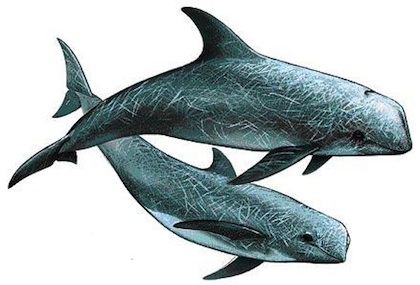
Il Grampo è un delfino molto particolare per la colorazione, l’aspetto del capo e la mancanza di rostro. La testa appare infatti tondeggiante, con un’infossatura longitudinale che unisce l’apice del muso allo sfiatatoio, da cui deriva il nome di “delfino ariete”, che venne assegnato ai primi esemplari osservati. I rappresentanti di questa specie si riconoscono in mare piuttosto facilmente grazie al loro aspetto vissuto e combattuto. Gli individui presentano alla nascita una colorazione grigio chiara, con il dorso leggermente più scuro. Con il passare degli anni, il corpo si ricopre di estese cicatrici bianche provocate dai combattimenti con altri adulti. I Grampi più anziani appaiono spesso quasi completamente bianchi per l’abbondante presenza di graffi e lesioni. Il carattere di questi animali è socievole ed il gioco è assai frequente. Spesso si osservano lo spyhopping (emersione del capo in verticale per osservare), il lobtailing (schiaffeggio dell’acqua con la coda), ed il porpoising (tuffo di testa). Il Grampo ancora oggi, in alcuni paesi come il Giappone, viene catturato per scopi alimentari. Nel Mediterraneo i rischi maggiori sono causati dalla cattura accidentale nelle reti da pesca, dove muore per soffocamento.
Caratteristiche: Lunghezza 3 - 4 m / Peso adulto 300 - 500 kg / Peso nascita non conosciuto / Dieta calamari, pesci /Gruppo 3 - 30 individui / Status comune
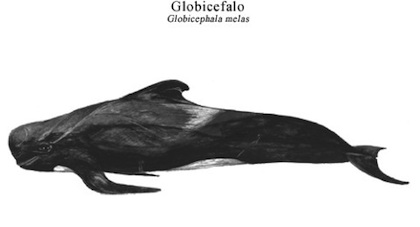

Questo delfino si distingue nettamente dagli altri rappresentanti della famiglia per la forma del capo e della pinna dorsale. Il capo, come indicato dal nome, è tondeggiante con il melone molto pronunciato e bombato ed il rostro quasi del tutto assente. La pinna dorsale è caratterizzata da una base molto larga e da una forma assai ricurva e falcata. Le pinne pettorali sono allungate, con il gomito ben evidente negli esemplari più anziani. I Globicefali sono animali decisamente gregari, e i gruppi sono spesso composti da numerosi esemplari. E proprio questa tendenza alla gregarietà è forse all’origine degli spiaggiamenti di massa, tipici della specie. Ancora oggi non si è in grado di fornire delle spiegazioni adeguate ai fenomeni di spiaggiamento ma si ritiene che la coesione degli individui porti i gruppi a seguire gli esemplari in difficoltà sino allo spiaggiamento collettivo.
Caratteristiche: Lunghezza 4 - 6 m / Peso adulto 2 - 3,5 t / Peso nascita 75 kg /Dieta calamari, pesci / Gruppo 10 - 30 individui.
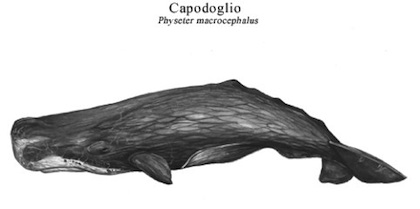

Il Capodoglio è l’odontocete (Cetaceo con i denti) di maggiori dimensioni. Il suo corpo misura fino a 18 metri ed alla nascita il piccolo ha già una lunghezza di 4 metri. Il capo è molto grande, squadrato e schiacciato. La testa raggiunge un terzo della lunghezza complessiva del corpo. Al suo interno è presente lo “spermaceti”, un particolare organo composto da sostanze oleose che, per aiutare la fase di immersione, vengono compresse all’estremità del muso per sbilanciarlo in avanti come una zavorra. Il Capodoglio è il detentore del record d’immersione dei Cetacei. Può infatti raggiungere i 3000 metri di profondità restando sott’acqua senza respirare per oltre due ore. La sua dieta è costituita da pesci d'ogni genere ma la prede preferite sono i calamari. Anche i calamari giganti sono frequentemente cacciati dal Capodoglio durante le immersioni in profondità, come dimostrato dai segni di combattimento sugli esemplari studiati. In mare questo odontocete è facilmente riconoscibile per il caratteristico soffio prodotto dallo sfiatatoio. Lo spruzzo è basso, denso ed angolato verso sinistra. Durante l’immersione l’enorme coda si distende completamente fuori dall’acqua.
Caratteristiche: Lunghezza 11 - 18 m /Peso adulto 20 - 50 t / Peso nascita 1 t.
Dieta calamari, pesci / Gruppo 1 - 6 individui
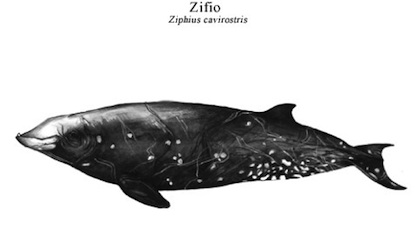
Lo Zifio è l’unico rappresentante della famiglia degli Zifidi presente nel Mediterraneo, benchè sia assai raro da avvistare. Il corpo, tozzo e robusto, appare simile ad un siluro. Osservando con attenzione il capo si nota come manchi la linea di demarcazione tra fronte e rostro ma certamente l’aspetto che maggiormente colpisce è quello della bocca. La linea boccale ha una caratteristica forma ad “S” che conferisce una sorta di perenne sogghigno ai rappresentanti di questa specie. La mandibola, inoltre, sporge rispetto alla mascella superiore. Nei maschi due piccoli denti sono ben visibili anche quando la bocca è totalmente chiusa. Questa specie racchiude ancor oggi molti segreti e poche sono le informazioni in possesso dei ricercatori. La mancanza di informazioni trova una spiegazione nel carattere timido e schivo di questo animale. Le rare notizie di cui disponiamo sono state rinvenute, purtroppo, attraverso l’analisi di animali spiaggiati.
Caratteristiche: Lunghezza 5 - 7 m / Peso adulto 2 - 3 t / Peso nascita 250 kg /Dieta calamari, pesci / Gruppo 1 - 10 individui


Insieme alla Balenottera minore è l’unico rappresentante dei misticeti presente nel Mediterraneo. La Balenottera comune dopo la Balenottera azzurra è l’animale più grosso della terra. Il suo corpo può raggiungere la straordinaria lunghezza di 27 metri con un peso di circa 70 tonnellate. Un individuo adulto di Balenottera comune necessita di quasi una tonnellata di cibo al giorno, che viene filtrato attraverso i fanoni. La dieta è costituita da plancton, krill e minuscoli pesci. Il piccolo di Balenottera alla nascita misura più di 5 m con un peso che si aggira intorno alle 2 tonnellate. Ogni giorno il neonato si alimenta con 100 kg di latte materno. Questo nutrimento, particolarmente ricco di grassi, permette alla giovane balenottera di crescere di 3 cm al giorno, aumentando quotidianamente il proprio peso di 60 kg. In sei mesi di vita raggiunge la lunghezza di 12 m. La vita di questi grandi misticeti è assai longeva, molti individui raggiungono e superano i 100 anni di età.
Caratteristiche: Lunghezza 18 - 22 m / Peso adulto 30 - 80 t / Dieta plancton, pesci /Gruppo 1 - 6 individui

La Balenottera minore è la più piccola della famiglia dei Balenotteridi. Il suo capo, come indicato dal nome scientifico, ha una forma molto appuntita ed è dotato di una cresta sporgente che collega l’apice del muso con lo sfiatatoio (narici modificate e posizionate nella zona più alta del capo). Il corpo piccolo e tozzo è di color grigio ardesia sul dorso e bianco-rosa nelle zone ventrali. Le pinne pettorali, appuntite e lanceolate, presentano evidenti bande bianche in netto contrasto con la colorazione scura del corpo. Le dimensioni ridotte di quest’animale consentono agli individui di esibirsi piuttosto spesso in spettacolari salti fuori dall’acqua. Il tuffo può essere di pancia, di fianco o più raramente di testa. La Balenottera minore ha un carattere socievole. La sua curiosità la spinge ad avvicinarsi frequentemente alle imbarcazioni e ad interagire con l’uomo.
Caratteristiche: Lunghezza 7 - 10 m / Peso adulto 5 - 15 t / Peso nascita 350 k / Dieta Plancton, pesci / Gruppo 1 - 3 individui
Whale Watch

L’escursione: Lo scopo d’ogni escursione è di avvistare i cetacei nel loro ambiente naturale, avvicinarli ed osservarli senza recare loro alcun disturbo, seguendo un adeguato codice di condotta. La permanenza in mare è di circa 5 ore.
La ricerca: A bordo è sempre presente un biologo per commentare gli avvistamenti e per raccogliere i dati relativi. Tale impegno ci permette di collaborare con molti istituti di ricerca italiani e stranieri fra cui Woods Hole Oceanographic Institution (USA), Istituto Tethys di Milano, Università degli Studi di Siena, Milano e Genova.
Condizioni meteo: Onde garantire una buona navigazione ed affinché vi siano le condizioni ideali per gli avvistamenti, viene svolto un controllo giornaliero dei bollettini meteo, E’ comunque facoltà insindacabile del comando di bordo rinunciare alla partenza senza preavviso o rientrare in porto anticipatamente qualora le condizioni del mare presentino peggioramenti.
Consigli utili: L’abbigliamento del “Whale Watcher” è decisamente sportivo. E’ consigliata una leggera giacca a vento ed una crema protettiva. L’equipaggiamento va completato con attrezzatura foto-video adeguata binocoli.
Delfini e Balene nel Mar Ligure: Il mar di Liguria e di Corsica, dal 1993 dichiarati area protetta per la tutela dei cetacei con il nome di "Santuario Internazionale", presentano un'altissima concentrazione di questo ordine di mammiferi marini. Osservando con attenzione la superficie delle acque di questa zona è possibile incontrarne regolarmente almeno otto specie diverse.
Sono in grado di compiere delle acrobazie fuori dall'acqua, il cui significato non è ancora chiaro. Tra queste le più comuni sono:
• Leaping: saltare completamente fuori dall'acqua;
• Tailspinning: "camminare" all'indietro sull'acqua utilizzando la coda come perno;
• Lobtailing : sbattere la pinna caudale sulla superficie dell'acqua;
• Bow : saltare verticalmente completamente fuori dall'acqua.
• Bowriding: nuotare sulle onde lasciate dalla prua delle imbarcazioni;
• Breaching: effettuare dei "tuffi" fuori dall'acqua;
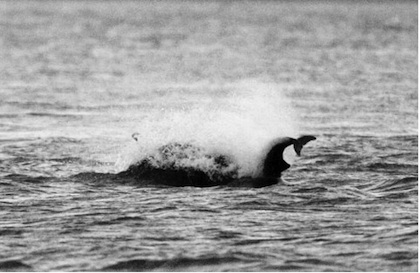
Focena attaccata e uccisa da un tursiope. Scozia, maggio 2005
Sono animali predatori, e spesso mostrano dei comportamenti aggressivi, che comprendono combattimenti tra maschi per le femmine e aggressioni nei confronti di altri piccoli delfini. La popolazione che vive in Scozia pratica l'infanticidio, e ricerche svolte dall'Univwersità di Aberdeen hanno dimostrato che i tursiopi uccidono le focene (Phocoena phocoena).

La focena o marsuino (Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)) è una delle sei specie di focena. È uno dei più piccoli mammiferi oceanici del mare. Come indica il suo nome comune inglese (Harbour porpoise, focena dei porti) risiede nei pressi delle aree costiere o degli estuari dei fiumi e per questo è la focena più familiare ai whale watchers. Spesso questa focena si avventura nei fiumi ed è stata vista a centinaia di miglia dalla costa.
Questo servizio é dedicato a mio nipote LEO amante delle Scienze Biologiche e della natura in generale!
Carlo GATTI
Rapallo, 23 Maggio 2015
GEORGES VALENTINE - Versione per IL MARE (Rivista Mensile)
GEORGES VALENTINE
IL VELIERO CAMOGLINO RITROVATO
Versione ridotta per la Rivista Mensile IL MARE - Rapallo

Com’é noto, la gente di mare di Liguria ama le montagne e spesso trascorre le vacanze frequentando i “rifugi alpini”, ma nessuno di loro, fino a pochi mesi fa, aveva mai sentito parlare di “case rifugio per naufraghi” che esistevano oltremare nei punti più pericolosi per la navigazione. Le “case rifugio”, figlie misericordiose del periodo più duro della navigazione a vela, erano lì a vegliare sui costoni rocciosi a picco sull’oceano, dove le correnti e le tempeste spingevano i “legni senza governo”. In quei cimiteri di navi finiva la loro esistenza e spesso anche il loro ricordo. I guardiani, veri angeli solitari della Provvidenza, quando era possibile accoglievano quei “POVERI CRISTI” che cadevano vittime delle tempeste e furono gli ultimi testimoni dell’epopea della vela ormai avviata al tramonto.
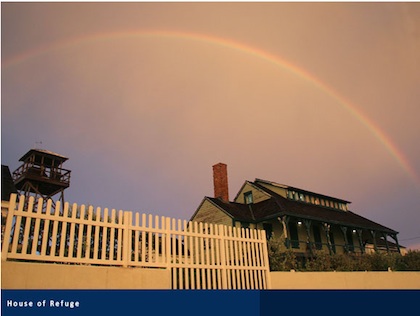
Costruita nel 1875, la Casa Rifugio di Gilbert's Bar é l'unica rimasta delle dieci edificate dal Governo degli Stati Uniti lungo la costa orientale della Florida per offrire assistenza ai superstiti dei tanti naufragi che avvenivano lungo quel tratto di costa. Spesso, chi riusciva a raggiungere la riva, era traumatizzato, ricoperto di ferite e generalmente moriva dissanguato per mancanza di soccorsi.
Dopo un felice periodo, il Piroscafo “Cape Clear”, fu venduto ad una compagnia di Navigazione Francese che lo trasformò in brigantino a palo. Un’idea in controtendenza: le fu tolta la parte motrice e da quel momento fu condannato a navigare a vela in mari tempestosi, come se la Rivoluzione Industriale non fosse mai passata da quelle parti... Una pazzia? Forse! Ma all’epoca non tutto lo shipping era d’accordo sull’economicità del motore.
Divenne quindi “Georges Valentine” e nel 1895 fu acquistata dagli armatori camogliesi Mortola e Simonetti e venne adibita a viaggi regolari per il trasporto del legname.
Nell'ottobre del 1904, il brigantino a palo Georges Valentine salpò da Pensacola per Buenos Aires con un carico di travi di mogano. L'equipaggio era formato da dodici uomini di differenti nazionalità, al comando del Capitano camoglino Prospero Mortola, detto “Testaneigra”.
Improvvisamente, mentre si trovava nello stretto della Florida, il brigantino fu investito da un fortunale che lo bastonò a lungo fino a costringere il Capitano al “gettito” a mare del carico che aveva in coperta: era l’ultimo tentativo di recuperare galleggiamento e stabilità.
Capitan Mortola manovrò le vele basse rimaste integre per mantenere il veliero in acque profonde, e lo fece con la perizia di un vero “lupo di mare”; ma tutto fu inutile. Il Georges Valentine scarrocciò inesorabilmente verso la costa di sottovento fin quando, verso le 20.00 del 16 ottobre, nel fragore delle onde che si rompevano contro la scogliera, la poppa urtò il fondale roccioso e in breve tempo l'intero scafo fu sospinto contro la costa disintegrandosi. Uno dopo l’altro i tre alberi d’acciaio caddero devastando il ponte e uccidendo un membro dell’equipaggio. Le sovrastrutture e le lance di salvataggio furono spazzate in mare dalle onde che poi le scagliavano sulle spiagge e sulle rocce diventando proiettili devastanti per chi si trovava nel loro raggio d’azione. In quella notte di tregenda i naufraghi del veliero di Camogli, si trovarono soli con se stessi in quel mare nero macchiato a tratti di schiuma viva e traditrice.
Qui comincia l’incredibile storia dei superstiti del Georges Valentine.
Il marinaio svedese Victor Erickson, trascinando a braccia l’esausto ufficiale Ernest Bruce, risalì l’impervia costa rocciosa fino a raggiungere la Casa Rifugio di Gilbert's Shoal. Giunto ormai al limite delle forze riuscì con eroico senso del dovere a dare l’allarme e organizzare insieme a Capitano William Rea, responsabile della struttura, l’immediata ricerca degli altri naufraghi.
Erickson non si diede per vinto. Dopo aver raggiunto la sommità del crinale roccioso, cominciò a brandeggiare la lanterna di Capitan Rea per richiamare l’attenzione dei suoi compagni ancora in difficoltà. Le ricerche durarono tutta la notte e per fortuna si conclusero con il ritrovamento di altri cinque uomini. La loro forza di volontà fu premiata, ma per il marinaio svedese e il guardiano Rea si trattò di una tremenda sfida ingaggiata contro il vento impetuoso che scagliava loro addosso le travi di bordo come fossero ramoscelli.
I naufraghi avevano riportato ferite, lacerazioni e fratture agli arti, ma furono aiutati a raggiungere la Casa Rifugio, dove furono curati e rifocillati.
Mancavano all’appello l’allievo ufficiale Prospero Modesti, il nostromo Francesco Schiaffino detto “Barbasecca” e il dispensiere Filippo Chiesa. Erano tutti di Camogli e non furono mai più recuperati. I resti del Georges Valentine divennero la loro tomba.
Il 17 ottobre 1904, quattro giorni dopo il naufragio, la nave spagnola “Cosme Calzado” s’incagliò tre miglia a nord del Georges Valentine. Dei sedici uomini d'equipaggio uno solo annegò perché rimase imprigionato nel sartiame. I superstiti riuscirono a guadagnare la spiaggia e a rifugiarsi in un capanno di fortuna. Ben presto furono ritrovati e condotti alla “Casa Rifugio” dove furono ospitati insieme all'equipaggio del Georges Valentine.
Capitan Rea e sua moglie si presero cura di tutti i naufraghi finché si rimisero in forze per intraprendere il viaggio verso le loro case. Il buon guardiano ebbe in seguito a dichiarare: “Non avevamo mai avuti tanti naufraghi ricoverati insieme nella Casa Rifugio: scozzesi, russi, italiani, spagnoli e svedesi, per la prima volta eppure, grazie a Dio tutto è andato bene e tutti hanno collaborato. Quando finalmente li ho accompagnati a Jacksonville per il rimpatrio tutti gli uomini mi hanno salutato sull'attenti e il Capitano Mortola, abbracciandomi, mi ha detto commosso “Good-bye Captain, non ci rivedremo più'”.
Gli equipaggi dei due velieri rientrarono in patria, tranne un russo, Edward Sarkenglov, che cambiò nome in Ed Smith e divenne un pescatore locale, conosciuto come “Big Ed”. Capitan Rea e sua moglie rimasero nella Casa Rifugio sino al maggio 1907.
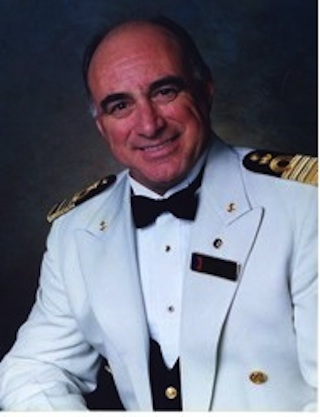
Il Comandante Roberto VOLPI di Camogli
Un'avventura incredibile, legata a Camogli e alla sua marineria! Dopo molti decenni, per la curiosità di un Comandante di Navi da Crociera, Roberto Volpi, viene alla luce uno di quei naufragi che chiameremmo spettacolari, e che una volta, purtroppo, non erano rari quando si navigava spinti soli dal “buon vento”.
Questa è la storia del Georges Valentine, una storia drammatica per la perdita di vite umane, ma anche di grande coraggio e immensa solidarietà. Una storia sconosciuta al di qua dell’Oceano fino a pochi mesi fa persino ai conservatori della Storia Marinara di Camogli del Museo Marinaro Giò Bono Ferrari che ringraziamo per avercela fatta conoscere.
Un RINGRAZIAMENTO particolare lo rivolgiamo al socio di Mare Nostrum comandante Bruno Malatesta che, venuto a conoscenza della Casa Rifugio e dell'epilogo del Georges Valentine, é volato in Florida per raccogliere dati, testimonianze e fotografie permettendoci così di pubblicare e diffondere in modo dettagliato la sua romanzesca storia.
Carlo GATTI
Rapallo, Lunedì 4 Maggio 2015






