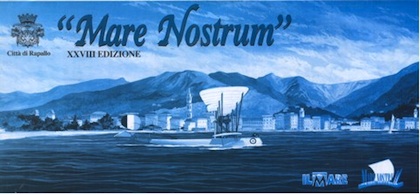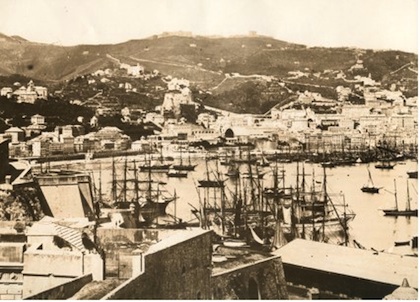GAZZANA PRIAROGGIA Gianfranco, un rapallese d'adozione
GIANFRANCO GAZZANA PRIAROGGIA
Un asso dei sommergibilisti atlantici della Regia Marina nella seconda guerra mondiale
di Maurizio Brescia
(dal n.ro 105 - giugno 2002 - di "STORIA Militare")
Questo articolo trae origine da una sezione - dedicata a Gianfranco Gazzana Priaroggia - della mostra "Mare Nostrum" (giunta nel 2006 alla 25a edizione), organizzata dal Comune di Rapallo e tenuta nel castello a mare della città ligure tra il 6 dicembre 2000 e il 6 gennaio 2001. Chi scrive ha curato questo specifico aspetto della rassegna, in ciò² coadiuvato dalla Famiglia Gazzana Priaroggia e dal locale Gruppo ANMI, di cui Gianfranco Gazzana Priaroggia é l'eponimo sin dalla sua fondazione.
Con undici mercantili affondati, per oltre 90.000 tonnellate di stazza lorda, Gianfranco Gazzana Priaroggia - decorato con Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria – E’ il sommergibilista italiano che conseguì i migliori risultati nel corso del secondo conflitto mondiale.
In aggiunta ad un'iniziale formazione nell'arma subacquea della Regia Marina durante la seconda metà degli anni Trenta, ebbe inoltre - prima di assumere egli stesso la responsabilità del comando - la possibilità di affinare ulteriormente la preparazione tecnica e le qualità militari operando in zona di guerra, in Atlantico, quale "secondo" del comandante Fecia di Cossato.
Nato a Milano il 30 agosto 1912 (figlio del N.H. Vittorio, avvocato, e della N.D. Maria dei Marchesi Cavriani - originari di Novi Ligure), Gianfranco Gazzana Priaroggia seguì la famiglia nei suoi spostamenti in Liguria: a Chiavari durante la prima guerra mondiale, a Genova dal 1920 e, dal 1941, a Rapallo ove ha abitato sino alla sua morte la sorella e ove risiedono tuttora altri componenti del nucleo familiare.
La vicinanza con il mare influì sicuramente sulla scelta di Gianfranco Gazzana Priaroggia di intraprendere la carriera militare nella Regia Marina: entrato all'Accademia Navale di Livorno nel 1931, dopo aver preso parte alle crociere addestrative del 1931 (sull'Amerigo Vespucci) e del 1932 (sul Cristoforo Colombo), venne nominato aspirante guardiamarina nel 1934 e promosso guardiamarina il 20 gennaio 1935.
Dopo una prima destinazione a bordo dell'incrociatore pesante Trento, all'inizio del 1936 imbarcò² sul gemello Trieste, venendo nominato sottotenente di vascello il 16 gennaio. Pochi mesi dopo, Gianfranco Gazzana Priaroggia entrò² a far parte della componente subacquea della Regia Marina e, nel breve volgere di quattro anni, venne destinato - con incarichi di sempre maggiore responsabilità - sui sommergibili Millelire (a bordo del quale prese parte a una missione durante la guerra di Spagna) (1), Sciré, Balilla e Malachite.
Il 22 gennaio 1940 giunse la nomina a tenente di vascello e, con essa, la destinazione a bordo del sommergibile Durbo in qualità di ufficiale in seconda. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, Gianfranco Gazzana Priaroggia imbarcò² - sempre come "secondo" - prima sul Malachite e poi (l'11 febbraio 1941) sul Tazzoli, all'epoca al comando del già famoso capitano di corvetta Carlo Fecia di Cossato. L'imbarco sul Tazzoli comportò² anche il suo passaggio alle dipendenze del "Comando Superiore delle Forze subacquee italiane in Atlantico", costituito a Bordeaux sin dal settembre 1940.
Sul Tazzoli a Bordeaux
Gli accordi tra la Kriegsmarine e Regia Marina, infatti, prevedevano la partecipazione di quest'ultima alla guerra sottomarina in Atlantico, e la scelta italiana per una base logistico-operativa per i propri sommergibili cadde sul porto fluviale di Bordeaux, ubicato sulla Garonne, a una cinquantina di chilometri a monte della via fluviale d'accesso al Golfo di Biscaglia, originata dalla confluenza della Garonne e della Dordogne nell'ampio estuario della Gironde.

A bordo del Tazzoli al rientro a Bordeaux dopo una missione di guerra in Atlantico. In primo piano, da sinistra: il comandante Carlo Fecia di Cossato e Gianfranco Gazzana Priaroggia (coll E.Bagnasco)
Dalla "B" ("Beta"), lettera iniziale di Bordeaux, venne tratta la denominazione di "Betasom" (Bordeaux - Comando sommergibili) che, da allora, non soltanto nei documenti ufficiali - ma anche nell'immaginario collettivo - avrebbe contraddistinto la base atlantica dei battelli della Regia Marina.
A bordo del Tazzoli Gianfranco Gazzana Priaroggia prese parte a quattro missioni nel corso delle quali il battello italiano affondò² 10 mercantili nemici per un totale di 54.362 tonnellate. Il comandante Fecia di Cossato fu - sicuramente - un'ottima guida per il suo ufficiale in seconda ( o "tenente", come era allora definito) che, il 21 febbraio 1942, venne destinato al comando del sommergibile Archimede, anch'esso di base a Bordeaux.
L'Archimede faceva parte della classe "Brin", composta da cinque unità (Brin, Galvani, Guglielmotti, Archimede e Torricelli) realizzate dai Cantieri Tosi di Taranto, entrate in servizio tra il 1938 e il 1939 e inizialmente armate con un cannone da 100/43 installato su una struttura brandeggiabile posta nella parte alta, verso poppavia, della falsatorre. Successivamente, il cannone da 100/43 fu sostituito con un pezzo da 100/47 sistemato nella più¹ tradizionale posizione in coperta, a proravia della falsatorre sul ponte di coperta (2).

Il sommergibile Archimede da “grande crociera” nel momento del varo
Al comando dell’Archimede
Con l'Archimede, Gianfranco Gazzana Priaroggia lasciò² Bordeaux per la sua prima missione in qualità di comandante il 26 aprile 1942, facendo rotta verso le coste settentrionali del Brasile, ma le consistenti misure antisommergibili predisposte nella zona dalle forze navali statunitensi limitarono notevolmente l'operatività del battello in quell'area. Cionondimeno, il 23 maggio, venne condotto un attacco contro una formazione navale americana (3) che, però², non portò² ad alcun esito. Ormai in procinto di intraprendere la navigazione di ritorno, l'Archimede affondò² il 15 giugno il mercantile panamense Cardina facendo rientro a Bordeaux il 4 di luglio.

A sinistra: Una intensa espressione di Gianfranco Gazzana Priaroggia a bordo dell’Archimede. A destra: Sempre a bordo dell’Archimede con alcuni membri dell’equipaggio
Il 10 agosto 1942 Gianfranco Gazzana Priaroggia passò² al comando del sommergibile Leonardo Da Vinci, un battello più¹ grande e più¹ moderno, appartenente alla classe "Marconi" di cui quattro unità (Maggiore Baracca, Michele Bianchi, Alessandro Malaspina e Luigi Torelli) erano state costruite dai Cantieri OTO del Muggiano e due (Guglielmo Marconi e Leonardo Da Vinci) dai Cantieri Riuniti dell'Adriatico di Monfalcone (4). Il Da Vinci, varato il 16 settembre 1939, era entrato in servizio il 7 aprile 1940. Le prestazioni dei battelli classe "Marconi" erano sostanzialmente analoghe a quelle dell'Archimede, ma il progetto di questi sommergibili era di concezione più¹ avanzata e li rendeva maggiormente adatti alle lunghe navigazioni oceaniche.
Nel settembre del 1942 il battello venne sottoposto ad alcune modifiche (sbarco del cannone ecc.) per effettuare delle prove di trasporto e rilascio di un piccolo sommergibile d'assalto, il CA 2, con il quale la X Mas aveva in progetto un attacco a New York. Conclusisi con successo gli esperimenti, il Da Vinci fu riportato in condizioni operative e, il 7 ottobre, lasciò² Bordeaux agli ordini di Gianfranco Gazzana Priaroggia, alla sua seconda missione atlantica come comandante.
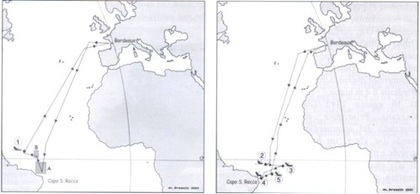
Le missioni di Gazzana Priaroggia
A sinistra:
Missione dell'Archimede (dal 26/4/1942 al 4/7/1942)
A) Zona operativa a Nord di Fortaleza (Brasile)
B) Zona più¹ a settentrione ove il battello italiano venne successivamente inviato Unità affondate nel corso della missione:
1) Piroscafo panamense Cardina (15/6/1942)
A destra:
Prima missione del Da Vinci (dal 7/10/1942 al 6/12/1942)
Unità affondate nel corso della missione:
2) Empire Zeal (inglese - tipo "Empire", 2/11/1942)
3) Piroscafo greco Andreas (4/11/1942)
4) Marcus Whitman (statunitense - tipo "Liberty", 10/11/1942)
5) Piroscafo olandese Veerhaven (11/11/1942)

Il Leonardo Da Vinci nel 1940 (coll.A.Fraccaroli)

Un picchetto di marinai del Reggimento "San Marco", di cui un distaccamento era assegnato a Betasom, presenta le armi al Da Vinci in arrivo a Bordeaux dall'Italia il 31 ottobre 1940. (Coll. E. Bagnasco)
Il passaggio al Da Vinci
"Betasom" aveva nuovamente assegnato al battello una zona di operazioni al largo della costa brasiliana (nel caso specifico a NE di Capo San Rocco) e in quest'area - tra il 2 e l'11 novembre 1942 - il Da Vinci affondò² in rapida successione quattro mercantili di quattro diverse nazionalità (Empire Zeal, tipo "Empire", inglese - Andreas, greco - Marcus Whitman, tipo "Liberty", americano - Veerhaven, olandese). Più¹ specificatamente, la terza e quarta unità vennero affondate a N di Recife, dove il Da Vinci si era spostato per evitare gli attacchi degli idrovolanti "Catalina" dell'U.S. Navy di base a Natal; il Veerhaven, in particolare, fu affondato a cannonate poiché il Da Vinci aveva ormai esaurito la propria dotazione di siluri.

Il piroscafo olandese Veerhaven, affondato dal Da Vinci l'11 novembre 1942. (coll. Mike Cooper)
Durante la navigazione di ritorno, il 28 novembre a N delle isole Canarie, il Da Vinci trasbordò² 30 tonnellate di nafta sul Tazzoli che - a sua volta - era diretto verso la propria zona di operazioni a N della costa brasiliana. La missione del Da Vinci, coronata dai notevoli successi appena descritti, ebbe termine a Bordeaux il successivo 6 dicembre.
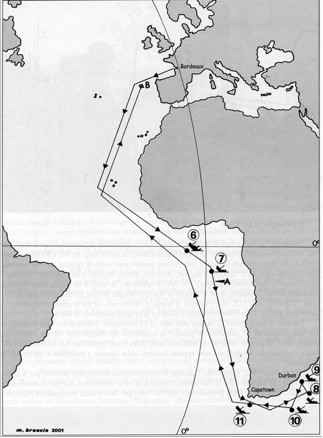
Seconda missione del Da Vinci (dal 20/2/1943 all'affondamento - 23/5/1943)
Unità affondate nel corso della missione:
|
6) "Liner" Empress of Canada (inglese, 14/3/1943) |
|
7) Piroscafo inglese Lulworth Hill (19/3/1943) A) Rifornimento dal Finzi (20/3/1943) |
|
8) Piroscafo olandese Sembilan (17/4/1943) |
|
9) Piroscafo inglese Manaar (18/4/1943) |
|
10) John Drayton (statunitense - tipo "Liberty", 21/4/1943) |
|
11) Petroliera inglese Doryssa (25/4/1943) B) Affondamento del Da Vinci (23/5/1943) |
Nel gennaio 1943, Gianfranco Gazzana Priaroggia tornò brevemente in Italia per trascorrere quella che sarebbe stata la sua ultima licenza e, il mese successivo, era già nuovamente in forza a "Betasom", impegnato nella preparazione del Da Vinci per una nuova, impegnativa missione. Infatti, viste le sempre maggiori difficoltà incontrate dai nostri sommergibili nell'Atlantico centrale (ove il traffico alleato di mercantili non facenti parte di convogli veniva sempre più¹ ridotto), Supermarina aveva da qualche tempo iniziato a studiare la possibilità di inviare alcuni battelli nell'Oceano Indiano meridionale dove - al contrario - quasi tutte le navi da carico alleate navigavano isolate e senza scorta. Per la prima missione di questo tipo venne per l'appunto prescelto il Da Vinci e, in considerazione della durata della navigazione e dell'autonomia del sommergibile, era previsto che - a S del Golfo di Guinea, circa 550 miglia a ENE dell'Isola di Sant'Elena - venisse effettuato un rifornimento di nafta e viveri dal Finzi, espressamente inviato nella zona.
Il Da Vinci salpò² da Bordeaux il 20 febbraio 1943 e - ancor prima di rifornirsi dal Finzi il 20 marzo - silurò² e affondò² il 14 marzo, una settantina di miglia a S dell'equatore, il "liner" Empress of Canada - che, con 21.517 tonnellate di stazza, fu la più¹ grande unitò mercantile affondata da sommergibili italiani nel corso del conflitto - e, quattro giorni dopo, il mercantile Lulworth Hill, entrambi britannici.
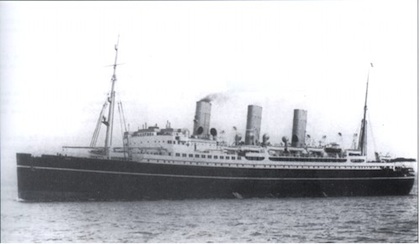
Il "liner" britannico Empress of Canada, qui in una fotografia della fine degli anni Trenta, apparteneva alla Compagnia Canadian Pacific Steamship Ltd. di Londra. Fu silurato e affondato dal Da Vinci, a S del Golfo di Guinea, il 14 marzo 1943. (coll. John Clarkson, via Mike Cooper)
L'affondamento dell'Empress of Canada, diretto a Durban (Sud Africa) da Takoradi (Golfo di Guinea), risultò² particolarmente drammatico poiché, tra gli oltre 1.400 passeggeri trasportati, si trovavano circa 500 prigionieri di guerra italiani che perirono numerosi nell'evento. Uno solo, il sottotenente medico del R.E. Vittorio Del Vecchio, venne tratto in salvo dal Da Vinci e, in occasione del già citato rifornimento, trasbordato sul Finzi (5).
Dopo aver doppiato Capo Agulhas il 5 aprile, il sommergibile comandato da Gianfranco Gazzana Priaroggia fece il suo ingresso nell'Oceano Indiano e raggiunse la propria zona di agguato al largo di Durban (Sud Africa) ove, tra il 17 e il 21 aprile 1943, affondò² i mercantili Sembilan (olandese), Manaar (inglese) e il "Liberty" John Drayton (americano). Inoltre, durante la navigazione di rientro, sempre al largo delle coste sudafricane (180 miglia a S di Port Elizabeth), il Da Vinci affondò² un'ultima unità - la petroliera britannica Doryssa che, proveniente da Table Bay (Sud Africa), stava navigando in zavorra diretta ad Abadan (Golfo Persico).

Un particolare della falsatorre del Da Vinci in missione in Atalntico e Gianfranco Gazzana Priaroggia a bordo dello stesso battello. (g.c. Fam. Gazzana Piaroggia)
Dopo aver conseguito nella sua seconda missione nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano questi congrui risultati, (che, tra l'altro, fanno del Da Vinci il sommergibile italiano che ottenne i maggiori successi in una sola navigazione), il comandante Gianfranco Gazzana Priaroggia intraprese la lunga navigazione di ritorno che avrebbe richiesto circa un mese per poter raggiungere la base di Bordeaux.
In considerazione del numero dei mercantili affondati e per l'ottima riuscita della missione, il 6 maggio 1943 Gianfranco Gazzana Priaroggia ricevette via radio, "sul campo", la promozione a capitano di corvetta per meriti di guerra: tutto era ormai pronto per una dovuta e trionfale accoglienza a Bordeaux, quando la dura legge della guerra impedì il ritorno del Da Vinci nella sua base atlantica.
Inizialmente, la navigazione di rientro procedette senza eventi di rilievo nel Golfo di Guinea e, in seguito, a ponente delle Isole del Capo Verde, delle Isole Canarie e al largo di Gibilterra. L'ultima comunicazione del Da Vinci risale al 22 maggio 1943: il sommergibile informava "Betasom" che - dal giorno successivo - avrebbe intrapreso la prescritta navigazione occulta a partire dal meridiano 15°00'W, prevedendo di raggiungere Bordeaux il 29 maggio.

I Mercantili affondati da G.Gazzana Priaroggia con i sommergibili Archimede e Leonardo Da Vinci

Il mercantile olandese Sembilan, una delle tre unità affondate dal Da Vinci nell'Oceano Indiano (coll. Alex Duncan, via Mike Cooper)
La perdita del Da Vinci
Alle 11.45 del 23 maggio 1943, però², circa 300 miglia a ponente di Vigo (Spagna), il Da Vinci venne individuato con il sonar ("asdic" nella terminologia britannica) dalla fregata inglese HMS Ness che, insieme ad altre unità della Royal Navy, faceva parte della cintura difensiva esterna di un convoglio alleato (6).
L'HMS Ness, al comando del Lieutenant G.P. Krieck, richiese l'intervento del cacciatorpediniere HMS Active, ed entrambe le unità sferrarono un attacco combinato contro il Da Vinci, effettuando diversi passaggi sul punto della posizione stimata del sommergibile con il lancio di numerose bombe di profondità . Come riportato dalla relazione britannica sui fatti, attorno alle 12.00 furono uditi numerosi boati in profondità e, in superficie, affiorarono rottami e materiali facendo ritenere praticamente certo l'affondamento del sommergibile individuato dalla HMS Ness.
Nel dopoguerra, l'esame comparato delle documentazioni ufficiali delle marine inglese, italiana e tedesca ha permesso di accertare che il sommergibile affondato il 23 maggio fu proprio il Da Vinci: nessun altro battello italiano o germanico venne attaccato quel giorno in quella zona e, tanto più¹, le coordinate del punto di affondamento del Da Vinci (42°05'N, 15°34'W) si trovano esattamente sulla rotta che il sommergibile avrebbe dovuto mantenere per raggiungere Bordeaux.
Insieme al comandante scomparvero tutti i 62 membri dell'equipaggio e non si ebbe alcun superstite. Alla memoria di Gianfranco Gazzana Priaroggia, già decorato con numerose onorificenze italiane e tedesche (7), venne concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare; tutti gli altri membri dell'equipaggio del Da Vinci furono decorati con la Croce di Guerra al Valor Militare alla memoria.

La fregata Ness, che il 23 maggio 1943 individuò² il Da Vinci con l'apparato sonar di bordo, qui in una fotografia risalente alla fine dello stesso anno. Apparteneva alla classe "River", di cui diverse decine entrarono in servizio con la Royal Navy tra il 1942 e il 1943; la Ness venne radiata verso la metà degli anni Cinquanta. (g.c. Biblioteca "A. Maj" - Bergamo - Fondo Occhini)

Il cacciatorpediniere Active (qui in una foto risalente al 1937) apparteneva alla classe "A" del 1929-30, Insieme alla fregata Ness prese parte all'azione che si concluse on l'affondamento del Da Vinci il 23 maggio 1943. (g.c. Biblioteca "A. Maj" - Bergamo - Fondo Occhini)
Gianfranco Gazzana Priaroggia è stato il sommergibilista italiano che ha conseguito, in termini di tonnellaggio, i migliori risultati nel corso del secondo conflitto mondiale, affondando undici unità per 90.637 tsl di naviglio nemico. Va peraltro ricordato che Carlo Fecia di Cossato (anch'egli decorato con la massima onorificenza al Valor Militare), pur occupando il secondo posto in questa particolare classifica con "soltanto" 82.821 tsl di mercantili alleati, con un totale di sedici unità risulta il miglior esponente dell'arma subacquea della Regia Marina considerando il numero delle unità nemiche affondate.
Anche dagli avversari di un tempo, dai membri degli equipaggi fatti prigionieri e dagli stessi Comandi della Royal Navy, Gianfranco Gazzana Priaroggia fu sempre riconosciuto quale nemico leale, cavalleresco, ricco di umanità e contraddistinto da capacità marinaresche di assoluto rilievo.
Non a caso, uno dei migliori giudizi su Gianfranco Gazzana Priaroggia é stato dato dagli autori tedeschi Bodo Herzog e Gunther Shoemajers nel loro libro "Ritter der Tiefe Graue Wolfe", ancorché riguardante soprattutto i noti successi degli "U-boote" della Kriegsmarine nella seconda guerra mondiale:
"La seconda navigazione del "Da Vinci" fu quella di maggior successo che un sommergibile italiano avesse compiuto in una sola missione. . . . Gianfranco Gazzana Priaroggia affondò² oltre 90.000 tonnellate di naviglio: né il migliore tra i comandanti americani, O'Kane, né il migliore tra quelli inglesi, Wanklyn, raggiunsero il tonnellaggio affondato da Gazzana Priaroggia. E, tra i sommergibili, nemmeno il famoso giapponese "I-27" raggiunse quello affondato dal "Da Vinci". La Marina Italiana perse insieme al "Da Vinci" un valoroso comandante e un glorioso equipaggio."
La Marina Militare, dopo aver assegnato il nome di Gianfranco Gazzana Priaroggia al sommergibile ex-americano Volador (SS-490), operativo sotto bandiera italiana tra il 1973 e il 1983 (8), ne onora anche oggi la memoria, avendo nuovamente assegnato il suo nome a un moderno, recente battello - appartenente alla quarta e ultima serie della classe "Sauro" - entrato in servizio nel 1995.
Maurizio Brescia
L'autore e "Storia Militare" ringraziano per la collaborazione prestata: Famiglia Gazzana Priaroggia, Rapallo; Sig. Franco Bernardini, Presidente del Gruppo ANMI "G. Gazzana Priaroggia" di Rapallo; Sig. Emilio Carta, già responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune di Rapallo; Mr. Mike Cooper di Southport (Merseyside, Inghilterra), "Membership Secretary" del Naval Photograph Club, per aver fornito notizie e documenti iconografici relativi a molti dei mercantili affondati.
I mercantili affondati da G. Gazzana Priaroggia con i sommergibili Archimede e Da Vinci:
(I numeri corrispondono a quelli riportati sulle cartine)
1 - Cardina (Panama)
5.568 tsl; lunghezza 129 m, larghezza 16,5m, pescaggio 8m; 1 macchina alternativa, vel. 10,5 nodi.
Costruita nel 1919 dal cantiere J.F. Duthie & Co. di Seattle (U.S.A.), nel 1941 venne venduta ad armatori panamensi.
aff. 15/6/1942 - 03°55'N, 42°40'W (in zavorra da Buenos Aires a New York Via Trinidad).
2 - Empire Zeal (G.B.)
7.062 tsl; lunghezza 136 m, larghezza 17m, pescaggio 8,3m; 1 macchina alternativa, vel. 11,5 nodi.
Unità tipo "Empire"; varata il 29 dicembre 1941 dai cantieri Lithgows Ltd. - Kingston Shipbuilding Yard di Port Glasgow (Scozia) per la Compagnia J. Morrison & Son.
aff. 2/11/42 - 00°20'S, 31°03'W (in zavorra da Durban a Trinidad).
3 - Andreas (Grecia)
6.566 tsl; lunghezza 130m, larghezza 18m, pescaggio 9,3m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.
Varata nel 1919 dai cantieri Harland & Wolff di Belfast, negli anni Trenta faceva parte della Compagnia greca Ionian Steamship Co. del Pireo.
aff. 4/11/42 - 01°34'S, 23°22'W (da Trinidad a Alessandria d'Egitto via Durban - carico: 8.516 tons di merci varie e munizioni).
4 - Marcus Whitman (U.S.A.)
7.176 tsl; lunghezza 144,7m, larghezza 18,7m, pescaggio 9m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.
Unità tipo "Liberty" varata nel luglio 1942 dal cantiere Oregon Shipbuilding Co. di Portland per la Matson Navigation Co. di San Francisco.
aff. 10/11/42 - 05°24'S, 32°41'W in zavorra da Table Bay a Paramaribo).
5 - Veerhaven (Olanda)
5.291 tsl; lunghezza 138,1m, larghezza 17,7m, pescaggio 8,3m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.
Varata nel 1930 in Inghilterra dal cantiere W. Gray & Co., Ltd. di Sunderland per la Compagnia olandese Van Uden's Scheepvart en Agentuur Maatschappij, Nv Gebr di Rotterdam.
aff. 11/11/42 - 03°51'S, 29°22'W (da Rosario e Buenos Aires per Trinidad - carico: 7.824 tons di rinfusa di semi di lino).
6 - Empress of Canada (G.B.)
21.517 tsl; lunghezza 199m, larghezza 25,6m, pescaggio 10m; caldaie a vapore, 4 assi, vel. 21 nodi.
Varata nel 1922 dai cantieri Fairfield Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. di Glasgow, sino all'affondamento fece sempre parte della Compagnia Canadian Pacific Steamship Ltd. di Londra.
aff. 14/3/43 - 01°13'S, 09°57'W (da Takoradi a Durban - circa 1.400 passeggeri).
7 - Lulworth Hill (G.B.)
7.628 tsl; lunghezza 132,2m, larghezza 19,6m, pescaggio 9,1m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.
Varata nel 1940 dai cantieri W. Hamilton & Co. di Glasgow per la Dorset Steamship Co., Ltd.
aff. 19/3/43 - 11°00'S, 00°35'E (da Mauritius e Table Bay per Freetown e Mersey - carico: 10.510 tons di zucchero e merci varie)
8 - Sembilan (Olanda)
6.568 tsl; lunghezza 127m, larghezza 18m, pescaggio 10m; 1 macchina alternativa, vel. 12 nodi.
Costruito nel 1922 dai cantieri Maatschappij voor Scheeps-en Werktuigbouw "Fijenooord" di Rotterdam per la "Netherland Line",
aff. 17/4/43 al largo di Durban (da Glasgow per Durban, Port Said e Alessandria d'Egitto - carico: 4.823 tons di merci varie e munizioni).
9 - Manaar (G.B.)
8.007 tsl; lunghezza 150m, larghezza 20,6m, pescaggio 8m; caldaie a vapore, 3 assi, vel. 16 nodi.
Varata nel gennaio del 1942 dai cantieri W. Hamilton & Co. di Glasgow e posta al servizio del Ministry of War Transport dalla Compagnia armatrice T. & J. Brocklebank Ltd. di Liverpool.
aff. 18/4/43 - 30°55'S, 33°40'E (da Mombasa e Beira per Durban - carico: 4.400 tons di rame e cotone)
10 - John Drayton (U.S.A.)
7.176 tsl; lunghezza 144,7m, larghezza 18,7m, pescaggio 9m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.
Unità tipo "Liberty" varata nel settembre 1942 dalla North Carolina Shipbuilding Co. di Wilmington per la Compagnia A.H. Bull & Co. di New York.
aff. 21/4/43 - 33°25'S, 34°10'E (da Khorramshar e Bandar Abbas per Table Bay - carico: 9.000 tons di petrolio in fusti).
11 - Doryssa (G.B.)
8.078 tsl; lunghezza 158,4m, larghezza 19,3m, pescaggio 9m; 1 macchina alternativa, vel. 12 nodi.
Petroliera varata nel 1938 dai cantieri Hawthorn, Leslie & Co. di Hebburn on Tyne per la Anglo Saxon Petroleum Co. (meglio nota come "Shell Oil").
aff. 25/4/43 - 37°03'S, 24°03'E (in zavorra da Table Bay per Abadan).
Note
(1) Per la partecipazione alle operazioni navali della guerra civile, il Governo Spagnolo decorò² Gianfranco Gazzana Priaroggia con la "Medalla del Alzamiento".
(2) Classe "Brin" - caratteristiche tecniche: dislocamento: 913t in superficie e 1.266t in immersione; lunghezza f.t.: 72,7m; larghezza max.: 6,7 m; pescaggio: 4,5m; app. motore: due diesel Tosi (3.400hp) e due motori elettrici Ansaldo (1.300hp); velocità max.: 17 nodi in superficie e 8,5 in immersione; armamento (2a g.m.): un cannone da 100/47, due m.g. binate da 13,2mm e otto t.l.s. da 533mm (14 siluri); equipaggio: ca. 60 uomini. L'Archimede e il Torricelli furono costruiti sotto particolari condizioni di segretezza per sostituire gli omonimi battelli del 1931-34, di cui non si era ritenuto opportuno rendere di pubblico dominio il trasferimento alla Marina della Spagna Nazionalista, avvenuto nell'aprile del 1937.
(3) L'attacco dell'Archimede fu portato contro l'incrociatore Milwaukee (CL-5) e il cacciatorpediniere Moffett (DD-362) dell'U.S. Navy; inoltre, nella zona si trovavano l'unità appoggio aerei americana Thrush (AVP-3) nonché un piroscafo e un rimorchiatore, entrambi di nazionalità brasiliana.
(4) Classe "Marconi" - caratteristiche tecniche: dislocamento: 1.036t in superficie e 1.489t in immersione; lunghezza f.t.: 76,5m; larghezza max.: 6,8 m; pescaggio: 4,7m; app. motore: due diesel CRDA (3.600hp) e due motori elettrici Marelli (1.500hp); velocità max.: 18 nodi in superficie e 8 in immersione; armamento: un cannone da 100/47, due m.g. binate da 13,2mm e otto t.l.s. da 533mm (12 siluri); equipaggio: ca. 60 uomini.
(5) Tra i superstiti britannici dell'Empress of Canadavi fu anche Kenneth Krieck, fratello del comandante della fregata Ness che, poche settimane dopo, insieme al cacciatorpediniere Active avrebbe preso parte all'azione in cui venne affondato il Da Vinci.
(6) Tra i vari convogli britannici del periodo, solamente tre si trovavano in navigazione - il 23 maggio 1943 - nella zona in cui andò² perduto il Da Vinci: MKS13G (partito da Gibilterra il 22/5 per Liverpool, ove giunse il 24/5), KMF15 (partito dalla Clyde il 19/5 e arrivato a Orano il 28/5) e i due convogli OG90-KX10 (costituenti un'unico insieme operativo) che lasciarono Liverpool il 20/5 e arrivarono a Gibilterra il successivo 31.
(7) Gianfranco Gazzana Priaroggia, inoltre, era già stato decorato con due Medaglie d'Argento e tre di Bronzo al V.M., cinque Croci al Merito di Guerra e, dal Governo Tedesco, con la Croce di ferro di 2a Classe e la Croce di Cavaliere.
(8) Il Volador era un battello classe "Tench", ampiamente rimodernato dall'U.S. Navy nell'ambito del programma "Guppy III", trasferito alla Marina Militare insieme al gemello Pickerel(SS-524) che assunse il nome di Primo Longobardo.
Bibliografia
Bagnasco, E.: I sommergibili della seconda guerra mondiale, Parma, Albertelli, 1973
Bagnasco E., Rastelli A.: Sommergibili in guerra (2a ed.), Parma, Albertelli, 1994
Bernardini, F.: Un'eroica figura: Gianfranco Gazzana Priaroggia, in "Notiziario della Marina", aprile 1999
Caccia Dominioni, A.: Aria alla rapida n° 32, Gruppo ANMI Milano, settembre 1996
Hague, A., The Allied Convoy System 1939-1945, Annapolis, USNI, 2000
Hervieux, P.: I "Marconi" in guerra, in "STORIA Militare" n. 70 (luglio 1999)
Jordan, R., The World's Merchant Fleets 1939, Londra, Chatham Publishing, 1999
Mattesini, F.: Betasom, la guerra negli oceani, Roma, USMM, 1993
Mori Ubaldini, U.: I sommergibili negli oceani, volume XII della serie "La Marina Italiana nella seconda guerra mondiale", Roma, USMM, 1976
Raiola, G.: Uomini in Atlantico, Milano, Longanesi, 1973
21.3.2013
A cura del webmaster
Carlo GATTI
RELAZIONE Attività Mare Nostrum 2009
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
A N N O - 2 0 0 9
28° Edizione di MARE NOSTRUM

PREMESSA
Nell’anno che è appena terminato, l’Associazione si è mossa su due linee guida ben distinte:
la tradizione e la novità
Ciò significa che il Direttivo, pur muovendosi nel solco della tradizione, ha deciso d’intraprendere la strada di un necessario rinnovamento. Da questi due segmenti, portati avanti con eguale determinazione, è scaturito un anno molto impegnativo in cui si è decisa la Costituzione in Associazione di Mare Nostrum con Atto Notarile che alleghiamo.
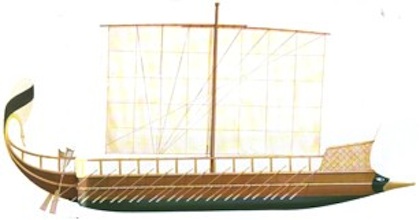
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
2.5-2009
Presso l’Oratorio dei Neri, si è svolto l’atteso appuntamento tutto rapallino:
“Il Naufragio della M/n LOCARNO sul lungomare”.
Grande affluenza di pubblico dinanzi ai relatori:
Emilio Carta e Carlo Gatti hanno rievocato storicamente e tecnicamente l’avvenimento invitando numerosi testimoni ad interloquire. Graditissimo è stato il filmato originale di Mauro Mancini e le numerose fotografie proiettate dal socio Ernani Andreatta.
14.5-17.5 / 2009
Si è concluso a Lavagna, presso il Porto Turistico, la Mostra-Expo TIGULLIO MARE. I reperti del Museo Marinaro del socio Nanni Andreatta hanno goduto di un ampio spazio in cui la nostra Associazione Mare Nostrum è apparsa per la prima volta in veste ufficiale. Tra i numerosi stands presenti, il "nostro" ha interpretato il concetto moderno di “mostra storica attiva”, proiettando interessanti filmati del socio E. Andreatta che hanno attirato numerosi visitatori, così come le pregevolissime stampe di navi e velieri, in versione telata di grande fascino e costo contenuto.
Compatibilmente con gli altri impegni di Mare Nostrum, G.Boaretto E.Carta/C.Gatti, G.Martini hanno dato la propria disponibilità inserendosi nel turno di guardia. Giancarlo Boaretto, il prezioso collaboratore del Museo Tommasino-Andreatta, ha partecipato con i suoi pregiati reperti da sub alla Mostra di Mare Nostrum divenendo pertanto nostro socio.
Altre adesioni: assessore alla cultura Gianni Arena - com.te Guido Martini e sua moglie Elvira Sbarbo - Avv. Elvira Indolfi.
16.5-2009
E.Carta/C.Gatti hanno partecipato per Mare Nostrum al convegno su “Navi di Linea-Polene-Sommergibili” che si è tenuto presso la Biblioteca Internazionale con sede a Villa Tigullio. Il numeroso pubblico ha calorosamente applaudito i relatori e la originale proiezione del filmato sull'U-455 di Portofino.
17.5-2009
Presso il Teatro delle Clarisse, Emilio Carta è stato al centro di "Prove Teatrali" per la versione in prosa del suo ormai celebre romanzo “I segreti di Cala dell'Oro che, trasformato in commedia teatrale dalla critica Etta Cascini, debutterà il 21 aprile 2010 con la Compagnia del Teatro Stabile RGG di Genova..
1.6-2009 Mare Forza/7
Si è svolta presso l'Oratorio dei Neri la 1° conferenza del programma con il patrocinio della rivista il MARE (dir.E.Carta) e di Mare Nostrum. E’ stato il turno di Mauro Mancini (poeta dialettale e cultore delle tradizioni di Rapallo), con racconti, proiezioni di foto, immagini, cartoline e testimonianze riprese da vecchi numeri della rivista IL MARE che ha superato brillantemente i cento anni d'età. E. Carta/C.Gatti hanno curato la presentazione. Buona partecipazione dei rapallini e dei nostri soci.
7. 6 - 2009
Il presidente C.Gatti è stato ospite per Mare Nostrum della n/pass. Costa Concordia a Savona. Le foto della nave sono disposizione per l’album della nostra Associazione.
12.6 -2009
In Comune, presente il Sindaco, il socio Gianni Arena (Assessore alla Cultura) e l'Assessore all’Istruzione, si è tenuta la premiazione del torneo di calcio abbinato a quattro libri di scrittori locali, intitolato "IL LIBRO E' ROTONDO". Quattro sono state le classi finaliste di due scuole di Rapallo. La manifestazione ha riscosso, curiosità, interesse, buona partecipazione dei ragazzi e desiderio generale di ripeterla sul modello sperimentato in tutta Italia.
Le Autorità si sono dimostrate, infatti, favorevoli all'iniziativa che sicuramente verrà riproposta anche in futuro. Un grazie particolare al sig. Silvano (Libreria Agorà) per l'impegno profuso. Ha vinto la squadra abbinata a "QUELLI DEL VORTICE" del presidente, che è felicissimo d'aver battuto il suo maestro Emilio Carta con "BANDIERA GIALLA- COLERA A BORDO" ed in successione l'esimio Prof. Federico Pastore con "LA RAGIONE E L'OCCULTO". Quarto in classifica, il libro di Sansò di cui non ricordo il titolo e me ne scuso, forse se aveva la tessera di socio me lo sarei ricordato...
Quindi, in breve, ha vinto MARE NOSTRUM con ben due soci al primo e secondo posto.
18.7-2009 Mare Forza/7
Con l'eccellente supporto informatico di E. Andreatta, E.Carta/C.Gatti hanno presentato l'ospite della serata: la signora Lilla Mariotti di Camogli. Lilla è una ricercatrice di "cose" di mare e per l’occasione ci ha intrattenuto con l'interessante storia dei Fari e Fanali partendo dall'antichità per arrivare fino ai giorni nostri. Il pubblico dell'Oratorio dei Neri, nello splendido giardino pensile, ha risposto, come sempre alla grande, dimostrando quanto la nostra iniziativa -"Mare forza 7 " - abbia ormai il suoi fedeli e affezionati supporters. Nell'occasione, due nuovi prestigiosi soci si sono aggiunti alla nostra Associazione: l'ing.navale (Fincantieri) Marco Prandoni e il cap. Umberto Ricci (noto storico locale e politico rapallese). Diamo a loro il nostro caloroso benvenuto.
Come già sapete, Mare Nostrum è legato profondamente alla Società Capitani e macchinisti navali di Camogli, della quale molti di noi fanno parte da molti anni (vedi sito internet). Dal loro direttivo ci è pervenuto l'invito a partecipare ad una preliminare esposizione dei libri scritti e pubblicati da Soci e associati capitani, ma anche da non soci che hanno testimoniato, tuttavia, l'amore per il nostro mondo marinaro con pubblicazioni sull'argomento.
1.8.2009 Mare Forza/7
Presso l'Oratorio dei Neri, è stato il turno del comandante N.Andreatta che ci ha raccontato la "splendida" quanto sconosciuta storia della LONGITUDINE (cronometro di Harrison). La conferenza è stata presentata da E.Carta/C.Gatti. Sono stati proiettati interessanti filmati storici concernenti il tema. L’avvenimento è stato patrocinato dal mensile il MARE e da Mare Nostrum. La serata ha proseguito con la storia sull'Armamento e Cantieristica di Recco nell'800. Le due affascinanti pagine di storia, hanno riscosso un successo veramente particolare, perchè ben pochi erano a conoscenza del fatto che Recco non è soltanto pallanuoto e focaccia, ma depositaria di tante tradizioni marinare ottocentesche. Il socio Andreatta ha anche raccontato (su richiesta del presidente) l'attività di costruttori navali svolta dal Cantiere Scogli di Chiavari che portò il prestigioso cognome di sua madre “Gottuzzo” (proveniente appunto da Recco). Abbiamo così saputo che ben 125 velieri oceanici sono stati costruiti dalla sua famiglia. E' stata così raccontata l'origine dei numerosi reperti che oggi fanno parte del Museo Andreatta di Caperana-Chiavari.
9.8. 2009
Organizzata da Rapallo Expo-2009, si è tenuta in piazza del Pozzo a Rapallo, una “variegata” conferenza. Per Mare Nostrum hanno preso la parola tre soci: Emilio Carta, con il racconto del relitto Mowack Deer. Carlo Gatti, con l’attività di Mare Nostrum. Umberto Ricci, con le tristi pagine della peste quando colpì Rapallo.
15.8. 2009 Mare Forza/7
Presso l’Oratorio dei Neri, il socio cap. Umberto Ricci ha tenuto l'interessante conferenza sul Circolo Nautico e Lega Navale di Rapallo, sulla base di un recente libro storico-documentale redatto in collaborazione col socio E/Carta. La Storia della città e quella dei due Clubs nautici si sono intrecciati sin dall'inizio del '900 coinvolgendo anche la politica cittadina. Il socio relatore ha ricordato i personaggi che hanno dato lustro allo sport della vela nel Tigullio. Si sono alternati interventi e dibattiti molto piacevoli, vivaci ed anche polemici sulla nascita e funzionalità del porto privato e sulla situazione turistica della città in generale (tema di grande attualità). Il pubblico è intervenuto numeroso, come il solito, ed ha dimostrato con numerosi applausi di gradire il nostro ciclo "Mare forza 7". Come sapete, le conferenze si sono tenute presso l'Oratorio dei Neri, la cui Confraternita ha supportato il ciclo insieme alla rivista mensile IL MARE e con la nostra Associazione Mare Nostrum, animata come sempre da E.Carta/C.Gatti.
Ringrazio i soci che ci seguono sempre con impegno ed entusiasmo, mentre un ringraziamento particolare va ad E. Andreatta indispensabile ed instancabile autore di DVD, montati ad hoc con scelta di testi e musica eccezionali. Il socio usa modernissimi apparati elettronici personali, garantendo spettacoli di sicura affidabilità, attualità e modernità.
Agosto 2009
Mare Nostrum è stata invitata all’evento “IL MARE CI UNISCE”. Il Comune di Camogli ha messo a disposizione dell'evento il Castel Dragone ed un gazebo per i libri in mostra. Aggiungo che l'idea della Società cap./macch. di Camogli mira al lancio di un "concorso nazionale letterario-marinaro " che è previsto per il 2011. I soci Carlo Gatti e Emilio Carta si sono dati disponibili.
Sabato 29.8-2009 Mare Forza/7
C.Gatti/E.Carta sono stati i conferenzieri che hanno chiuso il ciclo Mare Forza/7. Si è parlato del libro del Nuoto Masters, scritto dal presidente per rievocare anche l’ambiente delle Nagge, vecchio covo di nuotatori. E’ stato proiettato il bellissimo DVD creato dal socio N. Andreatta con testi di Emilio Carta e musica del ...socio ad honorem Ennio Morricone, sul tema caro ai rapallini - Il rione LE NAGGE - Durante l’amarcord sono stati ricordati i protagonisti di Rapallo: artisti, scrittori, poeti, nobili, ma soprattutto marinai e pescatori che hanno fatto la storia di questa spiaggia, le cui origini si perdono nel tempo, ma che affiorano qua e là negli scritti dei vecchi storici locali.
Il prof. Pietro Berri ci ha raccontato nel suo libro "Rapallo nei Secoli", che Pio VII, spedito in esilio per la seconda volta da Napoleone nel 1815, sbarcò alle Nagge, abbia sostato una notte presso l'ospedale S.Cristoforo (attuale albergo Europa) e sia ripartito, il giorno seguente, sempre dalle Nagge, tra il tripudio della gente. Pare che la prima parte della parola Ave-naggi risalga a quell'avvenimento, anche se le versioni alternative si sprecano.
Sono state molto apprezzate le testimonianze degli attuali personaggi delle Nagge: prof. Giorgio Odaglia, Rigoberto Vicentini e Alberto Ottonello che, insieme agli interventi dei soci, hanno animato la serata all'Oratorio dei Neri.
Colgo l'occasione per dare il benvenuto ad un nuovo socio: prof. Gian Paolo Buzzi.
Nel frattempo:
Continua la preparazione di Mare Nostrum in vista della Mostra al Castello e degli “eventi” connessi, che si terranno dal 3 novembre (inaugurazione) al 15 novembre (chiusura). Nel periodo indicato, oltre alla presentazione dell'annuale pubblicazione, avremo come 1° ospite lo scrittore e storico di fama internazionale Giorgio Giorgerini che ci intratterrà sul tema d'attualità "La nuova Pirateria intorno al globo: il caso Oceano Indiano" – Il 2° ospite sarà lo storico navale, scrittore ed editore Erminio Bagnasco che terrà una conferenza sulla “documentazione fotografica navale nella Seconda guerra mondiale”. Il 3° ospite della rassegna sarà Il cap. di fregata Marco Mascellani che ci parlerà invece dei "sommergibili ieri ed oggi".
Chi desiderasse acquistare, al prezzo-soci, i DVD relativi alla nostra attività sui temi che ogni volta vi abbiamo segnalato, può richiederli direttamente al suo unico autore Ernani Andreatta, (vedi mail-list) oppure al sottoscritto e sarà nostra cura produrli e distribuirli durante la Mostra.
sabato 17.9.2009
Si è svolto a Recco, presso la Sala multimediale “Franco Lavoratori” l'atteso Convegno sul tema HAVEN:
"La Tragedia e quanto rimane nei nostri ricordi".
L'Associazione Ardiciocca (Presidente ing.Ogno) ha organizzato l'incontro con il patrocinio dei Comuni di Recco/Camogli e con la collaborazione del Museo Marinaro di Camogli- La Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli- Mare Nostrum - Il Mare (periodico di Rapallo). Relatori: C.Gatti (storico e testimone), E.Carta (giornalista), A.Traverso (testimone), E.Andreatta (autore di un DVD sul relitto), Prof. G.Rellini (biologo). Il com.te B.Sacella (dir. Museo Marinaro di Camogli) ha presentato la manifestazione. Una bella cornice di pubblico ha assistito alla proiezione del film-documentario, davvero eccellente, (autore il nostro socio Com.te Andreatta) che ha spaziato dalla nascita del “gigantismo navale” petrolifero fino allo specifico tema della Haven con le tragiche foto relative alle 72 ore di agonia nel mare davanti ad Arenzano. I testimoni Gatti-Traverso hanno rievocato i momenti drammatici dalla prima esplosione fino all'affondamento della petroliera. Pilota in servizio e il Comandante di un rimorchiatore chiamato per un lavoro davvero speciale, hanno dato vita a momenti anche commoventi. E.Carta ha posto domande importanti e soprattutto mirate sull'attualità del mondo petrolifero. Il prof. Rellini ci ha tranquillizzato sulla situazione ecologica della zona interessata al relitto dandoci, con una interessante proiezione di slides una panoramica interessante e aggiornata sulla tematica. Il pubblico ha apprezzato particolarmente l'ascolto dell'intervista rilasciata alla RAI di Genova dall'eroico pilota portuale Giancarlo Cerruti che salvò con la sua pilotina ben 18 naufraghi della Haven che si erano tuffati in mare tra le fiamme. Il dialogo è stato improvvisato da E.Carta (RAI) e C.Gatti (G.Cerruti).
18-19-20. sett./2009
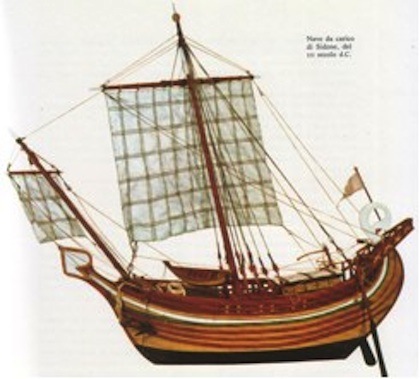
Si è conclusa a Camogli la rassegna cultural-marinara IL MARE CI UNISCE che si è svolta da venerdì a domenica. Con Mare Nostrum abbiamo partecipato attivamente nell'ambito "Prima Rassegna Di Testi Marinari" voluta ed organizzata dalla Soc. Capitani e Macchinisti di Camogli, di cui facciamo parte insieme con alcuni soci di Mare Nostrum. Il tempo variabile ha interrotto e disturbato qualche volta la successione degli eventi che ha avuto in ogni caso una buona affluenza di pubblico. Oltre alla presentazione di 60 testi di mare, la manifestazione è stata arricchita dalla magnifica presenza della Tall Ship "Pandora", da una decina di piccoli Leudi di Stintino (Sardegna) ed altri provenienti da località della tradizione. Importante è stata la presenza di intagliatori al lavoro, scultori (Franco Casoni), scuole di marineria, mostre di quadri interessanti ed altri gazebo d'arte marinara, parata di militari in costume, ed infine il celebre DRAGUN. Sul sito della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli si trova il rapporto completo degli avvenimenti. Una critica opportuna: sono state assemblate troppe "Chicche" nell' area ristretta della calata portuale. Purtroppo abbiamo anche riscontrato l'assenza di un coordinatore degli eventi. Pertanto, i rappresentanti hanno improvvisato le loro esibizioni rubandosi il pubblico che non aveva istruzioni su come procedere. L'idea è stata ottima, ma l'organizzazione dovrà migliorare parecchio e qualcuno dovrà prendersene carico. Negli stessi giorni analoga manifestazione dedicata al libro e al mare, curata dalla casa editrice Mursia, si è tenuta a Lerici, alla presenza di scrittori e velisti di caratura internazionale. All’incontro hanno partecipato tra l’altro i giornalisti-scrittori Fabio Pozzo originario di Recco (La Stampa) autore del volume “Assolvete l’Andrea Doria!” e per Mare Nostrum il socio Emilio Carta con “Il segreto di Cala dell’Oro” e “Bandiera gialla colera a bordo”. Carlo Gatti con “Quelli del Torregrande”, “Quelli del Vortice”, “Genova, Storie di Navi e Naufragi”.
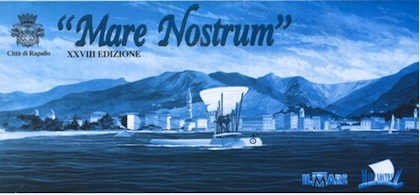
Con l'intento di offrire la massima visibilità alla Mostra - Eventi collaterali di MARE NOSTRUM, abbiamo raggiunto alcuni accordi pubblicitari con le testate del Secolo XIX e Corriere Mercantile.
Venerdì 30 ott. 09: Pagina Intera su Secolo XIX + Stampa-Mercantile
Venerdì 6 nov. 09: Mezza pagina su Secolo XIX + Pagina intera su
Stampa-Mercantile
Venerdì 13 nov. 09: Pagina Intera su Stampa-Mercantile
Sabato 31 ottobre 2009
Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune, con una buona partecipazione di pubblico, alla presenza delle massime Autorità cittadine e di studiosi, la Presentazione della 28° Mostra di Mare Nostrum e della annuale Pubblicazione – 2009, nonché degli eventi collaterali in calendario. La scrittrice camoglina Lilla Mariotti ha presentato, a seguire, il suo interessante libro "CACCIATRICI DI BALENE". Una ricerca, al femminile, di un argomento poco conosciuto e forse inedito, quindi molto apprezzato.
Sabato 7 novembre 2009
Presso la sala conferenze del Gran Caffé-Rapallo, Il socio prof. G. P.Buzzi ha presentato l’ospite, lo storico Giorgio Giorgerini che in seguito ha affrontato l'argomento di grande attualità: “La Pirateria sui Mari” dinanzi ad una sala gremita di pubblico. Sono intervenuti: C.Gatti/E.Carta/M.Brescia
Sulla rivista il MARE abbiamo dato ampio spazio al tema in programma e, per l'occasione, abbiamo riscontrato un forte interesse da parte di tutti. Giorgio Giorgerini è sicuramente il massimo esponente tra gli studiosi che hanno dedicato una vita alla minuziosa ricostruzione della Storia della nostra Marina. Ricordiamo che l’illustre ospite ha svolto un importante ruolo di Consigliere e Consulente dello Stato Maggiore della Difesa.
Sabato 14 novembre 2009
Presso la sala conferenze del "Gran Caffè Rapallo", il vicepresidente Maurizio Brescia ha presentato il com.te Erminio Bagnasco, direttore di "STORIA militare". Il gradito ospite ha tenuto la conferenza sul tema "La documentazione fotografica della guerra aeronavale italiana 1940-1945", con proiezione d’immagini d'epoca. La partecipazione alla conferenza, inserita nell'ambito delle manifestazioni collaterali alla mostra "Mare Nostrum 2009", è stata seguita da un folto pubblico. Nei giorni successivi, il comandante Erminio Bagnasco ci ha inviato il CD contenente le foto proiettate in sala. Qui di seguito riportiamo la graditissima lettera ricevuta dal nostro ospite.
Caro comandante C.Gatti,
Rientrato a Milano, voglio ringraziarti, anche a nome di mia moglie, per le infinite gentilezze e l'ospitalità ricevute a Rapallo in occasione dell'incontro promosso da "Mare nostrum".
Mi auguro che analoghi, piacevoli incontri possano ripetersi anche in futuro per i quali ti do fin d'ora la mia piena disponibilità.
Ancora complimenti per la vostra ottima organizzazione.
Un cordiale saluto.
Erminio Bagnasco
15.nov.2009
L'ultimo "relatore" del ciclo Eventi di Mare Nostrum 2009 doveva essere il capitano di fregata Mascellani il quale, purtroppo, alla vigilia della conferenza è stato aggredito dall’influenza "suina". Abbiamo pertanto ripiegato su un tema d'incontro molto caro ai liguri per la sua tragicità: La tragedia della Haven, che di recente avevamo tenuto a battesimo a Recco, su invito della Sociazione “Ardiciocca”. E' stato un successo per i seguenti motivi: il DVD creato appositamente dal socio com.te Nanni Andreatta, con il materiale del presidente (testimonial della tragedia), ha avuto un buon successo presso il folto pubblico. Il racconto di C.Gatti e gli interventi del com.te Andreatta, esperto di petroliere, hanno interessato la platea che in seguito ha rivolto intelligenti domande. Il socio Umberto Ricci, storico ed ex navigante, ha arricchito l'incontro con il suo intervento sempre brillante e molto simpatico. E' seguito un ricco quanto gradito "buffet" offerto da Mare Nostrum presso l'Hotel Europa dove si è felicemente concluso l'annuale appuntamento. Un grazie particolare al socio-segretario dott. D'este, che si è prestato, tra un impegno e l'altro, a presenziare e a testimoniare con la fotocamera ogni avvenimento. Anche il socio Claudio Molfino, espositore molto apprezzato, si è inserito nel turno al Castello, nonostante il suo impegno professionale. Altri soci, appena iscritti, si sono dati disponibili a collaborare con il Direttivo e credo che l'incremento costante degli impegni della nostra Associazione, non potrà fare a meno del loro supporto nelle prossime edizioni, per le quali ci daremo un assetto organizzativo ad ampio respiro.
15 Novembre 2009 - CHIUSURA MOSTRA
Si è chiusa la Mostra di Mare Nostrum 2009 con un flusso continuo di visitatori. Alla rituale cerimonia è intervenuto il socio-assessore alla cultura Gianni Arena, che ringraziamo particolarmente, perchè nell'occasione si è assentato dal Consiglio Comunale in corso e ci ha raggiunti al Castello per la consegna del ricordo (stampa del pittore di marina M.Locci) ai partecipanti alla Mostra. Mare Nostrum, al termine della cerimonia, ha invitato i partecipanti della 28a edizione al "speciale buffet" presso l'Hotel Europa. Questa è stata la prima volta in cui la "gente" di Mare Nostrum si è sentita unita, servita e riverita nel prestigioso Hotel e ce ne ha reso una gratificante testimonianza.
Devo dire, con grande soddisfazione, che quest'anno abbiamo avuto un incremento quantitativo e qualitativo di espositori, sia al piano superiore sia in quello inferiore presso i modellisti. Sarà raccolto il materiale fotografico, e conservato nell’album di Mare Nostrum. Pasquale "Cicci" Panella, comandante sup. d.l.c. da ieri è nostro socio. Cicci è noto per il suo modello "Cutty Sark" (campione del mondo), ma anche per essere prof. di astronomia, nonché autore di tre autorevoli libri nautici (purtroppo non pubblicati) dei quali mi onoro di possedere le prime fotocopie.
E’ sempre aperto l’invito ai soci-modellisti ad inviarci le foto dei loro modelli per farli conoscere anche ai soci lontani, al fine d’instaurare un dialogo storico-tecnico tra gli interessati. Ricordiamo ai nuovi soci che Mare Nostrum è nata da una costola dell'Associazione Modellisti Rapallesi di Nonno Franco.
A questo proposito ricordiamo che, per la prima volta, sono apparsi all'orizzonte due giovani modellisti sotto i 14 anni, che sono stati molto apprezzati. Con loro si proietta un cono di luce nuova e di speranza su una forma d'arte che purtroppo lancia segnali disperati d'allarme.... Silvano Porcile (Presidente), Mauro Rocca e Benito Sacco sono i tre alfieri-modellisti, nostri soci, sui quali ci appoggiamo ogni giorno sulla funzionalità della Mostra e per la risoluzione di tanti problemini. A loro dedichiamo un caloroso abbraccio colmo di gratitudine. Concludo con una nota di colore... Si ringrazia anche la gentile Jackline del Ghana, nuova guardiana del Castello, che sovente e spontaneamente si è offerta nella pulizia, nel trasporto e smontaggio del materiale espositivo.
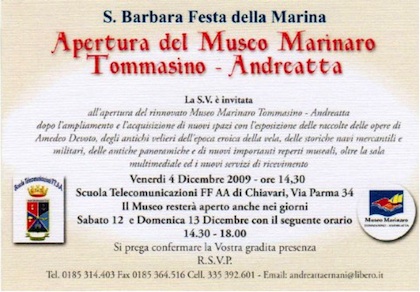
20 dicembre 2009
Il direttore Emilio Carta, c'informa che il 1° numero di RAPALLO NOTIZIE è in edicola fino ad esaurimento e che prosegue la distribuzione "gratis" di ben 15.000 copie nei locali pubblici e anche nelle case di Rapallo. Rendiamo noto che il nuovo mensile, editore Massimo Busco, ha mantenuto integralmente la redazione e i collaboratori del IL MARE.
Mare Nostrum augura "Vento in poppa e Buona Navigazione" al socio Direttore E. Carta e al presidente C.Gatti suo collaboratore in questa sua nuova avventura.
21 febbraio 2009
A cura dell’associazione culturale “La corallina” di Santa Margherita L., il giornalista Emilio Carta e il sub genovese Lorenzo del Veneziano sono stati protagonisti di un’avvincente conferenza su “Navi e relitti in Liguria - Le più recenti e misteriose scoperte” che si è svolta presso la sala convegni dell’Hotel Europa di Rapallo.
L’incontro è stato preceduto da un inedito filmato girato sui fondali della Liguria contenente le immagini dei principali relitti ritrovati tra le due riviere.
Come a noi è ben noto, Emilio Carta è l’autore autore della triplice opera “Navi e relitti da Montecarlo a La Spezia”, una importantissima ricerca che ha consentito, per la prima volta, la mappatura dei relitti di navi mercantili e da guerra, onerarie romane, sommergibili e aerei affondati nel mar ligure nel corso dei secoli.
Lorenzo Del Veneziano è un noto subacqueo cui si deve la scoperta di decine di relitti tra cui il recente ritrovamento dell’U Boot tedesco U 455 tra Portofino e Bogliasco e la rivisitazione del cosiddetto “relitto delle lanterne”.
13 novembre 2009
Vi allego la locandina di un' ulteriore interessante appuntamento cultural-marinaro curato della Società Capitani e Macchinsti Navali di Camogli.

Segue la lettera indirizzata al Comune avente per oggetto il
Calendario delle manifestazioni programmate dalla nostra Associazione
per l’anno 2010

Rapallo, 28 febbraio 2010
Spett.le
Comune di Rapallo
Piazza delle Nazioni, 4
16035 Rapallo (GE)
Alla cortese attenzione del
Signor Sindaco, Avv. Mentore Campodonico
e p.c.
Alla c.a.
Assessore alla Cultura, Rag. Gianni Arena
Oggetto: Progetto manifestazione MARE NOSTRUM 2010 – 29^ edizione
Preg.mo Signor Sindaco, preg.mo Assessore,
“Mare nostrum”, la manifestazione promossa dal Comune di Rapallo e dedicata al modellismo navale, alla storia, alla cultura ed alla documentazione marinara raggiunge quest’anno il prestigioso traguardo della ventinovesima edizione.
La “Associazione culturale Mare Nostrum Rapallo” è disponibile ad organizzare e a curare tutti gli eventi previsti in occasione della Mostra - ospitata sui due piani della cinquecentesca fortezza sul mare - compresa la predisposizione del relativo fascicolo storico e del depliant illustrativo afferente la manifestazione.
Di seguito si espongono brevemente gli aspetti salienti della manifestazione.
Curatori e collaborazioni
“Mare Nostrum Rapallo” si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Modellisti di Rapallo, guidata dal presidente Silvano Porcile, della competenza e della preziosa opera di volontariato dei propri soci, in particolare del giornalista-scrittore Emilio Carta, del sottoscritto presidente dell’Associazione comandante-scrittore Carlo Gatti, dello studioso e ricercatore della Marina Militare dottor Maurizio Brescia, del direttore del Museo marinaro Tommasino-Andreatta con sede presso la scuola Telecomunicazioni di Chiavari, comandante Ernani Andreatta, dell’appassionato d’arte Claudio Molfino. Si avvarrà inoltre della disponibilità del locale gruppo dell’Associazione Marinai d’Italia, che esporrà documenti e materiale storico-didattico della Marina Militare. La vocazione della nostra Associazione per la storia dei relitti e della subacquea, si avvarrà per la prima volta di uno stand con materiale espositivo d’epoca della Società MARES di Rapallo.
Sono stati inoltre avviati incontri propedeutici per dedicare la sala superiore alla Costa armatori, alla sua storia ed ai rapporti che la stessa famiglia Costa ha sempre avuto con Rapallo.
Come da indicazioni pervenute da codesto spettabile Comune, promotore dell’iniziativa, l’evento si terrà nelle sale dell’Antico Castello da sabato 30 ottobre (inaugurazione) al 14 novembre 2010 (chiusura). Per quanto precede, il Castello dovrà essere necessariamente messo a disposizione degli espositori il giorno precedente l’apertura ed il giorno seguente la chiusura per ovvie esigenze di allestimento/smantellamento della mostra.
Inoltre, sono previsti alcuni avvenimenti collaterali alla mostra quali: una conferenza stampa, la presentazione di libri a carattere marinaro, conferenze di esperti storici di assoluto valore, proiezione di documentari e filmati, tutti eventi che saranno tenuti nella Sala Consiliare comunale, o in altre sale di uguale prestigio, la cui concessione ed il cui utilizzo (gratuito) dovranno essere al più presto concordati con gli uffici comunali per le date di seguito indicate.
Calendario della manifestazione
Giovedì 28 – Venerdì 29 ottobre: Allestimento Mostra al Castello
Sabato 30 ottobre ore 10.30: Sala consiliare
Conferenza stampa per l’Apertura della 29° Edizione della Mostra di Mare Nostrum e presentazione della Pubblicazione di carattere storico curata da Maurizio Brescia, Emilio Carta e Carlo Gatti, alla presenza degli stessi autori.
Domenica 31 ottobre - ore 11,00: Lo specialista in modellistica statica e dinamica Angelo Parodi del Gruppo Modellisti di Rapallo, eseguirà la simulazione di una battaglia navale con “modelli dinamici-telecomandati” nella piscina scoperta dello stabilimento balneare ARISTON.
Lunedì 1° novembre (Tutti i Santi) – ore 11: conferenza al centro incontri del Gran Caffè Rapallo (sede sociale dell’Ass. Mare Nostrum) tenuta dal Comandante scrittore Mario Palombo, commodoro della Società Costa Crociere che avrà per argomenti la vita di mare, di come si navigava una volta e di come si naviga oggi, sulla manovra con moderni strumenti di navigazione, sulla salvaguardia ambientale e sicurezza oltre vari aneddoti divertenti. Saranno invitati alla conferenza personaggi del mondo dello shipping.
Domenica 7 novembre – ore 11: conferenza al centro incontri del Gran Caffè Rapallo del com.te Erminio Bagnasco sul tema “I mezzi d’assalto della 2° Guerra Mondiale”. Parteciperanno alla conferenza “testimonial” e importanti personaggi della marina tra cui il cap. Italo Ferraro, figlio della M.O. Luigi Ferraro.
Sabato 13 novembre (oppure) Domenica 14 novembre – ore 11: Presentazione libro Nanni “EPISODI DI MARE”. Verranno proiettati filmati inediti della 2° Guerra Mondiale con riferimento agli “Eroi del Tigullio”.
Domenica 14 novembre - ore 18: chiusura Mostra e saluto ai partecipanti
Lunedì 16 novembre – smantellamento della mostra
Orario apertura al pubblico:
Giorni feriali: ................................15-18
Giorni festivi e sabato: ................10-12; 15-18.30
Lunedì ...........................................giorno di chiusura
Le sale espositive
Antico Castello – sala al primo piano
Ivi saranno ospitati lo stand del locale gruppo della Marina Militare e la grande mostra espositiva sulla storia del mare e della navigazione attraverso il modellismo navale curata dall’Associazione modellisti “Nonno Franco” di Rapallo.
Antico Castello - sala al piano superiore
Ivi sarà esposto materiale storico iconografico della Società Costa Crociere, utilizzando le collezioni private del com.te Carlo Gatti, del curatore del Museo delle Telecomunicazioni com.te Ernani Andreatta, di Emilio Carta e dello studioso Maurizio Brescia.
Antico Castello - due salette al piano superiore
Ivi saranno ospitati:
- la mostra “Gli armatori Costa e Rapallo” con la riproduzione di materiale interessante a cura di Claudio Molfino.
- il materiale espositivo-didattico-museale messo a disposizione dal Curatore del Museo navale Tommasino-Andreatta, comandante Ernani Andreatta;
- Sala proiezioni per il pubblico con filmati di carattere storico e documentale navale;
Gestione della fase promozionale e operativa dell’evento
L’Associazione “Mare Nostrum Rapallo”, attraverso la propria struttura e personale esterno qualificato, è disponibile ad organizzare e gestire i seguenti “punti operativi” della manifestazione:
A. Realizzazione e stampa di n. 1.000 copie del fascicolo storico-illustrativo della Mostra, composto di 64 pagine e dal titolo (ancora provvisorio) “Gli Armatori Costa - La Famiglia, l’Armamento e le Navi” riportante testi scritti da Maurizio Brescia, Emilio Carta e Carlo Gatti, debitamente corredato da foto con relative didascalie.
B. Stampa di n. 5.000 depliants a quattro colori riportanti il programma dell’intera manifestazione unitamente a debite note illustrative dei contenuti delle varie sale espositive;
C. Realizzazione di uno stendardo promozionale e di un pannello mobile espositivo, posizionati a cura dell’Associazione all’’ingresso del castello;
D. Stampa di n. 100 locandine tipografiche contenenti il programma dell’evento;
E. Stampa di n. 100 locandine a 4 colori promozionale di Mare Nostrum;
F. Stampa di n. 100 stampe a colori della foto-icona da omaggiare agli espositori e alle varie personalità invitate;
G. Stampa n. 100 locandine promozionali della “Battaglia navale”;
H. Organizzazione della conferenza stampa illustrativa e stampa degli inviti relativi alla:
1) presentazione della mostra e della pubblicazione del fascicolo “Gli Armatori Costa-La Famiglia, l’Armamento e le Navi” alla presenza degli autori Maurizio Brescia, Emilio Carta, Carlo Gatti; (sabato 30 ottobre 2010 ore 11.00, Sala Consiliare)
2) presentazione del programma delle varie giornate dedicate a conferenze e proiezioni di filmati e documenti storici nonché i nominativi degli studiosi partecipanti di rilevanza nazionale (Sala Consiliare sabato 31 ottobre ore 10,30);
I. noleggio di televisore con videoregistratore DVD e filmati di carattere marinaro e navale, da proiettare in libera visione al pubblico al castello;
J. Spese di affissione delle locandine;
K. Presenza di idoneo personale per: distribuzione di locandine e depliants nei locali e nei principali punti di aggregazione, l’accoglienza dei visitatori nelle sale non custodite dal personale comunale e in appoggio, messa in opera di striscione e stendardo espositivi;
L. Ospitalità ai conferenzieri (rimborso spese, albergo e cena)
M. Eventuale affitto di sale conferenze in strutture private in caso di impossibile utilizzo della sala consiliare comunale;
N. Assicurazione dei modellini navali esposti attraverso idonea primaria società assicurativa;
O. Cocktail in occasione degli incontri e conferenze previste per Mare Nostrum;
Al fine di rendere possibile la manifestazione, a codesto spettabile Comune
si chiede
1. che la spedizione degli inviti venga effettuata per il tramite dei Vostri Uffici preposti;
2. l’utilizzo gratuito del videoproiettore e dello schermo, di proprietà del Comune, per le conferenze e proiezioni previste nella sala consiliare
3. la messa a disposizione gratuita di n. 17 pannelli elettorali metallici da utilizzare quali ripiani di appoggio per i modellini navali esposti al primo piano del Castello (i relativi cavalletti sono già presenti nel castello);
4. la messa a disposizione gratuita di n. 25 pannelli al secondo piano, con relativi supporti e plex di copertura;
5. l’erogazione di un contributo finanziario quantificato in euro 5.000,00 (euro cinquemila) per la copertura degli oneri previsti più sopra, ai punti da A. a O.
6. Offerta di un cocktail in occasione della conferenza stampa e presentazione della pubblicazione Mare Nostrum 2010 previsti nella sala consiliare in data sabato 31 ottobre 2010 alle ore 10,30;
Certi di un favorevole riscontro alla presente, resto in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e porgo deferenti saluti.
Associazione Mare Nostrum Rapallo
Il presidente - (Com.te Carlo Gatti)
SITO INTERNET
Proseguono i contatti del Direttivo per dotare Mare Nostrum di un sito internet. E’ nostra assoluta volontà poter sfruttare i mezzi di comunicazione moderni come il linguaggio informatico. Il nostro obiettivo finale è diffondere la nostra passione per il mare, la sua storia, la sua cultura e le sue problematiche. Vogliamo essere presenti su internet con un sito accattivante, che possa incuriosire i giovani e i meno giovani per avvicinarli, tramite un forum permanente, alla conoscenza della nave come risorsa economica umana tanto inestimabile quanto poco sconosciuta nel nostro Paese. Vogliamo entrare in internet per confrontarci con le altre Associazioni che hanno i nostri stessi obiettivi e per promuovere i nostri scritti che sono frutto di esperienza vissuta e degna di essere tramandata. Vogliamo entrare in internet per collegarci con i “liguri nel mondo” e donare ai “rapallini” delle Americhe e dell’Australia i nostri messaggi mensili contenuti in “Rapallo Notizie”. Vogliamo entrare in internet per ristabilire il cordone ombelicale con queste comunità che “sognano” la loro bella Rapallo e sperano che qualcuno si svegli un giorno pensando finalmente a loro. Il sito internet può anche diventare un veicolo di pubblicità e rendere risorse da investire in programmi sempre più ampi.
Il Presidente
Carlo GATTI
I RAPALLESI ALLA SPEDIZIONE DEI MILLE
I RAPALLESI ALLA SPEDIZIONE DEI MILLE
5 maggio 1860
In occasione del centocinquantesimo, 5 maggio 2010, anniversario dell’unità d’Italia ci sembra doveroso additare ai lettori tre coraggiosi Rapallini che, insieme ad altri 155 “pazzi” della Liguria (così l’ha definiti il Secolo XIX), hanno seguito volontariamente Garibaldi nell’impresa dei Mille ed hanno contribuito a darci una Nazione.
Questa immagine rispecchia fedelmente lo scenario portuale genovese nei giorni della famosa Spedizione dei Mille.
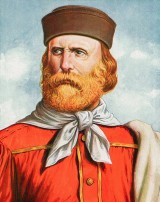
Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi

La stele rostrata dell’artista genovese Giovanni Scanzi è stata innalzata per commemorare i 50 anni della Spedizione dei Mille che da quel punto del porto prese inizio.
Anche Rapallo ha solide radici garibaldine. Ne parliamo con Umberto Ricci, cultore di storia locale
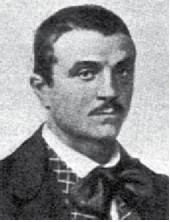
Bartolomeo Canessa, nato a Rapallo il 14 Marzo 1839, macchinista navale residente a Genova
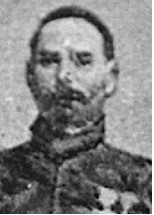
Lorenzo Pellerano, nato a Rapallo il 4 Luglio 1811, facchino residente a Livorno

Giovanni Pendola, nato a Genova (da genitori di San Maurizio di Monti - Rapallo) il 7 Marzo 1836, falegname mobiliere.
INTERVISTA del giornalista EMILIO CARTA
I tre moschettieri, gli indomabili spadaccini cari al mitico Alexandre Dumas, erano veramente tre oppure quattro? Cavalcando l’onda dell’ironia potremmo aggiungere: ma i garibaldini rapallesi erano quattro o sette?
Lo chiediamo all’amico e storico locale Umberto Ricci che, in questa stagione di ricorrenze ed eventi cari all’Unità d’Italia e ai suoi centocinquant’anni, ha provato a fare un po’ di chiarezza. Non certo sui moschettieri, quelli del “tutti per uno e uno per tutti” tanto invisi al cardinale Richelieu, quanto sulle più caserecce camicie rosse che non esitarono a seguire un certo Giuseppe Garibaldi a bordo del Piemonte e Lombardo.
A Rapallo in effetti, ad oggi, si ha notizia di Bartolomeo Canessa, Lorenzo Pellerano, Giovanni Pendola, Egisto Sivelli, Emanuele Figari, Lorenzo Pellerano e Giovanni Fontana. Giusto?
“Andiamo con ordine. Quattro garibaldini erano nativi di Rapallo ed in particolare Bartolomeo Canessa, Emanuele Figari, Lorenzo Pellerano e Giovanni Fontana. Per i restanti la situazione è leggermente diversa ma possiamo provare ad esaminare insieme il ruolo da loro con la nostra città.
Partiamo da Bartolomeo Canessa. Su di lui le notizie sono abbastanza frammentarie. Lo storico Poggi, nel suo “Dizionario del Risorgimento Nazionale – Fatti e persone ” - edito da Vallardi nel 1930, ne ricorda la figura anticipando di un giorno la data della morte effettiva ma si tratta proprio dello stesso Bartolomeo Canessa, nato a Rapallo il 14 marzo 1839, figlio di Benedetto e di Maria Canessa.
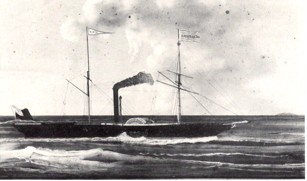
Il P.fo PIEMONTE sul quale imbarcò il fuochista rapallese Bartolomeo Canessa

Il P.fo LOMBARDO in un celebre dipinto d’epoca
Di mestiere faceva il fuochista (ovvero l’addetto alle caldaie in sala macchine) a bordo delle navi mercantili. Si trovava a Genova quando venne organizzata la Spedizione dei Mille “e la seguì"– sono ancora le parole di Poggi – "da modesto gregario qual era in mezzo a quei volontari da Quarto al Volturno”.
Assieme a quegli uomini colti dal sacro furore della Patria da unire portò la pelle a casa e, finita la Campagna, riprese l’esercizio della sua professione marinara continuandola con il grado di “macchinista”. Quindi si stabilì a Genova, trascorrendo gli ultimi anni di vita in agiato riposo, dove morì il 29 novembre 1890. Nell’elenco dei decessi come professione è designato “pensionato dei Mille”.
Dei vari quotidiani genovesi soltanto “L’Epoca” (di area di sinistra come si direbbe oggi) pubblicò un breve necrologio: “Dalle tavole necrologiche dello stato civile apprendiamo la morte del signor Bartolomeo Canessa di anni 51, pensionato, il quale fece parte della gloriosa schiera dei Mille. Deponiamo un fiore sulla tomba del patriota”.
Andiamo avanti!
Di Lorenzo Pellerano sappiamo soltanto che nacque a Rapallo il 4 luglio 1841. Aveva dunque meno di 19 anni quando si arruolò nella storica schiera, mentre 21 compiuti ne aveva il suo concittadino sopra citato. I ritratti qui pubblicati sono di entrambi, tratti da “L’illustrazione italiana” del maggio 1910, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell’impresa.
Forse il più citato fra i garibaldini di cui parliamo era Giovanni Pendola?
La Gazzetta Ufficiale del 1878 indica però Giovanni Pendola come nato a Genova anche se sulla lapide posta sul piazzale della chiesa di San Maurizio di Monti si legge “qui donde trasse origini”.
Il legame tra Rapallo e Giovanni Pendola però non faceva capo solo a un’origine più o meno remota. Abbiamo documenti che attestano una sua relazione con la località di San Maurizio di Monti, una radice molto sentita dimostrata dal fatto che a un certo punto della sua vita l’uomo decise di abbandonare Genova, dove pure era nato e vissuto, per trasferirsi nella frazione rapallese, luogo d’origine dei suoi antenati.
Giovanni Pendola era nato a Genova, nella parrocchia di Santa Zita nel 1836, figlio di Nicola e Nicoletta Castagneto. Dai registri parrocchiali di San Maurizio di Monti si ricava che il padre Nicola, figlio di Agostino, era nato nella frazione di Rapallo il 28 agosto 1812. Anche la madre si presume sia nata a San Maurizio di Monti.
Nicola Pendola era giunto a Genova nel 1830, in un momento storico e politico a dir poco tumultuoso. Infatti alcuni anni prima in una cava, che possiamo localizzare nell’attuale via Corsica, erano stati fucilati i rivoltosi che avevano partecipato ai moti della Giovane Italia, e l’influenza di Mazzini fra gli artigiani e gli scontenti del dominio dei Savoia era ben forte.
Si può quindi ipotizzare che Nicola Pendola, seppur arrivato dalla campagna si occupasse ben presto di politica. La sua prima residenza non fu all’interno della città di Genova bensì fuori delle mura, sulla riva sinistra del Bisagno, a Borgo Pila dove c’era, e c’è tuttora, una chiesa dedicata a Santa Zita. Un collegamento con la frazione di San Maurizio di Monte lo troviamo nei registri degli atti di matrimonio dell’anno 1859 quale testimone di un matrimonio.
Il figlio, Giovanni Pendola, però, fu un vero genovese, figlio degli anni tumultuosi seguiti al 1848 e divenne in breve tempo un seguace di Giuseppe Mazzini. Genova all’epoca era una città “di frontiera”, meta tra l’altro di numerosi profughi della Lombardia, regione dalla quale le idee repubblicane si diffondevano con sempre maggiore vigore fra gli artigiani.
La sua attività di falegname e commerciante - gestiva infatti un modesto negozio di vendita dei mobili che costruiva - lo portava spesso a contatto con quel ceto medio che trovava solidarietà nelle prime Società di Mutuo Soccorso che sorgevano appunto in quegli anni sulla scia del pensiero di Giuseppe Mazzini.
Rapallo, seppur in ritardo, fondò la sua Società di Mutuo Soccorso, l’ Aurora che nel 2010 ha compiuto i suoi cento anni di fondazione (1910-2010). Nella primavera del 1860, mentre Giuseppe Garibaldi riuniva i volontari per la spedizione in Sicilia, Giovanni Pendola liquidò l’azienda e si arruolò.
Partito da Quarto, durante la spedizione venne ferito in combattimento e, quindi, nominato Capitano. Al termine ritornò a Genova dove riprese la sua attività di falegname e fu tra i primi ad aderire alla Croce Rossa. Durante l’epidemia di colera che colpì la città a metà Ottocento primeggiò per coraggio fra i soccorritori.
A proposito di questo fatto, va ricordata la cessione di una foto con autografo di Giuseppe Garibaldi, scatto donato da quest’ultimo alla Marchesa Ernesta Cambiaso e da lei successivamente ceduta al garibaldino Giovanni Pendola a dimostrazione di riconoscenza della Marchesa, lei stessa crocerossina, per i servizi e gli aiuti resi dal Capitano durante l’epidemia alla popolazione genovese. Non sappiamo con certezza se Giovanni Pendola abbia partecipato direttamente alla politica nelle file repubblicane ma, da alcuni indizi, possiamo presumere una sua adesione a una loggia massonica genovese.
Il primo, naturalmente, è il carattere dell’associazione riformatasi in Italia al momento dell’Unità. Nelle file massoniche confluirono molti repubblicani e mazziniani. E molti furono i Mille che, prima o dopo la spedizione, aderirono alle logge. Giovanni Pendola non risulta in un elenco pubblicato di recente e neppure appare nel vari elenchi diffusi in appendice al libro.
Tuttavia a pagina 196 si legge che nel 1862, in occasione della morte di Giuseppe Garibaldi, “il fratello Pendola regalò due cornici fatte con il legno usato per la cassa funebre di Garibaldi”: Giovanni Pendola era falegname e quella cronaca ha quasi il sapore di una conferma.
Un altro indizio: la lapide che ricorda Pendola a San Maurizio di Monti è sovrastata da una stella. E’ una stella fiammeggiante che si incontra di frequente nella simbologia massonica e questa potrebbe essere stata incisa sulla lastra per comunicare in modo mascherato l’appartenenza di Giovanni Pendola all’istituzione, un’usanza frequentemente utilizzata in passato.
Ci furono anche polemiche legate alla sua morte?
Sul finire della sua vita - non si era mai sposato - sentì il forte richiamo delle colline rivierasche da cui erano partiti i suoi genitori. Si trasferì così a San Maurizio dei Monti dove visse (probabilmente da proprietario) nel Complesso Molitorio di Strada Antica di Monti, edificio oggi assurto a monumento nazionale.
Amava ripercorrere i suoi trascorsi, con voce suadente quanto autoritaria con chi l’aveva conosciuto ed era “avvezzo ad impartire ordini brevi, secchi, precisi, e ricordava volentieri i suoi amici migliori” riporta di lui “Il Mare” il 28 gennaio 1939.
Dopo una breve malattia, la morte lo colse nel 1907. I suoi funerali vennero però ricordati a lungo sulla collina. Si racconta infatti che il parroco di San Maurizio di Monti quel giorno pur di non celebrare il funerale ad un sovversivo anticlericale abbia chiuso, senza alcun preavviso, la porta della chiesa partendo per una località sconosciuta.
Ma da Rapallo – questa la cronaca riportata - giunse il deputato Cavagnaro accompagnato da un frate che portava un fazzoletto rosso al collo. Aperta la chiesa, Giovanni Pendola ebbe così il suo funerale e la salma venne inumata nel cimitero, coperta da uno strato di pietre di fiume (gea).
Per alcuni anni, in occasione della ricorrenza, nel piccolo cimitero la sua figura veniva ricordata con una cerimonia, che puntualmente era riportata sulla stampa locale.
Nel maggio 2010, come si può leggere su “Il Mare”, i rappresentanti dei Circoli mazziniani di Rapallo (SMS Aurora) e Genova (Libertà e Lavoro) lo commemorarono di fronte ad una grande folla. Ancor oggi, una lapide collocata nell’unica piazza di San Maurizio di Monti, ricorda Giovanni Pendola, mazziniano e garibaldino.
Il 12 agosto 2007 questa lapide è stata restaurata dall’Associazione culturale “La Cipressa” in occasione della ricorrenza del centenario della morte.
Se su uno di questi rapallesi che combatterono tra i Mille di Garibaldi, ci siamo appena soffermati diffusamente, ben di più furono i rapallesi che combatterono nelle battaglie del Risorgimento. Un elenco completo venne redatto a cura del Comune nel 1895 quando il giorno 20 settembre venne dichiarata Festa nazionale e, in occasione dell’inaugurazione del Vittoriano, il monumento nazionale dedicato a Vittorio Emanuele II (conosciuto anche col nome di Altare della Patria), ai reduci delle patrie battaglie venne assicurato un biglietto ferroviario a tariffa ridotta per recarsi a Roma alla celebrazione.
Giovanni Fontana non figura in questo elenco così come Emanuele Figari perché a quell’epoca il Fontana aveva già abbandonato la nostra città, dove era nato, da molti anni.
In suo nome non appare neanche nell’elenco dei Mille sbarcati a Marsala, perché in effetti in Sicilia era giunto qualche tempo dopo. Eppure Giovanni Fontana, rapallese, ha partecipato a molte battaglie del Risorgimento ed è stato amico e collaboratore di Mazzini contribuendo, nel suo piccolo, all’epopea risorgimentale partecipando alla lotta politica (e non solo) nel decennio successivo all’Unità d’Italia.
In Sicilia era giunto dopo che Garibaldi aveva già conquistato Palermo. E’ infatti noto che dopo la conquista della città, avvenuta nei primi giorni di giugno del 1860, le notizie della rapida avanzata di Giuseppe Garibaldi si erano diffuse rapidamente in Italia e in Europa grazie al telegrafo e alla stampa che avevano fatto da cassa di risonanza alla sua avanzata.
Di Egisto Sivelli l’unica prova che abbiamo è contenuta nell’elenco dei liguri sbarcati a Marsala, compilato da G. Garibotto, dei Mille.
L’ultima scoperta di un rapallese alla spedizione dei Mille è recente ed è stata pubblicata il 7 maggio 2010 da “Il Secolo XIX” dal titolo “Quel mio avo dimenticato che lottò per l’Unità d’Italia”: “…..Emanuele Figari nato a Rapallo il 15 dicembre 1839 e originario della frazione di San Quirico d’Assereto in Rapallo.
Si è conclusa così questa mia ricerca sui rapallesi che parteciparono alla spedizione dei Mille con la speranza che altri cultori di storia locale possano rintracciarne altri. Mai dire mai……..
BIBLIOGRAFIA
- Rivista “Rapallo” edita dal Comune di Rapallo dal 1958 al 1968. Articolo di P.L.Benatti
- “Il Mare” periodico settimanale politico amministrativo e culturale edito a Rapallo dal 1908
- Archivi della Memoria del dott. Agostino Pendola, cultore di storia locale
- Archivi della Memoria di Umberto Ricci , cultore di storia locale
- Archivio storico del Comune di Rapallo
OBBEDISCO!
di UMBERTO RICCI
Nel corso delle mie ricerche garibaldine ho scoperto anche alcuni episodi curiosi, successivi all’impresa dei Mille e legati alla successiva presenza a Rapallo di uomini che parteciparono alla gloriosa spedizione.
Il novarese Giovanni Pozzetti all’età di 72 anni muore in data 14 aprile 1914 a Rapallo. Da pochi giorni, dopo esserne stato il titolare, aveva ceduto il suo avviato Caffè Cavour (oggi Caffè Centrale). Lo riporta il periodico dell’epoca Il Mare: aveva partecipato alla seconda Spedizione dei Mille combattendo a Calatafimi e all’Aspromonte e per questo motivo gli erano state assegnate tre medaglie d’argento.
Scorrendo ancora le pagine de Il Mare (3 ottobre 1931) si scopre che a Rapallo visse anche un altro eroe dei Mille. Si trattava di Vittorio Lugaresi scomparso all’età di 82 anni. Aveva partecipato alla battaglia di Monte Suello e a Mentana. Di mestiere faceva il tappezziere con bottega in piazza Molfino in prossimità della stazione ferroviaria.
Ancora una chicca. La leggiamo sul foglio “Vita rapallese” del 1898 (il giornale ebbe vita breve, e chiuse solo dopo l’uscita di 6 numeri), diretto dal giornalista Antonio Scarsella. Nelle due pagine centrali riporta la notizia legata all’inaugurazione del busto di Giuseppe Garibaldi (attualmente i Giardini IV Novembre) e la contemporanea attività promozionale della società Pro Rapallo, una sorta di Proloco del tempo.
UMBERTO RICCI
Umberto Ricci è nato a Rapallo il 29 aprile 1940. E’ sposato con Anita Vanessa dalla quale ha avuto due figlie, Marina ed Elisabetta.
Un’intensa vita politica alle spalle, assessore e primo presidente eletto dal consiglio comunale rapallese, è stato per oltre 40 anni segretaraio generale e direttore delle Opere parrocchiali.
Appassionato cultore di storia locale è autore di numerose pubblicazioni di prestigio. E’ anche cofondatore di diverse associazioni tra cui i Volontari del Soccorso Sant’Anna e più di recente della Pro Loco del Capitanato di Rapallo nonché socio della nostra associazione Mare Nostrum Rapallo..
--------------§§§§§--------------------
I GARIBALDINI DI RAPALLO
di AGOSTINO PENDOLA
giovedì 7 ottobre 2010
A centocinquant’anni dalla spedizione di Garibaldi in Sicilia riscopriamo qual’è stato il contributo dei Liguri della Riviera di Levante e di Rapallo in particolare.
E’ indubbio il ruolo di Genova nell’elaborare le idee che portarono non solo all’Unità d’Italia, ma – attraverso la linfa del mazzinianesimo - prepararono la repubblica che sarebbe arrivata solo cent’anni dopo.
Anche la Riviera, e in particolare la Riviera di Levante, dette il suo contributo.
Nel 1847 a Chiavari la società Entellica riunì un gruppo studenti, tra cui Goffredo Mameli; a Rapallo, dopo il 1848, scesero profughi dalla Lombardia tornata austriaca. Ma furono soprattutto i commerci, gli scambi tra città e riviera, e poi l’emigrazione che segnarono la fine dell’isolamento delle nostre comunità e le inserirono nei grandi avvenimenti nazionali.
Con l’emigrazione i contadini delle nostre colline raggiungevano Genova, sia come momento intermedio nel viaggio verso le Americhe, sia per trovarvi un lavoro non troppo lontano da casa. Portando idee nuove ad ogni rientro al paese natale.
Nicola Pendola, nato a San Maurizio nel 1812 e stabilitosi a Genova fu uno di questi: suo figlio Giovanni sbarcò a Marsala con Garibaldi.
Con Giovanni altri rapallesi indossarono la camicia rossa, dalla Sicilia al Volturno.
Sabato 9 ottobre, alle ore 16,30, li ricorderemo con un convegno nella Sala consiliare del Comune, organizzato dall’Associazione Carrogio Drito, A Cipressa e l’Associazione Nazionale Volontari e Reduci Garibaldini.
Paolo Pendola ricorderà il suo avo Giovanni, vero rappresentante del popolo, falegname, pronto a rischiare la sua vita tra i colerosi così come l’aveva messa in gioco sulle colline della Sicilia quando il morbo percorse Genova negli anni Ottanta dell’Ottocento, perchè la solidarietà e la fratellanza fu il collante di chi aveva seguito non solo la spada ma le idee di Garibaldi.
Chi scrive traccerà un profilo dei garibaldini di Rapallo, in particolare si soffermerà sui motivi e le modalità che portarono questi nostri avi ad arruolarsi.
Getto Viarengo ci porterà una rilettura del Risorgimento in chiave microstorica e illustrando l’opera dei cantastorie: importanti protagonisti dell’informazione in quei giorni.
I cantastorie e i fogli volanti contribuirono a realizzare un’attenta partecipazione popolare ai sentimenti dell’Unità d’Italia.
Con Laura Merione e Giancarlo Piccitto, ricanteremo alcuni brani e distribuiremo i fogli volanti.
Con Franco De Leonardis (di Camogli - economista di professione, ha scritto su temi di scienza e storia economica, nonché sulla storia della libera muratoria nella sua universalità) l’orizzonte non si fermerà alla Liguria, ma spazierà fin dove i contatti latomistici hanno portato i liguri. Nel suo intervento si evidenzierà la partecipazione di logge di Stati Uniti, Inghilterra, Francia e America del Sud al vasto movimento che viene chiamato Risorgimento.
Annita Garibaldi, pronipote dell’Eroe dei Due Mondi, ci racconterà una parte ancora poco conosciuta della sua vita: gli anni a Costantinopoli prima della partenza per le Americhe. Quando il giovane Giuseppe, marinaio sulle navi commerciali, imparava il mestiere, ma anche incontrava persone, le più disparate, formando così il suo carattere.
Carlo GATTI
Rapallo, 19 luglio 2013
QUELLE PALLE MARRONE spiaggiate dalle mareggiate
QUELLE PALLE MARRONE ...
che arrivano sulla spiaggia con le mareggiate
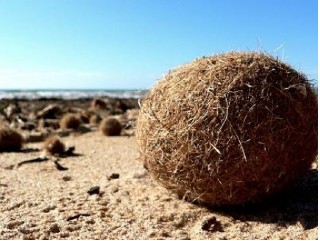
Palle marrone - Egagropili – “Stuppinelli”
Quando il P.fo LOCARNO naufragò sulla passeggiata a mare di Rapallo, ricordo che la mareggiata spinse nel ridossato “caroggio drito” un numero spropositato di “palle” marroni di tutte le misure e molto leggere, come mostra la foto. Vi siete mai chiesti cosa sono, e perché ormai da molti anni non se ne vedono più sulle nostre spiagge? Secondo Rigoberto Vigentini, noto pescatore di Rapallo, queste palle sono resti di Posidonia oceanica sminuzzati ed aggregati dal moto ondoso e poi spiaggiate. Sono conosciute come Delile (dal nome dello studioso Delile). Pare che in dialetto genovese, un tempo, le chiamassero “stuppinelli”. Ma abbiamo scoperto che queste perfette forme geometriche hanno anche un nome scientifico un po’ difficile da ricordare, come vedremo.
Giunti a questo punto, non ci rimane che addentrarci, brevemente, nei “meandri scientifici” e la nostra curiosità viene premiata:
Di solito si tratta di resti di “alghe”, come la Lattuga di mare (Ulva lactuca), o di frammenti di Posidonia, che non è un’alga ma una pianta come quelle terrestri (Posidonia oceanica).

Ulva Lactuc

Prateria di Posidonia oceanica - Portofino
Posidonia oceanica - Delile, 1813 è una pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo appartenente alla famiglia delle Posidoniacee (Angiosperme Monocotiledoni). Ha caratteristiche simili alle piante terrestri, ha radici, un fusto rizomatoso e foglie nastriformi lunghe fino ad un metro e unite in ciuffi di 6-7. Fiorisce in autunno e in primavera produce frutti galleggianti volgarmente chiamati ‘olive di mare’. Forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole importanza ecologica, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo ed esercitando una notevole azione nella protezione della linea di costa dall'erosione. Al suo interno vivono molti organismi animali e vegetali che nella prateria trovano nutrimento e protezione. Il posidonieto è considerato un buon bioindicatore della qualità delle acque marine costiere.

Dettaglio di rizoma
Della Posidonia, che forma praterie sottomarine, importantissime per la salute del Mare, sulla spiaggia si trovano sia pezzi delle loro foglie, sia resti delle radici.
Queste ultime, con il continuo moto ondoso, si riducono in sottili fibre, che si intrecciano fittamente fino a formare caratteristiche palline, più o meno grandi, di colore marrone, cui è stato dato un nome strano: “egagropili”.

Egagropili
Egagropili è il termine scientifico utilizzato per descrivere gli agglomerati sferici o ovali di colore marrone chiaro e di consistenza feltrosa costituiti da residui fibrosi di Posidonia oceanica che si accumulano sui litorali sospinti dalle onde.
La formazione degli egagropili, comunemente noti come palle di mare, polpette di mare o patate di mare, è frutto dello sfilacciamento dei residui fogliari fibrosi che circondano il rizoma della pianta e della loro aggregazione ad opera della risacca marina.
Formazioni simili sono prodotte anche dall'alga verde d'acqua dolce Aegagropola Linnaei, che quando si sviluppa forma grandi sfere verdi dalla superficie vellutata che di giorno galleggiano a pelo d'acqua (grazie all'ossigeno sviluppato con la fotosintesi) e di notte stazionano sul fondo.
Perché si vedono ormai raramente le Egagropili sulle nostre coste? Per questa domanda non abbiamo risposte certe. Ma siamo fiduciosi di pubblicare le vostre.
Carlo GATTI
Rapallo, 17 luglio 2013
IL PASSATO DI RAPALLO SUL MARE
Il passato di Rapallo sul mare
del Comandante Antonio Calegari, tratto dalla rivista "Il Mare" dell'11 Luglio 1954
Rapallo, spandorata lungo la spiaggia col suo pavese alberghiero e balneario, non conserva più alcuna tradizione marinara. Tutte le memorie d’un notevole passato marinaro sono sparite. Eppure in ogni tempo, salvo il presente, i rapallesi si dedicarono alla navigazione, ai traffici marittimi, affrontando spesso duri combattimenti sul mare. Fin dall’epoca romana Rapallo svolse notevole attività marittima specialmente quando si trovò collegata con la via Aurelia. Esistevano già infatti i suoi due portixeu, quello situato alla foce del “Boate” (che poi divenne il porto del Langano) e l’altro, a levante, dove sbocca il torrente “San Francesco”. Dopo un oscuro periodo, è in pieno medioevo che le cronache cominciano a parlare frequentemente del borgo di Rapallo e della sua marina. Rapallo, coinvolta nella generale distruzione compiuta da Rotari nel 641, risorge e ben presto raggiunge sicuramente una certa prosperità, se è fatta segno a ripetuti e violenti saccheggi. Così nel maggio 1087 i pisani vi piombano sopra “viriliter” (come scrisse l’Unghelli) smantellando il castello, incendiando la Chiesa e facendo schiavi uomini e donne. Così nel 1284 è duramente provata dalla flotta veneto-pisana, comandata da Alberto Morosini e da Loto Donoratico, figlio quest’ultimo del ben noto conte Ugolino. Pisa è la nemica di Rapallo, la quale arma alcune galere per contrastarne le forze, sempre in unione alla flotta genovese. Fin dal 1229 Rapallo si è volontariamente assoggettata a Genova.

Infatti nell’anno 1274 navi rapallesi partecipano valorosamente alla famosa battaglia della Meloria nella quale i pisani subirono così dura sconfitta.

Ma negli anni precedenti si ha notizia di galere rapallesi; nel 1232, quando Rapallo invia una galera a Genova per essere incorporata nella flotta destinata ad aiutare i cristiani di Ceuta minacciati dai saraceni; ed in seguito negli anni 1258, 1262, 1265, 1270, numerosi legni da guerra si affiancano alle navi di San Giorgio nella lotta contro i comuni nemici. Parallelamente nei secoli XIII e XIV, quei di Rapallo sviluppano una rilevante attività commerciale-marittima, soprattutto col Levante, a quanto è lecito supporre, per esempio, dalla numerosa colonia rapallese dislocata a Cipro. In essa emergono, come naviganti, armatori e commercianti, i nomi della casata dei Ruisecco e dei Pastene. Un Domenico Pastene (fine del ‘300) diventa il più grande commerciante dell’isola, viaggia molti anni in Egitto, Siria, Asia Minore, Mar Nero, sino al golfo Persico, inviando interessanti relazioni diplomatico-commerciali alla Repubblica di Genova, lasciando infine tutte le sue ricchezze al Banco di San Giorgio. E Rapallo manda persino sulle rive del Lemano alcuni suoi figli, un Sacolosi ed un Andreani, quali maestri d’ascia per la costruzione di galee sabaude. Pure alla fine del ‘300 un Antonio Colombo di Rapallo è comandante di galee.

L’Ammiraglio Biagio Assereto
Durante il 1400 Rapallo è ancora fatta segno a disastrosi saccheggi; la prima volta da 22 galere venete; poi è messa a ferro e a fuoco, in sul finire del secolo dalle truppe svizzere, sbarcate da navi francesi in conflitto cogli aragonesi (Genova reagisce con la legge del taglione). Intanto un rapallese è consacrato alla storia quale esperto comandante di armate navali: è l’ammiraglio Biagio Assereto, vincitore della battaglia di Ponza, la più grande del secolo XV. Tra gli uomini illustri assume particolare rilievo Giovan Battista Pastene, Almirante del re di Spagna, Pilota Major do Mar do Sud, fondatore di Valparaiso (1544). A questo punto si devono ricordare: Bartolomeo Canessa, capitano di galeazza con Patente di corsa della Repubblica Genovese; Agostino Canevale, comandante della galea Lomellina alla battaglia di Lepanto e Gio Bernardo Molfino, capitano della fregata Il Cacciatore, che a metà del ‘600 corseggiava nei mari del Levante. Pressappoco alla medesima epoca, gli abitanti del Capitanato di Rapallo largiscono una forte somma per la costruzione di una nuova galea, da incorporarsi col nome di Santa Maria del Monte Allegro, nella flotta genovese.

Rapallo contribuisce così alla sua difesa, ancor memore del furioso assalto compiuto un secolo prima dal celebre corsaro Dragut. Nei secoli XVI e XVII gli annali e le cronache parlano con decisa frequenza di Rapallo e della sua importanza nel campo marittimo.
A. Giustiniani ricorda che i borghesi di Rapallo sono “gente assai civile, mercadanti e marinai, quali hanno parecchi navili”; dal “Registro di Carattate” (1531) si rileva che “de tutti doi, barche piccole da mine 30 in 60, di cento incirca, la maggior parte da piscare”; in altre fonti sono menzionati legni rapallesi trafficanti in tutto il Mediterraneo, specie col Levante e la Spagna. Gerolamo De Martini scrive (1655); “Rapallum vero vicus est insignis mercatoribus nautisque frequens”. Padre Ludovico d’Amerio con uno slancio lirico, conferma il passato della nostra città, ricordando “… il lustro di segnalate imprese di mare” mentre il noto padre Antonio Bresciani dice che Rapallo “… ha popolo numeroso ed attivo in opere di navigare”. Anche dal “Codice diplomatico Rapallese” si ricavano importanti notizie a Rapallo ed alle sue imprese durante il colera che infierì a Genova nel 1650. Meriterebbe ben più lungo cenno il rapallese Visconte Maggiolo “maestro delle carte da navigare”, vera gloria nazionale, famoso iniziatore di una grande scuola cartografica. Pure degno di ricordo l’antica fiorente confraternita dei Marinai che già esisteva nel 1720 sotto il patronato di Sant’Erasmo.
Al principio del secolo scorso molti padroni di barca erano dediti alla pesca delle spugne; battevano i fondali delle acque dell’arcipelago greco. Molti altri, sfidando la minaccia dei pirati barbareschi che spesso li traevano schiavi, andavano alla pesca del corallo lungo la costa africana. Declinando l’industria corallina (1840-1860) ed al sopravvenire della decadenza della vela, buon nerbo di capitani e naviganti rapallesi emigrarono nel Sud America, specialmente nel Perù e nell’Argentina, continuando naturalmente la loro professione. Oggi si ricordano ancora parecchi piloti del Rio de La Plata oriundi di Rapallo, i cui nomi corrispondono ai vari Castagneto, Solari, Macchiavello, Arata, Sanguineti, ecc. Il nostromo Antonio Castagneto si ingaggiò, anzi, come “pilota major” nella marina da guerra del governo rivoluzionario colombiano, eroicamente battendosi a bordo di navi armate in corsa.
Durante il periodo velico di maggior splendore, Rapallo diede figure eminenti di Capitani di Lungo Corso, da Emanuele a Giacomo Bontà, a Pietro Felugo e a Cap. Agostino Solari, da Agostino G. B. Macchiavello a Valentino Canessa e a Biagio Arata (comandante di grandi velieri in lunghe navigazioni oceaniche), tutti valenti navigatori sulle rotte oceaniche mondiali. Parecchi rapallesi si contavano anche fra gli equipaggi della Real Marina Sarda.

L'antica Porta delle Saline
Rapalllo ebbe anche una buona e frequentata scuola nautica che esisteva nel 1865, diretta dal matematico Salviati (vicino alla porta delle Saline n.d.r.).

Lungo l’odierna passeggiata a mare, dove questa è allietata dai giardinetti, prima di arrivare al monumento di Colombo, sorgeva un cantiere navale che nel 1865 raggiunse una notevole importanza. Vi si costruirono non solo tartane, golette e scune, ma anche grossi bastimenti di oltre 1000 tonnellate, quali l’Iside, l’Espresso, il Genovese, il Ferdinando, il Siffredi, il Giuseppe Emanuele ed il maestoso Caccin di 1500 tonnellate, sotto la direzione di grandi costruttori navali come G. Merello, Graviotto ed Agostino Briasco.
Antonio CALEGARI
Foto Carlo GATTI
*Arturo Ferretto
(Rapall o, 21 aprile 1867 – Genova, 18 ottobre 1928 è stato uno storic o e archivista italiano . Pubblicò a soli ventidue anni un significativo opuscolo, Rapallo - spigolature storiche, cui seguirono numerosi importanti contributi di storia ligure, fra cui si segnalano Codice diplomatico de l Santuario di Monte Allegro (1557-1897) , Codice diplomatico delle relazioni tra la Liguria , l a Toscana e l a Lunigiana ai tempi d i Dante (1265-1281) (1901), Annali storici d i Sestri Ponente e delle sue famiglie ( 1904).
Si interessò anche di studi danteschi. Impiegato quale "ufficiale" presso il Regio Archivio di Stato di Genova , nel 1909 sposò a Chiavari Livia Oneto, da cui ebbe una figlia, Fortunata, e un figlio, Virgilio; in seguito risiedette a Genova. Collaborò intensamente ai periodici "Il Cittadino", "Il Caffaro" e, dal 1909, a "Il Mare"; su quest'ultimo dedicò 716 documentatissimi articoli a Rapallo e circondario. Ancora nel 1928 dava alle stampe Il distretto di Chiavari preromano, romano e medioevale, opera fondamentale per l'archeologia del Golfo del Tigullio Una strada di Rapallo ed una sita nel quartiere genovese di San Fruttuoso portano il suo nome.
3 Aprile 2013
Foto a cura del webmaster.
{jcomments on}
LOCARNO-Conferenza sullo spiaggiamento a Rapallo
SPIAGGIAMENTO DEL P.FO LOCARNO A RAPALLO
Sintesi della Conferenza tenuta a Palazzo DUCALE - Genova
Dal comandante Carlo Gatti e dal giornalista Emilio Carta
29 gennaio 2013

La LOCARNO in un dipinto di Amedeo Devoto
LOCARNO - dati nave:
Stazza Lorda = 3.862 tons
Lunghezza = 109,8 metri – Larghezza = 15,2 metri
Data di Costruzione = 1929
Costruita a Dunsley nel 1929 Cantiere Thompson-Southwick-UK
Materiale = Acciaio
Motore = Macch. Alternativa a triplice espansione Vapore di 2700 CV
Velocità = 10 nodi
Bandiera = Panama
Equipaggio = 22
Comandante = C.L.C. Vittorio Sallustro
Data perdita = 3.1.1961
Luogo = Rapallo (Italy)
Primo Armatore = Headlam & Sons (1929-1954)
Secondo Armatore = Società Marittima S.Rocco – Genova (1954-1961)
Sosta a Rapallo ai lavori per renderla navigabile = 43 giorni
Rimorchiata a Spezia per la Demolizione = 15.2.1961 dalla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova
Owned by S. Tuillier. Wrecked at Rapallo and BU (broken up) Spezia 15/2/61
Sito= http:p//www.wrecksite.eu/wreck.aspx?159352
LA CRONACA
Il 20 dicembre 1960 la Locarno arriva a Genova proveniente da Lubecca, ormeggia a Ponte Rubattino e sbarca 6.000 tonn. di lingotti di ferro.
Il 3 gennaio 1961 la Locarno parte da Genova diretta a Follonica (Toscana) che dista: 118 miglia. Al momento della partenza la Nave é in zavorra. Il gavone di prua, quello di poppa e i doppifondi sono pieni di acqua.
TESTIMONIANZA
Ricevute le regolari SPEDIZIONI dalla Capitaneria, la LOCARNO chiama il pilota portuale di turno L.A. per essere messa in partenza alle 08.00.
Il pilota giunge sottobordo alla nave ormeggiata a Ponte Rubattino Levante, e nota che lo scalandrone, lato terra, é già stato virato a bordo ed é rizzato. La biscaglina é appesa fuori bordo, lato mare. Per gli addetti ai lavori, questi preparativi indicano che il Comandante ha premura di partire...
Giunto sul ponte di Comando, il pilota lo informa della situazione meteo: “Comandante c’é in corso una forte Burrasca da Libeccio forza 6/7, le consiglio vivamente di rinviare la partenza di qualche ora. La nave é vuota “a pallone” e i bollettini del tempo non danno alcun miglioramento per almeno 12 ore”.
Ma il comandante Vittorio Sallustro é determinato a partire e risponde:
“Il viaggio é breve, soltanto 10-12 ore di navigazione per arrivare a Follonica. Questa nave resiste bene alle burrasche; da quando siamo partiti da Lubecca siamo passati da una burrasca all’altra pestando fino a Genova: prima lo Skagerrack, poi il Mare del Nord, la Manica, il Golfo di Biscaglia, il Golfo del Leone. Pilota stia tranquillo! Se vedo che ci sono problemi, ritorno indietro e vi chiamo!”
Magari lo avesse fatto! Il mio ex collega L.A. mi raccontò, dopo alcuni anni, che appena la LOCARNO uscì in mare aperto, le rollate erano così ampie e profonde che le lance di salvataggio lambivano le onde.
“La seguii a lungo con preoccupazione perché la vedevo scarrocciare verso la costa. Per fortuna il Comandante, ad un certo punto, si rese conto del pericolo e accostò a dritta riuscendo a prendere il mare sul mascone di dritta. Si allargò a sufficienza dalla costa, mi tranquillizzai e rientrai in torretta”.
EMILIO CARTA domanda:
a) - “Che stabilità aveva la nave essendo scarica e a “pallone”?
b) - “Può la Capitaneria di Porto impedire ad una nave di partire per ragioni di sicurezza meteo-marine-nautiche?”
CARLO GATTI risponde:
a) - “Quando la nave superò le burrasche nordiche e mediterranee, era carica di lingotti di ferro, quindi aveva una stabilità addirittura eccessiva, il massimo pescaggio le assicurava il massimo rendimento dell'elica e del timone. Nella situazione attuale: con nave completamente vacante, scarsa stabilità, poca superficie immersa, non ci sono le condizioni per contrastare l'effetto deriva prodotto dal forte vento di libeccio al traverso della sua rotta. Inoltre, lo scarso pescaggio in quelle condizioni di mare in burrasca, rende minima la forza propulsiva dell'elica, in quanto il forte beccheggio ne provoca la continua fuoriuscita dall'acqua, (cavitazione) con la conseguente scarsa governabilità da parte del timone”.
b) - “Fino a tutto il 2000, il NOSTROMO DI BANCHINA (di zona), mitica figura della Capitaneria, controllava che la nave, al momento della partenza, avesse: i bighi abbassati e rizzati, gli oblò eventualmente chiusi e corazzati, l’elica immersa, che non fosse sbandata, che non ci fossero sversamenti di liquidi sospetti ecc... Il sottufficiale controllava meticolosamente che tutto fosse in ordine secondo la prassi della buona marineria! Pertanto sono certo che la nave, al momento della partenza, era in ordine.
Il CRITERIO usato dalla AUTORITA’ MARITTIMA e/o PORTUALE per una nave in partenza o comunque in manovra, é quella di salvaguardare sia LE OPERE PORTUALI che la SICUREZZA di tutte le navi in manovra in quella determinata zona. Tuttavia, quando é possibile, la A.M. evita di incidere, sugli interessi privati della nave/armatori: interferenze sulle entrate, uscite che potrebbero ritardare le operazioni commerciali e “toccare” eventuali aspetti economici. In genere, per salvaguardare la SICUREZZA delle operazioni, ad un Comandante di nave in difficoltà, viene consigliato, (a volte lo si obbliga), ad attaccare uno o più rimorchiatori sulla base dei rischi in corso”.
RIPRENDE IL RACCONTO:
Poco prima delle 10 la LOCARNO giunge al traverso del faro di Portofino e il Comandante si rende conto che i forti movimenti di beccheggio e rollio rendono la navigazione pericolosa, se non impossibile, e solo allora decide di entrare nel Golfo Tigullio per cercare ridosso dal libeccio. Poco dopo, la nave viene vista manovrare davanti a Punta Pedale (Santa Margherita) e, poco dopo, dare fondo l’ancora. Alcuni testimoni oculari riferiscono che la LOCARNO si trova in buona posizione, ridossata e stabile alla fonda. Il Comandante rimane nell’attesa che il vento giri a TRAMONTANA per poter riprendere il viaggio.
Emilio Carta domanda:
Erano affidabili i Bollettini del tempo degli anni ’60?
Carlo Gatti risponde:
Occorre innanzitutto ricordare la dinamica di una depressione atlantica che investe il Mediterraneo occidentale: all’inizio si presenta con Vento da Scirocco, mano a mano che avanza, il vento gira a Libeccio rinforzando, poi passa a Maestrale aumentando ancora d’intensità, poi gira a Tramontana-Grecale e si allontana verso levante. Vi sono quindi due SEGNALI che l’uomo di mare tiene sotto controllo:
a)- La Direzione del Vento. A bordo, un tempo, veniva costantemente rilevato al ‘grafometro’ e successivamente alla ‘ripetitrice esterna’ della girobussola.
b)- L’Andamento del Barometro – Finché il barometro scende la depressione si trova a ponente dell’osservatore. Quando il Barometro interrompe la caduta e riprende a salire, significa che il centro della depressione sta passando e presto la Tramontana spianerà il mare. I bollettini del tempo dell’epoca erano basati sulle osservazioni locali delle Stazioni Meteorologiche dell’Aeronautica. Non c’erano ancora i satelliti-meteo con l’attuale diffusione a pioggia di bollettini. Pertanto le previsioni erano basate sulle indicazioni visive degli osservatori di terra, ma soprattutto sull’esperienza personale dei naviganti.
RIPRENDE IL RACCONTO
Purtroppo, quel 3 gennaio 1961, la situazione Meteo-Marina é molto più complessa del previsto: il vento, infatti, non va a completare il suo giro nel senso orario appena descritto, ma ritorna indietro sotto l’impulso di un’altra depressione che é già pronta a subentrare e a colpire alle spalle della precedente.
Il comandante Sallustro, quando pensa ormai d’averla scampata, s’accorge che il vento é improvvisamente girato a Scirocco sollevando altissimi marosi di prora (da Sud-Est). Decide immediatamente di salpare, scappare e mettersi alla ‘cappa’, (con la prora al mare) e prepararsi a passare una brutta notte in mare aperto.
Da questo momento comincia la fase più drammatica.
Per contrastare la forza crescente del vento, il Comandante avvia la macchina avanti e, quando l’ancora entra in cubia, mette ‘avanti a tutta forza’ per allontanarsi dagli scogli di poppa tentando di guadagnare il mare aperto.
La LOCARNO, purtroppo, ha una grande Superficie Velica e una potenza di macchina del tutto insufficiente per vincere il vento. La manovra non riesce e la nave si traversa al vento diventandone preda. Per mettersi in filo allo scirocco sarebbe necessario il tiro di un rimorchiatore di 3.000 cavalli di potenza, eventualmente posizionato di prora a dritta.
Il Comandante prova e riprova a raddrizzarsi con violente smacchinate:
avanti tutta-indietro tutta, ma non c’é nulla da fare. La nave scarroccia verso il centro dell’imbuto che porta a Rapallo sotto la spinta violenta del vento di scirocco in piena burrasca.
Emilio Carta domanda:
“A questo punto risulta che il Comandante abbia chiamato i rimorchiatori di Genova via radio. Un po’ tardi forse?”
Carlo Gatti risponde:
“Certamente ormai é tardi! I Rimorchiatori di Genova, avendo lo scirocco in prua, impiegherebbero non meno di 2 ore a compiere le 11 miglia che separano la Lanterna dal Monte di Portofino. Inoltre, c’é da aggiungere un altro elemento contrario: la corrente marina. Con la bonaccia di vento, la corrente marina sale da sud-est e lambisce le coste italiane viaggiando ad una velocità intorno al mezzo nodo, con la burrasca da scirocco, la sua spinta può arrivare e superare i 5 nodi di velocità”.

La nave comincia a scarrocciare “traversata” sottovento agli elementi. Il comandante si prepara a dare fondo le due ancore per tentare di frenare la corsa verso gli ostacoli di terra che si avvicinano ancora più minacciosi per l’imminente oscurità. Un urlo al megafono: “FONDO LE ANCORE”. L’ultima speranza del Comandante é riposta in questa massa di ferro che può significare salvezza oppure naufragio, la vita oppure la morte. La nave si orienta con la prua al mare. Il Comandante tira un sospiro di sollievo: “le ancore tengono”! Ma il vento al tramonto rinforza quasi sempre e la burrasca sembra aumentare ancora di più la sua forza. Le ancore tengono per alcune ore. Poi cominciano ad arare lentamente, ma inesorabilmente. Il fondale é sabbioso e, mano a mano che decresce, diventa più scivoloso, le ancore non mordono più. Il destino sembra segnato. La nave si avvicina lentamente al Molo di Langano. Il comandante avvia molte volte la ‘macchina avanti’ per allegerire lo sforzo sulle ancore. Con queste ripetute manovre, la nave resiste e mantiene quella posizione fin quasi alla mezzanotte.
Il vento non vuole mollare, le luci della passeggiata ormai vicina, vibrano e spandono scie luminose, sembrano allegri fantasmi che ballano con i marosi che frangono sugli scogli di protezione e proiettano spruzzi surreali, fosforescenti che danno vita ad una macabra festa di ballo.

In questa fotografia della LOCARNO si nota la mancanza della catena dell’ancora di dritta
Tutto ha un limite. Improvvisamente la catena dell’ancora di dritta che reggeva fino a quel momento lo sforzo, si spezza con uno schianto. La prua comincia a cadere e si capisce che l’ancora di sinistra non agguanta il fondale. Al comandante non rimane che tentare l’unica manovra possibile: smacchinare avanti e indietro nel tentativo di tenersi ad una distanza equidistante tra gli scogli della passeggiata a mare, il Molo del porticciolo e il cinquecentesco castello che sporge dalla spiaggia come un’isolotto. Gli scogli sono dappertutto. Ma c’é un altro pericolo, forse ancora più grave: si tratta del basso fondale. La nave, che in qualche modo era riuscita per molte ore a tenersi con la prua al vento, persa ormai l’ancora di dritta, e con quella di sinistra che non morde più il fondo, si traversa al vento e al mare e scarroccia più rapidamente verso la passeggiata. Il vento e le onde battenti sul fianco dritto la spingono verso il basso fondale e la inclinano. Quando lo scafo toccherà il fondale potrebbe anche rovesciarsi. Qui entra in gioco l’abilità e la freddezza, ma anche la fortuna del Comandante. Come abbiamo già detto, l’uomo ha a disposizione soltanto la motrice, che per fortuna non ha limitazione di avviamenti. Infatti, a riesce a correggere la posizione nello spazio libero, molto ristretto della baia e a farsi portare dal vento e dal mare ad appoggiarsi, con la prora a levante, contro il moletto dei Primeri, proprio a centro nave: un “punteruolo” che fuoriesce a 90° dall’asse della passeggiata a mare.
La LOCARNO sfiora tutti gli ostacoli e si va ad ormeggiare sulla più bella passeggiata della Riviera SENZA TOCCARE NULLA.
EMILIO CARTA domanda: I rimorchiatori arrivano ma si tengono al largo. Quali sono le ragioni per cui non possono tentare alcuna operazione di salvataggio.
CARLO GATTI risponde: Nel 1960 la maggior parte dei rimorchiatori di Genova erano a vapore, avevano un grande scafo di oltre 30 metri di lunghezza ed avevano un pescaggio di 5-6 metri. Il doppio della LOCARNO, che stimo potesse avere circa 3-3,5 metri. La loro potenza di 600/800 cavalli non gli consentiva di fare acrobazie o grandi colpi di mano. Quindi, i Rimorchiatori di Genova temevano di finire, a loro volta, nei bassi fondali della baia. La BATIMETRICA dei 5 metri unisce il vecchio molo di Langano con Villa Porticciolo. Internamente a questa linea il fondale decresce fino alla passeggiata.
Nella notte fonda tra il 3 ed il 4 gennaio 1961, sulla passeggiata a mare di Rapallo, si conclude uno dei più “spettacolari” drammi del mare: non solo la nave non si rovescia, ma le onde molto alte sollevarono la LOCARNO e la consegnarono quasi intatta tra le braccia ad anfiteatro della cittadina. L’equipaggio ne uscì incolume nonostante i molti brividi.
Emilio Carta riprende il racconto dell’incaglio della LOCARNO nel momento in cui la nave si é perfettamente ormeggiata a Rapallo anzichè a Follonica....
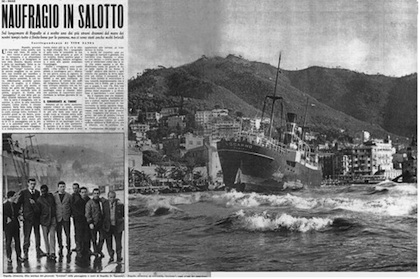
“Sono ancora tanti i “rapallini” che ricordano il 3 e poi il 4 gennaio 1961.
Quel “maledetto” quattro gennaio millenovecentosessantuno - precisano marinai e pescatori del borgo - quando, a causa di una fortissima libecciata, quel piccolo mercantile di 3.897 tonnellate, la Locarno, come una balena ferita a morte, si incagliò sulla scogliera del litorale rapallese.
A provocare tanto sconquasso non cera il mitico comandante Achab ma, più prosaicamente, un capitano di lungo corso, il quarantenne Vittorio Sallustro da Torre del Greco, che rivisse chissà quante volte, come in un incubo, quella notte di tregenda.
A bordo, con lui, c’erano ventidue uomini di equipaggio, molti dei quali genovesi, ed un abissino. L’ennesima tragedia del mare, che per fortuna non fece vittime, portò il nome della cittadina rapallese sulle prime pagine e sugli schermi di mezzo mondo e venne accompagnata da una serie di iniziative umanitarie e promozionali che oggi, probabilmente - non dimentichiamo che all’epoca correva l’anno 1961 - farebbero sorridere. Riuscii a filmare i momenti più drammatici della nave in preda alla tempesta con una piccola cinepresa ad otto millimetri - racconta il rapallese Mauro Mancini - Ricordo come fosse oggi che qualche settimana più tardi, i negozi di souvenirs avevano già in vendita le cartoline illustrate che mostravano la Locarno in mille pose, come una fotomodella, con la prua che sbatteva sulla scogliera del lungomare Vittorio Veneto.
Fu ancor più simpatica l’iniziativa dei vigili urbani rapallesi - aggiunge Mancini - I “cantunè” offrirono all’equipaggio i pandolci e lo spumante che avevano avuto in dono dagli automobilisti rapallesi per la caratteristica “Befana dei vigili”, un’usanza che in quegli anni si ripeteva un po’ dappertutto.
Il cargo, battente bandiera panamense, era giunto nel porto di Genova il 20 dicembre proveniente da Lubecca e, dopo aver ormeggiato al molo Rubattino, sotto l’occhio vigile della Lanterna, aveva scaricato seimila tonnellate di lingotti di ferro. Per l’equipaggio, insomma, era stato un Natale sereno, con la veglia di mezzanotte in cattedrale ed i piedi ben piantati sotto la tavola, come tradizione vuole, per tutte le feste comandate.
Il tre gennaio la nave aveva però lasciato molo Rubattino ed era ripartita con le stive vuote ma con i gavoni di prua e di poppa pieni d’acqua per zavorrare e stabilizzare il mercantile, diretto verso Follonica, in Toscana, per caricare minerale ferroso da trasferire in Germania.
Ma a quell’approdo la Locarno non arrivò mai perché la sua odissea, iniziata davanti al Monte di Portofino, si concluse proprio nelle acque del golfo Tigullio.
Alle dieci del mattino, infatti, il cargo venne avvistato al traverso di Santa Margherita Ligure, a circa un miglio dalla terraferma, dando l’impressione di essere in difficoltà. Alle sedici il mercantile, lungo centoquattordici metri ed appartenente alla Società Marittima Genovese “San Rocco”, arrivò davanti a Rapallo, all’altezza dell’Excelsior Palace Hotel.
Era ormai in uno stato di ingovernabilità che agli occhi esperti dei marinai - che da terra ne seguivano “a vista” la navigazione - appariva sempre più chiaro.
Il mare lo spingeva alla deriva e, per di più, a causa della forza del mare e del vento, le ancore aravano il fondo sabbioso, senza frenare a sufficienza quella folle corsa verso gli scogli, mentre da bordo gli uomini erano in trepida attesa dell’arrivo dei rimorchiatori.
Alle sedici e trenta il cargo era ormai a meno di trenta metri dal castello sul mare, mentre mezzora più tardi la nave si spostò leggermente verso ponente, a nemmeno cinquanta metri dalla balaustra in ferro della passeggiata a mare.
La situazione a quel punto precipitò e la lenta agonia della nave giunse al culmine: la distanza dagli scogli diminuiva progressivamente a venti metri, poi a dieci, a sette, a cinque.
Il mercantile infine si coricò leggermente sul fondo sabbioso arenandosi con la prua - alta fuori dell’onda quanto una casa di tre piani - sui macigni posti a protezione del lungomare.
«Fu una scena infernale alla quale assistettero migliaia di persone assiepate sull’asfalto della passeggiata a mare - ricordava anni dopo il rapallese Andrea Pietracaprina - Intanto, a bordo della Locarno, gli uomini d’equipaggio, flagellati dal vento e dalle onde che spazzavano il ponte, apparivano e scomparivano da una parte all’altra della coperta, riconoscibili solo dal luccichio degli impermeabili, per cercare di porre rimedio ad una situazione che appariva ormai senza speranza».
Alcuni rimorchiatori, provenienti dallo spezzino e da Genova non riuscirono ad agganciare lo scafo prima che la situazione precipitasse definitivamente e, per la Locarno, fu la fine.
Alle diciannove e venti i vigili del fuoco genovesi, alla luce di potenti fari, provarono con successo a sparare una sagola a bordo: ad essa, avvolto in un sacchetto di plastica, venne legato un messaggio con la richiesta di conoscere le condizioni dell’equipaggio.
Da bordo utilizzando lo stesso mezzo, il comandante rispose che non vi erano feriti.
Era impossibile comunicare “a vista” anche se vi provarono ripetutamente con i megafoni - raccontava alcuni anni dopo il barcaiolo rapallese Vittorio Pietracaprina - Il frastuono delle onde e del vento, unito allo sfregamento delle lamiere della nave sugli scogli rendeva vano ogni tentativo.
Rammento che prima del lancio della sagola a bordo, un radiotelegrafista, da terra, utilizzò il clacson di un’auto appositamente posizionata a poca distanza dal moletto normalmente riservato ai battelli turistici. Cercò di comunicare con l’ufficiale marconista di bordo attraverso l’alfabeto morse e a bordo ricevettero il messaggio anche se nessuno fu in grado di rispondere.
La buona sorte, infine, aprì la propria bisaccia: la Locarno virò di circa novanta gradi distendendosi in senso longitudinale lungo l’asse della passeggiata a mare, con la prua rivolta in direzione levante.
La fiancata andò provvidenzialmente a toccare il moletto d’ormeggio dei “primeri” ed alle quattro del mattino l’equipaggio potè finalmente scendere a terra con l’ausilio di una biscaglina.
A terra li attendevano coperte ed un pasto caldo.
Mentre i Vigili del fuoco riponevano cavi e fari, utilizzati sino a qual momento per illuminare a giorno la scena, sulla torretta del castello si spegneva anche la grande stella cometa natalizia.
I tecnici si ponevano intanto i primi interrogativi sulle cause che avevano provocato l’incaglio della nave. Il comandante aveva escluso, infatti, qualsiasi avaria alle caldaie o alla macchina del timone. Priva di carico, e quindi meno resistente alla forza del vento e del mare, la nave, in preda al maltempo, probabilmente non era più riuscita a governare ed aveva cominciato ad andare inesorabilmente alla deriva.
A terra, ovviamente, iniziava il business “made anni Sessanta”, mentre il pittore Nerone Uselli, spalle alle nave e fiasco di vino accanto alla tavolozza, in sommo disprezzo per tutto ciò che era acqua, dipingeva in un celebre quadro l’apocalittica scena”.
Al termine del Convegno, il pubblico rivolge molte domande. Riportiamo le più interessanti con le risposte dei conferenzieri.
a)- Perché il comandante della LOCARNO partì da Genova, nonostante il tempo fosse proibitivo?
b)- Il breve viaggio Genova-Follonica forse ha spinto il Comandante ad osare...?
c)- Forse l’Armatore può aver spinto il Comandante a partire?
d)- Le navi a vapore non hanno limiti di avviamenti, ma forse hanno altri limiti tecnici?
a) – Le Condi-meteo erano proibitive. La Burrasca da Libeccio, oltre ad essere stata regolarmente annunciata, era già in corso, sotto gli occhi di tutti.
b) - Doveva ascoltare il consiglio del Pilota. Il Pilota é pagato dall’Armatore della nave. E’ un ex comandante, “esperto” conoscitore di tutte le situazioni meteo-nautiche locali e le mette a disposizione dei comandanti di navi. Spesso accade anche il contrario, cioé che il Comandante si rifiuti di partire dicendo: “ME LO HA CONSIGLIATO IL PILOTA PER RAGIONI DI SICUREZZA” – E tutti se ne fanno una ragione!
c) - La Nave non doveva lasciare il porto - Ogni comandante deve conoscere i limiti della propria nave che, nel caso della Locarno, aveva ben 31 anni di anzianità.
Il comandante disse al pilota che la LOCARNO aveva superato tutte le burrasche che la tormentarono per tutto il viaggio, dalla partenza all’arrivo. Tuttavia faccio osservare quanto segue:
- La nave superò le burrasche nordiche perché era carica di lingotti di ferro.
- La nave possedeva una stabilità addirittura eccessiva.
- La nave era alla “marca”, cioé al massimo del pescaggio consentito, che gli assicurava un rendimento ottimale dell'elica e del timone.
La LOCARNO in partenza da Genova era nella situazione completamente opposta:
- Nave completamente ‘vacante’ in zavorra, con grande superficie velica esposta al vento.
- Scarsa stabilità.
- Poca superficie immersa, insufficiente a contrastare l'effetto deriva, prodotto dal forte vento di libeccio al traverso della sua rotta.
- Lo scarso pescaggio in quelle condizioni di mare in burrasca, rendeva minima la forza propulsiva dell'elica, in quanto il forte beccheggio ne provocava la continua fuoriuscita dall'acqua, con la conseguente scarsa governabilità da parte del timone.
d) – Genova – Follonica (120 mg) é un tratto breve di navigazione, ma é di traversia al libeccio: pertanto il ragionamento messo poi in atto dal Comandante é completamente errato e ingiustificabile. Inoltre posso aggiungere che La Spezia, posizionata al centro del percorso, all’epoca non poteva ricevere navi in emergenza, specialmente di notte, perché aveva il canale d’entrata disseminato di BOE MILITARI. E’ successo proprio al sottoscritto di essere lasciato fuori, tutta la notte, a pendolare con una “Liberty” a rimorchio nella burrasca, proprio in quegli anni per quell’assurdo motivo.
Il Comandante conosceva questa ‘impossibilità’ di potersi rifugiare a Spezia.
La LOCARNO avrebbe caricato “ferraccio” a Follonica, se avesse ritardato la partenza da Genova di un solo giorno, non avrebbe certamente inciso sull’economia di nessuno. Quale motivazione l’ha spinto a decidere di partire? Nulla che avesse a che fare con una decisione marinaresca ponderata e saggia!
Vorrei terminare il mio pensiero con una considerazione da PILOTA. Quel tipo di nave, lunga, vuota e a vapore, che ho avuto modo di pilotare tante volte, aveva due grandi difetti: Poca POTENZA e Superficie del TIMONE relativamente piccola rispetto a tutte le altre navi in circolazione in quel periodo. La nave a vapore era al tramonto, aveva un ratio d’accostata lentissimo, ma il Comandante non ne tenne conto.
Carlo GATTI - Emilio CARTA
Rapallo, 19 febbraio 2013
In VIAGGIO con i CORMORANI
IN VIAGGIO CON I CORMORANI
L’ISOLA CHE NON C’E’. Nel nord della Norvegia, il cormorano è tradizionalmente considerato un uccello semi-sacro. Si ritiene sia un segno di buona sorte avere dei cormorani vicino al proprio villaggio. Secondo un’antica leggenda nordica, le persone che muoiono in alto mare, senza alcuna possibilità di recupero dei loro corpi, trascorrono l'eternità sull'isola di Utrøst che può solo occasionalmente essere avvistata dai viventi. Gli abitanti di Utrøst possono visitare le loro case soltanto nelle sembianze di cormorani. L’isolotto fantasma si trova al limite meridionale delle isole Lofoten, famose per la pesca dello stoccafisso. Poco sopra Utrøst si trova la più famosa isola di Røst dove naufragò il comandante veneziano Pietro Querini con la sua cocca nel 1432. Dopo una sosta forzata di circa 8 mesi, l’equipaggio ritornò in Italia diffondendo la cultura dello stockfisk.

Agli inizi del 1970 vidi per la prima volta un cormorano, detto anche marangone,* appollaiato su una delle boe che segnalano il canale d’entrata del Porto Petroli di Multedo (Ge). Nell’attesa di prendere il cavo della petroliera in arrivo con il mio grosso rimorchiatore, mi avvicinai fin quasi a toccarlo. Era grande, aveva il ciuffo e si sentiva al sicuro. Dopo qualche mese di frequentazione quotidiana diventammo amici e presto mi presentò la sua compagna. Sparirono in primavera e quando ormai ero lontano dall’idea di rivederli, il primo ottobre di quello stesso anno ritornarono sulla stessa boa con tre giovani esemplari al seguito, più piccoli e un po’ più chiari.

Quella piccola famiglia diventò una colonia che presto si spostò nella più tranquilla riviera di levante. Il ricordo di quell’incontro mi accompagnò per lungo tempo e durante i miei viaggi, quasi sempre di mare, mi divertivo a notare le differenze tra le sei specie di cormorani esistenti al mondo. Passarono ancora molti anni quando, un giorno, alcuni amici mi proposero di scoprire la bellezza della passeggiata costiera: Covo di Nord Est – Paraggi. Era la fine di settembre e quella camminata mi aprì un mondo di meraviglie naturali. Improvvisamente mi venne in mente la fatidica data legata al ritorno dei cormorani e, di getto, mi prese l’ansia per il loro arrivo.


E’ il primo ottobre del 2012. Emozionato come un bambino al primo giorno di scuola, riparto dal Covo armato di binocolo e, scandagliando metro dopo metro la scogliera, vedo un grosso esemplare di cormorano staccarsi dalla roccia e planare sull’acqua dopo un breve volo radente. Ha fame, si guarda in giro, e all’improvviso s’inarca all’indietro per poi scattare come una freccia che sale e poi discende tuffandosi in perfetta verticale con la testa in giù e le zampe verso il cielo.
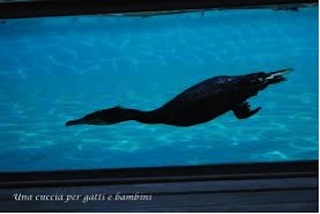
Sparisce per 30-40 secondi e riemerge a 60-70 metri di distanza, senza scia.
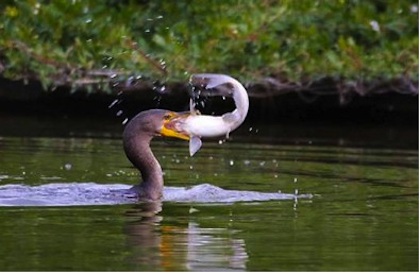
Il suo punto d’emersione é sconosciuto ed appartiene alla sua strategia di caccia. Non ho alcuna cognizione scientifica della sua velocità in immersione, ma intuisco che il cormorano potrebbe essere un ottimo atleta in grado di nuotare i 100 metri sotto il minuto mentre insegue la preda.
Quando giungo sotto il monastero della Cervara, là dove iniziano i millenari scogli di puddinga, vedo quattro cormorani appostati sul faraglione, si crogiolano al sole. Appaiono stanchi. Sono appena arrivati dalla Scandinavia.

Al ritorno da Paraggi ne intravedo uno da lontano con le ali aperte. Probabilmente é appena ritornato da un’immersione e si asciuga al sole. Alcuni gabbiani hanno trovato spazio sullo scoglio di puddinga. Non c’é alcuna lotta per il territorio, anzi, parlottano tra loro come vecchi amici che si ritrovano dopo una lunga assenza.

I cormorani sono uccelli tranquilli e pazienti, tuttavia, può succedere anche nelle buone famiglie che qualcuno debba sloggiare.....

Anche tra il cormorano e l’airone cenerino non c’é alcuna rivalità, ed é facile vederli in compagnia come nella foto sotto.

Ma anche a Portofino (foto sopra), oppure sul faraglione di puddinga in compagnia di un gabbiano (foto sotto).

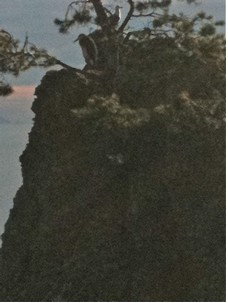
Sul lungomare di Rapallo l’airone sverna con gli anziani villeggianti e spesso si apparta nei dintorni del Castello medievale.
Un Po’ di Storia.
La pesca con il cormorano ha radici antichissime. In Giappone, la pesca con il cormorano veniva chiamata Ukai. L'attività di pesca attraverso questo metodo era concentrata in 13 città tra cui Gifu, ancora oggi comunità-simbolo della pesca con il cormorano sul fiume Nagara.
La pesca Ukai era molto popolare durante i periodi Heian e Edo, e veniva patrocinata dai governatori locali per catturare il pesce da donare alla famiglia imperiale.
Questa forma di pesca primordiale, mosse quindi i suoi primi passi in Giappone intorno al VII° secolo, fu importata in Cina intorno al X° secolo dopo Cristo, ed è cambiata molto poco nel corso dei secoli. In Cina, il pescatore usa ancora oggi una zattera assemblata con canne di bambù, passa l’intera vita sull'acqua con i suoi uccelli e li addestra, con un piccolo trucco, a restituire il pesce che cattura. La pesca con il cormorano è veramente uno spettacolo da vedere per la sua semplicità ed efficacia allo stesso momento. Tutto quel che serve è un natante che galleggi, un paio d’anni per l’addestramento del cacciatore e, soprattutto, un millennio di tradizione... Infatti, gestire un cormorano non è l'impresa più facile di questo mondo: i pescatori legano una sottile corda di canapa (o un anello metallico) attorno alla gola del volatile per evitare che possa ingoiare il pesce grande, lasciando inghiottire quello più piccolo. Con questo metodo astuto e non violento, il cormorano soddisfa le sue esigenze alimentari ed il pescatore quelle commerciali.

Appena il cormorano cattura il pesce, il pescatore lo rimorchia verso la barca tramite una sottile cimetta costringendolo a sputare il pesce.
Come avviene l’addestramento? Innanzitutto occorre catturare i cormorani, che vengono scelti tra le quattro specie di cormorani marini, più grossi dei loro parenti di fiume e in grado di trasportare più pesce. Sono inoltre dotati di una maggiore resistenza, hanno un'indole più docile, tendono a non competere tra loro per il cibo e sono facilmente catturabili. Il pescatore usa la dolcezza e l’amicizia. Ogni mattina, il pescatore lo porta al fiume a fare il bagno tenendolo con un sottile guinzaglio legato attorno al collo. In questo modo il cormorano si abitua alla presenza del padrone che ogni tanto lo accarezza e lo coccola.


Occorrono quasi tre anni per addestrare un cormorano marino selvatico. In questa lunga fase “scolastica” viene nutrito con pesce d'acqua dolce che non ha mai pescato prima.
In Giappone la pesca col cormorano inizia intorno alle 19.30 e dura quasi tutta la notte. Per cinque mesi all'anno, 10-12 cormorani e 3-6 pescatori escono in barca illuminando il fiume con torce di legno di pino.
Ad un segnale del capo pesca, i cormorani si tuffano in acqua e iniziano a nuotare perlustrando la zona che gli é consentita dal lunghezza della cima. Un cormorano può raggiungere diverse decine di metri di profondità, anche se la pesca Ukai si svolge generalmente in acque dolci alquanto basse.
Ogni cormorano si nutre di circa 750 grammi di pesce al giorno, e può ritornare verso la barca con 5-6 pesci dopo ogni tuffo.
*Nota. La parola CORMORANO, detto anche MARANGONE deriva dal nome degli uccelli «smergo», uccello tuffatore. Deriva dal Latino classico: mergus, “smergo”, dal verbo “mergo” immergere, tuffare. E’ evidente il passaggio al nome “palombaro”, ma anche al marangone (in veneto: marangoni de nave é il carpentiere specializzato in riparazioni subacquee). Sul sito di Mare Nostrum Rapallo abbiamo dedicato al saggio: “La navi di Caligola a Nemi”, un importante capitolo in cui si narra che il primo tentativo di recuperare quelle navi fu fatto nel 1446 dal celebre architetto Leon Battista Alberti, che si avvalse dell’opera di nuotatori subacquei genovesi chiamati, appunto, “marangoni” per la loro resistenza e capacità di lavorare in immersione.

*Il CORMORANO è un uccello di grandi dimensioni dal manto parzialmente nero e il becco ad uncino. Vi è comunque un'ampia variazione in termini di dimensioni nella vasta gamma di specie. Sono stati riportati cormorani dal peso di 1,5 kg fino a 5,3 kg, ma il peso medio si aggira fra i 2,6 a 3,7 kg. La lunghezza può variare da 70 a 102 cm e l'apertura alare da 121 a 160 cm. Ha un lungo collo a forma di S elastico che permette di far passare pesci grandi fino all'esofago. Gli adulti si distinguono dai giovani dal piumaggio marroncino. Ben adattato sia all'acqua dolce sia salata, il cormorano gode di una buona vista fino a nove metri. I cormorani hanno le piume permeabili e per questo motivo passano molto tempo al sole ad asciugarsi le penne. Le zampe hanno grandi membrane che gli danno una grande spinta sott'acqua. Inoltre, quando s’immerge, può arrivare ad una profondità di 6 metri. E’ molto aerodinamico grazie alle ampie ali e alla forma affusolata, invece il decollo dall'acqua è complicato a causa della posizione eretta delle zampe e del peso dell'acqua che impregna le piume. La maggior parte dei cormorani emigra all'inizio della primavera, per la riproduzione, nell'emisfero Sud.
Tutte le specie di cormorano sono carnivore e si nutrono principalmente di pesce, sia d'acqua dolce che d'acqua salata. Spesso per giustificare inutili mattanze si utilizzano leggende metropolitane sostenendo che il cormorano mangia fino a 50 kg di pesce al giorno.
Molti pescatori vedono nel cormorano un concorrente per la pesca. A causa di ciò esso è stato cacciato fin quasi all'estinzione in passato. Grazie a sforzi di conservazione il suo numero è però aumentato. Al momento esistono circa 450.000 uccelli nidificanti in Europa Occidentale. L'aumento della popolazione ha posto ancora una volta il cormorano in conflitto con la pesca. Nel Regno Unito ogni anno, vengono rilasciate delle licenze che permettono di uccidere un numero specificato di cormorani, al fine di contribuire a ridurre la predazione; è tuttavia ancora illegale uccidere un uccello senza tale licenza.
I cormorani della specie Guanay, inoltre, acquisiscono una certa importanza nelle attività agricole, per il fatto di essere le principali fonti di guano, usato come concime.
Carlo GATTI
Rapallo, 25.12.2012
Ringrazio gli autori delle bellissime fotografie “firmate” che ho usato a puro scopo divulgativo della cultura marinara, essendo questo il primo articolo dello Statuto della nostra Associazione senza scopo di lucro.
(Webmaster Carlo Gatti)
RAPALLO naviga sui SETTEMARI
LO SAPEVATE CHE LA M/N RAPALLO
“NAVIGA” SUI SETTEMARI?

La MSC (Mediterranean Shipping Company) di Gianluigi Aponte ha voluto riservare, proprio a noi rapallini, rapallitani (vedi Treccani) e rapallesi, una sorpresa che non può passare inosservata: ha battezzato MSC RAPALLO la sua ultima unità entrata in servizio nel 2012.
La flotta comprende navi con una capacità massima di 14.000 TEU includendo una delle più grandi navi portacontenitori del mondo, la MSC CAMILLE. L'azienda è interamente posseduta dal suo presidente G. Aponte e dalla sua famiglia, un grande esempio di capacità imprenditoriale italiana.

MSC RAPALLO
13.050 TEU (N° contenitori - Twenty feet - equivalent - unit)
143.521 tonnellate di Stazza Lorda.
Lunghezza = 366 metri - Larghezza 48 metri
Anno di costruzione 2011
La portacontenitori MSC RAPALLO é una delle navi più grandi al mondo. Fa parte dell’enorme Flotta (444 navi) che il Comandante sorrentino Gianluigi Aponte ha creato dal nulla, con tanto coraggio e antico fiuto marinaro.
L’Impero di Gianluigi Aponte

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

30 maggio 2012 - Parte la MSC DIVINA nel nome di Sophia Loren a braccetto del comandante Bossi e dell’amico d’infanzia Gianluigi Aponte
Gli armatori che dominano la scena mondiale dei trasporti marittimi nel nuovo millennio, sono per lo più magnati del petrolio, potenti gruppi bancari e ricchi imprenditori che provengono anonimamente dai più disparati settori economici. Non tutti sanno, per esempio, che il nostro bistrattato Paese vanta in questo settore una “eccellenza” che tutti c’invidiano e che oggi andiamo a conoscere più da vicino.
Autore di questa grande impresa é l'armatore Gianluigi Aponte, discendente di un’antica stirpe di armatori sorrentini. La sua carriera inizia con il grado di giovane marinaio che si diploma al Nautico e arriva in pochi anni ad ottenere il sospirato Comando, ma come notiamo scorrendo alcune pagine della sua vita, l’uomo aveva ben altro nel suo DNA. Oggi é l’unico Armatore di alta classifica mondiale ad essere proprietario “esclusivo” delle sue navi mantenendo intatta la tradizione di tanti armatori privati italiani del recente passato che, mettendoci il nome e la faccia, crearono benessere e tanti posti di lavoro. I loro nomi sono: Barbaro, Bibolini, Bottiglieri, Cameli, Costa, Cosulich, D’Amico, D’Alesio, D’Amato, Fassio, Frassinetti, Gavarone, Grimaldi, Lauro, Messina, Onorato, Ravano ecc... alcuni dei quali sono ancora oggi sinonimo di grande prestigio dell’Italia sul mare.

MSC RAPALLO
Un po’ di Storia
Nel 1969, con coraggio e lungimiranza, G.Aponte acquista la sua prima nave da carico Patricia, e inizia così a trasportare diversi tipi di merci sulle rotte africane. Gli affari vanno bene. Ormai ha rotto il ghiaccio.
Nel 1970 fonda la Compagnia privata Aponte Shipping Company e l’anno successivo compra un'altra nave ancora più grande a cui dà il nome di sua moglie, Rafaela.
Nel 1973 Arriva la terza unità, il Carriere Ilse. Queste tre navi sono inizialmente posizionate in Mediterraneo, in Africa orientale e nel Mar Rosso, ma in seguito diventano operative anche in Nord America e in Australia. Passano circa 14 anni di serio e duro lavoro, ma anche di grandi profitti.
Nel 1987, la Compagnia si affaccia nel settore crocieristico con l’acquisto della vecchia nave passeggeri Monterey (monoelica) che viene successivamente venduta quando Gianluigi Aponte, in onore del suo mentore, Achille Lauro, decide di rilevare quella che fu la prestigiosa Flotta Lauro. MSC Crociere decolla come parte di un solido gruppo e aggiunge alla sua flotta altre due navi passeggeri usate, ma eleganti: Rhapsody e Melody. Nell’ambiente si intuisce che l’invisibile (così fu definito) armatore napoletano Gianluigi Aponte é un imprenditore capace, dotato di notevole carisma, che sa scalare le posizioni in classifica con prudenza, ma anche con infallibile fiuto e determinazione.
Nel 1995 l'ormai famoso armatore sorrentino acquisisce anche la Compagnia Marittima “Snav”, società costituita da aliscafi e traghetti a impegnata nei collegamenti con le principali isole italiane . Tutto ciò che fallisce per incapacità imprenditoriale, nelle sue mani diventa reddito e posti di lavoro, sia a bordo che in terra. Assorbe numerose navi porta contenitori della Soc. Italia e Lloyd Triestino ormai in dissesto finanziario, ma anche navi di altre Società che non funzionano per altri motivi. Trascorrono otto anni di lavoro intenso con grande espansione di traffici e successi crescenti.
Nel 2003 ha inizio il piano d’investimenti da 5,5 miliardi che ha reso MSC Crociere una delle più giovani Compagnie di crociere leader a livello mondiale. Il piano, terminato nel 2010 con l'entrata in servizio dell'undicesima unità, è stato integrato con la commessa di una nuova nave ammiraglia da 4.000 passeggeri: la MSC Divina che é stata inaugurata il 26 maggio del 2012 a Marsiglia. Dopo diversi anni di crescita senza precedenti, oggi MSC Crociere è in grado di ospitare 1,2 milioni di passeggeri a bordo delle sue navi e con l'arrivo di MSC Divina raggiungerà il traguardo di 1,4 milioni passeggeri l'anno.
Nel 2007 La linea è stata nominata "Compagnia di Navigazione dell'anno" dalla Lloyds Loading List.
Nel 2008 è stato inaugurato il quartier generale di MSC India, MSC House.
Nel 2008 Forbes gli attribuisce un patrimonio di 2,8 miliardi di dollari dichiarando Gianluigi Aponte il 412° uomo più ricco del mondo.
Nel 2009 diventa uno degli azionisti della CAI (Compagnia Aerea Italiana) in seguito alla privatizzazione voluta dal Governo italiano.
Nell'ottobre 2010 acquisisce il 51% delle azioni della compagnia navale " Grandi Navi Veloci" che fonderà con SNAV.
Nel novembre 2011 acquista il 51% di "Bluvacanze" “ e "Cisalpina Tour".
Nell'aprile 2011 la MSC si avvicina a quota 2 milioni di TEU nella capacità complessiva della sua flotta.
La compagnia oggi
Il quartier generale della Compagnia é a Ginevra , in Svizzera, la sede operativa a Piana di Sorrento, in Italia, mentre il principale hub* della linea si trova ad Anversa, in Belgio .
La Mediterranean Shipping Company (MSC) , compie 43 anni ed è la seconda Compagnia merci più grande del mondo dopo la danese Maersk-Sealand . Dispone di 420 Agenzie di rappresentanza impiegando un totale di 28.000 persone in tutto il mondo ed è dotata di una flotta di 444 navi da carico che scalano 306 porti di tutti i continenti. Si tratta di un record decisamente storico per la compagnia.
Concludiamo con il formidabile elenco delle navi della MSC Crociere:
MSC MAGNIFICA, MSC FANTASIA, MSC POESIA, MSC MUSICA, MSC LIRICA, MSC ARMONIA, MSC DIVINA, MSC SPLENDIDA, MSC PREZIOSA, MSC ORCHESTRA, MSC OPERA, MSC SINFONIA, MSC MELODY.
Com’é noto, grazie a queste modernissime navi passeggeri, la MSC si é strategicamente posizionata tra i due gruppi CARNIVAL CORPORATION e ROYAL CARRIBEAN INTERNATIONAL che fino a qualche anno fa si dividevano, incontrastate, il mercato mondiale delle crociere.
* Hub Port: porto nodale scalato dalla nave “madre” sul quale converge e dal quale muove il traffico smistato dalle navi “feeder”.
Carlo GATTI
Rapallo, 24.12.2012
ALBUM FOTOGRAFICO





(Archivio Pino Sorio)
Un "SUPERSTITE" del REX
EZIO STARNINI
Un "superstite" del REX
Mare Nostrum 2012 ha operato un full immersion nel periodo più glorioso della marineria italiana e forse, senza neppure accorgercene, ci siamo imbarcati sul mitico REX dove abbiamo conosciuto personaggi della Riviera che, con la loro tipica semplicità marinara, ci hanno fatto rivivere momenti di autentica magia.
EZIO STARNINI é uno degli ultimi superstiti dell’epoca d’oro dei transatlantici, uno dei pochi che ancora oggi possa dire con orgoglio:
“Nel viaggio inaugurale del REX e del CONTE DI SAVOIA, c’ero anch’io! Avevo 16 anni, ero ascensorista e da Piccolo di Camera fui promosso Garzone di prima scelta. Un carrierone!”
In effetti, sfogliando il suo libretto di navigazione, scorrono gli imbarchi che fece sia con il Comandante Francesco Tarabotto (Rex), sia con il comandante Antonio Lena (Conte di Savoia) sulla quale rimase per ben quattro anni.
Totalizzò in tutto 42 mesi e rotti giorni di navigazione. Nel 1936 rimase “incastrato” in Marina e si fece anche tutta la Seconda guerra mondiale riportando anche gravi ferite. L'8 settembre del ‘43 dovette scappare senza ordini (come tanti italiani... purtroppo!). Si rifugiò sui monti fino alla fine della guerra. Nel dopoguerra si diplomò ‘ragioniere’ e fece un’ottima carriera nella MOBIL OIL a Roma dove diventò dirigente d’Azienda.

Ezio Starnini (nell'ovale), era uno sportivo e faceva parte della squadra di pallacanestro del CONTE DI SAVOIA. Nella foto giganteggia Primo Carnera, il più grande boxeur italiano (in tutti i sensi...) che viaggiava su quella nave, diretto in America alla conquista del titolo mondiale dei pesi massimi. Concedeteci un’amena curiosità: di ritorno dagli States, il pugile venne borseggiato in un vicolo dell’angiporto genovese. Il fatto venne riportato da IL SECOLO XIX e il ladro – aggiungiamo noi con un pizzico di preoccupazione - doveva essere un temerario considerando la stazza di Carnera che se si fosse accorto in tempo del furto lo avrebbe sicuramente conciato per le feste!
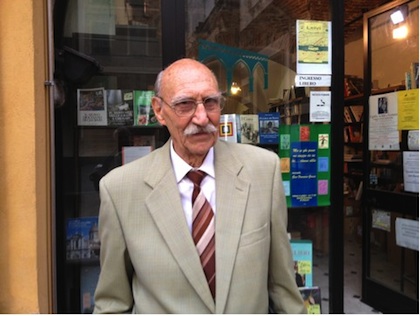
EZIO STARNINI, 96 anni, (nella foto) é una persona speciale, un vero signore d'altri tempi. Al suo curriculum occorre aggiungere un “tassello mancante”, infatti, il nostro 'superstite' è anche estremamente attivo come scrittore avendo recentemente pubblicato un libro dal titolo, appunto:
"IL TASSELLO MANCANTE"
Ezio ha voluto darci un ‘assaggio’ della sua vena letteraria con una testimonianza che vi proponiamo qui di seguito: é il racconto di un’emergenza che visse personalmente sul Conte di Savoia al comando di Antonio Lena.
VISSUTO D'EPOCA SUL CONTE DI SAVOIA
Nel Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, osservo interessato i modelli in scala di due grandi transatlantici: il REX e il CONTE DI SAVOIA. Noto in essi la perfetta riproduzione, dei particolari: l'armamento, Ie verande, il Sun-deck, gli arredi esterni nella loro stupenda minuziosità, gli ampi oblò a finestra del Ponte A ... il Salone-Colonna!
Ed eccomi, a novantasei anni, avulso dalla realtà e riprovare, con emozione crescente, un episodio nel mio vissuto d'epoca: groom sedicenne, ascensorista a bordo del Conte di Savoia in rotta verso New York.
Vengo svegliato a notte fonda dal Capitan d'arme che, sbrigativo, con due marinai di coperta mi sloggia dal letto, mi allontana in malo modo e si appropria del materasso. Al mio sbalordito e ritroso : "Ehi... che fate?... Perche?", risponde brusco: "Una falla nella murata di babordo; imbarca acqua e bisogna tamponarla. Tu porta l'ascensore del Ponte A, su, al Salone Colonna. Stai pronto e zitto."
Burbero come quando era entrato, seguendo i marinai con l'ingombro esce dalla cabina senz'altro aggiungere. Sconcertato, mi domando perché proprio il "mio materasso", e non ... La risposta mi viene spontanea; occorre, subito, un ascensorista e un materasso?
Eccoli pronti, l'uno e l'altro contemporaneamente; nel bisogno la praticità è preziosa!
Mi vesto in fretta, mentre nel cervello in subbuglio i pensieri si accalcano: una falla?; quanto sotto se imbarca? E in pieno Gulfstream. II silenzio delle macchine mi dice che la nave è ferma, ragiono. Per niente impaurito, salgo agile per conosciute scale e corridoi, raggiungo presto l'ascensore del Ponte A e lo porto su, al Salone Colonna, meraviglia d'arte e vanto della Classe di lusso della nave. Entro ed osservo stranito la scena nella luce abbassata del vasto locale. Il Comandante Lena, il Primo Ufficiale e un Terzo, il Capo Allogi mio diretto superiore - due garzoni di sala, sono sporti dalla finestre sulla murata, gli splendidi tendaggi arrotolati, poltrone dorate spinte altrove, il prezioso tappeto parzialmente ripiegato... disordine. Trovo spazio, mi sporgo, sull'immensità buia e corro con gli occhi nella luce incrociata di due fari puntati sulla murata, in basso, all'altezza del Ponte C, in corrispondenza verticale con Ie finestre dove si trovano il Comandante e il Primo Ufficiale.
Dal portello aperto sul bagagliaio in quella precaria luminosità esce lento un tavolone grezzamente squadrato, col mio materasso inchiavardato: il tampone. Legato a dei cavi, scorre in basso a piccoli strappi accompagnato dalla luce dei fari; scende giù fino al pelo dell'acqua; acqua per fortuna non molto agitata, ma sempre mare dell'Oceano Atlantico, nel pieno della corrente ascensionale del Golfo, non lontano dalla punta Nord del famigerato triangolo delle Bermude. Nella chiazza di luce, calato con una robusta cima al petto, appare un uomo, Egli si agguanta al tampone, ad ampi gesti verso I'alto ne coordina la posizione, quindi, saldamente aggrappato al pesante aggeggio, affonda, scompare.
I fari battono il mare, ma la luce non mostra l'uomo faticare, privo del respiro, nell'opera viva della nave; non penetra I'agitata compattezza marina. Un paio di metri sotto il livello, in apnea, nell'acqua gelida e irrequieta, I'uomo farà una cosa straordinaria: profittando del vorticare del gorgo, ma pure temendone la forza attrattiva, farà scorrere sul corpo grinzoso della nave, il grosso, riluttante e mobile tampone sulla falla; col residuo delle forze fisiche e del respiro, cercherà di sistemarlo al meglio sullo squarcio dai margini sghembi e taglienti fra gli impeti del gorgo e risalirà all'aria stremato.
Teso quasi allo spasimo, fisso con gli occhi sbarrati la macchia di luce sul mare che copre I'uomo da troppo tempo: minuti, ma quanti? II tempo scorre lento e l'ansia ! Un improvviso rigurgito su quella superficie agitata, è il segno che la falla è finalmente otturata; ma il breve sollievo non sminuisce I'ansia: I'uomo ? ... Egli affiora nel ribollio dell'acqua, la testa ... respira; la corda al petto si tende ed egli è issato velocemente nel ventre delta nave, giusto da dove ne era uscito per I'arduo compito.
II Comandante si erge lento, sul suo volto un sorriso fugace lascia il posto al consueto tono di fermezza; dalle labbra semiserrate, un "bravo" appena si ode,
Affiancato dal Primo Ufficiale sollecito e sorridente; e da tutti seguito, s'avvia spedito all'uscita - che io ho appena oltrepassato. Senza fermarsi, con voce chiara scandisce:
"Domattina, quassù deve essere tutto in perfetto ordine. Ora scendiamo nel bagagliaio del Ponte C. Stringerò la mano a un mio eroico marinaio".
Di quell'uomo, del marinaio Gennaro Donnarumma divenni amico allorchè, stringendogli anch'io la mano, ebbi modo di raccontargli Ie mie ansie. Modestamente, come semplice e modesto egli stesso era, sorridendo mi disse: "Embè.. guagliò, quando c'e da fare, si fa, Non te lo scordare",
Ed io, come questo racconto-verità lo dimostra, ancora ricordo.
Ezio Starnini
A cura di
Carlo GATTI
Rapallo, 22.11.2012
Si ringraziano i com.ti Ernani Andreatta ed Enzo Gaggero. Alla loro disponibilità si deve la presente testimonianza.
L'UOMO DI MARE - Poesia
RICORDI DI MARE
Il signor Francesco Bodrati di Camogli era il proprietario di un negozio di alimentari di fronte alla Chiesa del Boschetto che svetta sopra l'Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Camogli. Oggi é ultraottantenne ed é difficile calcolare quanti "equipaggi" di studenti abbia sfamato, dal dopoguerra in poi, con la vendita e la distribuzione di FOCACCIA all'ora della ricreazione. La maggior parte di noi, forse, si é dimenticato di quell'uomo, ma lui non si é dimenticato di noi che salpammo un giorno portandoci nel cuore il ricordo degli anni più belli della nostra vita: gli anni del Nautico. La poesia che segue é semplice, spontanea, ma densa di significati e ricordi. Grazie Bodrati, anche tu hai navigato con noi, ma solo oggi l'abbiamo capito.
Ringrazio il Comandante Mario Terenzio Palombo per avercela segnalata.
Carlo Gatti
31 ottobre 2012
L’UOMO DI MARE
“Cosa ti spinse a navigare?
-chiesi un dì ad un uomo di mare-
Fu forse il canto di una sirena
che emersa dall’onde ti ammaliò?”
Non sentì la mia voce,
una mano portò sopra il petto:
si fece il segno di croce
chinò riverente il capo a Maria
venerata nel nostro Boschetto.
Quando il sole tramonta e viene la sera,
dalla vecchia tua casa in collina,
devoto saluti con la preghiera
chi dall’alto ti è stata vicina.
Con gli occhi socchiusi ti par di sognare
paesi lontani e burrasche passate,
un po’ del tuo cuore è rimasto sul mare!
Ora lascia le carte, riponi il sestante:
“Auguri a te Comandante!”
Tu che con fretta passi per via,
il tuo andare spedito rallenta:
volgi un pensiero a Maria
che con occhi benedicenti
fortuna augura ai naviganti.
Francesco Bodrati
Camogli
11-2011