UN IMBARCO ISTRUTTIVO... GIUAN DI CARUGGI
UN IMBARCO ISTRUTTIVO…
Giuan di caruggi…


La NESSY FRIEND era una moderna petroliera dei primi Anni ’60.
Buona strumentazione, locali spaziosi all’americana, una palestra da ginnastica (rimasta sempre chiusa per ordine del Comandante) ed altri comfort che, al momento dell’imbarco, ci avevano fatto dimenticare i disagi raccontati da tanti marittimi imbarcati su carrette tirate su dal fondo nel dopoguerra. La nave aveva una potente turbina che ci spingeva a quasi 20 nodi ci velocità e i viaggi ci sembravano più corti, ma era solo un’impressione. La sala macchina era sempre pulita e gli ufficiali indossavano la tuta bianca come gli ingegneri di terra. Il loro “sano” ambiente sembrava appartenesse ad un’altra nave, o quanto meno ad un’altra famiglia, saggia e di buoni principi.
L’equipaggio era sottoposto alla universale legge del mare:
- - fare la guardia con scrupolo per partire, navigare e arrivare in sicurezza;
- - controllare la posizione della nave tre volte al giorno;
- - raschiare e pitturare in continuazione, anche in Golfo Persico in estate con 50°-60° di calore, non escluso i gavoni di prora e di poppa;
- - il radar era un ottimo Raytheon ma apparteneva ad una sola persona: il Comandante che non era uno stupido, tutt’altro! Ma per capire il suo modo di pensare e di agire occorreva aggiungere circa 130 anni ai suoi 45, e andare indietro nel tempo: al trasporto dei Coolies cinesi nelle stive da Macao al Perù… (Vedi su questo sito: NAPOLEONE CANEVARO, i COOLIES cinesi si ammuntinano).
Per lui la parola DEMOCRAZIA era svuotata di ogni significato in tutti i suoi pensieri, atti ed atteggiamenti.
L’equipaggio proveniva dalle due riviere, solo il Comandante, naturalizzato genovese, era di una città vicino a Napoli.
Quella nave aveva un solo difetto: batteva bandiera ombra - liberiana e l’unica legge vigente a bordo era quella del Comandante che, come avete capito era uno “padre - padrone psicopatico”.
La parte burocratica del viaggio: registrazione arrivi e partenze dai porti, le avarie della nave, del carico, sbarchi-imbarchi equipaggio, eventuali problemi di qualsiasi tipo (assicurazioni, perizie ecc…) erano “risolti” presso il Consolato Liberiano del porto scalato, il quale era del tutto disinteressato alle “beghe da frati” che accadevano tra i rissosi equipaggi latini…
A dire il vero il Comandante era un uomo di mare che conosceva alla perfezione il numero dei bulloni della “sua” nave, era un “tappo” che faceva coppia con il 1° Uff.le di coperta; avevano la stessa età ma tra loro c’era un abisso nell’intendere il concetto di normalità da applicare in un ambiente di lavoro difficile, insano e dislocato in mezzo al mare.
I due soggetti entrarono in conflitto fin dalla partenza da Palermo dove la nave aveva fatto lavori importanti sia in macchina che in coperta.
Quell’imbarco “sui generis” iniziò quando fu anche troppo evidente che i Sottufficiali di coperta prendevano ordini soltanto dal Comandante, in barba all’antica consuetudine di bordo che vede tuttora il 1° ufficiale assegnare ogni mattina i lavori giornalieri al nostromo, tankista, carpentiere e cuoco. Il 1° ufficiale del ponente ligure non accettò mai di essere messo da parte in quel modo scorretto e prepotente e da quel momento condusse una battaglia psicologica che caratterizzò e classificò quell’imbarco come il peggiore in assoluto vissuto da quell’equipaggio nella loro vita da naviganti.
Alla mafia dei “torresi”, così era configurata quella particolare situazione di bordo, si aggiungevano altre figure direi “intimidatorie” che seguivano fedelmente il Comandante ad ogni imbarco: uno era un gigantesco lericino, cameriere della mensa Ufficiali, quarantenne che pochi anni primi era stato campione di pugilato nella categoria dei mediomassimi. Poi c’era il suo cameriere personale, una specie di “rasputin” che aveva il compito di riportargli tutti i “ceti” che origliava tra le “sonorizzate” paratie della nave.
Comandante e 1° ufficiale si parlavano per interposte persone ed era ormai percezione comune che prima o poi ci sarebbe scappato il morto… Per fortuna non andò così, ma non mancarono le risse e le beccate tra questi due “pesi gallo”, qualche occhio nero, minacce di denunce che poi vennero sempre archiviate a causa della “disinteressata” bandiera liberiana…
Le disavventure di quell’imbarco durarono a lungo e peggiorarono quando la parte “normale” dell’equipaggio si accorse che le provviste “buone” della cambusa venivano sbarcate e contrabbandate nei porti dalla “famiglia caina”, e per l’equipaggio rimaneva soltanto da consumare il cibo in scatola.
Questa fu l’atmosfera che respirai al mio primo imbarco da Allievo Ufficiale di coperta che mi vide subito schierato, direi “appiccicato” al 1° ufficiale perché da lui dovevo imparare il mestiere, sia durante le guardie in navigazione, sia in segreteria, sia nella gestione del carico.
Un imbarco sfortunato e scioccante che per fortuna si concluse dopo 7 mesi e 24 giorni quando il santo protettore dei marittimi s’impietosì al punto da dire: “ora basta”!

Il Golfo Persico


Il monte Fuji detto anche Fujiyama
La nave, dopo sei viaggi consecutivi Golfo Persico - Giappone, ne fece un altro per Luanda (Angola) e poi finalmente si verificò il miracolo che nessuno aveva osato immaginare: il viaggio per Genova, dove ¾ dell’equipaggio sbarcò per motivi personali… senza doversi pagare il viaggio di rientro, per esempio dal Giappone, e neppure quello del rimpiazzo subentrante.
Solo in questo modo il nostro “dimagrito” equipaggio ebbe il suo giorno della liberazione!
Un imbarco così disastroso avrebbe meritato di essere analizzato da una commissione di psichiatri e non solo… anche perché non poteva che concludersi con un finale altrettanto “psicopatico”; vi anticipo che non fu tragico come l’immaginazione di ognuno potrebbe suggerire, ma fu di tutt’altro tipo che definirei comico… giudicate voi stessi!
Direi quindi che lo scopo di questo memory non é quello di coinvolgere il lettore nella storia “pietistica” del mio primo imbarco che potrebbe interessare solo una piccola parte dei miei conoscenti; ma piuttosto l’esperienza che ne derivò dall’aver scoperto quanto la solitudine del marittimo sia la causa di tanti malesseri che sono difficili da spiegare alla gente di terra che ogni sera, nella propria oasi famigliare, scarica le tensioni e poi “risorge” per affrontare lo stress del giorno dopo nell’ambiente che gli dà le risorse per vivere.
Vi devo subito presentare l’elemento “chiave” di quell’avventuroso arrivo a Genova.
Giuan di caruggi, imbarcato sulla Nessy Friend con la qualifica di “giovanotto di coperta”, era la sagoma di bordo, ovvero il “giullare” di quei pochi momenti di relax che erano rimasti tra un programma e l’altro di RADIO CUCINA che annunciava solo casini…

Giuan nel suo regno
Giuan era una leggera da angiporto, una specie di saltimbanco, di scimmia ammaestrata, che prendeva tutti per il culo senza offendere nessuno, rispettava i graduati ma con loro scherzava sempre tra ironia e satira e non andava mai sopra le righe. Il suo pensiero era uno soltanto… “prima o poi ve lo metterò in quel in posto…”.
Aveva ragione! Il suo momento di gloria non tardò ad arrivare, l’home-voyage per i Porto Petroli di Multedo-Genova era stato annunciato giusto in tempo per fargli organizzare un “progetto di rapina ad hoc”.

In quegli anni il Giappone viveva il suo magic moment tecnologico ed aveva imposto sui mercati internazionali il primato di qualità e quantità di macchine fotografiche, walky-talkie, radio di ogni tipo, altoparlanti, binocoli e registratori. I marchi Minolta, Canon, Yashica, Fuji ed altri che non ricordo, erano sulla cresta dell’onda ed i lettori con i capelli grigi li ricorderanno per aver caratterizzato i mitici anni ’60, un decennio reso famoso per il boom economico che rappresentò il più importante rinnovamento, anche generazionale, del secolo scorso.
L’Estremo Oriente, tra cui le città-stato: Hong Kong e Singapore, aveva il monopolio della costruzione e della vendita di questi richiestissimi prodotti altamente sofisticati che si trovavano sparsi nelle vetrine di tutti i mercati del mondo. Tuttavia, a questo enorme “laboratorio” ufficiale, si associava un altro mercato parallelo che viveva sottobanco ed alimentava il contrabbando internazionale specialmente negli angiporti europei.
Tra i marittimi c’era una specie di malattia da competizione tra chi riusciva a farne incetta con il miglior rapporto prezzo/qualità, ma quegli apparati avevano il fascino della modernità orientale: antenne lunghe e tante minuscole manopole che miglioravano i suoni e le musiche secondo parametri a noi sconosciuti. Le “voci dall’Italia” giungevano chiare di notte sulle onde corte “e il naufragar (dello spirito) m’era dolce in questo mare”.
Anche il look era particolare: prevaleva il colore nero lucido con strisce metalliche lucenti che davano eleganza e mistero all’oggetto.
In Giappone i loro prezzi erano di gran lunga convenienti, circa un terzo del valore pattuito di contrabbando in Italia, insomma si trattava di un business molto ambito da tutti i marittimi in circolazione in quel periodo! Guadagnarsi un extra stipendio era il sogno che spesso faceva dimenticare le disavventure di bordo, la nostalgia e la lontananza dall’Italia.
Forse avrete già capito il senso del contendere: sei viaggi per il Giappone in quel periodo potevano valere una fortuna per i contrabbandieri di alto bordo, ma anche per i marittimi di un certo tipo…

Purtroppo l’ingenuità dei marittimi più abbelinati stava per scontrarsi con la strategia dell’astuto Giuan di caruggi!
Arrivammo a Genova nel tardo pomeriggio. I piloti del porto ci avvisarono che l’ormeggio al porto Petroli di Multedo si sarebbe liberato soltanto dopo qualche giorno e il Comandante fu invitato a dare fondo l’ancora garantendo l’ascolto continuo per eventuali istruzioni.
Il Comandante abitava a Genova-Sturla per cui decise di dare fondo in quella zona per poter salutare sua moglie con il fischio di bordo.
Non essendo la nave in “libera pratica” (sanitaria) era tassativamente proibito all’equipaggio trasferirsi a terra con qualsiasi mezzo si fosse presentato sottobordo.
“Fatta la legge trovato l’inganno” !
Giuan di caruggi conosceva il Codice della Navigazione più di tanti esperti ufficiali di bordo e trovò il modo e la maniera di “portare in porto…” il suo sogno!
Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni di bordo, verso le due di notte un motoscafo o qualcosa del genere, si affiancò a luci spente dal lato di sottovento dov’era pronta una biscaglina pronta ad essere calata in mare al segnale pattuito.
In pochi minuti 20 valige piene di prodotti giapponesi, furono calate sulla lancia tramite due heaving-line, con la PROMESSA che sarebbero state occultate in un magazzino costiero nella vicina Sturla, nell’attesa di essere ritirate, previa compensa, dai proprietari che mai sarebbero passati da un varco doganale del porto di Genova per pagare le dovute tasse allo Stato italiano.
Il cliente più diffidente dell’equipaggio, all’ultimo momento ebbe qualche dubbio e chiese a Giuan di caruggi delle garanzie sull’intera operazione: costi e recupero della merce. Evidentemente non era tutto chiaro! Ma a quel punto venne fuori la prontezza di spirito e la genialità di Giuan il funambolo il quale, messo un po’ alle strette, dichiarò solennemente:
“Io sono la vostra garanzia. Seguirò la merce fino a destinazione. Sparirò dalla nave per qualche ora, vi lascio i miei documenti e i miei averi in consegna, ecco le chiavi della cabina e del mio armadietto. Se nel frattempo mi cercassero, voi non sapete nulla e non avete visto nulla! Rientrerò in tempo per fare la mia guardia in coperta. State tranquilli! Sistemerò io le vostre valige e al momento giusto festeggeremo il business nel miglior ristorante di via Pré!”
La merce lasciò la Nessy Friend scivolando via tra le acque amiche velate di tramontana e di tanto mistero!
A questo punto anche il lettore meno smaliziato avrà capito che quella notte Giuan di caruggi passò al comando di quel motoscafo-fantasma e sparì per sempre… chissà dove… chissà con chi… e di lui non si seppe più nulla, for ever!
A bordo, il giorno dopo, in tanti piansero rendendosi conto di non poter mai più rivendicare la loro merce di contrabbando… altri se la risero di nascosto ma con l’amaro in bocca per non aver sconsigliato con più veemenza quella pazza idea al loro compagno di bordo e di sventura.
Chi scrive ebbe un’altra storia: quella di sentirsi totalmente “abbelinato” per circa sette mesi! Poi, quando ormai si era convinto d’aver sbagliato tutto, improvvisamente, si vide consegnare presso le FFSS di Rapallo un gran bel pacco con tutto quello che aveva comprato e spedito da Yokohama seguendo il consiglio di un anziano giapponese in kimono che lo aveva intenerito con i suoi numerosi inchini di rispetto e per l’antica saggezza che emanava sotto i baffi e la barba bianca, lunga e appuntita.
Il pacco, imbarcato chissà su quale misterioso treno, attraversò tutta l’Asia imballato a regola d’arte, al punto che nulla fu danneggiato, neppure il servizio da tè, con le belle geishe in trasparenza sul fondo, che ancora oggi “sorridono” nel mio salotto buono…

In seguito si seppe che il Comandante cambiò velocemente Compagnia, forse trovò imbarco su una riedizione del Vascello Fantasma in compagnia dei suoi fedeli pirati… Il suo intimo motto era: Dopo di me il nulla! O forse “despues me Dios!”
Ma ne aveva anche un altro meno aulico e di più recente memoria:
“O con me o contro di me!”
Per ¾ dell’equipaggio sbarcante, quel diavolo di Comandante scrisse peste e corna, tra cui: “l’allievo di coperta non é navigabile”.
Quell’uomo mi aveva profondamente deluso: era un buon marinaio che conosceva tutti i segreti della nave… ma non era un conoscitore di uomini. Dote che in seguito ravvisai in Comandanti, in Direttori di Macchina e in tanti Ufficiali delle tre sezioni con i quali feci lunghissimi imbarchi. Di tutti loro conservo intatto il ricordo della loro umanità e qualità professionali che mi aiutarono a crescere!
Ma la domanda finale é questa: Quanti giovani allievi di coperta avranno rinunciato a battere le VIE DEL MARE per colpa sua?
Carlo GATTI
Rapallo, 25 Febbraio 2018
U FUNTANN-A... era stato fuochista sul REX
U FUNTANN-A

.... era stato fuochista sul REX
Un ricordo del C.l.C. Nunzio Catena
Penso che non vi sia un marittimo della Soc. ITALNAVI che non abbia conosciuto "u FUNTANN-A" a Buenos Aires. Era vicino agli 80 quando l'ho conosciuto, e sono sicuro che é vissuto fino agli 85.
Il REX a Genova. Nel ricordo ormai sbiadito del comandante Nunzio Catena, U FUNTANN-A era alto, magro e molto somigliante alla persona che si trova a cavalcioni sulla pala dell'elica a sinistra della foto.
Era stato fuochista sul REX, poi si era fermato in Argentina, ma non aveva fatto fortuna.
Quando sento quella struggente canzone genovese "..ma se ghe penso.."
Allora penso a u Funtann-a. Quando lo conobbi, allora parlava un po’ di più, gli dicevamo:
"Dàgghe Funtann-a, torna a Zena con noî, no ti devi paga o bigetto, noî émmo l'isolamento, una cabinn-a tutta pe ti, non te daiâ fastidio niscîun.."
E lui rispondeva: "Mi no pòsso, mi sòn vægio, dove vàddo? mi no ò ciù niscîun, chi ò i figgi, i nevi chi àn bezeugno de mi." E gli occhi già stanchi, si inumidivano di lacrime.
A tutti i Comandanti dava del tu, perchè li aveva conosciuti da Allievi. Io gli volevo un bene matto... la mia cabina era a sua disposizione, e quando arrivavamo a Baires, forse era l’unica persona che desideravo incontrare ultimamente, date le sue condizioni. U Funtunn-a era abbastanza alto e robusto, ma conoscendo la sua storia, sembrava di vederlo ancora, dalla piega del suo corpo, intento con la pala di carbone davanti a quelle bocche infernali dei forni, sollecitato dal sadico caporale del REX.
Arrivava e rispondeva ai nostri saluti, quasi distrattamente, come se ci fossimo visti il giorno prima, per lui il tempo era come se non contasse, mentre la sua andatura era sempre più incerta, stanca, triste. Conosceva tutti, ma non ricordava più i nomi, la sua mente era lontana e, a stento, gli veniva in mente il nome della nave ed il grado che ricopriva.
Aveva una borsa di tela olona ritagliata da un pezzo d’incerata blu da boccaporto, stinta dal sale, dai colpi di mare e bruciata dal sole mordente dei tropici. Quell’articolo era così macilento da non potersi usare neanche come 1a incerata, (la peggiore, quella usata a contatto dei colpi di mare). Sarà stato un regalo di qualche nostromo, mentre la confezione è stata fatta da qualche robusto pennese con aghi da vela e guardamano.
Era molto semplice: un pezzo di tela, piegato in due, cucito ai lati, la parte superiore era avvolta e cucita intorno a due bastoncini, eccetto la parte centrale dove erano ricavate, due grosse asole per l'impugnatura. Tanti anni dopo, ho visto borse di forma e materiale identici, reclamizzate da famose ditte e non ho potuto fare a meno di ricordare U Funtann-a e pensare che, se avesse depositato il brevetto, almeno i suoi nipoti, sarebbero diventati ricchi !!
Arrivava al mattino verso le 10, lui rispondeva al saluto di chi lo incontrava, ma non andava a salutare neanche il Comandante, c'erano troppe scale da fare, s’informava solo se era quello del viaggio precedente. Venendo a conoscenza della presenza d’U Funtann-a, il Comandante sarebbe sceso lui stesso a salutarlo.
Di solito all'arrivo, lo vedevo spuntare in fondo al pontile, tiravo un sospiro di sollievo e gli andavo incontro...
- "Funtann-a... come và??!
- "Mi staggo ben! ben! Ti m’ae portòu ae ciappellette sciacché?"
Forse non mi guardava neanche, cercava la mia spalla per appoggiarci la mano e teneva lo sguardo un po’ basso, come se guardare lontano fosse inutile non avendo mai trovato nulla di buono, oppure per guardare le asperità del terreno che gli rendevano ancora più difficile il passo.
Arrivati a bordo, lo facevo accomodare sul mio divano, riprendeva un po’ il fiato, qualche volta accettava di bere qualcosa... il suo silenzio mi struggeva e spesso non sapevo cosa dire. Se avevo saltato un viaggio, mi chiedeva una giustificazione che suonava come un rimprovero e, dopo la mia spiegazione, mi diceva:
- "L’ho sentio dî da u Secundo Uffiziale do Cervinia". (La M/N Cervinia della stessa Compagnia di Navig.)
- “Adesso Fontann-a, riposati!”
Gli avrei dato del VOI, per rispetto, come si usava dalle mie parti in quel tempo, ed ancora di più, perchè in lui non vedevo più un uomo, ma una vittima sulla quale la natura matrigna aveva sempre infierito e quindi era più degno di rispetto, ma gli davo del TU per farlo sentire più vicino.
- “Adesso vado a dire al Cuoco che mangi dai Sottufficiali. Poi mi dici quello che ti serve. Per il resto non ti preoccupare, ci penso io, ma adesso ho da fare!"
E lui rispondeva:
- "Quande andae via?"
- "Tra tre o quattro giorni!" - Io esageravo sempre un po’.
Durante il pranzo, quand’era possibile, andavo da lui per farlo parlare un po’ con i suoi ‘colleghi più vicini’. Ma non sempre riuscivo nell'intento, poi lo riaccompagnavo in cabina, si sdraiava sul divano, cercavo in qualche maniera di parlare e quando riuscivo ad incrociare il suo sguardo, era come se mi pregasse di lasciarlo da solo.
Quando era ora di andare, nella sua capiente borsa, c'era un po’ di tutto: sigarette, whisky, caffè ed altre cose delle quali era vietata l'importazione. Purtroppo, il povero Funtann-a era conosciuto anche dai finanzieri: quando usciva gli facevano sempre delle storie, o per sequestrargli qualcosa o per rubargli metà del ‘carico’ prima di lasciarlo andare. A pensare che non fermavano neppure i camion che arrivavano sottobordo pieni di ... contrabbando.
Allora, ogni volta mi pregava così:
- "Amìa, quelli da Doganna me fan giâ e cuggie, accumpagname au varcu, ghé sempre un figgio de na gran bagascia che o me ferma tutte ae votte."
Io di solito lo precedevo per sistemare le cose con il finanziere, in modo che si girasse o si allontanasse addirittura quando passavamo noi.
La fermata del ‘collettivo’ era poco distante, ma chi è stato a Baires in quegli anni ricorderà che gli autobus strapieni, alle fermate rallentavano soltanto, la gente ormai saliva e scendeva in corsa, appesi alle maniglie e roba del genere. Quando sarebbe salito U Funtann-a su un autobus? E poi gli avrebbero rubato tutto. Allora gli chiamavo un taxi, con il quale mi mettevo d'accordo per accompagnarlo ed andare a riprenderlo all'indomani, finché eravamo in porto. Quella mattina, mentre lui scendeva, ho regolato il conto con il tassista per non ripetere la corsa nel pomeriggio, temevo che potesse intuire qualcosa. Comunque, prima di scendere da bordo, gli ho detto:
- "Funtann-a, noi dovremmo salpare domani sera, ma se partissimo prima, avviserò il tassista che verrà a dirtelo. Vedi questa busta, ci sono i miei saluti per te, adesso li mettiamo dentro la fodera della giacca. Vedi? Non farli vedere a nessuno. Appena arrivi a casa, nascondili da qualche parte, dove nessuno te li deve trovare. Magari mettili dentro un barattolo che infili sotto terra. Sono già cambiati... prendi quelli che ti servono! Non darli a nessuno mi raccomando!! Hai capito?”
- "Va ben, va ben!"
Prima di salire sul taxi, mi fece la sua ultima richiesta:
- "Non te scorda e ciappellette pe u gasu!”
- "Stai tranquillo Funtann-a!!"
Quando era seduto, ho chiuso la porta ed il suo ultimo saluto me lo fece così: aveva la mano destra sulla spalliera del sedile anteriore, sollevò solo pollice, l’indice e il medio, girando appena la testa verso di me.
Questo fu l'ultimo saluto con "u Funtann-a", io sapevo che sarei sbarcato all'arrivo a Genova, l' "ITALNAVI" non c'era più! Incertezza per noi, la fine della Compagnia do U Funtann-a. Questo è stato il saluto più struggente della mia vita. A quella età, credevo che le lacrime non le avessi (contrariamente a quanto mi accade ora da vecchio, che mi commuovo per molto poco), eppure, oltre ad un nodo al collo dal dolore indescrivibile, forse qualche lacrima uscì.
Buenos Aires. La M/n CESANA della Società ITALNAVI é la nave in seconda linea che si vede per intero. Gli incontri tra il comandante Nunzio Catena e U FUNTANN-A si svolgevano a bordo di questa nave da carico.
Tornando a bordo, immaginavo il prossimo arrivo del M/n Cesana a Buenos Aires, U Funtann-a che va sottobordo e vede tutti visi nuovi. Preso dallo sgomento, chiede a qualcuno :
"U ghé u Segondo de coverta? Comme belin o se ciammava quello con a barba...., u Cadenn-a!"
La paura di non trovarmi, forse gli aveva fatto ricordare anche il nome... forse una distratta risposta:
"E’ SBARCATO!".
Non posso immaginare quel vecchio, stanco, distrutto dall'ultimo suo dolore, dalla perdita della sua ultima speranza di quel giorno, magari seduto su una bitta..., aspettando che qualcuno si accorgesse di lui per aiutarlo. Immagino poi, tornare indietro, con quella sacca vuota, tanto da ripassare il varco questa volta senza paura!
Oppure, e glielo auguravo, la sua stanchezza sia stata tale, da non permettergli più di tornare in porto e d’immaginare una ‘SUA’ nave ad ogni arrivo della SESTRIERE: "Lì u ghé u Terso Uffiziale.....,"
CESANA: "Li u ghé u Segondo ... Comme belin o se ciammava quello con a barba..."
Non fa niente Funtann-a, non sforzarti.., basta che mi ricordi così!!
Ortona, 28.aprile 2013
IL CLIPPER MARLBOROUGH-UN MISTERO IRRISOLTO
Clipper MARLBOROUGH
E' PASSATO UN SECOLO DAL PRESUNTO RITROVAMENTO

Era scomparso da 23 anni....
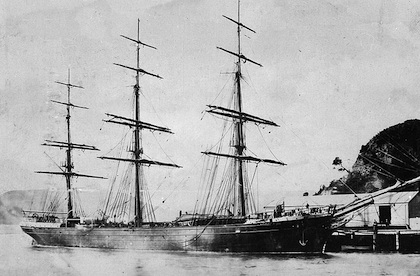
Il clipper Marlborough
![]()
Il Marlborough (nella foto) fu un grande clipper da carico, costruito in ferro dal famoso Cantiere scozzese Robert Duncan – Port Glasgow che lo varò nel 1876 per l’armatore J.Leslie, che più tardi lo vendette alla Albion Company.
Ecco le sue caratteristiche:
Dislocamento: 1.124 tons – Lunghezza: 69 mt. – Larghezza: 11 mt. Pescaggio: 6.58 mt
Nave a tre alberi con bompresso e vele quadre – Equipag.: 29
Dal 1876 al 1883, durante i viaggi per Lyttelton e Dunedin (versante sud-orientale della Nuova Zelanda) il veliero fu comandato dal capitano Anderson che fece anche alcuni veloci rientri in Inghilterra. Si ricorda in particolare quello del 1880, quando impiegò soltanto 71 giorni da Lyttelton a Lizard in Cornovaglia.
Per tutti gli anni ’80 concluse felicemente 14 viaggi d’andata con immigrati, (sempre sulla tratta Inghilterra – Nuova Zelanda) ritornando quasi sempre alla base con le stive piene di lana e carne congelata. Il Marlborough scomparve nel 1890 quando era al comando del capitano Herd che imbarcò all’ultimo momento per quel maledetto viaggio da Littelton a Londra, scomparendo senza lasciare tracce.

La cartina mostra la rotta compiuta dal Marlborough nei suoi viaggi dall’Inghilterra alla Nuova Zelanda via Capo di Buona Speranza, ed il ritorno via Capo Horn proveniente dall’Oceano Pacifico.
Ma cosa successe?
L’11 gennaio 1890, il Marlborough lasciò Lyttelton (N.Z.) diretto a Londra con il solito carico di carne congelata e lana, con un equipaggio di 29 uomini e 1 passeggero. Il clipper fu visto per l’ultima volta il 13 gennaio 1890 al largo della Nuova Zelanda, dopodiché, non se ne seppe più niente.
La lunga attesa della nave e del suo equipaggio fu dedicata in parte alla sua ricerca lungo la rotta presunta del viaggio, ma anche all’inchiesta promossa dalle Autorità del Commonwealth sulle condizioni della nave al momento della partenza. Ne risultò che il carico era stato stivato a regola d’arte e che la nave era partita in perfetto assetto di navigazione.

Il famigerato Capo Horn
Dopo alcuni mesi il Lloyd di Londra dichiarò la nave “dispersa”, mentre la convinzione generale fu che la nave fosse entrata in collisione con uno dei tanti iceberg che si aggirano nei pressi di Capo Horn e che fosse quindi affondata in quel terribile cimitero di navi, dove un veliero su tre si perdeva nei Furious Fifties (40° ruggenti, 50° urlanti...) di latitudine. La tesi fu supportata dal comando del postale a vapore inglese RMS Rimutaka, il quale riferì agli inquirenti che proprio in quel periodo erano stati avvistati grandi formazioni di ghiaccio tra Chatam Island e Capo Horn.
Era il 1913 e il ricordo di quel meraviglioso clipper non si era ancora del tutto perso, specialmente negli ambienti navali europei, quando, il mistero del Marlborough riesplose improvvisamente alla notizia diffusa via radio dal piroscafo inglese Johnson che dichiarò d’aver localizzato il clipper di Glasgow, poco a nord di Capo Horn. La scarna descrizione era quella di un vascello che aveva un aspetto spettrale, incolore, marcescente. I pochi brandelli di vele stracciate, appese ai pennoni, ricordavano i corpi di tanti marinai giustiziati. Nessuna voce umana aveva risposto ai ripetuti fischi emessi del Johnson. Il veliero era senza equipaggio.
Erano passati ben 23 anni ed il mistero del clipper Marlborough ritornò alla ribalta come un’autentica ‘replica’ del Vascello Fantasma di wagneriana memoria, la cui ‘prima’ era andata in onda nel 1843, 70 prima.

Punta Arenas
Il capitano del piroscafo Johnson si trovava al largo delle baie rocciose vicino a Punta Arenas, c’era molto vento e cercava di avvicinarsi a terra in cerca di ridosso. Le insenature erano profonde e la navigazione era pericolosa per la presenza di rocce frastagliate presenti ovunque. Era una serata inquietante e selvaggia con il sole rosso ormai vicino al tramonto. Doppiata una punta rocciosa, da bordo videro una nave a vela con brandelli di vele che fluttuavano nel vento alla distanza di circa un miglio. Il comandante fece segnalare la propria presenza e salutò il vascello in panne senza avere risposta: nessun essere vivente sembrava esserci a bordo. Con i binocoli inforcati, gli ufficiali videro soltanto gli alberi e i pennoni ricoperti di lepego verde con segni evidenti di abbandono e degrado. La nave si trovava come incastrata tra le rocce, era dentro una specie di culla naturale che la proteggeva dalle furie di Capo Horn.

Lo Stretto di Magellano e Capo Horn
L’unico inquietante lamento proveniva dai rintocchi metallici dei bozzelli e delle redance penzole che sbattevano ad ogni rollata contro le manovre dormienti del clipper e producevano suoni sinistri, simili a miagolii disumani. Si avvicinarono e videro che sulla poppa era ancora leggibile il nome della nave: Marlborough - Glasgow, scomparsa 23 anni prima nei pressi di capo Horn. Il comandante fece ammainare una scialuppa e ordinò al 1° ufficiale di condurre un’ispezione a bordo del relitto con una squadra di marinai esperti.
Rapportino del 1° ufficiale: "Finalmente giungemmo sottovento alla fiancata del clipper. Non c'era alcun segno di vita a bordo. Salimmo a bordo e quando fummo in coperta, tutto scricchiolava e sembrava sbriciolarsi sotto i nostri piedi. Ciò che apparve ai nostri occhi era mostruoso. Sotto la ruota del timone giaceva lo scheletro di un uomo. Camminando con cautela sui ponti in decomposizione, c’imbattemmo in altri tre scheletri. Tra la cucina e la riposteria trovammo i resti di dieci corpi e altri sei li vedemmo ancora sdraiati negli alloggi. Uno soltanto si trovava sul ponte di comando e dalla vecchia uniforme indossata, sembrava lo scheletro del Capitano. La muffa era posata ovunque e profumava i libri d’umidità rendendo illeggibili lettere e documenti presenti nella cabina del Capitano Tutti indossavano ancora i resti delle loro uniformi. Anche il giornale di bordo su cui era appoggiata una spada arruginita, era ammuffito e risultava illeggibile”.
Grazie al telegrafo senza fili inaugurato da Marconi, le notizie viaggiavano ormai nell’etere alla velocità della luce, e il giorno dopo titoli giganteschi campeggiavano sulle più importanti testate dei quotidiani di tutto il mondo. Il tono era questo:
“Il relitto galleggiante del clipper inglese Marlborough, scomparso 23 anni fa nelle acque di Capo Horn, ricompare all'improvviso con un equipaggio di scheletri vestiti con vecchie divise. Il Marlborough fa rivivere la leggenda di un'altra nave-fantasma....”.” Capo Horn restituisce le sue prede...”
E così via....
Ancora oggi, dopo 100 anni esatti dal ritrovamento del Marlborough noi, comuni mortali, ci poniamo le stesse domande che molti si facevano allora, ma le risposte appaiono sempre dubbiose e velate dallo stesso mistero.
- Com’é possibile che le acque tempestose di Capo Horn possano restituire i resti di un vascello ancora galleggiante dopo 23 anni ?
- Com’é possibile che nessuna altra nave avesse avvistato quel grande clipper prima del P.fo Johnson, quando tutto il traffico navale tra i due Oceani maggiori passava per Capo Horn?
- O forse la nave era stata avvistata, ma non era stata abbordata per paura del contagio di malattie come la peste, il colera, la febbre gialla, all’epoca frequenti e virulente?
- Che ruolo potrebbe aver giocato invece la superstizione? Quando tutti sapevano che l’incontro con un ‘cimitero galleggiante’ era sempre un presagio di sfortuna?
- Perché non esiste una testimonianza fotografica di quel ritrovamento quando l’invenzione della fotografia aveva già mezzo secolo di storia?
- Fu ricuperato il relitto? Dove si trova ora?
* Nota: Il racconto di un vecchio ‘vascello fantasma’, manovrato da scheletri, che corre i mari senza meta arrecando ‘malasorte’ a chiunque lo incontri, é uno dei segreti che i vecchi marinai lasciano in eredità ai giovani su quei bordi ancora impregnati di autentica marineria che affonda le sue secolari radici nel mondo della vela.
E’ difficile dare oggi delle risposte razionali influenzati, come siamo, dalla tecnologia che pare aver tagliato i ponti con il passato e sorride di tutto ciò che non proviene dai ‘ragionamenti’ del computer e della scienza. Eppure, un secolo fa i velieri non finivano sugli scogli così facilmente, come succede ancora oggi a certe supernavi ed il caso del Marlborough sembra mettercela proprio tutta per dimostrarlo...
Tuttavia, facendo qualche passo indietro tra le pagine ingiallite della vela, quando la velocità di un clipper era quella consentita dal vento e dal moto ondoso, ci si rende conto che la vita a bordo degli ultimi velieri era ancora intrisa di grandi difficoltà. I marinai erano spesso alle prese con cibi ammuffiti che si contendevano con i topi e i ‘caccaracci’.
* Nota: I caccaracci sono gli scarafaggi sovente presenti a bordo nelle cucine e nei locali caldi e umidi dove scarseggia la pulizia.
Quando finiva l’acqua piovana non rimaneva che bere quella inquinata e maleodorante. L’equipaggio viveva in spazi ristretti, sporchi, umidi nel caldo torrido, oppure ghiacciati nel freddo polare dei mari del sud ed erano quasi sempre bagnati in una specie di salamoia che penetrava in profondità provocando artrosi e artriti in tutte le articolazioni. Gli unici rimedi erano i salassi, le purghe e qualche pomata... per i fatti più gravi non rimaneva che la cerimonia a cielo aperto del seppellimento in mare del cadavere.
Di questa storia non rimane che rivedere alcuni punti controversi:
L La zona intorno a Capo Horn è soggetta a forti tempeste e correnti da Ovest verso Est. La navigazione é sempre minacciata dalla presenza di iceberg che si staccano dalla calotta antartica posizionandosi come ostacoli assai difficili da aggirare senza finire in secca da un lato, oppure troppo in fuori dall’altro, dove i venti sono urlanti, ruggenti e pronti a fare a pezzi tutte le navi che sfidano la loro potenza. Tutto ciò accadeva un secolo fa; oggi, le navi sono robuste, veloci ed hanno in dotazione il radar e molti altri ausili alla navigazione. Inoltre, oggi non é neppure più necessario doppiare Capo Horn per scalare i porti del Cile e del Perù, per cui la nostra mentalità marinara é molto distante da quella problematica che ci appare così lontana. Detto questo, é molto difficile immaginare che un clipper di 1.200 tonnellate possa aver vagato in balia delle correnti, ‘invecchiato’ si, ma incolume dopo 20 anni di slalom tra le banchise, gli iceberg, i bassi fondali, le scogliere e le barriere semisommerse.
Come si é detto, la rotta di Capo Horn era l’unico passaggio navigabile da un oceano all’altro ed il flusso di velieri nei due sensi era consistente, programmato e cadenzato. A noi sembra addirittura impossibile che nessuno abbia mai avvistato il vascello fantasma prima del Johnson in quei 23 anni di vagabondaggio alla deriva. Aggiungiamo, inoltre, che la zona attorno a Capo Horn era all’epoca ritenuta il centro di ricerca di naufraghi e navi più animato e turbolento al mondo a causa dell’elevato numero di disastri marittimi.
Si ricorda infine che nel 1890, un cospicuo numero di ricercatori d’oro si era anche insediato proprio nei dintorni di Punta Arenas, dove fu avvistato il clipper, ma nessuno lo vide mai.
Vorremmo concludere questa storia che ha fatto discutere milioni di persone con la famosa frase di un noto politico italiano:
“A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”
Nell’agosto del 1914, pochi mesi dopo l’avvistamento del Marlborough, fu inaugurato il Canale di Panama che permetteva, in 5 ore di navigazione, di aggirare il Sud America. Occorreva forse una ‘storia orrida e fantastica’ come quella del ritrovamento del clipper, per segnare una svolta definitiva nella storia dei traffici marittimi, una sorta di manifesto pubblicitario che disegnasse i confini tra la rotta della morte (Capo Horn) e quelle della speranza (Canale di Panama). Occorreva un attestato che certificasse la sicurezza e la rapidità dei viaggi degli emigranti e del turismo dei nuovi ricchi. Qualche mente raffinata dello Shipping britannico di cento anni fa pensò che un’idea forte e un po’ bizzarra era in grado di sconfiggere la millenaria superstizione che delineava l’epopea della vela. La rivoluzione industriale era in piena evoluzione e la tecnica pubblicitaria doveva, in qualche modo, promuovere la conquista del New World americano con i nuovi mezzi della tecnica navale, ossia il motore al posto della vela. Il Canale di Panama doveva cancellare per sempre l’idea che il veliero fosse sinonimo di sofferenza umana e morte per naufragio e che la nave a vapore e a motore si proponesse come il “simbolo della rinascita dei Trasporti Navali alla conquista di nuovi orizzonti”.
C Carlo GATTI
Rapallo, 19 febbraio 2013
Raimondo MONTECUCCOLI, una storia goliardica e fortunata
Raimondo MONTECUCCOLI
UNA STORIA GOLIARDICA... e fortunata
E’ stata brillantemente rievocata dal comandante Sergio Nesi nel suo:

Tutto ruota intorno alla figura di Raimondo Montecuccoli, condottiero seicentesco ma anche moderno “fantasma” con la divina missione di proteggere l’incrociatore che porta il suo nome dalle mille insidie delle missioni di guerra nel Mediterraneo.
Tutto nasce da una storia vera che diviene uno degli spassosissimi aneddoti raccontati dal comandante Sergio Nesi, amico dei Piloti del Porto di Genova, nel suo libro “Volo dell’Alcione”.
Allo scoppio della guerra, il T.V. Giulio Pelli, estroso Ufficiale di rotta del Montecuccoli, introdusse l’usanza di coprire con la carta di un cioccolatino la “O” del motto “Centum Oculi” che campeggiava in alto sul quadro del condottiero posto nel quadrato Ufficiali della nave. Questa semplice accortezza, nell’idea del Pelli, avrebbe procurato all'incrociatore, che secondo lui difettava di corazzatura, una discreta “scorta” di ben cento colpi di fortuna da "spendere" durante il corso della guerra.
La cosa andò ovviamente ben oltre la trovata goliardica.
Un paio di marinai di guardia in coperta svennero dallo spavento asserendo di aver visto il fantasma del condottiero comparire dal buio della notte mentre i colpi di fortuna che riguardarono l’incrociatore nelle sue navigazioni di guerra continuarono a moltiplicarsi stante la carta stagnola ben appiccicata sulla “O” del motto del condottiero.
Ma il sugello alla leggenda del fantasma di Montecuccoli si ebbe il 15 giugno 1942, durante la battaglia di Pantelleria. Il solo colpo d’artiglieria che raggiunse il Montecuccoli attraversò il quadrato ufficiali seminando nell’ambiente diversi fori di scheggia. Una di queste schegge andò proprio ad impattare sul quadro del condottiero provocando la chirurgica asportazione della famigerata “O” del motto “Centum Oculi”. La goliardica storiella del fantasma di Montecuccoli divenne pertanto storia.
Ecco quindi il filo conduttore di questo bel romanzo del Nesi. La storia della vita terrena del condottiero “rigorosamente desunta dalla vasta letteratura citata nella indicazione bibliografica desunta da padre Berardo Rossi […] nel suo bellissimo libro Raimondo Montecuccoli” e la vita ultraterrena del suo fantasma, raccontata attraverso il personaggio del giovane Ufficiale Sergio Rocca, unico nome di fantasia del romanzo, che altri non è che il Nesi stesso.
Nonostante il rigore storico che contraddistingue l'opera, il romanzo del Nesi è tutt'altro che noioso. Grazie allo stile brillante dell’autore che, come nella precedente trilogia dell’Alcione, è prodigo di aneddoti e freddure, la lettura è piacevole e scorrevole.
Per chi non fosse in possesso poi della già citata ormai introvabile trilogia, inoltre, il romanzo è anche un ottima occasione per poter leggere una buona parte delle incredibili avventure trascorse dal Nesi durante la Seconda guerra mondiale. Quelle appunto che si riferiscono al suo periodo d’imbarco sul Montecuccoli.
Post Scriptum:
Per chi fosse riluttante a credere alla storia del fantasma di Montecuccoli, ecco le foto del quadro in questione che, dopo il disarmo dell’incrociatore, fu collocato nel Museo Navale di Venezia.


Ringrazio il nostro Vicepresidente, lo storico Maurizio Brescia, socio di BETASON, per la gentile concessione e il socio di Mare Nostrum Franco Bernareggi per la segnalazione del libro di Sergio Nesi e della foto del quadro dallo stesso ammirato nel Museo Storico dell’Arsenale veneziano.
A cura di
Carlo GATTI
Rapallo, 24.12.2012
IL TEMPIO DELLA FRATERNITA', Chiesa-Museo della guerra
IL TEMPIO DELLA FRATERNITA'
"La storia del Tempio della Fraternità é una storia semplice, legata al ricordo dell'ultima guerra mondiale, quando infuriavano in tante contrade solo odio, violenza, persecuzione e delitto. Un cappellano militare, reduce dalla guerra, dopo aver visto tante distruzioni, si andava tormentando di poter fare qualche cosa anche lui, perché tornassero tra gli uomini una vera pace e una serena convivenza.
Un giorno, trovandosi nella necessità di dover ricostruire la piccola chiesa del suo paese sui monti, ebbe l'idea di raccogliere le rovine del conflitto e con esse ricostruire il tempio come simbolo ed auspicio di una ricostruzione più grande: quella della fratellanza umana; e poi arredarlo liturgicamente con tanti ricordi dolorosi della nostra generazione, trasformando gli ordigni di distruzione e di morte in simboli e richiami di vita."
Il Tempio della Fraternità sorge a Cella di Varzi ridente località del boscoso Appennino Pavese a 700 m. di altitudine. Ad esso si arriva dalla Valle Staffora risalendo la Voghera a Varzi; e dalla Valle Curone risalendo da Tortona a Fabbrica Curone e poi Cella. Per chi arriva in autostrada le uscite consigliate sono Voghera sulla Torino Brescia e Casei Gerola o Tortona sulla Milano-Genova.
Per ulteriori info rivolgersi al Rettore del Tempio: Tel 0383 52371 - 0143 323621 - 338 9261500
Fotografie a cura del webmaster Carlo Gatti
UNA CHIESA NEL BOSCO
Di Andrea AMICI

Il Tempio della Fraternità in Cella di Varzi
Oggi è la seconda volta che vengo qui. Tutti gli altri giorni in cui avevo progettato di venire era nato sempre un nuovo problema e nel primo tentativo mi ero addirittura perso: dalla quantità di stradine e sentieri smarrire la strada non è affatto difficile. Oggi sicuramente andrà bene, ne sono sicuro. E’ inverno, il termometro segna tre gradi sotto zero e tra non molto sarà notte.
Il paesaggio della pianura sta diventando collina, viaggiando attraverso filari di viti e scheletrici alberi da frutta, tra la neve ormai turchina per il crepuscolo. Poche case, lontane una dall’altra. Un piccolo paesino con la sua piazzetta, il baretto, il tabacchino, il ferramenta e la farmacia. Natale è finito e l’aria di festa sa già di nostalgia. L’anno prossimo il presepe sarà più bello, anche se domani dovremo smontare quello di quest’anno, senza farci vedere dai bambini. Loro lo vorrebbero vedere sempre lì, anche in estate, in tutta la sua verdognola e colorata poesia.
Mentre penso ai bellissimi Natali passati, la strada si fa sempre più piccola e ripida. Ormai i campi sono finiti, sto viaggiando in un bosco sempre più fitto e deserto. Sono le diciassette e tra mezz’ora devo essere al mio appuntamento; se va bene sarò un po’ in anticipo. Mentre viaggio attraverso questo luogo desolato, il crinale della montagna oscura il cielo violaceo del vespro di una giornata stupenda. Ancora un po’ e finalmente lo vedrò. Chissà come si presenterà quest’oggetto che da tanto tempo vado inseguendo. Chissà che viso avrà il suo custode, che conosco solo per esserci parlati al telefono. Mi aspetta su, in questo posto sempre più mistico e misterioso, di cui ho sempre sentito parlare. A quanto pare si tratta di un luogo unico al mondo. Chi me lo ha descritto ha sicuramente esagerato. Vedremo.
Non so perché, ma mentre proseguo sulla mia strada mi viene in mente Erasmo da Rotterdham, il personaggio de Il nome della rosa di Eco, che in groppa al suo asinello andava a far visita al misterioso monastero sito sulle Alpi Provenzali, dove era custodita la più ricca e proibita biblioteca, seconda solo a quella di Alessandria d’Egitto, perduta per sempre. “Calmati vecchio mio - penso tra me -, non essere presuntuoso: non sei certo QQQuil saggio Erasmo dei tempi dell’Inquisizione, sei solo uno dei tanti del nuovo millennio che sta guidando la sua automobile, facendo attenzione a non finire fuori strada a causa del ghiaccio”. Lo stereo sta diffondendo nell’abitacolo le note di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Che pezzo! Insieme al flauto, gli arpeggi della dodici corde di Jimmy Page e la suadente voce di Robert Plant sembrano fondersi magicamente nell’atmosfera del mio viaggio.
Ormai manca poco, sto per vedere e, forse, toccare ciò che sto aspettando da tanto tempo. Proprio mentre l’acustica di Page fa spazio allo splendido assolo della Telecaster, eccomi arrivato.

F-104 Starfigter
Sulla sinistra di questa strada, meglio adatta ai trattori che alle automobili, ecco apparire un vecchio aereo F 104 sistemato su una base di cemento. Come sarà arrivato fin qui? Sarà atterrato da qualche parte? Mistero… Poco più in là una piramide alta quanto un piano di una casa, con la base nascosta dalla neve. Proseguo altri cinquanta metri ed ecco apparire una chiesa, spoglia ed abbastanza sgraziata per la verità. Emerge dal buio e dagli alberi imbiancati che la circondano con austerità. Il tramonto è ormai cessato e in fondo alla valle una nebbia fosforescente sembra aver trasformato in un morbido materasso le foreste di latifoglie: un quadro che ha un che di gotico, in questo luogo decisamente strano ed inquietante… Mi dispiace interrompere il reprise di Plant, per un cultore come me equivale ad un delitto, ma ho fretta di scendere. La mia guida mi sta aspettando qui, anche se non la vedo.
Parcheggio l’auto dietro l’abside, a fianco all’edificio della canonica. Prendo il piumino e la fotocamera digitale, non si sa mai. Mi guardo intorno in cerca dell’uomo: nessuno. E’ ormai buio e fa un freddo che si gela. Nella penombra sembra di riconoscere la sagoma di un carro armato. Mi avvicino.

Carro Armato M7 SEAXTON e cannone modello 57/50 della guerra 1940-45
Si tratta proprio di un vecchio carro armato perfettamente conservato, anch’egli coperto da una spanna di neve gelata. Pare un molosso impigrito, che dorme sulla porta della sua cuccia. Ma non sono qui per lui. Mi avvicino al lato più luminoso della chiesa e scatto un paio di foto alla valle incantata. Sembrerebbe, da un momento all’altro, di vedere Odino uscire da quelle nebbie!

Missile di Smg

Cannone antiaereo della Seconda guerra mondiale

L’ancora davanti all’entrata del Tempio

Altare della Marina
Arrivo sulla porta della chiesa e ciò che appare ai miei occhi è quanto di più strano e bizzarro abbia mai visto: un missile di sottomarino, un cannone, un’ àncora, un altare montato su mine e bombe d’aereo, siluri, ali ed eliche d’aeroplano. Una moltitudine di oggetti bellici che sembrano non avere proprio alcun senso con il piazzale di un edificio di culto cristiano. Il primo concetto che mi passa per la testa è che si tratti del giardino di un eccentrico artista, dall’estro un po’ confuso. Mentre continuo a girarmi intorno, da una automobile scura parcheggiata nell’ombra scende un uomo. Mi avvicino lentamente a lui, con un po’ di timore. Tutto è così strano… Anche lui sembra essere un po’ cauto, ma pochi istanti dopo ci stringiamo la mano affabilmente, presentandoci finalmente di persona. E’ il sacerdote della chiesa ed è anche il suo custode. Ora la chiesa è chiusa, ma dato che vengo da molto lontano, si è offerto volentieri di aprirmela. Per un attimo ho temuto che mi facesse tornare la terza volta, negli orari d’apertura al pubblico.
Ci dirigiamo velocemente verso la canonica, attraverso un sentiero battuto nella neve. Ho con me la mia fedele Mini Maglite blu, che si rivela utilissima per salire i gradini ghiacciati e trovare la toppa della serratura. Il sacerdote entra ed accende la luce, mentre rimango un attimo sul pianerottolo. Una volta entrato si gira verso di me domandandomi: “Ragazzo, cosa è che ti ha spinto a venire fin qui a quest’ora? Cosa vuoi vedere in particolare qui? Dentro c’è talmente tanta roba che non so neppure se c’è ciò che stai cercando!”
“Sono alla ricerca della cima di un nave, reverendo. Mi mostri i reperti e sono sicuro che se c’è la troverò da solo!”
Mi guarda con un’espressione di incredulità. Forse sta pensando di avere a che fare con un tipo un po’ svitato. Annuisce con il capo accennando una smorfia con la bocca, mentre proseguiamo passando sotto un porticato per poi avvicinarci alla porta della sacrestia. La mia piccola torcia tascabile deve far luce ancora un momento e poco dopo siamo dentro. C’è un’aria inquietante, arcana e misteriosa. Sembriamo due carbonari con la lanterna, nelle segrete di una fortezza. Manca solo essere vestiti con il mantello e la tuba.
La porta che accede all’altare è chiusa, il sacerdote tenta di accendere l’illuminazione interna maneggiando i tasti di un quadro elettrico. Niente da fare, bisogna accontentarci di una fioca luce di un paio di lampadine. Poco male, la Maglite andrà benissimo!
Entriamo nella sala, a fianco dell’altare al quale ci inginocchiamo, nell’eco cattedralico dei nostri passi. Guardo verso il centro, a destra e poi a sinistra rivolgo lo sguardo verso l’altare. Non è possibile! Sono sbalordito, tutto questo è pazzesco! Fisso il tabernacolo e penso di essere finito in un manicomio.

Altare Maggiore costituito da rovine giunte dalle principali capitali mondiali; il pavimento del Presbiterio é la vecchia pavimentazione del Duomo di Milano, così come alcuni pinnacoli visibili ai lati.

Navata centrale e presbiterio con il paracadute
Lo scrigno dell’Eucaristia è formato da un grosso proietto d’artiglieria navale, verniciato di rosso. Alzo lo sguardo sul ciborio: un vecchio paracadute militare! “Ma qui sono tutti matti!” penso tra me. La mia guida mi dice di seguirlo dietro al coro, sfiorando delle teche contenenti moltitudini di oggetti. “Questi simboleggiano i militi ignoti, di tutte le patrie!” indicandomi delle tombe stilizzate con elmetti di varie parti del mondo e di diverse epoche. Straordinario… Nelle nicchie della balaustra è custodita la terra di tutti i luoghi dove si sono combattute sanguinose battaglie.

Il volto di Caino con cimeli giunti da tutto il mondo

La tomba del Milite Ignoto é posta dietro l’Altare Maggiore
delle teche contenenti moltitudini di oggetti. “Questi simboleggiano i militi ignoti, di tutte le patrie!” indicandomi delle tombe stilizzate con elmetti di varie parti del mondo e di diverse epoche. Straordinario… Nelle nicchie della balaustra è custodita la terra di tutti i luoghi dove si sono combattute sanguinose battaglie.

Le spiagge del D-Day: Juno, Omaha, Gold. Utah......
Sono ammutolito nel vedere i colori della terra di Auschwitz, El Alamein, Stalingrado, Omaha Beach, Monte Cassino, la sabbia dei fiumi vietnamiti e tanta altra polvere di Mondo. In vita mia non mi ero mai trovato in una situazione come questa. Vorrei poter stare qui tutta la notte, se fosse possibile; ma il tempo stringe. “Padre mi porti dove c’è la cima d’ormeggio! Tornerò con più calma e di giorno ad ammirare tutti questi oggetti!”. Dico al sacerdote. “Va bene - mi risponde lui - ma prima dai un’occhiata a questo!”. Su una parete è appeso un grande Crocifisso.

Crocefisso realizzato con armi giunte dai principali campi di battaglia di tutto il mondo
E’ in ferro, tutto arrugginito. “Guardalo bene, devi guardarlo da vicino!” mi dice. Lo osservo e immediatamente dopo una sensazione agghiacciante mi assale. E’ costruito con pezzi di armi, schegge di bombe, pugnali, spade e tant’altro. Mai, mai avrei immaginato di vedere una cosa del genere. Solo adesso inizio comprendere appieno che questo luogo non è stato costruito da un artista eccentrico. E’ stato edificato da un genio! Un genio che ha voluto trasmettere un messaggio ai posteri, utilizzando i cocci della Storia che scrissero.

Materiale bellico proveniente dall’Africa
Sotto la scultura sono posate mine anticarro, bombe a mano, maschere antigas e tanti altri ordigni. A fianco, il pulpito è formato dai legni di due imbarcazioni del D-Day, lo Sbarco in Normandia.

Fonte Battesimale costituito dall’otturatore di cannone della corazzata “Andrea Doria”
Proseguo la mia veloce visita in cerca dell’oggetto famoso, mentre mi viene mostrato il fonte battesimale: l’otturatore dei cannoni da 320 mm della Regia Corazzata Andrea Doria. Oggi fa anche da culla per il Bambino, essendo anche l’angolo del presepe. Ormai non mi sorprendo più. Ma non ho ancora trovato l’oggetto che mi interessa più di ogni altro.
Scorro con gli occhi tutti i manufatti sistemati alla rinfusa, quando ad un tratto il fascio della mia torcia si ferma da sé su un oggetto in particolare, come se una forza inconscia guidasse il mio polso fino ad esso. Il vapore del mio alito nell’aria gelida, tra i miei occhi e la torcia quasi offusca la sua immagine. Mi giro per vedere dov’ è il sacerdote. E’ tornato accanto all’altare, molti metri dietro di me. Sono solo.

Ecco il pezzo di gomena (cavo di canapa) della corazzata ROMA che l'Autore ha ritrovato sopra altri Cimeli della guerra marittima 1940-45
Mi avvicino all’oggetto, appeso a due chiodi sulla parete. Sotto di lui, su una mensola, alcune malconce statuette dei Re Magi in terracotta plasmano uno scampolo di colore tra le foto in bianco e nero che lo circondano. Sbiadite, come i ricordi che hanno impressi. Sono come rallentato dall’emozione e dalla riverenza che questo cimelio mi trasmette, allungando la mano e la torcia per toccarlo e vederlo da vicino. Non è che un pezzo di gomena di canapa lungo un metro, ma è preziosissimo. Sopra di esso un cartellino scritto a pennarello racconta la sua storia: tutto coincide. E’ lei! Una cima d’ormeggio, che mi lega al mio passato. Il silenzio si è fatto immenso. La mia mente inizia a viaggiare indietro in un tempo lontano. Perduto. Sembra quasi vedere le mani dei marinai che la stanno tagliando, impiombando. Sento le loro risate, l’odore di sigarette e del sudore sulle divise da fatica. Parlano di ragazze, di partite di calcio. Sono felici, la guerra sembra non far parte di quei momenti. E’ estate e fa caldo, siamo a prora della Regia Corazzata Roma, seduti sul ponte d’acciaio accanto ad una delle catene che si infilano nella cubìa. Tutto sembra essersi trasformato in una sorta di macchina del tempo…

Pezzi di gomene ed altri cimeli marinari
Ma la magia dura lo spazio di qualche istante. Si avvicina il sacerdote, chiedendomi se è questo quello che cercavo. Mi chiede anche qualche informazione più precisa sulla storia di questa nave, menzionata nel cartello. Mentre gli spiego quello che so, compreso il fatto che mio nonno era su quella sfortunata nave, il mio sguardo cade su alcuni boccaporti d’acciaio. Incredibile! Si tratta di un boccaporto, con il passo d’uomo, e di una porta stagna del Cacciatorpediniere Carabiniere, una delle quattro unità che recuperarono i naufraghi della Roma, portandoli poi in Spagna. Su quelle stesse lamiere, oggi posate sul pavimento di una chiesa di montagna, la sera del 9 settembre 1943 si sedettero i naufraghi di quella maledetta giornata. E lì sopra vennero adagiati i Caduti ripescati e quelli che morirono quella notte per le ferite.
Ora è notte, devo andare via. Mentre ci avviamo verso la sacrestia, mi giro ancora un istante verso la penombra, per salutare tutti i ricordi di questo luogo, sovrastati dalle bandiere di tutto il Mondo. Il mio istinto sembra come percepire la presenza di occhi invisibili, che mi osservano nel buio della sala. Tornerò, sicuramente non da solo, anche se l’emozione che mi ha dato questo posto visitandolo in questo modo è a dir poco irripetibile.
Ma il tempo concessomi è terminato e velocemente il mio nuovo amico mi saluta, andando via con l’auto. Rimango solo nel piazzale a riflettere su questa esperienza. Credevo di venire qui a trovare qualche oggetto esposto come ex-voto tra le opere d’arte che di solito adornano una chiesa, invece me ne sto andando pensando al nome che è stato dato a questo luogo. Niente di più appropriato. E ripenso anche se è giusto dire che si viene a visitare questa specie di museo. Credo sia più opportuno dire che si viene a rendere omaggio a tutte le gocce di Storia che ogni oggetto trasuda. Qui la Storia non ha colore, non ha odore né lingua. Qui la Storia dell’Uomo moderno trasmette la sua anima.

Zattera Carley appesa alla parete del Tempio
Mentre passo davanti alla facciata dell’edificio, mi soffermo ancora un istante a osservare il Carley appeso al muro.
Appartenne anche lui al Carabiniere? Si tratta forse di una delle zattere di legno e sughero in cui vennero adagiati i corpi dei marinai della Roma, ricoprendoli con la Bandiera italiana? A quelle sagole si aggrapparono le giovani e disperate mani che poco prima si staccarono dalla Roma in fiamme?
Non lo so. Mi avvicino all’auto, con passi che scricchiolano nella neve ghiacciata del giardino del Tempio della Fraternità. Intorno a me il silenzio della foresta addormentata. Fa freddo e la strada è brutta. Devo andare.
Andrea AMICI
Foto di Carlo GATTI
Appennino Ligure, 7 gennaio 2006
Andrea Amici vince a Chiavari il concorso di narrativa 2012, dedicato al Ten. Emilio Ruocco C.V.M.
Chiavari (Genova), venerdì 21 settembre 2012. Presso la Scuola Telecomunicazioni Forze Armate di Chiavari, si è svolta la premiazione del concorso di narrativa dedicato al Tenente C.R.E.M. Emilio Ruocco C.V.M., disperso nel naufragio della R.N.Roma. L’elaborato di Andrea Amici ha vinto il primo premio del concorso, riservato unicamente al personale delle FF.AA., Croce Rossa, Guardia Forestale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, ecc.
CARLOFORTE - LA MADONNA DELLO SCHIAVO
LA MADONNA DELLO SCHIAVO

A sinistra l’isola di S.Pietro (Sardegna)
Verso la metà degli anni ’60, La Società Rimorchiatori Riuniti di Genova rinforzò la sua già potente flotta (50 unità circa) con nuove costruzioni finanziate in parte dalla Cassa del Mezzogiorno. Con questo escamotage politico-economico furono varati sei potenti ‘mastini’ ai quali vennero assegnati tipici nomi sardi: Torregrande, Casteldoria, Nuraghe, Capo Ferro, Capo Testa, Capo Caccia. Avevano una banda blu, pitturata sopra il bottazzo, che correva lungo il panciuto scafo nero e facevano compartimento CAGLIARI, la cui scritta era ben visibile sulla poppa.
Una clausola dell’operazione prevedeva che l’armatore assumesse equipaggi sardi che, guarda caso, furono reclutati in larga parte a Carloforte (Isola di S.Pietro), baluardo di scuole nautiche d’eccellenza, e di grande tradizione marinara. In quegli anni i carlofortini (alias carolini) erano sparsi ovunque sulle navi della marina mercantile di Stato, di quella Libera ed anche militare.
I nuovi ‘barcaccianti’ * sardi furono accolti come lontani parenti che ritornavano a Genova dopo tanti anni di lontananza storpiando un po’ il dialetto, ma che di Genova-Pegli ne sapevano più di tanti locali...
La comunità composta di marinai, motoristi, ma anche comandanti ed ufficiali non solo s’inserì facilmente nel tessuto portuale sotto la Lanterna, ma fu subito stimata per le qualità marinare che dimostrò anche nella nuova e difficile attività dei ‘rimorchi d’altomare’.
Dai loro racconti, ben presto venne alla luce la sofferta storia di quest’antica etnia di corallari ‘pegioti’, inviata a Tabarka (Tunisia) dalla nobile famiglia dei Lomellini e per i barcaccianti autoctoni, meno acculturati, si trattò di una autentica scoperta. La storia si diffuse su tutti i bordi e in breve tempo, non pochi scelsero u schéuggio come meta delle loro vacanze. Da una conoscenza più approfondita emerse allora che l’identità di questa minoranza, non solo correva lungo il meridiano che passa per Ge-Pegli, l’isola di S.Pietro e l’isolotto di Tabarca in Tunisia, ma che queste sparse radici sostenevano un unico tronco ben piantato nella terra dei nuraghi.
Già, i tabarchini si sentono più sardi che continentali ed é giusto che sia così! Se in tutto il mondo ogni isola attrae i suoi figli con una speciale forza magnetica, i carlofortini o carolini sentono ancor di più questa triplice forza ‘insulare’ in virtù, anche, della consapevolezza di sentirsi una maglia d’unione tra l’Europa e l’Africa.

Forte genovese di Tabarca

Veduta aerea di Tabarca
A questo punto, per chi non si fosse ancora imbattuto in questa simpatica comunità etnica che parla il dialetto genovese, consigliamo di seguirci in questa veloce cavalcata storica...
Nel 1542 un nucleo di marinai e pescatori partì da Pegli e dai vicini paesi della riviera ligure, al seguito del potente casato genovese dei Lomellini che aveva avuto concessioni territoriali in Nord Africa, e s’insediò sulla costa e sull'isolotto di Tabarka (Tunisia) che si trova nei pressi del confine con l’Algeria.La loro storia prese avvio con redditizi traffici commerciali di spezie e stoffe pregiate, ma soprattutto con la pesca e la vendita del corallo che durò fino al 1738, anno in cui partì la prima richiesta di rimpatrio. Dopo una pacifica convivenza con le altre comunità della zona magrebina, durata ben 196 anni, la concessione dei Lomellini diventò improvvisamente un problema. Sui fondali intorno all’isola cominciò a scarseggiare il corallo, i mercati languirono e iniziarono a moltiplicarsi le incomprensioni. Le contestazioni politico-commerciali con alcuni rais locali si risolvevano sempre più spesso con l’uso della violenza contro la comunità cristiana. Le convivenza prese una pessima piega quando cessò il dialogo, e il ricatto e la schiavitù diventarono le uniche armi imposte da chi regnava a Tunisi o ad Algeri in quel momento. Per questi motivi, stanchi di crescenti vessazioni, una parte dei Tabarchini, con a capo Agostino Tagliafico, nel 1738 chiese al re Carlo Emanuele III di Savoia di rimpatriare in un luogo sicuro, in pace e libertà, per continuare i commerci con il resto del Mediterraneo. Fu scelta l'isola degli Sparvieri, allora deserta, mediante una regolare infeudazione. Oggi l’isola si chiama San Pietro e si trova in prossimità della costa Sud-Occidentale della Sardegna.

Stemma del Comune di Carloforte (6.420 ab.) (Isola di S.Pietro)

Gonfalone

Calata Mamma Mahon (Carloforte)

Spiaggia da Bobba (Carloforte)
Grati per la soddisfacente sistemazione, i nuovi abitanti dell’isola eressero una statua in onore del Re nella piazza principale del Paese (U Pàize) che fu chiamato Carloforte come segno di riconoscienza e fedeltà. A San Carlo Borromeo fu invece dedicata la Chiesa parrocchiale. Il Re donò per l'occasione un pregiato quadro raffigurante il Santo Patrono, ancora oggi situato nell'abside della Chiesa. Nel 1770 un seconda comunità di coloni provenienti da Tabarka s’insediò nella vicina Isola di Sant'Antioco, sul lato prospiciente l'Isola di San Pietro, dove fu fondato il paese dio Calasetta. Evidentemente, i conti tra i tabarchini e i berberi nord-africani non si erano chiusi definitivamente. Infatti, il 3 settembre 1798, nelle primissime ore del mattino, gli equipaggi di tre navi corsare algerine sbarcarono nel porto di Carloforte e l’isola subì una feroce incursione piratesca. 933 carlofortini (circa la metà degli abitanti dell’isola) furono catturati, deportati e tenuti schiavi a Tunisi per cinque anni, fino al 24 giugno 1803, giorno in cui furono riscattati e poterono ritornare in patria. *
Sono passati ormai 215 anni da quella tragica ‘Via Crucis’ sofferta dai deportati carlofortini. Quale ricordo é rimasto oggi nel cuore e nella mente dei suoi discendenti? Oltre all’incancellabile ‘passaparola’ tramandato come un tam-tam di generazione in generazione, é rimasta per sempre una testimonianza di fede che vale la pena ricordare.
Durante il quinquennio di schiavitù, il prigioniero Nicola Moretto, un ragazzo che era riuscito a farsi benvolere dal suo padrone e quindi a godere di qualche libertà, rinvenne sulla spiaggia di Nabeul, vicino a Tunisi, una statua lignea. Quel pezzo di legno, nonostante fosse consumato dalle burrasche e corroso dalla salsedine, conservava ancora i lineamenti di una Madonna con il Bambino. Il ragazzo, come preso da un incantesimo, la nascose nel suo mantello e la riportò a casa difendendola dalla curiosità degli altri servitori musulmani. Riuscì a fatica a consegnare la statua a don Nicolò Segni, che dopo una sommaria ‘ritoccata’ la pose subito in venerazione.

Chiesa della Madonna dello Schiavo (Carloforte)

La Statuetta ritrovata
Il ritrovamento, é facile immaginarlo, fu accolto come un segno tangibile della protezione della Vergine e, improvvisamente, il morale dei deportati passò dalla disperazione alla speranza, e quindi alla fiducia in una prossima liberazione. Fu un evento miracoloso? Quei 933 disperati lo interpretarono, sicuramente, come un segno del cielo che avrebbe dato, prima o poi, i suoi frutti. Da quel fatto ebbe origine il culto della "Madonna dello Schiavo" protettrice dei Tabarkini.
Si tramanda che persino i musulmani, che venerano Maria (Maryam) e credono nella sua eccellenza e verginità, guardarono a quel ritrovamento con profondo rispetto e, da allora in poi, trattarono con maggiore rispetto gli schiavi cristiani.
Successivamente, re Carlo Emanuele III di Savoia pagò un oneroso riscatto e gli schiavi poterono ritornare in Sardegna.** La piccola statua della Madonna fu portata anch'essa a Carloforte e per accoglierla fu costruita l'omonima Chiesa della "Madonna dello Schiavo".
Le persecuzioni piratesche continuarono ancora per diversi anni, fino a quando il fenomeno fu definitivamente represso in tutto il Mediterraneo. Ma questa é un’altra storia. Concludiamo questo rapido sguardo a “volo d’uccello” segnalando che nella storia della comunità Carolina, dal 1738 fino ai giorni nostri, spiccano personaggi divenuti famosi nel mondo dell'arte, della cultura, della politica, nelle armi, delle arti e dei mestieri. Una parte cospicua della sua etnia risiede in tutti i continenti, non solo per necessità, ma per vocazione marinaresca, tanto che molti anziani ritornano a pösâ e osse nella loro terra d'origine: ‘u schéuggio’.
Carloforte é gemellata con le seguenti città: Tabarca (Spagna)- Camogli, dal 2004 - Montecchio Maggiore, dal 2009.
Note:
* La parola Barcacciante, deriva probabilmente dal termine francese ‘barcasse’ che indica un’imbarcazione portuale tuttofare.
** Solo sei carlofortini, per salvarsi dalla schiavitù, abiurarono la fede cristiana divenendo musulmani. Gli altri perseverarono, sostenuti da un certo don Nicolò Segni, che aveva seguito volontariamente i suoi concittadini nella prigionia; può essere interessante sapere che tale don Segni è un lontano parente della ben nota famiglia di politici sardi.
*** I padri Mercedari si impegnarono a fondo nella raccolta della somma necessaria per il riscatto, che, rispetto ai valori di allora, fu enorme: 655.000 lire sarde; della somma il 12% era stato raccolto dai frati, mentre il resto fu a carico delle famiglie degli schiavi e del Regno sardo. L’evento della liberazione ha avuto il suo epilogo nel santuario di Bonaria (Cagliari), retto dagli stessi Mercedari, con una particolare celebrazione di affidamento a Maria Santissima.
Carlo GATTI
Rapallo, 13.9.2012
CANI "MARINAI" d'amare di B.Malatesta e C.Gatti
CANI MARINAI
Cani d’amare
L’ambigua pronuncia del titolo si riferisce ad un argomento che solo pochi di noi hanno mai preso in considerazione: la frequentazione dei nostri amici a quattrozampe sulle navi. Credo invece che parlarne possa svelare degli aspetti, a dir poco, sorprendenti.

Sicuramente in molti abbiamo notato almeno una volta una simpatica bestiola che abbaia scodinzolando sulla coperta di un rimorchiatore oppure quando sfreccia con brio da prua a poppa su una chiatta nei canali del Nord Europa. Ma chi ricerca attentamente su questo soggetto, trova la conferma che cani e uomini hanno condiviso da tanto tempo il loro destino in mare e non solo nei momenti di reciproca compagnia.
Quando ero giovane ufficiale, negli anni '70, una delle ricorrenti affermazioni che sentivo a bordo era un antipatico commento ripetuto durante le interminabili ore di navigazione notturna nell’oceano. Forse per rompere il silenzio ovattato del ponte di comando, il saggio di turno declamava in maniera pseudo-filosofica: "la guardia, la fanno solo i marinai e i cani!".
Da allora è passato del tempo e dopo aver terminato la mia carriera e le guardie sulle navi, ho deciso di avere come amico un cane del quale sono perdutamente innamorato. Durante i momenti di reciproca e naturale incomprensione mi chiedo a volte quale sia l’eventuale attaccamento del mio amico verso una nave, se mai vi si trovasse sopra. Dalle prime ricerche fatte, ne ho ottenuto un risultato inaspettato, che rende inappropriata la seppur amorevole definizione di “mascotte di bordo”: cioè il nostro amico ne merita davvero una ben più consistente. Vediamo alcuni aspetti di questo discorso.
E’ risaputo che i cani occupano i primi posti per dedizione ed attaccamento alla famiglia, sia quella gioiosa di un’abitazione che quella più atipica dell’equipaggio di una nave. Lo si denota dalle immagini che ci giungono nel tempo: prima i quadri bucolici del ‘600, poi gli innumerevoli dipinti delle scene di caccia, quindi le dagherrotipie e fotografie di fine ‘800 che ritraggono equipaggi di velieri con il loro fedele amico. In queste ultime, spesso l’animale è immortalato vicino al Numero Uno, il Comandante, quasi come se tra i due vi fosse un legame invalicabile alle persone che collega la solitudine del comando da una parte con l’eterna ed incommensurabile fedeltà dall’altra.

L'equipaggio del veliero "Bedford" (1904): il cane è vicino al Capitano! (tratto da http://content.lib.washington.edu)
Tempo fa, mi aggiornai su uno dei transatlantici più gloriosi della nostra Marina Mercantile, il Rex. La veloce unità, come è noto, nel 1933 guadagnò con onore il Nastro Azzurro per aver compiuto la traversata atlantica ad una velocità di 29 nodi circa (54 Km/h)! Il suo Comandante, Francesco Tarabotto, splendida figura di Capitano Marittimo di Lerici, diplomato nautico a Genova, teneva a bordo una femmina di terrier, Lilly.
La testata americana Niagara Falls Gazette scrive, tra l’altro, nell’ottobre 1934: “ Il Comandante Tarabotto è scapolo e se gli chiedete perché, lui sorride riservatamente e asserisce che i suoi unici amori sono il Rex e la sua cagnetta Lilly, un terrier arrogante che scorrazza tra il ponte di comando e gli alloggi ufficiali”.

Uno splendido quadro di Marco Locci: Il Rex, il Conte di Savoia e il Conte Grande
Coloro che conoscono anche a tratti la storia del Rex, sorrideranno all’accostamento di Tarabotto, ufficiale imponente, che incuteva immediato rispetto, con la vivace bestiola, ma evidentemente anche lui se ne era “innamorato”.
Quello scritto mi stimolò a continuare a ricercare notizie dei cani sulle navi, a capire cioè se la loro presenza fosse unicamente quella di tenere compagnia alla gente o se ci fosse qualcosa di più. I due esempi che seguono ci dicono infatti che il comportamento di quegli animali verso le navi è, a dir poco unico e forse, ancora inspiegabile.
Mi ricordai infatti dell'articolo sul nostro sito di Carlo Gatti, past President della Società, che narrava le tragiche vicende della piccola nave da carico Fiducia, poi affondata, il cui equipaggio fu salvato dalla nave passeggeri italiana Vulcania nel dicembre del 1962 a nord della Sicilia. Gatti si trovava lui stesso a bordo della nave passeggeri come Terzo Ufficiale di Coperta.
Si legge tra l’altro: “…ci fu, purtroppo, una vittima di cui non abbiamo ancora fatto cenno. Su quella coperta inclinata e flagellata dai marosi, scivolava da paratia a paratia, abbaiava e piangeva un pastore tedesco, che nessuno poteva più aiutare. L'equipaggio stremato ed ancora impaurito, ma ormai al sicuro sul ponte passeggiata del grande transatlantico, volle seguire con lo sguardo il drammatico epilogo della sua nave. I naufraghi si schierarono l'uno accanto all'altro, s'appoggiarono tristemente al parabordo del ponte e fissarono a lungo, con gli occhi sbarrati, l'ultimo comandante di bordo che, abbandonato per sempre dagli uomini, s'allontanava incredulo nel buio più profondo.

L'affondamento della nave da carico FIDUCIA (arch. C. Gatti)
Lo salutarono sbracciando i loro baschi fradici tra le lacrime e gettando nell'angoscia, non solo i passeggeri, ma anche il collaudato equipaggio dell'anziana Vulcania. A bordo, tutto si fermò per un attimo, il nostro Comandante, stagliato come una sfinge sull'aletta della plancia, salutò con tre fischi lunghi e mesti la coraggiosa Fiducia che si apprestava a compiere la sua ultima traversata verso gli abissi, con il suo indomito e fedele nocchiero. La nave poco dopo sparì, trascinando con sé il suo ultimo compagno di viaggio, il più fedele. Se ben ricordo, il suo nome era Dock. (l’articolo completo è a http://www.scmncamogli.org/oldsite/pagine/nfiducia_nar.htm).
Dopo qualche tempo, un altro evento, toccante come il precedente, richiamò la mia attenzione. Nel dicembre 2010, la nave italiana Jolly Amaranto fu investita da una terribile tempesta nel Mediterraneo. L’unità fu abbandonata in quell’inferno e l’equipaggio venne salvato da un rimorchiatore. A bordo c’era un cane, Athos, che fu anch’esso portato in salvo. Dopodichè in un attimo successe l’imprevisto: il cane si lanciò in acqua per raggiungere la nave morente in mezzo alla tempesta!
Vano fu il tentativo di un marinaio che si tuffò dietro di lui per soccorrerlo, anzi dovette lui stesso essere portato in salvo dai sopravvissuti. La povera bestia sparì nelle onde implacabili e buie di quel mare in tempesta. (vedi toccante testimonianza a You Tube a http://www.youtube.com/watch?v=uQPsdywrVTs).
Dock e Athos si sono comportati in maniera simile, erano vincolati alla propria nave in maniera sublime, sino a sacrificare la vita, nonostante i propri padroni, sicuramente gli esseri a loro più vicini e più cari, fossero già tratti in salvo.

San Rocco di Camogli: Il monumento al cane, amico fedele dell'uomo (foto B. Malatesta)
A San Rocco di Camogli, il 16 agosto di ogni anno, si celebra la Festa del Cane, dove vengono premiati quegli animali che si sono distinti per le loro azioni di eroismo verso gli umani. Sarebbe bello che un segmento della manifestazione fosse dedicato ai quattrozampe delle navi, i quali ci ricordano istintivamente che l’unità sulla quale lavoriamo è davvero qualcosa di vitale importanza e che dobbiamo fare di tutto per salvaguardarla.=
Bruno Malatesta - 8/2012
Appendice: I cani nella storia marinara
I cani, si sa, hanno molta storia e tradizioni in comune con le persone. Sin dall’inizio della navigazione, questi animali sono sempre stati a bordo e siccome molti secoli fa le imbarcazioni naufragavano frequentemente, succedeva che i quattro zampe sopravvissuti abbandonavano l’unità arenata negli scogli, avventurandosi così in un nuovo paese, a volte originando quelle razze che oggi sono considerate pure. Nel 15mo e 16mo secolo per esempio, gli esploratori europei giunsero sulle coste del Nord America portando con loro mastini, cani pastore e waterdogs. Il famoso ed utile Terranova che, insieme al Labrador, è forse il cane acquatico più conosciuto, è il risultato dell’insieme di quelle razze.

Un Terranova
Ma non è solo l’aspetto della genesi di stirpi canine che richiama il nostro interesse. Ben presto, quando s’intese che i cani potevano essere addestrati con risultati sorprendenti, vennero utilizzati per espletare alcune operazioni di bordo, soprattutto il lavoro duro.
Nei vascelli da guerra erano impiegati per scambiare messaggi strategici tra i comandanti, cioè come dei veri e propri messaggeri acquatici; sulle navi da pesca invece raccoglievano il pesce o lo spingevano nelle reti o addirittura sistemavano tali reti ed altra attrezzatura che si trovava sia a bordo che in mare. Nei casi di razze pregiate, costituivano preziosa merce di regalo verso potenti dignitari che avrebbero assicurato così buoni affari al comandante della nave. Potevano anche servire per cacciare i ratti di bordo; per esempio, i piccoli Chihuahua scovavano soprattutto i vermi che si infilavano dove altri cani di taglia maggiore non arrivavano. Infine, compito molto importante, riportavano a bordo tutto quello che cadeva in mare, persone comprese. =
Ancora una testimonianza!
UNA MANOVRA DA CANE........
Entrai in timoneria mentre il traghetto della Tirrenia, proveniente da Porto Torres, stava imboccando l’entrata del porto.
“Ciao Comandante, ben arrivato!”
“Ben trovato a te! Stamattina abbiamo un pilota in più!” – Pensai d'incontrare quel collega che ogni tanto ritornava a Genova dai suoi genitori. Mi guardai intorno, ma vidi solo il timoniere ed un cagnone nero accucciato in un angolo. Il comandante rideva di sottecchi...mi spiegò:
- “Quella specie di orso bruno là nell’angolo si chiama Pilot e fa parte dell’equipaggio. Si é imbarcato con me un mese fa e sbarcherà con me tra dieci giorni! Non ci crederai, ma a bordo ha le sue mansioni e guai ad interferire... E’ un cane molto orgoglioso!”
Lo guardai incuriosito e dissi: “Lo hai assunto come ‘gigolot’ per le cagnette di certe anziane passeggere ? O l’hai chiamato così in onore della mia categoria...?”
“Ad essere sincero né l’uno né l’altro. Il mio cane, di razza sconosciuta, sente la manovra come uno di noi e, allora, capisci, non potevo chiamarlo in un altro modo... Non vorrei che la battuta ti suonasse un po’ strana. Non c’è alcun doppio senso, credimi.”
Il Comandante sembrava davvero preoccuparsi della mia reazione e replicai: “Amo i cani e se anche fosse così, troverei la tua descrizione originale e assolutamente divertente”.
Poi mi rivolsi direttamente all’interessato come fosse un collega: “Se sei dei nostri e ami la manovra, come dice il tuo datore di lavoro, uno di questi giorni ti porto sulla Torre/Piloti per farti conoscere i miei colleghi. Magari alcuni li conosci già”.
Pilot mi fissò con un occhio solo e poi girò il testone per indicarmi la prua. Capii che non voleva assumersi alcuna responsabilità circa la mia distrazione !
C’era un po’ di tramontana, chiudemmo la porta di sopravvento e cominciammo a far ruotare la nave a dritta di 180° per portare la poppa in direzione della scassa n. 4 di Ponte Colombo. Durante la rotazione era immobile e concentrato, ma appena la nave terminò l’accostata, Pilot si alzò e con tutta calma ci precedette verso l’aletta di dritta, si sistemò vicino ai comandi esterni, poi si girò impaziente verso di noi facendoci intendere: ‘avvicinatevi é il momento di portare la nave in banchina’.
Il suo padrone non gli aveva fatto alcun cenno. Rimasi basito. Pilot aveva segnalato non solo l’inizio della seconda fase della manovra, ma si era anche trasferito verso il lato d'attracco previsto quel giorno, che poteva essere un altro tra i quattro in funzione nel terminal. Una cosa é certa: Pilot non si sbagliò. Non dissi nulla. La nave andò regolarmente all’ormeggio e i cavi vennero filati a terra e poco dopo il Comandante urlò all’interfonico: “Abbassate la rampa!”. A quel punto Pilot lasciò la postazione scrollandosi di dosso le ansie accumulate e pensando: “La manovra é finita. Missione compiuta”. Lasciò il Ponte di Comando e se n’andò in cabina ad aspettare il suo padrone per ricevere le meritate coccole.
A quel punto mi rivolsi al mio amico Comandante e chiesi con morbosa curiosità:
- “Comandante, la manovra non é mai la stessa e noi lo sappiamo perché ogni giorno la cambiamo in base al vento e alle esigenze del Terminal. Ora ti chiedo: Pilot si é mai spostato verso il lato sbagliato della manovra?”
- “No! Non é mai successo! Io credo che lui percepisca il mio pensiero e analizzi inconsciamente i miei gesti. Le sue reazioni si basano, credo, sulla nostra empatia.
- “Ma si comporta allo stesso modo anche nella manovra di partenza?”
-“Si ! Anche alla partenza. Pilot anticipa sempre di qualche minuto la mia salita sul Ponte di Comando e appena sente l’ordine: “Rimanere su un cavo e lo spring”, si sposta sull’aletta di manovra, quella giusta! Appena molliamo i cavi da terra, lui rientra prima di me in timoneria, si sistema davanti al vetro centrale per indicarmi la rotta d'uscita dal porto”.
Quando siamo in mare aperto, a volte succede che mi trattenga sul ponte a scambiare quattro chiacchiere con gli ufficiali ma, anche in questo caso, non riesco mai a fregarlo. Sembra che Pilot capisca dalle mie parole e dal tono della voce quando sta per giungere l’attimo del mio congedo. Fino a quel momento rimane impassibile nell’attesa della mia decisione che lui percepisce sempre nell’attimo giusto e ancora una volta mi precede dandomi il tempo di salutare i presenti.
Carlo, cerca di venire anche alla partenza. Credo che Pilot voglia farti vedere ancora qualcosa...
T’aspetto!”
Una nota sul TITANIC

A bordo del transatlantico affondato al largo di Terranova il 14 aprile 1912 c'erano, a quanto riporta lo storico del Titanic Claudio Bossi, ben 35 cani che accompagnavano passeggeri di prima classe, e per i quali fu approntato anche un canile. Non risulta invece che ci fossero gatti.

La presenza di cani di razza a bordo era tale che, per il 15 aprile, era stata anche prevista un'esposizione canina per intrattenere gli ospiti che, ovviamente, non ebbe mai luogo. Due cani sopravvissero al naufragio.
Qualche tempo dopo l'arrivo dei naufraghi a New York, il quotidiano N. Y. Herald pubblicò la storia di Rigel, un terranova che sarebbe appartenuto al primo ufficiale William Mc Master Murdoch, il quale avrebbe nuotato per ore abbaiando fra le scialuppe alla ricerca del padrone scomparso, attirando così l'attenzione dell'equipaggio della Carpathia, la nave che giunse per prima e raccolse i superstiti.
Carlo GATTI - Bruno MALATESTA
Rapallo, 26.08.12
URAGANO "EMILY" - Una dura prova per M.T.Palombo
URAGANO "EMILY"
Comandante CSLC Mario Terenzio Palombo
Sono nato a Savona il 30 agosto 1942, da famiglia di tradizioni marinare: mio padre Francesco, autentico “lupo di mare” era originario di Porto Santo Stefano (Monte Argentario), mia madre Renata Mattera, era dell’Isola del Giglio. La mia famiglia nel 1935, per esigenze di lavoro, si trasferì in Liguria, nella pittoresca cittadina di Camogli.
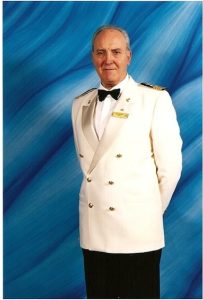
Il comandante Mario Palombo nel 1983
Mio nonno Biagio, già armatore del pinco-goletta Nettuno, comandato da mio padre, si mise in società con una famiglia camogliese ed iniziò i trasporti e la vendita a Camogli e Santa Margherita Ligure, di carbone e legna proveniente dalla Sardegna.
Mi sono diplomato nel 1963 all’Istituto Nautico “Cristoforo Colombo” di Camogli.
Dopo varie esperienze su navi da carico e petroliere, nel 1972 iniziai la mia carriera su navi passeggeri con la Società di navigazione Home Lines, assumendo il mio primo comando nel 1983. Nel 1988 questa Società fu venduta e venni, nello stesso anno, assunto dalla Società Costa Crociere dove rimasi a ruolo, sino al 30 giugno 2007. Con queste due importanti Società maturai sempre più la mia esperienza professionale partecipando a vari allestimenti di nuove navi, con l’affidamento del comando di navi prestigiose.
Il 21 giugno 1987 mi imbarcai al comando della M/n Atlantic (Home Lines) impegnata sulla linea New York – Bermuda. Fu una bella stagione calda e le crociere andarono a gonfie vele. L’alta temperatura aveva favorito lo sviluppo di depressioni e tempeste tropicali e alcune di queste erano già passate nelle vicinanze dell’isola, ma per fortuna sino a settembre le tempeste si erano esaurite durante la nostra sosta in porto e avevano permesso un tranquillo viaggio di rientro a New York.
La sera del 24 settembre, però, mentre eravamo tranquillamente in porto ad Hamilton (Bermuda) un comunicato straordinario ci informava che la tempesta tropicale che si trovava a 480 miglia a SW dell’isola, nelle vicinanze delle Bahamas, stava dirigendosi verso Nord rafforzandosi, con previsioni di ulteriore peggioramento e probabile passaggio, nelle seguenti 36 ore, su Bermuda.
L’intera isola era in stato d’allarme, tutti però speravano, come era successo molte altre volte, in un cambiamento di direzione della tempesta in prossimità della terra. Convocai subito nel mio studio il comandante in seconda Giorgio Bercic, il direttore di macchina Martino Gallinaro, il capo commissario Augusto Fazzio e il nostromo Latino Calloni per informarli sulla mia decisione in merito all’uragano e sui preparativi per affrontare il maltempo in navigazione. Studiata la situazione sulla carta nautica e valutate varie ipotesi, quella più valida al momento era di partire in tarda serata o in prima mattinata, di passare a Sud dell’isola e, una volta ricevuto il bollettino meteo aggiornato con l’ultima posizione, assumere una rotta di allontanamento in tutta sicurezza, per poi dirigere verso la costa (Cape Hatteras) e quindi verso New York. Avevamo, in questo modo, un buon margine da poter sfruttare convenientemente. Purtroppo la navigazione nei canali di Bermuda, data la loro ristrettezza era interdetta durante la notte e, nonostante la nostra motivata richiesta, non riuscimmo ad ottenere il permesso di partenza.
Non rimaneva che attendere la mattina successiva con una buona dose di ottimismo.
Il capo commissario preparò un avviso che fece diramare in tutte le cabine passeggeri, con il quale si comunicava che la nave, per l’avvicinarsi dell’uragano all’isola, non potendo rimanere in porto, per motivi di sicurezza, avrebbe anticipato la partenza al mattino successivo alle 07.00. Seguirono annunci per altoparlante in modo che tutti fossero informati sulla situazione. Il comandante in seconda fece chiudere le corazze degli oblò dei due ponti al di sopra del galleggiamento ed il nostromo preparò alcune pompe portatili che installò in prossimità degli ombrinali in cui l’acqua piovana avrebbe potuto defluire con difficoltà e causare allagamenti.
Informai la nostra agenzia sulla decisione di partire la mattina seguente. Il responsabile, un certo John Moore (mio amico già dal mio primo arrivo a Bermuda), essendo anche lui esperto di mare, approvò la mia idea e mi confermò che, essendo previsti piovaschi, le autorità portuali avevano ulteriormente esaminato la nostra richiesta di partenza notturna giungendo però alla conclusione di non accoglierla. Passai la notte nell’attesa di ricevere qualche bollettino meteo di aggiornamento. Purtroppo a quel tempo le previsioni non erano così accurate come oggi e per avere la posizione della tempesta e l’intensità del vento bisognava attendere che un aereo da ricognizione si recasse sopra l’occhio dell’uragano e con un’apposita sonda, rilevasse tutti i dati.
Provai pure a chiamare il Miami Hurricane Center, ma non avevano aggiornamenti. La mattina del 25 settembre 1987 il cielo si presentava grigio scuro ed il mare calmo, non un alito di
vento. Il barometro scendeva rapidamente. Da 1000 hPa, in pochissimo tempo, era già arrivato a 980 hPa. La cosa mi insospettì, la tempesta doveva essere vicinissima a noi. Avevamo appena iniziato ad alleggerire gli ormeggi per la partenza prevista alle 07.00, ma diedi ordine di sospendere, per attendere l’emissione del successivo bollettino meteo. Telefonai nuovamente al Miami Hurricane Center e mi dissero che a breve avrebbero diramato l’aggiornamento, infatti, poco dopo, il nostro strumento inizio a scrivere il messaggio.
Come pensavo, in realtà, la tempesta tropicale era molto più vicina a Bermuda e durante la notte si era intensificata trasformandosi in uragano e dirigendosi a forte velocità verso l’isola, in quanto aveva trovato condizioni meteo favorevoli con l’avvicinarsi alla terra. Si calcolò che aveva addirittura galoppato spostandosi ad una velocità superiore ai 30 nodi (55 Km/H) e che la forza del vento aveva raggiunto raffiche oltre i 100 nodi (180 Km/H). Il bollettino concludeva scrivendo che l’impatto con l’isola era previsto alle 08.00 del mattino. L’unica cosa da fare era riormeggiare la nave con tutti i cavi a disposizione e sperare in un cambiamento di rotta dell’uragano.
Ricordo che passammo intorno alle bitte d’ormeggio disposte in banchina almeno una dozzina di cavi a prora e poppa, in aggiunta feci mettere spezzoni di cavo d’acciaio, di cui la nave era dotata, tra le bitte di ormeggio lungo lo scafo e lungo la banchina. Questi spezzoni servivano a non far allargare troppo la nave dalla banchina durante le raffiche, evitando che aumentasse la tensione dei cavi di prora e di poppa. Feci zavorrare la nave per aumentarne la stabilità durante le forti raffiche ed in caso di una possibile perdita d’ormeggio. Feci inoltre devirare l’ancora di dritta in mare (lato banchina) sino a otto lunghezze (220 metri di catena) e feci disporre tra la banchina e la nave tutti i parabordi di cui la nave era dotata (circa una dozzina).
L’ancora in mare sarebbe stata una sicurezza in più nel caso in cui il vento fortissimo ci avesse fatto rompere i cavi e perdere l’ormeggio. Quando tutto il nostro personale addetto a queste operazioni salì a bordo, togliemmo lo scalandrone e rimanemmo in attesa degli eventi, con i motori in moto, pronti all’emergenza.
Tutti gli abitanti dell’isola si erano barricati in casa cercando di sbarrare e chiodare le finestre per limitare i danni. Puntualmente alle 08.00 il cielo, che prima era grigio, diventò nero, praticamente buio come la notte. Il barometro scendeva paurosamente a rotta di collo. La pioggia in pochi minuti diventò torrenziale e la quantità d’acqua caduta in pochi minuti fu tale da allagare tutte le strade, mentre le nostre pompe ausiliarie, fortunatamente, reggevano bene salvaguardando dall’allagamento l’interno della nave. La potenza del vento era paurosa. In porto sembrava di essere in mare aperto. In certi momenti le raffiche raggiungevano gli 80 nodi. Le barche ormeggiate poco distante dalla nave, strapparono gli ormeggi e rimasero in balìa del mare come fossero dei leggeri fuscelli.
Intanto la depressione che si era creata proprio al centro di Bermuda fece salire la marea di oltre due metri, il barometro era sceso ancora sino a 960 hPa. Il mare lambiva l’orlo della banchina. Guardandoci attorno, osservando le case sulle isolette, sembrava che l’isola dovesse inabissarsi. Sulla banchina riservata alle navi da carico ubicata proprio dietro di noi, le fortissime raffiche di vento fecero cadere tutti i containers vuoti accatastati e li spinsero in mare.

In porto ad Hamilton (Bermuda)
Danni causati alle bitte di ormeggio dalle prime raffiche violente di vento
I tetti delle case non resistettero a questa forza tremenda e di tanto in tanto, grossi pezzi di copertura dei tetti venivano sradicati e volavano via. La stazione marittima venne scoperchiata completamente. Il nostro scalandrone volò in mare. Le macchine e le moto rimaste in strada volavano via e venivano accatastate una sull’altra. Le uniche piante a resistere alla furia del vento erano le palme lungo la passeggiata. Venivano strapazzate in tutti i sensi, si piegavano quasi a toccare terra, ma resistevano. La nave, invece, quando la raffica aumentava di intensità veniva sbattuta contro la banchina, si avvertivano i forti colpi e le vibrazioni, ma i parabordi aggiuntivi che avevo fatto mettere proteggevano lo scafo che si manteneva integro. Il vento soffiò da SW, sbattendo la nave contro la banchina per oltre un’ora, poi il vento incominciò a girare da W e poi da NW, segno che il centro dell’uragano si stava allontanando, ma la forza del vento in questo settore era ancora più forte. Per circa cinque minuti le raffiche diminuirono di intensità, ma dovevamo aspettarci qualcosa di ancora più forte e tremendo. Improvvisamente le raffiche ripresero superando i 100 nodi ( 180 Km/H.), parte dei tetti ripresero a volar via e una forte raffica spinse violentemente la nave lontano dalla banchina, Si pensò che i cavi avessero ceduto, invece guardando tra la pioggia li vidi penzoloni e mi accorsi che in banchina mancavano tutte le bitte da ormeggio.
Praticamente i cavi avevano resistito, ma le bitte con tutto il cemento armato avevano ceduto e oltre alle bitte erano venuti via blocchi di banchina. Avevamo perso l’ormeggio.

Perdita dell'ormeggio causata dal fortissimo vento
Le bitte avevano ceduto perché su ognuna di esse c’erano almeno tre o quattro cavi che, insieme, avevano formato un fascio molto resistente che superava la tenuta della bitta stessa.

La furia dell'uragano contro la nave Atlantic
Una scena che, a prima vista, mi lasciò sbalordito. Fortunatamente mi ripresi subito pensando che la poppa della nave spinta dal vento avrebbe potuto urtare contro la banchina, il vento infatti aveva fatto ruotare velocemente la nave. Tolsi tutte le sicurezze sui motori per avere l’intera potenza disponibile e misi le leve di colpo avanti tutta.

Perdita dell'ormeggio causata dal fortissimo vento
La nave reagì subito, ebbe un balzo in avanti portando via anche le bitte di ormeggio di poppa. La nave fu salva dal possibile urto contro la banchina. Subito per altoparlante gridai al nostromo di cercare di recarsi a prora per dare fondo all’ancora di sinistra.
Mi dissero dopo che, sentendo la mia voce così forte e decisa, l’equipaggio e i passeggeri si rassicurarono pensando che chi stava in quel momento al comando, non aveva perso la calma. Il nostromo Latino Calloni fu rapido, passò dal portello di prora, riuscì con una cintura di sicurezza a legarsi al verricello e, al mio ordine, quando la catena di dritta che era già in mare si stese tutta, diede fondo all’ancora di sinistra lasciando andare, anche su questa, circa sette lunghezze (200 metri). Ci trovavamo in mezzo alla baia del porto con le due ancore in mare.

In porto ad Hamilton (Bermuda) si lotta contro le violente raffiche di vento
Pioggia e vento non mollavano, non si vedevano neppure la banchina e la terra intorno a noi per le forti raffiche di vento e per la pioggia torrenziale. Mi sentivo però più sicuro, dentro di me pensavo che le ancore avrebbero salvato la nave. In tutto questo frangente si doveva pensare anche ai nostri passeggeri e all’equipaggio. Il nostro direttore di crociera era sul ponte per dare informazioni sull’accaduto con messaggi sempre ottimistici. Feci anche dire loro di stare tranquilli perché in quelle circostanze il luogo più sicuro era la nave e anche se ci fossimo arenati, non ci sarebbe stato alcun pericolo.

In porto ad Hamilton (Bermuda) la nave lotta contro la furia dell'uragano Emily
Le raffiche di vento causavano improvvisi sbandamenti a dritta e a sinistra di oltre 10 gradi. Cercavo di manovrare la nave con i motori, non si vedeva nulla per la furia della pioggia e per il vento. L’ufficiale a poppa di tanto in tanto gridava che la nave si avvicinava paurosamente alla banchina ed io prontamente agivo sui motori per evitare l’urto.

In porto ad Hamilton (Bermuda): raffiche violente di vento
Molte volte arrivammo a meno di un metro di distanza, ma riuscimmo sempre a evitare il contatto. La forte escursione di marea aveva fatto sì che la nave galleggiasse tranquillamente anche nella parte più interna del porto, dove veniva sospinta dal vento.

In porto ad Hamilton (Bermuda) la nave lotta contro la furia dell'uragano Emily
Tutto intorno a noi lo scenario era terrificante: a terra case scoperchiate, strade allagate, macchine accatastate, in porto barche e containers rovesciati e alla deriva.


Nelle tre foto: in porto ad Hamilton (Bermuda), raffiche violente di vento contro le case
Dopo circa due ore di furia, finalmente, verso mezzogiorno, il vento incominciò a placarsi. In mezz’ora il tempo fece un rapido cambiamento. Prima si calmò il vento, poi il cielo da nero diventò grigio e poco dopo incominciò a schiarirsi fino a divenire completamente sereno.

In porto ad Hamilton (Bermuda): la furia dell'uragano si sta placando
Il barometro che aveva raggiunto un picco in discesa sino a 956 hPA,( mai visto così basso!) stava salendo molto rapidamente e ciò significava che l’uragano dopo aver scaricato tutta la sua furia sull’isola si era diretto in mare, degradato a depressione tropicale. Come avevo pensato le ancore avevano salvato la nave.
Con una lancia messa a disposizione dalla nostra agenzia feci un giro di ispezione intorno alla nave. Nessun danno allo scafo e alla sovrastruttura, nessun vetro di oblò rotto.
L’isola fu invece semidistrutta dalla tempesta. Mentre giravo con la lancia intorno alla nave, i passeggeri applaudivano e mi gridavano «Bravo Mario, grazie!». Anche da terra molti abitanti usciti di casa applaudivano nel vedere la nave integra in mezzo a tutto quel disastro.
Prima di poter partire per New York si dovette attendere qualche ora per consentire al comandante del porto di far sgombrare l’area dalle imbarcazioni che si trovavano in mezzo al canale e sulla nostra rotta. Rimanemmo nella rada di Hamilton antistante la banchina di ormeggio, inoltre studiammo con il comandante, il pilota e il nostro agente, il capitano John Moore, la priorità delle azioni da intraprendere per poter far scalo senza problemi la settimana successiva.
C’erano da ripristinare le bitte, da riparare il tetto della stazione marittima e da ripescare il nostro scalandrone caduto in mare. Per le bitte i tempi erano lunghi, in quanto si doveva attendere che il cemento armato facesse ben presa e quindi si decise, per almeno due o tre scali, di utilizzare la catena di emergenza sistemata nei pozzetti della banchina di prora e di poppa della nave. Questa catenaria nei casi di vento fortissimo, veniva di proravia connessa alla catena della nave, di poppavia ad un fascio di almeno tre cavi, di cui uno di acciaio. In questo modo l’ormeggio poteva considerarsi sicuro, di certo non in caso di uragani, in quanto era meglio che le navi lasciassero per tempo il porto per raggiungere mari più tranquilli. Nel nostro caso, le catene non erano state utilizzate in quanto pensavamo di partire in prima mattinata, ma la nave era stata salvata dalle proprie ancore.
Suggerii al comandante del porto di far installare bitte molto resistenti, almeno due in testata ed in radice della banchina, con un solido e profondo basamento. Ci vollero tre settimane, ma finalmente avevamo nuove bitte molto forti posizionate a regola d’arte.
Liberato il canale da tutti gli oggetti pericolosi per la navigazione, poco dopo le 14.00 partimmo per New York. Avevo passato quattro ore terribili in piedi, nonostante tutto mi sentivo ancora forte sulle gambe. Durante la navigazione lungo la costa dell’isola era possibile osservare le spaventose distruzioni provocate alla vegetazione e alle case dall’uragano.
Lasciata la costa a circa cinque miglia di distanza, al limite della barriera corallina l’uragano Emily che dirigeva verso Nord Est e che era ormai solo una depressione tropicale, ci aveva lasciato un’ultima sorpresa: davanti a noi il mare lungo formava, sui bassi fondi, onde tra i sei e i dieci metri che frangevano sulla barriera, sollevate da raffiche violente di vento. Feci subito fare un annuncio ai passeggeri che avremmo affrontato le onde a bassa velocità e che non ci sarebbe stato alcun pericolo per loro e per la nave.

Sotto le coste di Bermuda, primo impatto con le onde lasciate dall'uragano "Emily"
Affrontata la prima onda, dovetti diminuire e subito aumentare la velocità per governare bene la nave. L’ Atlantic si comportò egregiamente; data la bassissima velocità, l’onda passò senza provocare forte movimento di beccheggio né tantomeno forte impatto. A seguire ce ne furono altre quattro, tutte tra i sei e gli otto metri. Finalmente fuori, assumemmo la rotta iniziale più verso Cape Hatteras, dove il mare era previsto molto più calmo. Il viaggio fu buono e i passeggeri rimasero soddisfatti.

Impressionante veduta delle onde lasciate dall'uragano "Emily"
Sul programma del giorno chiamammo la serata dell’ arrivederci “Gala dell’uragano Emily” e dovetti poi firmare tutte le copie perché i nostri passeggeri lo vollero tenere come ricordo.
La stessa sera ricevetti moltissime lettere di elogio e di ringraziamento dai passeggeri. Avrei dovuto scendere in ristorante, ma ero troppo stanco, mi feci vedere soltanto durante i due cocktail prima dei due turni della cena. Fui accolto con grandi applausi, elogiai i nostri passeggeri per la calma mantenuta durante l’emergenza e poi mi ritirai per un meritato riposo.

Onde montagnose lasciate dall'uragano "Emily"
Non riuscii a dormire quella notte, sentivo forti crampi alle gambe per la stanchezza e poi il pensiero del pericolo corso e superato mi veniva continuamente in mente. Rivedevo chiaramente tutto. Ringraziai il Signore per avermi dato così tanta forza da mantenermi sempre calmo e lucido in tutte le decisioni e negli ordini impartiti e per avermi fatto uscire dalla tempesta con la nave integra.


Nelle foto sopra: impressionanti vedute delle onde lasciate dall'uragano "Emily"
La notizia dell’uragano e della nave scampata al pericolo era rimbalzata su tutte le reti televisive degli Stati Uniti. In arrivo a New York, la mattina di lunedì 27 settembre, un elicottero di una rete televisiva sorvolò la nave e, all’arrivo in stazione marittima fui intervistato varie volte sull’accaduto.
Vidi poi in televisione che tutti i passeggeri intervistati avevano rilasciato dichiarazioni encomiabili nei confronti miei e di tutto l’equipaggio per come era stata gestita l’emergenza e per l’informazione continua e rassicurante. Per alcuni giorni in TV non si parlò d’altro che di me, della nave e dell’uragano. Fu una buona pubblicità per la nostra Compagnia.
Anche i passeggeri appena imbarcati non facevano altro che parlare di questa storia e, appena mi vedevano, mi fermavano per conoscerne i dettagli .
Ritornati a Bermuda, guardando l’isola con l’occhio più attento, notammo moltissimi tetti delle case distrutti e tantissimi alberi abbattuti. Gli abitanti avevano iniziato la riparazione provvisoria dei tetti utilizzando della tela in attesa che giungesse sull’isola altro materiale idoneo per la riparazione.
Ci ormeggiamo in porto ad Hamilton utilizzando l’unica bitta rimasta di prora e di poppa ed in aggiunta, come avevamo già stabilito, le catene sistemate nei pozzetti della banchina.
Appena arrivati ci fu una bella sorpresa: la banda dell’isola ci diede il benvenuto. Ricetti l’invito di presentarmi dal governatore dell’isola: fu una cerimonia molto toccante che culminò nella firma dell’evento dell’uragano su un registro dove di solito firmano le persone importanti.
Il governatore John W. Swan mi consegnò una targa in memoria del passaggio dell’uragano e oltre al suo encomio personale mi diede una lettera dove esaltava il mio comportamento e mi dichiarò cittadino onorario dell’isola per tutta la stagione 1987. Fui veramente commosso e nello stesso tempo fiero per quanto, con l’aiuto di Dio, ero riuscito a fare.

Firma del registro "Eventi straordinari su Bermuda" in presenza del governatore dell'isola
Riporto qui di seguito i contenuti della lettera ricevuta:
PREMIER – THE CABINET OFFICE – HAMILTON 28.9.1987.
Caro Comandante Mario Palombo,
Tutti, tra coloro che sono stati testimoni delle difficoltà duramente provate dalla m/v Atlantic, nel culmine del cattivo tempo causato dall’uragano Emily, lo scorso venerdì, sono rimasti sbalorditi dalla consumata destrezza con la quale Tu sei stato capace di portare la Tua Nave fuori dal pericolo.
La subitaneità con la quale Bermuda è stata colpita dall’uragano, ha colto molta gente di sorpresa, ma le storie rimangono di quelli che, come Te, sono stati capaci di emergere dall’occasione. La Tua rapida azione ha certamente allontanato ciò che poteva essere un disastro molto pericoloso. Quindi, a Nome del Governo, ho il piacere di encomiare Te ed il Tuo Equipaggio per la pronta ed efficiente azione con la quale Tu hai manovrato la Tua Nave fuori dal pericolo, Vogliamo sperare che, da oggi in poi, Noi navigheremo mari più tranquilli. Cordiali e personali saluti, sinceramente John W. Swan.
Alcuni giorni dopo dal presidente della Compagnia ricevevo la seguente lettera:
HOME LINES INC. 5 Ottobre 1987.
Caro Comandante Mario Palombo,
Voglio congratularmi con Te e con il Tuo Equipaggio per il modo coraggioso con il quale avete affrontato le difficoltà causate dall’uragano Emily.
Vi porgo i miei migliori saluti, sinceramente. N. Vernicos Eugenides President.
Il Presidente della Home Lines New York mi scriveva in data 1 Ottobre 1987.
Caro Comandante Mario Palombo,
a seguito della nostra conversazione telefonica relativa all’atroce uragano Emily, voglio esprimere per iscritto il nostro apprezzamento e ringraziamento per il modo magistrale con il quale Tu hai manovrato la Tua nave durante quei critici momenti. Noi siamo estremamente orgogliosi di avere Comandanti del Tuo calibro nella nostra Famiglia Home Lines.
Congratulazioni, sinceramente, Franciskos G. Stafilopatis, President.
Dal nostro Comandante di armamento di Genova ricevevo :
AGENZIA MARITTIMA ITALO SCANDINAVA Sede in Genova, 7 Ottobre 1987.
Caro Comandante,
Ho appena finito di leggere ed osservare tutto il materiale, fotografie, estratto giornale, lettera del Primo Ministro ecc. da lei cortesemente inviatomi relativamente alla famigerata “Emily”. Naturalmente sono tornato con la mente alle conversazioni telefoniche con Lei avute quando mi ha informato di quanto accaduto e mi viene il dubbio che in quelle nostre conversazioni forse non sono stato capace di esprimerLe appieno il mio apprezzamento e la mia ammirazione per la capacità con cui ha saputo affrontare la pericolosa emergenza ed essere padrone della nave malgrado tutte le circostanze avverse che, in breve giro di tempo, si sono scatenate contro di Lei e la sua nave. Solo la Sua perizia e la Sua calma Le hanno consentito di manovrare in condizioni praticamente impossibili e di tener testa agli elementi. Ammirevole è stato anche il comportamento del Suo Equipaggio al quale La prego di esternare il mio apprezzamento. Lei non può immaginare quale soddisfazione sia per me il poter dire una volta di più che i Marittimi della Home Lines sono sempre i migliori di tutti.
Con i più cordiali saluti, Diego Voussolinos.
Inoltre il giornale di Bermuda la “ Royal Gazzette “ riportava un articolo da un bellissimo titolo : “ATLANTIC NEVER LOST CONTROL” dove esaltava la mia impresa e dove ringraziavo il mio bravissimo direttore di macchina Martino Gallinaro per la collaborazione ricevuta nel mantenere sempre tutti i servizi nave in efficienza durante questa dura prova. Riportava che, mentre l’isola era stata colta di sorpresa, io non mi ero lasciato sorprendere, mi ero preparato, mettendo a frutto la mia esperienza, per affrontare le intemperie. In questo articolo riportavano anche quanto io ero fiero dei miei ufficiali e del mio equipaggio per il comportamento coraggioso dimostrato in questa occasione.
In conclusione posso dire che fu veramente una brutta esperienza dalla quale venni fuori senza danni con l’aiuto di Dio. Il fatto di aver pianificato ogni cosa e cercato di prevedere il peggio mi fu senz’altro di grande aiuto in quanto tutti i miei ufficiali erano pronti all’emergenza ed erano a conoscenza del miei piani in tutti i dettagli e, quindi, sapevano come muoversi. Inoltre l’equipaggio era stato informato su come intervenire in aiuto, se fosse stato necessario, dei nostri passeggeri e soprattutto sapeva di dover agire con calma evitando di creare panico. Fu proprio la calma, che grazie a Dio, riuscii sempre a mantenere, a farmi prendere le giuste decisioni per la nave, i passeggeri e l’equipaggio.
dal Libro : "La mia vita da uomo di mare" del Com.te Mario Terenzio Palombo - Editrice Innocenti - Grosseto (4/09)
Carlo GATTI
Rapallo, 15.03.12
MARIETTO ed il suo rimorchiatore d'altura Casteldoria
MARIETTO DI BARTOLOMEO
ed il rimorchiatore Casteldoria

Il m/r Casteldoria
Una buona macchina della sua epoca
Gli armatori di allora lo avevano programmato e realizzato per farne un “uso allargato” e per questo motivo la “barca” aveva uno shape più elegante e navigabile di quei “mastini portuali” che avevano la prora bassa, rincagnata e richiamavano alla memoria la virilità dei gladiatori romani. Sul suo unico albero svettava l’antenna del radar che gli conferiva un portamento nobile e suscitava una certa invidia tra le altre barcacce del porto che erano destinate allo stesso impiego.
Tuttavia, il suo compito principale era pur sempre il “servizio portuale” che era alle prese, in quegli anni di boom economico, con il gigantismo crescente delle petroliere e dei primi containers transoceanici, ragion per cui, i suoi 1.535 cavalli di razza erano sempre molto richiesti sulle tre imboccature del porto di Genova.
Ma la Società aveva da difendere “Il suo Marchio RR” anche nel settore dell’Altura a corto e medio raggio e certamente non era disposta a lasciarsi scappare i vecchi clienti e qualche “nolo buono” da mettere nella “cantia”. Il Casteldoria nacque così nel 1961 per soddisfare questa doppia esigenza economica e operativa.
In realtà, fuori dell’ambiente di Ponte Parodi, pochi erano in grado di distinguere le diversità tra le due attività di rimorchio: portuale ed alturiera che, in qualche modo, pur partendo da una radice comune, erano ben presto destinate a dissociarsi al traverso del fanale rosso del porto, per seguire rotte ben distinte e caratterizzate da responsabilità oggettive ed esperienze tecniche complementari, ma differenti.
In porto occorreva imparare una tecnica per la verità molto complessa, che si affinava in molti anni di gavetta e si realizzava di pari grado con la personalità, il coraggio ed il senso marinaro del suo comandante che agiva per mezzo del timone e di un potentissimo motore, ma che interagiva con un “suo” equipaggio motivato, addestrato e direi personalizzato. L’intelligenza complessiva dell’equipaggio doveva poi adattarsi alle caratteristiche della nave da rimorchiare in porto, al suo personale, alle condizioni meteo e soprattutto al pilota portuale che, con un suo metodo originale, dirigeva la manovra accanto al comandante della nave.
“Saper navigare” costituiva invece il presupposto del rimorchio d’altura. In mare aperto, il Casteldoria ed il suo equipaggio cessavano di essere un “servizio portuale” retribuito dalla nave in manovra e diventavano una “unità indipendente”, un piccolo e poderoso scafo che però si allungava con quasi 300 metri di cavo e terminava sul dritto di poppa dell’unità trainata. Il rimorchiatore era soltanto la testa del convoglio che esercitava il comando su quasi 500 metri di spazio “nazionale”. Il Casteldoria, steso tutto il suo cavo, diventava improvvisamente la nave più lunga del mondo ed il suo esiguo equipaggio aveva il compito di controllare una superficie di mare che durante i piovaschi invernali, le mareggiate e le nebbie adriatiche diventava impervia, infinita, difficile da gestire per l’occhio e l’orecchio umano che erano ancora sprovvisto, a quell’epoca, di moderni strumenti ed “aiuti” alla navigazione.
Il comandante del Casteldoria cessava così di prendere ordini dall’alto e diventava autonomo nelle sue decisioni e responsabilità. Proprio su questo punto fondamentale del Codice della Navigazione si dividevano quindi le due principali attività di rimorchio.
“In mare non ci sono taverne!”
Con questa pittoresca sentenza, i marinai di una volta usavano sottintendere il concetto di pericolosità delle furie del mare in burrasca e le difficoltà di trovare un ridosso nell’attesa di un cambiamento favorevole del tempo. Ma questo monito sembrava ancor meglio “appiccicarsi” alla realtà di un rimorchio d’altura che poteva navigare solo in alti fondali, lontano dalla costa, a causa dell’immersione (pescaggio) di circa 20-30 metri che disegnava l’arco (catenaria), del suo cavo filato fuoribordo.
In inverno le burrasche erano di gran lunga più veloci dei “rimorchi” d’altura che annaspavano a 5/ 6 nodi, senza alcuna possibilità di fuga su rotte alternative. Il risultato era sempre lo stesso: lunghe notti alla cappa (con la prora al mare), “ballando con i lupi”, piegati su se stessi, nell’attesa che il vento girasse a tramontana per poi controllare i danni e riprendere la rotta.
Era importante per un comandante d’altura, che non poteva “scappare” da una depressione, capire i segnali del tempo, intuire la verità tra le righe dei bollettini meteo e capire poi con l’esperienza, quali erano i bollettini affidabili, quelli meno e quelli addirittura pericolosi. Ma era ancora più difficile decidere di “mollarsi” dal porto o dal ridosso quando il meteo non dava alcuna certezza e i Ricevitori, qualche volta, premevano per esigenze legate ai loro programmi operativi.
Ricordo di un Rimorchio in Mediterraneo
Spero che gli amici barcaccianti abbiano già perdonato la lunghezza di questo cappello introduttivo teso, nelle nostre intenzioni, soltanto a proiettare alcuni sprazzi di luce su un mondo che troppo a lungo è stato occultato in una nicchia, che molte volte è stata scambiata e confusa con altre realtà marinare e che, ancora oggi, sfugge quasi sempre alle giuste interpretazioni.
Il motivo di tanto silenzio sta nella ritrosia dell’uomo di mare che rifugge dalle operazioni di marketing terrestre e - dialoga solo con il mare - come sosteneva il celebre scrittore di mare Vittorio G. Rossi.
Questa “piccola” storia di un viaggio del Casteldoria non è altro che l’occasione per ricordare il comandante Marietto Di Bartolomeo che ci ha lasciato in questi giorni. Il suo amico e compagno di bordo per oltre vent’anni, il direttore di macchina Osvaldo “consumi” Schiano di Porto S. Stefano, mi ha chiamato al telefono e con un comprensibile magone alla gola mi ha raccontato un episodio, uno fra i tanti vissuti accanto al “suo” comandante sicuramente, per essergli ancora un po’ vicino, su quel ponte angusto del Casteldoria dove le decisioni, le gioie e le sofferenze legavano le persone ben oltre i normali rapporti di lavoro.

Un Pontone della Soc. MICOPERI al Traino del M/r CASTELDORIA
VIAGGIO MARS EL BREGA-CAGLIARI- e rientro a GENOVA
Dal 14 al 23 dicembre 1970
Osvaldo racconta:
“Per quattro giorni consecutivi, dalla partenza da Mars El Brega (Libia), la navigazione era stata regolare e veloce fino all’alba del 18.12, quando il primo bollettino meteo delle 06.25 ci fornì un preoccupante Avviso di Burrasca forza 7 sul Canale di Sardegna, quindi sulla parte finale del nostro viaggio da compiersi in mare aperto.
Il comandante Marietto Di Bartolomeo, serio e scrupoloso come sempre, ci chiamò sul ponte e illustrò il bollettino del tempo, sentì le nostre opinioni e poi decise di rallentare l’andatura per portarsi a ridosso di Capo Mustafà (Tunisia) situato ad una ventina di miglia a ponente di Capo Bon. L’intenzione era quella di giungervi all’alba per constatare “de visu” la situazione meteo, per poi decidere se pendolare dietro la punta o rischiare l’avventura sperando in un rallentamento o meglio in una deviazione della depressione”.
A questo punto del racconto, Osvaldo rivive la stessa tensione emotiva di quel lontano inverno del ‘70 e con la consueta verve esuberante della sua gente toscana, riprende il racconto al presente storico, ma la sua voce ogni tanto è rotta dall’emozione.
“Verso le 04, improvvisamente il beccheggio causato dal mare lungo in prora s’interrompe. Il vento leggero che sibilava al traverso si ammutolisce, il convoglio frena dolcemente fino a fermarsi. Sembra un incaglio. Ma il Casteldoria, con il cavo già abbondantemente accorciato, non è ancora sotto costa; allora è evidente che abbiamo incocciato qualcosa. Il cavo si è stirato ma ha tenuto. Sveglia generale. Tutti sul ponte di comando, per guardare la carta nautica che però è muta. In quella zona non è segnalato alcun relitto. Abituati come siamo a vedere il nemico in faccia, è davvero traumatico sentirsi aggrediti alle spalle, anzi sotto i piedi, vigliaccamente!
Marietto, grande marinaio, rimane calmo e tranquillizza l’equipaggio, smorza subito qualsiasi suggerimento avventuroso e comincia ad “assaggiare il fondale” con qualche timido strappetto teso a sganciarsi, ma è chiaro che teme di peggiorare la situazione. Prova qualche accostata da ambo i lati e poi desiste.
Marietto mi guarda e intuisce che forse il suo fedele direttore di macchina, munito di una cospicua esperienza sui pescherecci di Porto S. Stefano, potrebbe aver già conosciuto quel problema che penalizza, ogni giorno, numerosi pescherecci che sono costretti a lasciare costosi pezzi di rete a strascico, cavi e attrezzi vari sui relitti del Mare Nostrum che, com’è noto, da oltre duemila anni è teatro d’affondamenti di navi mercantile e militari di ogni razza e bandiera.
Nel suo sguardo leggo un invito a prendere la parola.
- Marietto ascolta! Una volta ci è capitato con il “Papetto II” d’incocciare un relitto, pare si trattasse di un’ala d’aereo abbattuto a sud della Capraia e so che da queste situazioni non si esce tirando a strappare… ma lavorando con il cervello, con la calma e con l’astuzia. Io, come sai, non sono un manovratore e non ho la sensibilità di sentire sulla pelle se il cavo resisterà o cederà, come invece capita a te, ma questo lavoro l’ho visto fare numerose volte.
“Dai Osvaldo, dimmi la tua!”
- Rispose con la solita ironia Marietto che aggiunse:
“Quando mi g’anavo ti ne vegnivi! (quando io ci andavo tu ne venivi!) Così recita un vecchio proverbio genovese che si tramanda da padre in figlio, e se fosse una belinata, pazienza, qui ne sento tante…!”
- Ascolta Marietto:
Molliamo il cavo di rimorchio dal gancio del Casteldoria.
Lo filiamo tutto in mare. Quando siamo liberi, passiamo di poppa al pontone e sbarchiamo due uomini.
Gli passiamo un cavo da mettere alle bitte e noi ci portiamo l’altra estremità al gancio.
Poi toccherà a te cominciare a tirare piano piano il pontone verso l’alto fondale. Con un po’ di fortuna, il cavo di rimorchio impigliato e venuto nel frattempo in bando, dovrebbe liberarsi -
“Ho capito Osvaldo!”
Risponde preoccupato Marietto.
“Con questo sistema dobbiamo però virarci ancora parecchi metri di cavo, che nel recupero potrebbe incocciare altri punti del relitto. L’idea mi sembra buona, ma ho l’impressione che per risolvere il problema, ci vorrà molta fortuna….!”
- Purtroppo non conosco altre soluzioni!
– Insiste Osvaldo –
Marietto era un uomo molto riflessivo e da esperto uomo di mare, non tardò a capire che la strategia suggerita da Osvaldo era valida, ma sentiva che la buona riuscita dell’intera operazione sarebbe dipesa dalla tattica impiegata, cioè dalla scelta di una manovra basata sulla sensibilità, sul sentire, attraverso le vibrazioni del cavo, la descrizione “visiva” di quel misterioso fondale.
Occorreva impadronirsi di una telecamera virtuale che aiutasse ad immaginare la posizione del relitto che imprigionava il cavo di rimorchio, forse sotto una lancia di salvataggio, oppure sotto la poppa di un vapore inclinato. Occorreva captare la giusta sensazione e indovinare la direzione di tiro da imporre al pontone, con uno spostamento viscido, scivoloso, subdolo ma efficace.
Osvaldo prosegue nel racconto.
Marietto pensò tutto questo e poi decise di tentare.
Portò tre uomini sulla Micoperi, gli fece stendere il cavo e con molta tranquillità disse all’equipaggio:
“Ragazzi! Quando “veniamo in forza” datemi una mano ad osservare le reazione del pontone: anche il minimo rumore, sussulto, oppure il più impercettibile sbandamento; datemi tutte le variazioni della velocità d’avanzamento ed avvertitemi immediatamente se ci fermiamo”.
Io mi misi silenzioso sul telefono di macchina ed ascoltavo i battiti del motore ed ero pronto a comunicare al 1° macchinista la potenza che Marietto voleva. La mia preoccupazione era superiore a quella di sempre. I miei suggerimenti erano stati accolti dal comandante, ma ne sentivo in qualche modo il peso, la condivisione della responsabilità anche se Marietto, ormai, aveva deciso che quella era la tattica migliore. Tutto sarebbe dipeso dalla dea bendata, e solo lei poteva vedere sotto la superficie di quel mare verde ingannatore, ma a parte la superstizione, tutti noi speravamo nella mano marinara di Marietto che non ci aveva mai deluso”.
Quando le prime luci dell’alba diffusero ampi e crescenti chiarori rossastri, il comandante dette il via all’operazione “recupero cavo”.
La dea bendata quella mattina era dalla nostra parte. Dopo circa 30 minuti di tiro, il cavo si liberò e lo recuperammo tutto, senza aver riscontrato il minimo danno. Rifacemmo l’attacco e si partì per Cagliari. Natale era alle porte e Marietto riuscì a portarci dalle nostre famiglie in tempo per festeggiare la festa più importante dell’anno, a “porto cosce”!
Carlo GATTI - 04.03.12
Equipaggio:
Comandante - Mario Di Bartolomeo
D.M.: - Osvaldo Schiano
1°Uff.le cop. – Luigi Gabrielli
1°Macch. – Angelo Angius
Marò - Maiulo (senior)
-“- - Giovanni Bottino
-“- - Antonio Mazza
-“-/cuoco - Parodi
 In ricordo di “Marietto”
In ricordo di “Marietto”
Sabato 29 Settembre 2007.
Cari Amici,
......oggi abbiamo salutato un caro amico che ci ha lasciato: il Comandante Mariano Di Bartolomeo…..
per tutti da sempre Marietto per il suo imbarco giovanissimo nel Mondo dei Rimorchiatori, il nostro Mondo. Comandante e Uomo di grande statura morale nella professione e nella vita.
Ci ha stupito la mancanza alla mesta cerimonia di una partecipazione delle nuove generazioni a testimonianza di un Mondo, che pur nelle personali divergenze, raccoglie il testimone di una appartenenza e la porta oltre.
Vedete, la mia generazione pur avendo conosciuto di sfuggita Uomini della generazione precedente ha sempre onorato chi ci ha preceduto e che tanta storia ha tramandato ai successori.
Per quasi un secolo questo filo non si è interrotto.
Un filo tessuto dalla dura vita di Bordo, dalle vicissitudini dei colpi mare presi su mezzi allora inadeguati…un filo tessuto consolidando amicizie e sentimenti di fratellanza che hanno segnato la nostra vita professionale ed umana e che ci saremmo portati dietro per tutta la vita.
Il Mondo dei Rimorchiatori come senso di appartenenza ad una “casta”(passatemi il termine) privilegiata che ci onorava e ci onora ancora con orgoglio.
Abbiamo avuto dure vicissitudini sociali, scontri (per noi, e a quel tempo) epocali ma mai abbiamo messo in forse questi sentimenti ed il desiderio in qualche modo di tramandarli, mai il senso di appartenenza a questo Mondo ci ha abbandonato, e mai abbiamo dimenticato il rispetto verso la Società (Rimorchiatori Riuniti) che ci ha aperto a questo Mondo anche se il dialogo talvolta si faceva aspro.
Oggi sembra che quel filo si sia spezzato, le nuove generazioni restano chiuse nel breve spazio della loro attuale professionalità esercita, sorde verso preziose testimonianze storiche e, forse, poco o nulla interessate a passare il testimone.
Un mondo in via di estinzione che resterà senza passato e dal futuro incerto se non innervato su sentimenti di alto profilo umano.
……oggi abbiamo salutato un caro amico che ci ha lasciato, il Comandante Mariano Di Bartolomeo…….
mi va di dire: ti sia lieve la terra, Marietto, sei un galantuomo e tale resti con noi.
TESTI di:
Carlo Gatti
Silvano Masini
Paride Faggioni
Navigare contro "MELTEMI" ?
NAVIGARE CONTRO MELTEMI ?
NOTIZIARIO DELLA
GUARDIA COSTIERA
ANNO XIII - DICEMBRE 2011

Un racconto inedito di un’avventura realmente vissuta.
di Marinella Gagliardi Santi



Nata a Milano, la scrittrice Marinella Gagliardi Santi ha poco della cittadina. Frequenti le sue e fughe dalla città per raggiungere la Liguria, considerata da sempre terra d’adozione. Perché il mare è una presenza sottile e insinuante nella vita di Marinella, nome che gli aderisce veramente addosso. E qualcosa deve essere scritto nel suo DNA, visto un nonno e uno zio navigatori transoceanici e una bisnonna che affittava imbarcazioni sul lago Maggior fatto insolito per una donna, vista l’epoca! Impegnata per parecchi anni come insegnante, per fuggire la metropoli oggi Marinella - con il marito, suo skipper e compagno d’avventure - vive e scrive sul Lago di Varese. Non è il mare, ma sempre acqua è...
Non riusciamo ad avanzare oltre, il vento contrario è troppo forte… non ci consente di raggiungere Amorgos…Anche il mare era peggiorato. Le onde, oltre a colpirci in continuazione con violenza, stavano squassando troppo la barca, erano diventate incrociate… La frase, pronunciata da Rinaldo, mio marito, alle cinque di un pomeriggio di agosto, trovava un po’ sgomenti sia me che il nostro amico Elio, compagni di avventura con lui nelle Cicladi in una sfida contro il famoso vento greco, il Meltemi. Di necessità avevamo scelto di navigare non sotto la sua spinta, ma affrontandolo a viso aperto! Dunque avremmo ripiegato su Astipalaia, un’isola che fa parte del Dodecanneso: era l’approdo più vicino, ma ci saremmo arrivati in piena notte. E avremmo ancorato al buio in una baia interna sconosciuta, raggiungibile attraverso uno stretto passaggio… Unico dato consolante, il vento in poppa, e se vai col vento, sia pur forte, ma in poppa, è tutto un altro discorso che averlo frontale e furioso come questo famoso vento greco. Per tornare all’origine della nostra avventura, devo dire che quella volta l’avevo fatta davvero bella. Avevo detto sì alla richiesta del nostro amico di dargli una mano per riportare la sua barca a vela dalla Turchia al Peloponneso. Elio, partito da Genova su Alga, un Cirano 38, progetto Sciomachen, aveva cambiato più equipaggi nella sua Odissea verso oriente: ora, arrivato in Turchia e rimasto solo, ci aspettava, come gli avevamo promesso. E tu gli hai detto sì! Aveva commentato, preoccupato e incredulo Rinaldo quando avevo accettato la proposta di Elio. Avevo capito che anche tu fossi d’accordo… A parte il fatto che preferisco navigare sulla mia, di barca, ma sai almeno a cosa vai incontro? Certo, in agosto, il Meltemi, nelle Cicladi… Ma sai anche che non si va mai contro questo vento? Nelle Cicladi tutti navigano da ovest verso est, tenendoselo in poppa e le barche vengono riportate indietro quando ha finito di soffiare! E tu vuoi navigare di bolina contro una furia di vento? E come può Elio da solo? Del resto ormai ho preso l’impegno, hai brindato anche tu all’impresa, siamo ingaggiati.
Sì, ma io proprio non avevo capito a cosa stessimo levando i calici! Ed ecco il portolano, in inglese, che sconsiglia la nostra navigazione asserendo che non si va contro il Meltemi e consigliando una rotta ben precisa attraverso le Cicladi, se proprio non se ne può fare a meno! La mia adesione risaliva all’inizio di giugno, perciò ho avuto tempo di rielaborare le mie ansie per due mesi abbondanti, anche sulla scorta di letture varie, a volte intercettate del tutto casualmente. Una, in particolare, trovata su una rivista, continuava a riaffiorare impietosa nella mia mente: il succo dell’articolo era che contro il Meltemi navigano al massimo quelli di Caprera, con il rischio, però, di far dei danni all’attrezzatura, se non di farsi male loro stessi…
Due mesi, perciò, di attesa che si era depositata in modo fastidioso nel mio inconscio e ogni tanto affiorava, interrogandomi circa la mia decisione e la mia convinzione di voler affrontare davvero quel famoso terribile e temibile vento greco… Ed eccoci arrivati ad uno dei momenti delicati del nostro viaggio per mare. Amorgos era lì, a sole due miglia, ma la nostra velocità di avanzamento era nulla. Le onde, incrociate, si accanivano contro la barca e anche contro di noi, chiusi e sprofondati nelle nostre cerate (è l’inizio di agosto e fa freddo!). Il Meltemi a 38-40 nodi, urlava tutta la sua rabbia, si sarebbe detto che ce l’avesse proprio con noi, in quel momento. Un simile urlo di vento, cupo e profondo che stordiva ed intimidiva, non l’ho mai sentito, a parità di intensità, da nessun altra parte del Mediterraneo che ho visitato, ma nemmeno ai Carabi… Il Maestrale ha sì un suono forte, ma lo ricordo più sibilante e metallico. Dunque, invertita la rotta, puntiamo su Astipalaia, la città vecchia letteralmente, in greco; l’isola a forma di farfalla, geograficamente. Sia pur forte il Meltemi, ma averlo che ti spinge da poppa è davvero tutto un altro vivere, l’onda, poi, che ti arriva da dietro, ti fa sì surfare, ma diventa un divertimento a confronto dell’impatto frontale che avevamo prima, mentre viaggiavamo contro vento. I problemi sorgono dopo cinque ore di navigazione, quando intravediamo appena, nel buio di una notte senza stelle, la sagoma scura di una collina lunga e omogenea. A parte un piccolo faro sulla punta del promontorio alla nostra sinistra, luci a terra, nessuna. Punti cospicui, perciò, zero! Lasciata quell’unica luce, è l’oscurità più totale…
Non ci restava che affidarci al plotter e verificare attentamente latitudine e longitudine confrontandole con le coordinate del portolano per identificare, e questo era il bello, non un’ampia e accogliente baia, bensì uno stretto passaggio tra le rocce che si apre su un canale di accesso, che finalmente, ci avrebbe condotto a un’ampia, e, si sperava, tranquilla baia interna… Con quel buio pesto l’avremmo trovato? In più ora avevamo un’andatura al traverso, di certo meno tranquilla del gran lasco di prima. Avvolgiamo, perciò, lo yankee, e accendiamo il motore per poterci avvicinare con maggior cautela.
Certo che il Meltemi non demorde neanche di notte, non va a dormire insieme al sole come fanno certi venti per bene… continua a soffiare invariato e spinge le onde davanti a sé, a frangersi sulla scogliera. Spingerà anche noi… dobbiamo individuare con certezza questo benedetto accesso! Ora il varco dovrebbe essere davanti a noi. Ci comunica Rinaldo che non stacca gli occhi dal plotter e non si stanca di asciugarlo dalle continue ondate, mentre io credo di interpretare il suo pensiero: quando siamo all’ormeggio, nei porti, è successo più di una volta che lo strumento non mettesse la barca dove in effetti era, ma spostata, anche se di poco. E se qui ci posiziona davanti al canale di accesso sbagliando anche solo di poco? Mi consolo pensando che, se non altro, i fondali erano dati sicuri, puliti. Anche quella, però, è una certezza del tutto relativa. Insomma, in quelle condizioni e senza il radar, bisognava fidarsi, di necessità, di quello strumento che per fortuna ci eravamo portati con noi dall’Italia, perché Elio non ce l’aveva, lui vuole navigare - come dice Rinaldo - duro e puro.


Ecco che si materializzavano, in quel frangente, parte delle mie inquietudini dei mesi passati: quell’alta collina continuava ad incombere nera e cupa, gelosa del suo varco… Dai, Marinella – incalza Rinaldo – dicci qualcosa tu, che avevi 11 decimi! Ecco, appunto, avevo! Vi sembra di vedere qualche novità in questo nero omogeneo? Incalza Elio che, giustamente è al timone di Alga, visto il frangente. La responsabilità della barca è tutta sua… Silenzio da parte nostra.
Cosa dite, avanzo? Perché ora la parete rocciosa è ben vicina! Vai, fidiamoci del plotter, ci dà l’ingresso proprio davanti a noi… Che tensione tremenda in questa notte impenetrabile: vento che incalza, onde che spingono, rocce incombenti… E vai che c’era davvero l’ingresso davanti alla nostra prua! E’ Rinaldo che ce lo comunica per primo, lui che è il più alto e quindi vede fuori dalla capottina già di suo, senza bisogno di scomode torsioni, come facciamo noi. Alla fine il plotter era stato onesto, ci aveva condotto al varco, che però ci sembrava davvero un po’ stretto. Colpa del buio, di certo, ma non è che fosse un passaggio poi così ampio, rivisto di giorno. Più a destra, Elio! Ero io che guidavo il procedere di Alga seduta sul winch di sinistra guardando con estremo rispetto la parete rocciosa dalla mia parte. Ma non troppo a destra, Elio! controbatteva dall’altra parte della barca Rinaldo, seduto sul winch opposto come osservatore della roccia di destra. Ma come è lungo questo canale, sembra non finire mai! Voi continuate a dirmi se sto timonando bene nel centro, sto facendo del mio meglio, dato che il vento e le onde continuano ad accompagnarci anche qui senza demordere…Insomma la tensione ancora non ci abbandonava… Finalmente, sulla sinistra, si apre una baia ampia e tranquilla, delimitata da alte colline.
Era ora, il Meltemi ne è rimasto fuori e le onde con lui. Primo sospiro di sollievo. Non si vedono luci, ma si intravedono due case bianche, distanziate tra loro. Avanziamo pianissimo, ci sembra incredibile: ad agosto nemmeno una barca? O siamo noi che non le individuiamo? È vero, non ce ne sono proprio. Questa navigazione nelle Cicladi, contro il Meltemi, sulla scorta della rotta suggerita dal Portolano, ci sta portando lontano dal turismo, attraverso le isole nelle quali vanno in vacanza i Greci. Addirittura in baie di notte deserte! Questo è uno degli aspetti più avvincenti del nostro viaggio: niente affollamenti né confusione, solo qualche barca di pescatori; luoghi, almeno all’apparenza incontaminati, che ti consentono ancora di vivere il mare nella sua integrità. È quello che vorremmo trovare sempre, lontano dalla confusione dei porti estivi e dalla mondanità. L’ancora ha preso. Spegniamo il motore, non c’è un rumore, l’acqua sembra quella di un lago. Pare incredibile questo silenzio se paragonato con l’ululato cupo del Meltemi che ci accompagna incessante durante la navigazione. Secondo respiro di sollievo. Sorgono spontanei tra noi dei batti cinque incrociati, ripetuti e molto soddisfatti. In realtà non siamo riusciti a superare il primo puntum dolens (in tutto sono due) dell’incanalamento del Meltemi tra le Cicladi, là dove, arrivando da nord-est, raggiunge spesso forza 10. Ma domani ci riproveremo. Una suoneria rompe l’incanto del silenzio… è Miriam, la moglie di Elio, davvero molto inquieta: Ma dove vi eravate cacciati, sono ore che chiamo i vostri cellulari! Siamo appena atterrati a Vathi, nella baia interna di Astipalaia. Rispondo io, che sono corsa a recuperare il telefono. Ma cosa vi viene in mente di navigare di notte col Meltemi? Lei ha le sue ragioni, ma come spiegarle che non si poteva fare altrimenti? Poi capirà. Dunque a domani, Meltemi, per oggi hai vinto tu, ma domani sarà un nuovo round… speriamo di uscirne dignitosamente vincitori! P.S. Sembra quasi inutile che io stia qui ad aggiungere che il nostro amico Elio, appena tornato in Italia, è corso a comperarsi un plotter cartografico… la prova dei fatti l’aveva convinto!
Marinella Gagliardi Santi
Rapallo, 03.03.12

