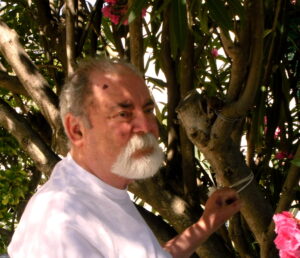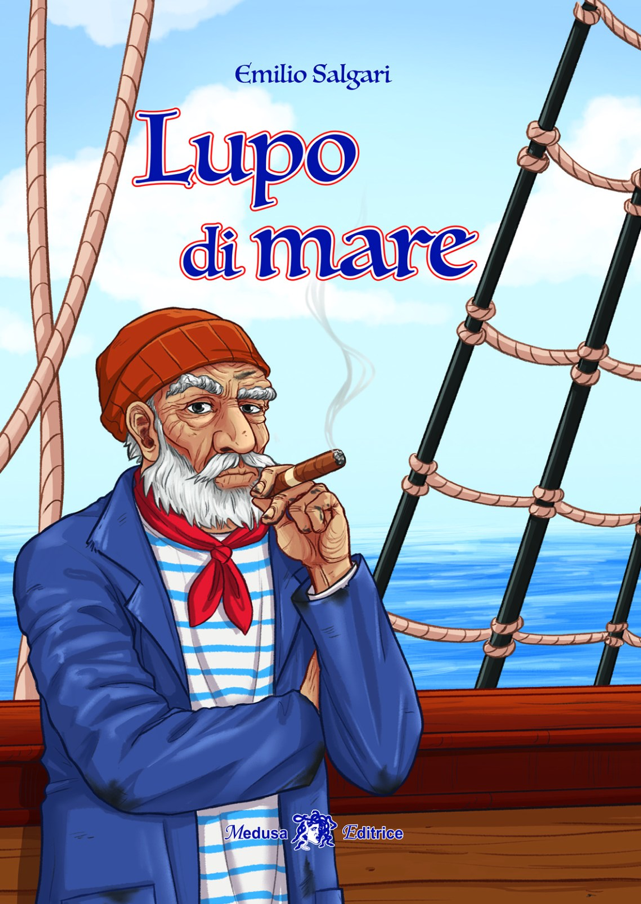RICORDO DEL COMANDANTE NUNZIO CATENA
RICORDO DEL COMANDANTE NUNZIO CATENA
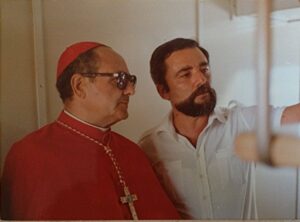
Care Amiche e cari Amici,
Purtroppo devo darvi una ferale notizia: è mancato il nostro carissimo Amico Comandante Nunzio CATENA di Ortona, socio della nostra Associazione insieme alle tre figlie da diciassette anni. Nunzio è salito in cielo alle 02,30 del 31 ottobre scorso nell’ospedale di Chieti dov’era ricoverato dal 26 ottobre per insufficienza respiratoria.
Come molti di voi sanno Nunzio, classe 1940, trascorse sulla carrozzella gli ultimi 29 anni della sua vita terrena a causa di un incidente che lo colpì il 28 luglio 1993. Nunzio ha resistito stoicamente a questa tragedia per tutti questi anni dedicando le sue forze residue alla moglie Marilena anch’essa malata da trent’anni. La loro vita, se così si può chiamare, è paragonabile soltanto al CALVARIO patito da Gesù Cristo.
In questo tragitto di estrema sofferenza, questi due SANTI VIVENTI hanno avuto soltanto un GRANDE dono dal destino: TRE FIGLIE MERAVIGLIOSE, Marina, Selene e Martina.
In questo momento ci uniamo a loro e a Marilena sentendoci uniti dallo stesso dolore.
Con questo manifesto funebre MARE NOSTRUM RAPALLO ha voluto salutarlo per l’ultima volta nella sua amata Ortona:
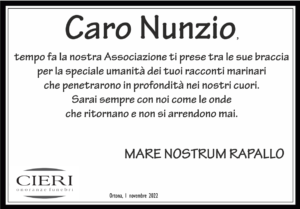

RICORDO DI NUNZIO CATENA

Da sinistra: Marina, Nunzio, Selene e Marilena
Nunzio era dotato di una intelligenza non comune che insieme ad un sense of humor straordinario lo rendevano un personaggio simpatico ed autoironico di grande spessore umano.

Nunzio e Martina
UN RICORDO INDELEBILE

Il REX conquistò il “Nastro Azzurro” nell’Agosto del 1933 ad una velocità media di crociera di 28,92 nodi, strappando il record detenuto dal transatlantico tedesco Bremen. Il 10 Agosto 1933 la nave salpò da Genova alla volta di New York comandata dal lericino Francesco Tarabotto. Percorse il tragitto da Gibilterra al Faro di Ambrose (3.181 miglia) in 4 giorni, 13 ore e 58 minuti. A bordo numerosi erano i lericini.
Per festeggiare gli 80 Anni di quella mitica impresa, Lerici dedicò gran parte del 2013 a molti eventi importanti: Una grande mostra di cimeli di Transatlantici con pezzi originali e di pregio; un convegno con i massimi esperti sui Transatlantici; coinvolgimento delle scuole; tavole rotonde; regata d’altura; spettacoli a tema; i Grandi Chef e l’alta cucina; la V edizione di “Lerici Legge il Mare” incentrata sul Rex e transatlantici.
Per l’organizzazione di quella grande FESTA ligure, fu chiesta la partecipazione di non pochi esponenti di Mare Nostrum Rapallo che fu la prima Associazione che iniziò le celebrazioni dedicando a quel mitico viaggio del REX l’annuale MOSTRA al Castello cinquecentesco riportata nel manifesto qui sotto. Era l’ottobre del 2012. In quella occasione, voglio ricordare l’operato di Nanni che diede TANTO in fatto di esperienza e reperti museali.
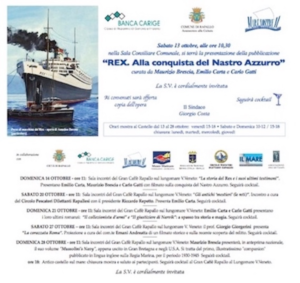
Durante il CLOU della manifestazione, in una splendida serata estiva che vedeva sullo sfondo il Castello di Lerici apparve, per un’improvvisa magia, la gigantesca sagoma luminosa del REX proiettata sul vecchio maniero.
Dinanzi alla platea di un migliaio di persone, parlai del Comandante del REX, il lericino Francesco Tarabotto il quale, durante il periodo bellico, si era trasferito nel mio quartiere di S. Agostino a Rapallo.
Conclusi il mio intervento con la lettura del saggio:
U FUNTANN-A… ERA STATO FUOCHISTA SUL REX
del Com.te Nunzio Catena che commosse non pochi spettatori meritando una “standing ovation”.
GLI SCRITTI DI NUNZIO CATENA
… Da SAGGISTICA NAVALE / Mare Nostrum Rapallo
U FUNTANN-A… ERA STATO FUOCHISTA SUL REX
https://www.marenostrumrapallo.it/nunzio/
OSSO DI SEPPIA
file:///Users/carlogatti/Desktop/OSSO%20DI%20SEPPIA%20–%20MARE%20NOSTRUM.webarchive
IL FERROVIERE CHE GUARDAVA VERSO IL MARE
https://www.marenostrumrapallo.it/rocco/
ATTENTI A QUEI DUE
https://www.marenostrumrapallo.it/terry/
IL REZZAGLIO DEL MIO AMICO “COCOLA”
https://www.marenostrumrapallo.it/coco/
GIA’, AVEVO UN BEL FIATO …
https://www.marenostrumrapallo.it/nunzio-2/
NEL PIENO DELLA TEMPESTA
https://www.marenostrumrapallo.it/ricordi-di-guerra/
ANNI ’60 – RICORDI DI BORDO E DINTORNI…
https://www.marenostrumrapallo.it/ricordi/
MOSCIAMME
https://www.marenostrumrapallo.it/mosciamme/
… DA STORIA NAVALE/Mare Nostrum Rapallo
ITALNAVI SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE - GENOVA
https://www.marenostrumrapallo.it/italnavi/
Colgo l’occasione per essere ancora una volta spiritualmente accanto al mio fraterno AMICO NUNZIO con un articolo dedicato al Com.te Francesco TARABOTTO che ho spesso citato sopra...
Francesco Tarabotto, il Comandante del REX, sfollato a Rapallo nella Seconda guerra mondiale.
https://www.marenostrumrapallo.it/tarabotto-il-comandante-del-rex/

IL GIGLIO DI MARE ora cresce anche nel mio giardino di Rapallo. Quattro anni fa Marina m’inviò da Ortona i bulbi di questo “raro” fiore delle dune sabbiose che vive solo 24 ore, poi muore e risorge ogni anno nel mese di luglio. Quest’anno ne sono fioriti 35 ed aumentano sempre.
Il GIGLIO DI MARE
https://www.marenostrumrapallo.it/pancratos/
di Carlo Gatti – Rapallo Arte
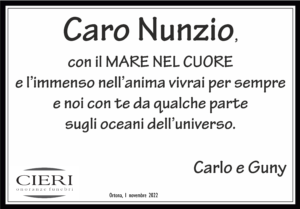
Ciao Nunzio – R.I.P – Alle 08 di ogni mattina che verrà penserò a te e tu sai perché!
Carlo e Guny
Carlo GATTI
Rapallo, 25 Novembre 2022
ROMA - LA FONTANA DELLA BARCACCIA
ROMA
„Sì, posso dire che solamente a Roma ho sentito che cosa voglia dire essere un uomo. Non sono mai più ritornato a uno stato d'animo così elevato, né a una tale felicità di sentire. Confrontando il mio stato d'animo di quando ero a Roma, non sono stato, da allora, mai più felice.“
Johann.Wolfgang.von.Goethe
FONTANA DELLA BARCACCIA
Immersa nella fontana omonima, il nome barcaccia è già di per sé un programma … poiché non era proprio una bella imbarcazione, anzi era piuttosto tozza e possente proprio come una barca da lavoro che era per certi versi simile ad un rimorchiatore laborioso ed instancabile del secolo scorso.
Un breve inciso:

Quando fui assunto dalla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova, la prima cosa che imparai salendo a bordo del M/r BRASILE fu davvero sorprendente: non si chiamava “rimorchiatore” ma BARCACCIA per i furesti, BARCASSA per i genovesi: un nome particolare che avevo ignorato fino a quel momento. Mi suonava “strano” soprattutto perché il BRASILE era stato varato da pochi anni ed aveva una linea molto elegante che le conferiva il primato di “primadonna” tra una sessantina di “mastini” molti dei quali meritavano il nome di “gloriosa barcaccia”.
Non era un termine dispregiativo, ma piuttosto la reminiscenza storica di un “barcacciante”, (uomo di rimorchiatore, esperto nelle manovre navali portuali, che sa come aiutare una nave in difficoltà), che era stato a Roma per turismo e dopo aver visto LA FONTANA DELLA BARCACCIA, ritornò a Genova per diffondere un nuovo termine marinaro che testimoniasse la gloriosa discendenza del “gruppo RR genovese” dai navigatori portuali tiberini i quali, come i loro antichi predecessori romani, trasportavano le merci dal porto “marittimo” di Traiano a quello fluviale di Ripetta nel centro di Roma.
Si parla della FONTANA DELLA BARCACCIA come di uno dei luoghi più fotografati di Roma, sarà per la presenza di Piazza di Spagna che si trova ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, sarà per il rituale di bere un sorso d’acqua, ma forse perché la Barcaccia è uno dei piccoli grandi capolavori di Roma.
L'opera fu costruita al livello del suolo per compensare la poca pressione dell'acquedotto dell'Acqua Vergine che in quel punto era molto bassa. Sulla parte esterna della prua e della poppa sono due grandi stemmi di Urbano VIII con tre api, simbolo della famiglia Barberini; ai lati degli stemmi l’acqua esce da finte bocche di cannone. Nella parte interna vi sono invece due soli con volto umano, altro emblema dei Barberini, dalle cui bocche esce l’acqua, raccolta da volute che la incanalano verso l’esterno. Al centro, da una vasca, esce un altro grosso zampillo d’acqua.
FONTE: Anna Maria Cerioni



L’insolita vasca a forma di barca riceve l’acqua versata da un catino centrale allungato e da due grandi soli, posti internamente a prua e poppa dello scafo. Dai lati, realizzati in modo da dare la percezione che la barca stia affondando, l’acqua trabocca nell’ampio bacino sottostante, in cui, delle bocchette di finte cannoniere, sui lati esterni a prua e poppa, versano zampilli d’acqua, incorniciando gli stemmi papali con le tre api, simbolo della famiglia Barberini.
Tra le diverse interpretazioni che riguardano la fontana della BARCACCIA di piazza di Spagna, ne segnaliamo due che hanno antiche tradizioni popolari. La prima ci racconta come la particolare forma della “fontana della Barcaccia” deriverebbe dalla presenza nella piazza di una barca in secca giunta lì a causa della piena del Tevere del 1598.
L’altra ipotesi parte ancora da più lontano e riporta che sul posto vi si svolgesse una naumachia che nell’Antica Roma era uno spettacolo direi “teatrale” che rappresentava una storica battaglia navale del passato.

Per l’inaugurazione del tempio di Marte Ultore (Marte Vendicatore), Augusto diede una naumachia che riproduceva fedelmente quella di Cesare. Come ricorda egli stesso nelle Res gestae, fece scavare sulla riva destra del Tevere, nel luogo denominato “bosco dei cesari” (nemus Caesarum), un bacino dove s’affrontarono 3.000 uomini, senza contare i rematori, su 30 vascelli con rostri e molte unità più piccole.
Riferimento: due LINK di Carlo GATTI
LE NAUMACHIE PIU’ FAMOSE DELLA STORIA
https://www.marenostrumrapallo.it/nau/
STORIA DELLA NAUMACHIA
https://www.marenostrumrapallo.it/machi-2/
Infine, in base allo shape stesso della “Barcaccia”, con le sue murate basse e larghe, non è da escludere la teoria che, nel mondo romano, la barcaccia fosse semplicemente un’imbarcazione, che risaliva il Tevere fino al vicino porto di Ripetta, ed era adibita al trasporto fluviale dei barili di vino provenienti dalle province romane del Mare Nostrum.

La fontana della Barcaccia, collocata al centro di piazza di Spagna fu commissionata da Papa Urbano VIII Barberini (1623-1644) il quale mise in atto un progetto del 1570, relativo alla costruzione di fontane pubbliche nelle piazze principali di Roma attraversate dall’antico Acquedotto Vergine ristrutturato.
Fonte: Romano Impero: La fontana fu commissionata a Pietro Bernini architetto dell’Acqua Vergine dal 1623 e padre del più celebre Gian Lorenzo (1598-1680) con il quale non è da escludere vi sia stata una collaborazione.
Autore: Pietro Bernini - (1562-1629)
Datazione: 1626-1629
Materiali: travertino
Alimentazione originaria: Acquedotto Vergine
Le fontane di Roma dimostrano come i romani abbiano sempre avuto una gran passione per le acque pubbliche, dagli acquedotti alle terme e come, dopo i secoli della decadenza, tale passione si sia affermata nella costruzione delle numerose fontane (oltre 2.000) che ancora oggi ornano vie e piazze romane.

Scalinata di Trinità dei Monti
https://sovraintendenzaroma.it
La Scalinata di Trinità dei Monti, realizzata tra il 1723 e il 1726 su progetto dell’architetto romano Francesco De Sanctis (1693-1740), costituisce il raccordo scenografico tra le pendici del Pincio dominate dalla chiesa della SS. Trinità e la sottostante piazza di Spagna.
L’idea di superare il forte dislivello con una scalea è documentata già nel 1559. Venti anni dopo la Camera Apostolica acquistò il terreno ai piedi della chiesa per realizzare la scalinata che negli intenti di papa Gregorio XIII (1572-1585) doveva essere “simile a quella dell’Aracœli”. Solo nel 1660, grazie al lascito del francese Stefano Gueffier, furono redatti i primi progetti da parte di numerosi architetti: è di questo periodo quello attribuito alla bottega di Gian Lorenzo Bernini, fondamentale per la successiva progettazione in quanto propose l’andamento concavo e convesso delle pareti e le rampe a tenaglia. Sorse allora l’annosa controversia tra lo Stato della Chiesa e la corona di Francia sul possesso dell’area interessata, che costituì una delle cause del mancato avvio dei lavori.
Nel 1717, infine, Clemente XI bandì un concorso per il progetto a cui parteciparono i maggiori architetti del tempo. I lavori, sempre a causa della citata controversia, iniziarono solo sotto Innocenzo XIII (le aquile araldiche della sua casata - Conti - compaiono, insieme ai gigli di Francia, sui cippi alla base del monumento), e furono ultimati da Benedetto XIII nel 1726.
La lunga scalinata, che sembra adagiarsi sul colle articolandosi in un continuo alternarsi di sporgenze e rientranze, è espressione di una monumentalità tipica del settecento romano che la accomuna alle altre importanti realizzazione urbane del secolo costituite dal porto di Ripetta (demolito alla fine del XIX secolo) e da fontana di Trevi.
Sottoposta nel tempo a numerosi interventi di manutenzione, la scalinata è stata oggetto di un importante restauro completo nel 1995.
Dall'ottobre 2015 la scalinata è stata sottoposta nuovamente a restauro; l’inaugurazione dopo i lavori si è svolta giovedì 22 settembre 2016 (maggiori informazioni sul restauro)
Dal 23 settembre 2016 la scalinata ridiviene normalmente percorribile.
IN ETA' IMPERIALE
Augusto e in particolare Tiberio, si impegnarono per pulire gli argini dai detriti e impedire che si costruisse sulle rive del Tevere per evitare danni quando il fiume si innalzava; in pratica venne istituito un piano regolatore che impediva ai privati di costruire vicino agli argini e tutte le case costruite abusivamente venivano distrutte.
Possiamo solo constatare che l’abusivismo edilizio è una malattia endemica della nostra etnia latina che viene da lontano…
L’ANTICO PORTO DI RIPETTA

Il porto di Ripetta, così detto per distinguerlo da quello di Ripa Grande dopo l'Isola Tiberina, non esiste più: con i lavori di costruzione dei muraglioni è stato sepolto sotto il Lungotevere in Augusta che costeggia l'Ara Pacis, il mausoleo di Augusto imperatore, e le due chiese attigue: San Rocco, dedicata agli osti che qui ricevevano i rifornimenti di vino, e San Girolamo degli Schiavoni. Proprio davanti a quest'ultima si trovava l'approdo, che ebbe una sistemazione architettonica solo nel Settecento, quando si poterono utilizzare le lastre di travertino del Colosseo cadute a causa di un crollo. L'opera, voluta da Clemente XI, fu affidata ad Alessandro Specchi nel 1705, che realizzò una raffinata scalinata digradante verso il fiume. Il porto era decorato con una fontana che serviva anche da faro, sormontata da una lanterna a forma di stella, simbolo araldico della famiglia di papa Clemente, gli Albani. La fontana era circondata da una balaustra e le due colonne, erette alle estremità, fungevano da 'idròmetri' e vi si segnava il livello del Tevere quando straripava. La fontana, unico elemento del porto rimasto, si trova oggi poco lontano, in un giardinetto presso ponte Cavour sulla sinistra del fiume, in vista di Palazzo Borghese. Tra le memorie del porto di Ripetta, toccante è quella di San Camillo: giovane scapestrato, lavorava come inserviente nel vicino ospedale di San Giacomo al Corso, per ripagare le cure che gli avevano guarito una piaga alla gamba. In quel periodo, andava spesso a giocare a carte con i "barcaroli" di porto Ripetta. Anni dopo si convertì e divenne il "padre dei poveri", fondatore dell'ordine dei Camilliani, dediti ad alleviare fame e miseria. Come ogni grande città, Roma richiamava folle di mendicanti e diseredati. All'epoca di Camillo il numero degli 'straccioni' si era fatto incalcolabile e capitava periodicamente che un bando ne decretasse l'espulsione. Così Camillo s'imbatté un giorno in una carovana di miserabili diretta al porto di Ripetta per l'imbarco. Camillo tentò di tutto per fermare la triste partenza, ma gli sbirri erano irremovibili. S'inginocchiò e scongiurò di dargli almeno i due più malmessi. L'accorata petizione toccò il comandante delle guardie che, commosso, acconsentì. Il santo scelse i due più vicini alla morte e li portò sulla riva del fiume, dove a lungo e ad alta voce li consolò e pregò che potessero concludere i loro giorni in grazia di Dio.
Dove siamo?
Come potete vedere dalla mappa, non ci siamo allontanati granché dalla BARCACCIA.
In questo modo potrete scoprire anche il Porto di Ripetta all’epoca del Bernini.
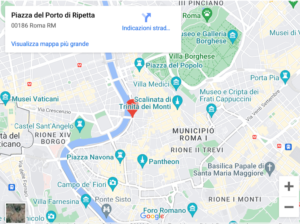
Da GUIDE DI ROMA:
Quando, nei primissimi anni del Settecento, si pose mano alla realizzazione dell’approdo monumentale, si trovarono sotto le melme della riva le tracce degli antichi attracchi: la Roma Antica, in epoca imperiale, utilizzava infatti talmente tanto intensamente il fiume Tevere che quasi tutte le rive dello stesso erano affiancate da banchine adatte all’approdo dei natanti (che alcuni studiosi sostengono si svolgessero ininterrottamente dal Campo Marzio fino al Testaccio).
Fu la costruzione delle mura difensive di Aureliano alla fine del III secolo d.C. che, anticipando in qualche modo l’effetto moderno dei muraglioni, distaccò gran parte della città dal fiume: un lungo muro intervallato da piccole torri si distese infatti a quel punto dall’altezza della Porta Flaminia (la nostra porta del Popolo) fino al Ponte di Aureliano (più o meno all’altezza di Ponte Sisto).
Queste mura sul fiume furono tuttavia rese permeabili ad un certo traffico mediante l’apertura di alcune posterule: una di queste venne a trovarsi all’altezza dell’attuale Chiesa di San Rocco. Da lì, attraverso i giardini del Mausoleo di Augusto, si raggiungevano le zone edificate del Campo Marzio fin sotto le pendici, estese dal colle Quirinale al Pincio e lussureggianti di fastose dimore gentilizie.

Abbiamo scelto alcuni dipinti d’epoca che rappresentano momenti di vita fluviale quotidiana:


Battelli a vapore con ruota a pale sul TEVERE
Una visione comune in tutto l'ottocento e primi del novecento, i piroscafi erano un modo efficiente ed elegante per il trasporto di merci e di persone.
Il porto, prima dei Ponti
Lo scalo di Ripetta, con un movimento minore rispetto a quello di Ripa Grande, accoglieva il traffico fluviale proveniente da monte e serviva allo smercio dei carichi diretti al centro di Roma. Vi ancoravano, partiti da Orte e da Terni, i barconi carichi di legna, carbonella e grano, portando quei vini leggeri e comuni che il Belli e con lui i Romani chiamavano “l’acquaticci de Ripetta”.


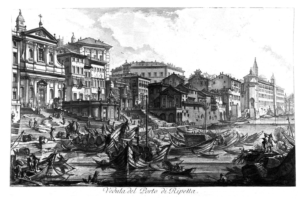
Incisione di Giovanni Battista Piranesi (ca.1750)
Il porto Clementino, detto comunemente “di Ripetta” per distinguerlo da quello maggiore di Ripa Grande, fu sistemato da papa Clemente XI, donde il nome. In effetti, in una delle numerose posterule delle “Mura Aureliane” (che allora correvano ancora dall’antico “ponte Aureliano” fino all’altezza di “porta Flaminia”) si era venuto a formare, già dal XIV secolo, un piccolo, rudimentale porticciolo “abusivo”, pressappoco all’altezza della chiesa di S.Rocco, per lo scarico di legname, carbone e vino. Nel 1704 papa Albani, Clemente XI, approvò la proposta del suo presidente delle strade per la creazione di un sistema di banchine, scalinate e piazzale superiore, un progetto, cioè, che prevedeva la sicurezza e la facilità di approdo di un porto unito alla bellezza ed alla gradevolezza di un monumento.
L’arrivo del sale a Roma in un dipinto di Gaspar Van Wittel


Il porto di Ripetta in un’incisione di Ettore Roesler Franz del 1880. Si intravede appena, sulla destra, seminascosto dalla scalinata, lo zampillo della fontana.

Piazza del Porto di Ripetta. La fontana del porto e la sua lanterna, fondamentale per l'approdo notturno (foto Marco Gradozzi).

Piazza del Porto di Ripetta. Una delle due colonne su cui furono incisi i livelli raggiunti dal fiume durante le inondazioni più celebri (foto Marco Gradozzi).
Abbiamo dato un breve sguardo panoramico sul movimento portuale di RIPETTA che ci ha permesso di intravedere sulle sponde del fiume dettagli architettonici interessanti, ma anche le linee delle imbarcazioni tipiche della Roma del ‘600, quelle che percorrevano il Tevere con le derrate alimentari ed avevano i bordi molto bassi per facilitare il ruzzolare delle cisterne e le botti del vino.
Concludiamo con l’immagine del Ponte Rotto, icona della esondazione del Tevere nel 1598 che non fu mai più ricostruito. La BARCACCIA che ispirò il Bernini… sarebbe stata trascinata da quella devastante piena del Tevere fino ai piedi di Trinità de’ Monti dove si sarebbe incagliata.
Il PONTE ROTTO
(detto anche Ponte maledetto)

La metà del ponte rimasta in piedi, ancorata alla riva destra, fu trasformata in giardino pensile, una sorta di balcone fiorito sul fiume che restò tale fino alla fine del Settecento, quando la precaria stabilità del ponte lo rese del tutto inagibile.
Nel 1853, le nuove tecnologie industriali, con un progetto dell'ing. Pietro Lanciani, restituirono vita al ponte con una passerella metallica, che venne costruita per colmare la parte mancante del rudere. Dopo oltre 300 anni il ponte riprese a collegare le due rive opposte e poté essere nuovamente attraversato. Tale soluzione durò fino al 1887, quando fu decretato l'abbattimento della passerella e la creazione del nuovo e adiacente Ponte Palatino.
Carlo GATTI
Rapallo, 4 settembre 2022
GUERRA E PACE ... AD ALLEGREZZE
GUERRA E PACE…. AD ALLEGREZZE
Fu un Agosto di sangue quello del 1944 in Val d’Aveto (GE). Siamo nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale e i nazisti sono in ritirata dietro la linea Gotica dopo un anno dalla caduta del fascismo, con la collaborazione di delatori in camicia nera al servizio di Mussolini e della Repubblica Sociale di Salò.


Di giorno il marittimo ligure è occupato a tener d’occhio il mare, la nave ed il carico, ma quando riposa sogna i verdi campi, le vallate e spesso addirittura le montagne. Chi ha navigato lo sa, e quando ritorna a casa porta la famiglia a villeggiare in Trentino oppure in Val D’Aosta. Il perché di questa “transumanza” non la conosco, ma forse si tratta del desiderio di uno “stacco” geo-climatico che, tuttavia, dopo una settimana trascorsa tra le mucche scompare per fare posto nuovamente ai sogni di mare.
Fu così che dopo aver scoperto il Trentino e la Val d’Aosta c’innamorammo perdutamente della nostra più vicina Val D’Aveto, dei loro valligiani, delle loro storie e delle tante gite che dal Passo del Tomarlo si potevano fare nei dintorni: Bobbio, il Penice, Grazzano Visconti, Compiano, Bardi alla scoperta d’incantevoli borghi medievali e persino quelli “antico-romani” a Velleia.
Il destino volle che nel 1978 “gettassimo l’ancora” a 920 metri d’altezza, qualche chilometro prima di Santo Stefano D’Aveto, precisamente ad Allegrezze, un borgo di poche case che tuttavia aveva una scuola elementare, un piccolo Ufficio Postale, un negozietto di generi alimentari, un tabacchino ed una vista mozzafiato che va dal Monte Penna all’Antola da cui scendono ripoidi versanti verso il Tigullio ed il golfo Paradiso.
Nella casa attigua alla nostra abitavano i fratelli e le sorelle di ALBINO BADINELLI. Persone umili, sempre disponibili, religiosissimi con i quali ci siamo ben presto sentiti come un’unica famiglia.
Fu così che piano piano venimmo a conoscenza di ciò che accadde a quella sfortunata famiglia e all’intera comunità che si trovò, durante la Seconda guerra mondiale, in un autentico ciclone che ora cercherò di raccontare.
ALBINO BADINELLI
1920 - 1944
UN EROE IN ODORE DI SANTITA’
Il carabiniere che si costituì ai nazifascisti per salvare 20 ostaggi e l'intero paese dalla rappresaglia
Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

La chiesa di Santa Maria Assunta sorge in località Allegrezze di Santo Stefano D'Aveto, isolata, con orientamento Est-Ovest, preceduta da un ampio sagrato, lastricato in pietra, chiuso sul lato destro da un basso muretto, in pietra. La facciata a salienti, in pietra a vista è rinserrata agli angoli da cantonali in conci di pietra posti a risega. Al centro si apre il portale, rettangolare, con stipiti e architrave, modanati, in arenaria. Il portale è coronato da una cornice, in aggetto, su mensole a voluta, in pietra. Al di sopra del portale si apre una piccola nicchia a tutto sesto che accoglie la statua, in pietra, della Madonna Assunta. In alto, centrale, si apre il rosone circolare. I fronti laterali, nella parte alta sono forati da quattro monofore a tutto sesto, per lato. La parte bassa del fronte sinistro, corrispondente alla parete della navata minore, presenta una monofora a tutto sesto. Al fronte destro si addossa la Canonica. Al fronte sinistro, sul retro si addossa un edificio parrocchiale. Sul retro l'abside semicircolare è forato ai lati da due larghe monofore a tutto sesto. All'abside si addossa, sul retro, un volume, in leggero aggetto, con fronte a capanna, con rosone che si apre al centro del timpano. Il campanile sorge isolato a sinistra della chiesa. In pietra a vista, a pianta quadrata, su due ordini, separati da una leggera cornice marcapiano, con fronti decorati a specchi rettangolari, strombati, ad angoli smussati, termina con una cella con lesene d'angolo doriche che reggono una trabeazione curvilinea in aggetto. La cella è forata sui quattro lati da alte monofore a tuto sesto e sormontata da un tamburo ottagonale, forato su quattro lati da monofore a tutto sesto e coperto da tetto a guglia piramidale, con manto in lamiera.

L’esterno e l’interno della chiesa di Allegrezze

Eretta parrocchia nel X secolo, i primi documenti sulla locale chiesa di Allegrezze risalgono al 1287 quando un cartario del monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia accertò la presenza di una cappella dedicata alla Vergine Maria.
Dipendente fino alla metà del XVI secolo dal monastero pavese fu in seguito aggregata alla pieve di Ottone in val Trebbia, in occasione della visita pastorale di monsignor Maffeo Gambara vescovo della diocesi di Tortona.
L'interno dell'edificio è diviso da colonne in ardesia - denominata anche "pietra nera" - e conserva sul muro della vasca battesimale un affresco raffigurante il Battesimo di Gesù di pittore sconosciuto, ma forse risalente al Cinquecento.
Negli anni della Seconda guerra mondiale l’artista Italo PRIMI, nato a Rapallo nel 1903 e spentosi nel 1983, da sfollato ad Allegrezze, dedicò il suo tempo alla cura architettonica e artistica della chiesa di Allegrezze riportando alla luce tesori d’arte come le colonne originali in pietra nera (ardesia) della navata centrale che erano ricoperte da comune materiale edilizio e naturalmente valorizzando altre opere importanti già esistenti.
Italo PRIMI era un artista a tutto tondo: scultore, pittore, creatore di forme e oggetti. Stimato scultore, appassionato pittore, abile decoratore e uomo legato alla sua famiglia e alla sua terra, non ha mai smesso di coltivare la sua passione per l’arte. Artista vivace e aperto a nuove sperimentazioni, ma anche uomo riservato e incline alla solitudine.
All’epoca quel piccolo angolo di mondo girava intorno alla sua chiesa, un antico santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, da cui il nome Allegrezze. Il suo altissimo campanile è visibile dappertutto ed è tuttora il punto di riferimento della religiosità molto sentita dalle comunità montane di quel comprensorio. Il borgo si anima d’estate con la presenza di famiglie rivierasche attirate dalla posizione dominante alla quale si accede dalla costa attraverso i Passi della Forcella (875 mt.s.l.m.) o della Scoglina (926 mt.s.l.m.)
Negli anni ’80-‘90 la maggior parte dei giovani residenti abbandonarono i campi e le stalle e si trasferirono nelle grandi città in cerca di lavoro. Oggi si assiste ad un ritorno al passato molto promettente che vede alcune iniziative famigliari dedite non solo alla produzione di latte ma anche dei suoi derivati: formaggi tradizionali della vallata, e persino yogurt che sono molto richiesti per la loro fragranza.
Non hanno più riaperto il negozio d'alimentari e gli altri esercizi cui accennavo perché le anime di questo paese non raggiungono il numero di 25 e, sia i pochi residenti che i turisti, sono ormai motorizzati e raggiungono in pochi minuti il vicino comune di Santo Stefano. Le mucche sono 35, il numero è proporzionate al terreno di pascolo dei proprietari.
A questo punto vi chiederete: “ma perché Carlo ci ha portato fin quassù dopo averci abituato ai settimanali viaggi di mare … ?”
Innanzitutto, dopo questa estate infuocata, penso che una gita da queste parti vi possa solo giovare… dal punto di vista climatico e non solo… ma il vero motivo è un altro, ed è giunto il momento d’entrare in argomento.
QUADRO STORICO
Dopo lo sbarco in Sicilia degli Alleati e la caduta del fascismo il nuovo governo italiano tratta con gli Alleati per uscire dalla guerra. I tedeschi capiscono quello che sta per accadere e danno il via all’Operazione Alarico, con cui mandano consistenti truppe nella penisola. Mentre le trattative per l’armistizio vanno avanti tra ambiguità e tentennamenti da parte italiana, i nostri vertici militari si preparano al mutare degli eventi. In un documento: la Memoria Op 44, si danno disposizioni su come reagire alla probabile rappresaglia tedesca dopo l’armistizio, e si indicano chiaramente i nostri ex alleati come il nuovo nemico. Nonostante tutto, l’8 settembre ‘43 coglie il governo impreparato. Gli ordini non vengono diramati, i vertici dello Stato e delle forze armate abbandonano la capitale e lasciano i comandi territoriali, in Italia e all’estero, privi di indicazioni. Molti decidono di combattere, ma vengono presto sopraffatti dai tedeschi, che in poco tempo catturano un milione di militari italiani, la maggior parte dei quali viene condotto in prigionia nei lager di Germania e Polonia.
I Carabinieri sono tra i pochi militari che rimangono al loro posto, in virtù delle funzioni di polizia che devono svolgere e grazie alla loro presenza capillare sul territorio. In quei giorni concitati, a Torrimpietra, una località a 30 chilometri da Roma, un'esplosione causata incidentalmente da un gruppo di paracadutisti tedeschi durante un'ispezione, viene fatta passare per un attentato. I tedeschi rastrellano per rappresaglia 22 civili, destinandoli alla fucilazione. Il vicebrigadiere dei carabinieri SALVO D’ACQUISTO, di stanza in caserma, si autoaccusa dell'atto e sacrifica la propria vita per salvare quella degli ostaggi. Medaglia d'oro al valor militare, Salvo D'Acquisto diventa il simbolo della dedizione e dello spirito di sacrificio dell'Arma e il suo gesto non rimarrà isolato. Durante i venti mesi di occupazione tedesca, infatti, altri carabinieri daranno la vita per proteggere le popolazioni civili, oppure supporteranno la Resistenza e la lotta di liberazione.
Nella Val D’Aveto. Un anno dopo!
ALBINO BADINELLI (6.marzo 1920- 2.settembre 1944)
il carabiniere che si costituì ai nazifascisti per salvare 20 ostaggi e l'intero paese dalla rappresaglia.
La strada che taglia l’abitato di Allegrezze porta il nome di questo giovane carabiniere: Albino Badinelli che testimonia al passante un gesto di amore ed altruismo infiniti nel dare la propria vita per salvare quella di 20 civili avetani presi a caso e destinati alla fucilazione quali vittime di un’infame rappresaglia decisa dal comando nazifascista di Santo Stefano D’Aveto per vendicare alcuni militari caduti tra i reparti della Monterosa.
La Monterosa fu una delle unità militari create durante la Repubblica Sociale Italiana dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, nonché una delle più importanti che combatterono sotto le insegne del Fascismo repubblicano. La divisione, composta da circa 20.000 uomini era stata addestrata in Germania e quando tornò in Italia fu impiegata a ridosso delle Alpi Apuane e dell’Appenino Tosco-Emiliano ed anche nella Val D’Aveto.

ALBINO BADINELLI in alta uniforme
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15, 13).
Davanti al plotone di esecuzione, come Gesù in croce, Albino disse: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Un perdono che nasceva da una fede nutrita in famiglia, fin dall’infanzia. E la Chiesa guarda con crescente interesse alla sua figura.
Settimo di 11 figli di Caterina e Vittorio, contadini, Albino nasce ad Allegrezze, frazione del paesino ligure di Santo Stefano d’Aveto. Fin da piccolo, quando non è impegnato con la scuola, aiuta la famiglia nei campi. La sera, per genitori e figli, è consueta la recita del Rosario attorno al focolare. Albino porterà sempre con sé la devozione per la Madonna coltivata tra le mura domestiche ed espressa anche con il custodire, nelle sue tasche, la coroncina del Santo Rosario.
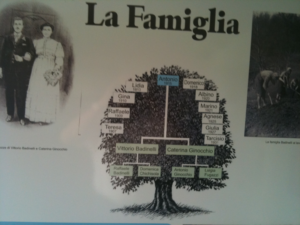
Il giovane carabiniere di Allegrezze, dopo l'8 settembre 1943, privo di comando nella Caserma di S. Maria del Taro a cui era stato assegnato, torna presso la famiglia di origine che cerca in tutti i modi di aiutare con il suo lavoro nei campi e nella ricerca del fratello disperso in Russia.
Nell’agosto 1944 diversi scontri tra partigiani e nazifascisti mettono a ferro e fuoco i paesi del circondario. Per contrastare gli attacchi della Resistenza, il comandante della Divisione Monte Rosa (maggiore Cadelo) minaccia di incendiare S. Stefano d’Aveto e di uccidere 20 ostaggi se i partigiani e gli sbandati non si presenteranno al Comando. Poiché nessuno si costituisce, terrorizzato dall’idea che venti innocenti possano essere trucidati, Albino si presenta il 2 settembre in caserma accompagnato dalla madre, invocando moderazione e pace. Viene invece immediatamente condotto davanti al plotone d’esecuzione presso il Cimitero del borgo attiguo alla chiesa, dove confida al sacerdote, un attimo prima di essere fucilato, la volontà di perdonare i suoi carnefici.
Segnalato da Tommaso Mazza, pronipote. Candidatura proposta per il Monte Stella nel 2016
Desidero a questo punto aggiungere alcune testimonianze, rese a chi scrive, dal fratello Antonio (Tony) e da sua moglie Augusta durante i lunghi pomeriggi trascorsi insieme.
“Le sue giornate passavano tra casa, campagna e chiesa. Albino leggeva molto e studiava sempre, era il più intelligente di tutti noi. Fin da bambino aveva dimostrato un forte senso religioso, intriso di profondi valori cristiani: umanità, generosità, carità, bontà d’animo e spirito di servizio. Albino era profondamente radicato nelle tradizioni religiose proprie della nostra montagna.
Albino aveva una bella voce, ed il suo canto aggiungeva solennità alle celebrazioni liturgiche in occasione delle festività, e anche quando poteva ogni mattina alle messe feriali, mentre nel tempo libero si dedicava a disegni artistici.
Diventare carabiniere era il suo sogno fin da bambino. Nel 1939 entrò all’Accademia Militare di Torino. Ai primi di marzo del 1940 venne incorporato, quale Carabiniere Ausiliario a piedi, presso la Legione Allievi Carabinieri di Roma, con la ferma ordinanza di leva di mesi 18.
Nominato Carabiniere il 10 giugno dello stesso anno, fu trasferito alla Legione di Messina il 14 successivo, per poi prestare servizio nella cittadina di Scicli. Il 2 maggio 1941 è assegnato alla Legione di Napoli per il costituendo XX Battaglione Mobilitato e giunge in Balcania, territorio dichiarato in stato di guerra, il 21 settembre 1941.
Nei primi tempi Albino non se la passò male, almeno non come nostro fratello Marino che non tornò mai più dalla campagna di Russia. Tutto cambiò nel 1944 quando, dopo la distruzione della caserma in provincia di Parma dove prestava servizio, fu invitato a tornare a casa in attesa di ordini. Molti suoi colleghi in quei mesi passarono tra i partigiani. Lui era un animo pacifico, ma aiutava come poteva coloro che si erano dati alla macchia per non essere catturati e deportati.
Nell'estate del 1944 i partigiani uccidono cinque fascisti. Per rappresaglia, il comandante Cadelo della divisione Monterosa, “Caramella” era il soprannome che gli fu dato per il monocolo che gli copriva un occhio, fece diffondere un ultimatum terribile: se i partigiani non si fossero consegnati subito, avrebbe fatto fucilare tutti i civili, tra i quali c'erano anche donne e bambini, detenuti nella Casa Littoria del paese. In più avrebbe dato ordine di incendiare Santo Stefano, come già era stato fatto con alcuni paesi vicini. Di fronte a questa prospettiva, Albino prese la sua decisione:
“Prima che uccidano qualcuno, mi presento io. Altrimenti non avrei pace”
ci disse. “Noi eravamo tutti terrorizzati, ma pensavamo che al massimo l'avrebbero portato in Germania. E invece quando “Caramella” lo vide si mise a urlare:
"Tu sei un carabiniere! Il tuo dovere è catturare i disertori!”.
Albino provò a obiettare che lui voleva solo la pace, ma "Caramella" urlò ancora più forte:
“Altro che pace! Il plotone di esecuzione ti aspetta!”.
In una delle lettere di quel periodo, il 7 giugno 1942, scrive:
«Cara mamma, non posso descriverti tutta la poesia che mi suscitò nel cuore l’immagine di quella Madonnina alla quale vengono rivolte preghiere che non potranno non essere esaudite, essendo rivolte con tanta devozione dal cuore di una madre, che con ansia implora la protezione dei figli lontani... Siate sempre tranquilli, perché ovunque Ella stenderà il Suo manto sopra di noi, ne conserveremo la devozione».
Il 21 agosto successivo, in un’altra lettera, raccomanda ai familiari: «Rassegnatevi sempre al volere di Dio».
Nel biennio ’43-’44 la famiglia Badinelli è segnata prima dall’angoscia di non avere più notizie di uno dei fratelli di Albino, Marino, impegnato a combattere sul fronte russo, e poi dal dolore per la certezza della sua morte. Sarà san Pio da Pietrelcina - una delle persone a cui mamma Caterina aveva scritto - a far sapere alla famiglia di non cercare più Marino perché giaceva sepolto in una fossa comune in Russia. Circostanza che verrà confermata dal Ministero della Difesa negli anni Ottanta.
Nel ’43, Albino viene richiamato in Italia per prestare servizio a Santa Maria del Taro, piccola località in provincia di Parma. Il giovane carabiniere stringe amicizie profonde e non manca, nel suo piccolo, di evangelizzare. Testimonierà il collega Fabio Morelli, conosciuto durante l’esperienza lavorativa nel parmense: «Albino era una persona speciale, dotata di grande umanità e profonda religiosità. Andava ogni giorno a Messa nella chiesa parrocchiale e spesso ci invitava tutti a pregare il Rosario con lui. Era un grande esempio per noi che gli eravamo legatissimi […]».
LA GUERRA CIVILE
Ulteriori testimonianze
Dopo il Proclama Badoglio dell’8 settembre ‘43, che annuncia l’armistizio con gli Alleati, l’Italia si trova spaccata in due, tra nazifascisti e forze della Resistenza. Anche Albino sperimenta presto la durezza di quella guerra nella guerra, dove pure vecchi amici e familiari possono trovarsi su fronti opposti. Alcuni partigiani, siamo già nel ’44, attaccano la caserma di Santa Maria del Taro, devastandola con una bomba. Seguendo gli ordini di un superiore, Albino fa ritorno a casa, ma prima si libera del moschetto perché sconvolto dall’idea di potersene servire per uccidere dei fratelli.
Come abbiamo già visto, anche la Val d’Aveto non rimane estranea agli scontri tra “repubblichini” di Salò e "partigiani". È l’agosto del ’44 quando la Divisione nazifascista Monterosa entra in quei territori, incendiando le case in diversi borghi. Al suo comando c’è il maggiore Girolamo Cadelo, il quale ha diversi obiettivi: stanare i ribelli che infestavano quelle campagne, neutralizzare l’attività partigiana e rastrellare disertori e renitenti alla leva (in osservanza del decreto legislativo del Duce 18 febbraio 1944, n. 30:
“Pena capitale a carico di disertori o renitenti alla leva”)» [cfr. Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri, Anno II, n. 4, p. 93].
Nel giorno dell’ingresso a Santo Stefano d’Aveto, il 27 agosto, la Monterosa subisce un agguato partigiano, patendo alcune vittime. La frazione di Allegrezze, due giorni più tardi, viene incendiata dalle bande fasciste. Arriva quindi il 2 settembre. Il maggiore Cadelo e i suoi uomini hanno con sé una ventina di ostaggi. Dei manifesti, sparsi in tutto il territorio cittadino, invitano i giovani “sbandati” a presentarsi alla locale Casa del Fascio. In caso contrario, i prigionieri saranno uccisi e le case di Santo Stefano date alle fiamme. Pochi si consegnano e tra questi - pur non partecipando attivamente alla Resistenza - c’è Albino, che ai familiari aveva detto: «Devo presentarmi prima che venga ucciso qualcuno, perché non avrei più pace. Io devo essere il primo!».
Alla Casa del Fascio, Badinelli spiega a Cadelo di appartenere all’Arma e di volere la pace, ma il maggiore gli urla di aver mancato al dovere di catturare i disertori ed emette la sua ‘sentenza’: «Plotone di esecuzione!». Albino chiede a quel punto di potersi confessare, ma gli viene negato. Un giovane ha però la pietà di andare a chiamare monsignor Giuseppe Monteverde, un anziano sacerdote del posto, che accompagna Albino verso il luogo dell’esecuzione, il cimitero di S.Stefano D’Aveto, e ne raccoglie le ultime confidenze. Tra queste, c’è anche il perdono per coloro che di lì a breve saranno i suoi uccisori. Il buon sacerdote lo benedice, gli consegna un crocifisso e lo raccomanda alla Madonna di Guadalupe, molto venerata a Santo Stefano.

Chiesa parrocchiale di Santo Stefano - Santuario della Madonna di Guadalupe
Nell'edificio viene conservata un'immagine della Santa portata nel santuario nel 1804 dalla chiesa di San Pietro in Piacenza. Il santuario conserva dal 1811 anche una tela che raffigura la Vergine donata all'edificio dal cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphilj, segretario di Stato di papa Pio VII. Si narra che questa tela fosse sulle navi del suo antenato Andrea Doria nel 1571, durante la Battaglia di Lepanto. Il quadro, copia dell'immagine impressa sulla tilma, gli era stato donato all'ammiraglio dal re di Spagna Filippo II. La chiesa di stile gotico toscano fu ricostruita nel 1928 in sostituzione della vecchia settecentesca di cui rimane il campanile. L'altare maggiore espone ai lati del vecchio quadro due pale dedicate a Santo Stefano ed a Santa Maria Maddalena. Le parti in legno sono state eseguite da maestri della val Gardena.

Albino BADINELLI fu fucilato con la schiena al muro dove oggi è posta la targa commemorativa qui fotografata mentre viene benedetta da un sacerdote.

LA MEDAGLIA D’ORO conferita al carabiniere Albino Badinelli

Onorificenze e riconoscimenti
Domenica 25 settembre 2016, durante la visita a Stella (Savona), paese natio di Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Agnese Badinelli, sorella di Albino.
Dal 6 marzo 2017 Albino Badinelli viene commemorato come “Giusto dell’umanità”, titolo riservato a coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi. A lui e ad altre venti figure è stata dedicata la cerimonia di apertura delle celebrazioni per la Giornata europea dei Giusti, a Palazzo Marino, Milano, con la consegna delle pergamene per l’inserimento nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo. E’ seguita poi la commemorazione in Consiglio Comunale, con la lettura dei nomi dei nuovi Giusti, ospiti d’onore nella seduta del Consiglio.
Anche la Chiesa cattolica sta lavorando per riconoscere ufficialmente la fama di santità di questo giovane. Papa Francesco è stato informato della vicenda legato alla figura di Albino Badinelli nel settembre 2015, quando il Comitato, in visita a Roma, ha donato un piccolo volume a Papa Francesco, nel contesto dell’Udienza generale. Nella stessa occasione, il volume è stato dato anche al Papa emerito Benedetto XVI, attraverso il suo segretario personale.
Il 2 gennaio 2016, Tommaso Mazza, sacerdote della diocesi di Chiavari, ha avuto l’opportunità di intrattenere una conversazione personale con Papa Francesco a Casa Santa Marta. In questa occasione, tra le molte cose proposte, ha presentato al Santo Padre, in modo più dettagliato, la storia di Albino Badinelli, facendo particolare riferimento alla storia della sua morte. Nel maggio 2018 i Cardinali e i Vescovi lo hanno scelto come “Testimone” del Sinodo dei Giovani.
Decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 2017
Medaglia d'oro al merito civile alla memoria |
|
«Carabiniere effettivo alla Stazione di Santa Maria del Taro (PR), dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, non volendo venir meno al giuramento prestato e deciso a non far parte delle milizie della Repubblica di Salò, si dava dapprima alla macchia e successivamente decideva di consegnarsi al reparto nazifascista che, come rappresaglia ad un attacco subito, minacciava di trucidare venti civili inermi. Condotto davanti al plotone di esecuzione sacrificava la propria vita per salvare quella dei prigionieri. Chiaro esempio di eccezionale senso di abnegazione e di elette virtù civiche spinte fino all’estremo sacrificio. 2 settembre 1944 Santo Stefano d'Aveto(GE).» |

Giunti al cimitero del Comune di Santo Stefano d’Aveto, Albino viene posto con le spalle al muro. È in quegli istanti che, dopo aver baciato con grande devozione il crocifisso, dice come Gesù in croce:
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno».
Qualcuno nel plotone si rifiuta di sparare. Ma la sua sorte è segnata. Viene raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due al cuore e uno alla testa. Così, il 2 settembre 1944, il ventiquattrenne Albino torna al Creatore (sul luogo della sua morte, oggi si trova una lapide, la cui scritta finisce così:
«O tu che passi / chinati al suo ricordo / e prega a lui ed al mondo / pace»).
A piangerlo, tra i tanti familiari e amici, la fidanzata Albina, che tempo dopo chiederà di essere sepolta insieme alle lettere che lui le scriveva.
Il suo cadavere, ancora sanguinante, viene lasciato per un po’ davanti al cimitero e poi portato nel coro della vecchia chiesa parrocchiale, con l’ordine del maggiore Cadelo di non spostarlo da lì, perché serva da monito. Ma nella notte il corpo esanime di Albino viene trafugato da alcuni compaesani, guidati da monsignor Casimiro Todeschini, per dargli degna sepoltura.
Il suo sacrificio contribuisce comunque a placare l’ira di Cadelo, che rinuncia al proposito di uccidere gli ostaggi e incendiare Santo Stefano. Lo stesso maggiore finirà vittima di un’imboscata alcuni giorni più tardi, il 27 settembre, nei pressi del Passo della Forcella.
Ma chi comunica il fatto a mamma Caterina, pensando di portarle una buona notizia, si sente rispondere da lei:
«Non voglio ritirare il perdono che mio figlio ha dato prima di morire!».
E qualche tempo dopo, mentre sta recitando il Rosario in un angolo della sua cucina, interpellata da un cappellano militare giunto con altri a raccogliere informazioni sulla morte di Albino, la donna confida:
«Prego per coloro che hanno ucciso mio figlio».
Da quel giorno il ricordo del sacrificio di Albino non si è ancora spento: a suo nome è stata intitolata una via del Comune, dove si trovano la stazione dei Carabinieri e la scuola.
Nel 2015 è stato poi fondato il Comitato Albino Badinelli, per favorire lo sviluppo e la conoscenza della sua testimonianza.
«In questo modo - come afferma una dichiarazione di un testimone - il Carabiniere Albino Badinelli entrò nel novero di quegli eletti che, con il loro sacrificio supremo, resero possibile il nostro riscatto».
ESEMPIO PER LA CHIESA E IL MONDO
Naturalmente, la Chiesa guarda con grande attenzione alla figura di Badinelli. Almeno quattro Papi - Pio XII, Paolo VI, Benedetto XVI, Francesco - hanno conosciuto ed espresso in vario modo la loro gratitudine per l’esempio di Badinelli. Ratzinger ha parlato del suo sacrificio come «testimonianza di amore e di pace che dona forza e stimolo ai giovani del nostro tempo». E nel Sinodo dei Giovani del 2018, voluto da Bergoglio, Albino è stato incluso tra i testimoni dell’amore di Cristo da far conoscere alle nuove generazioni.

Di recente lo stesso giornalista Italo Vallebella ha scritto per il SECOLO XIX un articolo così intitolato:
Santo Stefano D’Aveto, beatificazione e canonizzazione del carabiniere Badinelli: la Congregazione dà il nulla osta
Per saperne di più:
Libro: L’amore più grande
Autore Tommaso Mazza
LA BATTAGLIA DI ALLEGREZZE NELL’ANNO 1944
http://www.valdaveto.net/documento_655.html
Con il nome di Bando Graziani furono chiamati una serie di bandi di reclutamento militare obbligatorio, destinati ai giovani italiani nati negli anni tra il 1916 e il 1926, emanati dal Ministro della Difesa della Repubblica Sociale Italiana, Rodolfo Graziani, per la costituzione del nuovo Esercito della RSI.
Il primo di questi bandi risale al 9 novembre 1943 e riguardava i giovani delle classi 1923, 1924 e 1925. Dei 180 000 richiamati alla leva da questo primo bando, solo 87.000 si presentarono, tutti gli altri disertarono e molti di loro fuggirono raggiungendo le formazioni partigiane. Il 18 febbraio 1944 un decreto di Mussolini sanciva la pena di morte mediante fucilazione per i renitenti e i disertori. Questi bandi, tuttavia, ebbero scarso successo e anzi rafforzarono la resistenza partigiana clandestina, verso la quale furono attratti inevitabilmente i tanti renitenti in fuga dalla leva.
Come un ruvido panno passa sull'umanità, privandola di quelle differenziazioni sociali di cui la collettività stessa si nutre.
Rimane infine l'uomo, nella sua essenza. Nel bene e nel male.
Ecco allora che questa pagina rievocando i drammatici accadimenti della cosiddetta Battaglia di Allegrezze, rappresenta un vero monito per tutti: non lasciamo mai che la bestia che vive in ognuno di noi prenda il sopravvento.
Pensiamo al prof. Podestà, al canonico Moglia e al falegname Zaraboldi. Diversi per formazione e ruolo sociale, ma accomunati da quello che più conta: essere uomini.
Nell'accezione più sublime del termine.
Di Massimo Brizzolara
Chiavari 30 giugno 1946
Il sottoscritto dichiara che la sera del 27 agosto 1944 alle ore 17 circa, venne prelevato (arma alla mano) da due soldati accompagnati da due borghesi che erano stati prelevati in rastrellamento da una colonna di nazifascisti (gruppo Cadelo di esplorazione della Monte Rosa) ed invitato a recarsi ad Allegrezze d'Aveto per prestare soccorso medico a feriti nel combattimento in corso con un gruppo di partigiani che aveva aggredito la colonna stessa.
Il sottoscritto era a La Villa d'Aveto dove aveva la propria famiglia sfollata e da pochi giorni era venuto a visitarla. Il sottoscritto si fece accompagnare dal figlio del suo padrone di casa sig. Zaraboldi Costantino ed insieme ai militari e borghesi suddetti si recò ad Allegrezze che dista circa 1 Km.
Ferveva sempre il combattimento, ivi giunto trovò il parroco Don Primo Moglia dal quale apprese che lui stesso era stato preso in ostaggio dal comandante della colonna dei nazifascisti e che mentre veniva condotto a S. Stefano d'Aveto con la stessa, aveva inizio un fiero combattimento con i partigiani, per cui la colonna stessa era stata decimata ed aveva dovuto retrocedere.
Il parroco Don Primo allora aveva disposto il raccoglimento dei feriti e dei morti, improvvisando in casa sua (canonica) l'infermeria. Infatti io trovai nei vari letti e stanze, una quantità di feriti più gravi. Pregai il parroco di disporre in modo che mi si aprisse la scuola di fronte alla sua canonica per poter medicare e ricoverare anche altri feriti che via via affluivano portati dai borghesi. Posso attestare che la popolazione di Allegrezze guidata dal suo parroco fece miracoli in quella sera e in tutta la notte successiva, mettendo a disposizione i pagliericci e la biancheria occorrente a medicare e ricoverare ben 37 feriti gravi e a portare al cimitero sette morti.
Furono tutti medicati dal sottoscritto con l'aiuto della popolazione e in modo speciale dal parroco e da una donna che era stata presa in ostaggio certa Caprini Maria.
Nella notte stessa, con l'aiuto dell'interprete tedesco P. Tomas Ruckert, il sottoscritto potè tenere dal tenente tedesco delle SS che apparteneva al Comando della colonna stessa, la promessa su parola d'onore dello stesso, di liberare all'alba gli ostaggi presi e tra questi il parroco Don Primo Moglia ed il giovane sacerdote Giovanni Barattini di Alpicella.
Tutto ciò in premio dell'opera veramente encomiabile prestata da Don Primo e dalla popolazione della sua parrocchia da lui guidata. Infatti, all'alba del giorno dopo, prima di partire io stesso recandomi alla sua abitazione mi accertai personalmente che tale liberazione fosse mantenuta.
ALLEGREZZE BRUCIA
29 AGOSTO 1944

Purtroppo, il giorno appresso venne bruciato il paese, su ordine di un militare italiano Maggiore Cadelo che comandava la colonna.
Infrangendo la parola d'onore con il sottoscritto impegnata in proposito dal Tenente tedesco delle SS a lui in sott'ordine, mentre al mattino del 29 agosto 1944 il parroco Don Primo Moglia celebrava la messa per la festa della Madonna della Guardia presente tutti i suoi parrocchiani, faceva circondare il paese e appiccare il fuoco a tutte le abitazioni della frazione impedendo ai parrocchiani di altre frazioni di accorrere in aiuto per spegnere gli incendi. La chiesa fu salva soltanto perchè il parroco si era adoperato come già detto per i feriti. Così anche la scuola, la canonica e la stessa sua vita.
Giorni dopo assieme al parroco Don Primo Moglia, al becchino e al figlio del mio padrone di casa sig. Costantino Zaraboldi, per mia iniziativa ci recammo in località "La Cava" per raccogliere il cadavere del partigiano Berto, che su ordine del su menzionato Maggiore Cadelo, era stato lasciato sulla strada con minaccia per chi lo avesse toccato e gli demmo onorata sepoltura.
La bara fu fabbricata dallo stesso Costante Zaraboldi gratuitamente.
Un mese dopo circa, tanto il sottoscritto (che aveva rimesso di proprio tutta la medicazione dei feriti stessi) che il Zaraboldi e il padre suo, vennero arrestati assieme al parroco di S. Stefano d'Aveto ed al parroco di Pievetta sotto l'accusa di collaborazione con i partigiani e non vennero fucilati insieme ad altri otto disgraziati del luogo, solo perché nel frattempo il Maggiore Cadelo (che aveva dato ordine di fucilazione) venne ucciso in imboscata dai partigiani.
In fede di quanto sopra firmato Dott. Prof. Vittorio Podestà *
* Medico Chirurgo Radiologo - Docente nella Regia Università di Genova - Perito Medico Giudiziario
I due partigiani: BRIZZOLARA ANDREA di Villanoce e SILVIO SOLIMANO “BERTO” di Santa Margherita Ligure caddero combattendo contro i nazifascisti ad Allegrezze il 27 Agosto 1944.


Albino Badinelli – L’Arcivescovo di Chiavari, incontra la sorella del carabiniere martire.
http://www.ordinariatomilitare.it/2021/04/28/albino-badinelli-larcivescovo-a-chiavari-incontra-la-sorella-del-carabiniere-martire/
TESTIMONIANZE RACCOLTE PRESSO I PARENTI DI
ALBINO BADINELLI

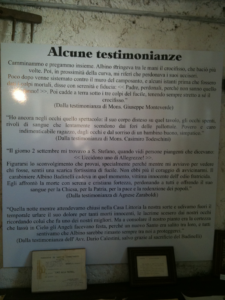

IL CIMITERO DI ALLEGREZZE
Due giganteschi alberi di SEQUOIA fanno da guardiani e custodiscono la memoria per sempre
Anni Ottanta dell’Ottocento, epoca della messa a dimora da parte di Agostino Zanaboldi, figlio di immigrati liguri negli Stati Uniti, che ritornò da New York con due piantine di sequoia….

Concludo con alcune riflessioni personali:
I carabinieri avevano due compiti principali:
di polizia, tutela della sicurezza della popolazione italiana - di militari nelle Forze Armate, avevano giurato fedeltà al re e non al fascismo.
Domenica 25 luglio 1943 ore 17.00
Tra coloro che si occupano dell'arresto di Mussolini: i carabinieri Giovanni Frignani e Raffaele Aversa saranno tra gli uccisi alle cave Ardeatine.
Per questo motivo i nazifascisti non si fideranno mai dei carabinieri.
La situazione diventa estremamente difficile per l’Arma Regia dopo l’8 settembre 1943, quando il Re abbandona la capitale e l’Arma dei Carabinieri riceve l’ordine di rimanere sul posto per mantenere l’ordine pubblico e collaborare con l’occupante.
Viene chiesta loro la “fedeltà a Salò” e da quel momento iniziano le diserzioni, le deportazioni e gli arruolamenti presso le unità partigiane.
In questo drammatico quadro storico avviene la fucilazione di Salvo D’Acquisto seppure innocente e riconosciuto tale dal comando tedesco.
Il suo gesto eroico salva la vita a 22 ostaggi presi nei dintorni quando tutti sapevano che la causa della morte di due militari tedeschi era dovuta ad una esplosione da loro stessi provocata. Gli ostaggi furono liberati ma i tedeschi ottennero il loro scopo: creare panico e terrore tra la popolazione.
A guerra finita i numeri ci spiegheranno meglio di tante parole il SACRIFICIO dei Carabinieri:
2.735 ……….. caduti
6.521 …………feriti
0ltre 5.000… deportati in Germania
Nel 2001 Papa Giovanni Paolo II, in un discorso rivolto ai Carabinieri disse:
La storia dell’Arma dimostra che si può raggiungere la vetta della SANTITA’ nell’adempimento fedele e generoso verso il proprio STATO.
SALVO D’ACQUISTO:
Nascita:
Napoli, 15 ottobre 1920
Morte:
23-settembre-1943
Località Torre Perla di Palidoro, nella frazione di Palidoro, nel comune di Roma (oggi-Fiumicino).
ALBINO BADINELLI:
Nascita:
Allegrezze, 6 marzo 1920
Morte:
2 settembre 1944
Santo Stefano D’Aveto
Tra questi due GIGANTI dello SPIRITO DI SERVIZIO è difficile trovare persino le più sottili differenze caratteriali e comportamentali.
Entrambi si presentarono spontaneamente davanti ai loro carnefici esibendo ciascuno il PROPRIO ONORE MILITARE, QUEL VALORE che non trovarono sia nel Comando Tedesco di Roma sia in quello Nazifascista della Liguria montana.
Rimane soltanto da aggiungere qualcosa sull’enfasi, la pubblicità dei media, del cinema e della politica data al tragico evento riferito al povero Salvo D’ACQUISTO ed il lunghissimo SILENZIO dedicato al NOSTRO carabiniere Albino BADINELLI.
Gli storici “sopra le parti” affermano che la politica non nobilita mai certi fatti… ma che è soltanto capace di MITIZZARE la parte che più gli conviene.
Credo si riferiscano all’azione compiuta dai Gruppi di Azione Patriottica il 23 marzo 1944 quando attaccarono una colonna del battaglione di polizia tedesca Bozen in via Rasella a Roma provocando la morte di 26 soldati austriaci, fatto che fece scattare immediatamente la “rappresaglia nazista”.
Nessuno degli autori di quella strage si presentò per autodenunciarsi al Comando tedesco e, com’è noto, la conseguenza fu la seguente: il giorno dopo, il 24 marzo 1944 un plotone tedesco, comandato da Herbert Kappler giustiziò 335 italiani “incolpevoli” alle Fosse Ardeatine.
Un massacro tra i più efferati della storia della Seconda guerra mondiale.
Una giustificazione per i responsabili dell’eccidio di Via Rasella esiste in ogni caso: Kappler, per ordine perentorio dello stesso Hitler, fu obbligato a eseguire la strage in tempi brevissimi, motivo per cui non ci sarebbe stato il tempo materiale per mettere a punto una qualsiasi strategia tesa ad evitare la morte di quei poveri Martiri delle Fosse Ardeatine.
Tutto comprensibile! Ma per i nostri due VALOROSI Carabinieri:
SALVO D’ACQUISTO E ALBINO BADINELLI
A IMITAZIONE DI CRISTO
bastarono pochi minuti per autodenunciarsi, salire sul patibolo e morire per salvare degli innocenti.
Carlo GATTI
Rapallo, 3 Agosto 2022
IL MARINAIO DI UN TEMPO CHE FU...
IL MARINAIO DI UN TEMPO CHE FU …

Vita di bordo

Porto di Savona – MONUMENTO AL MARINAIO
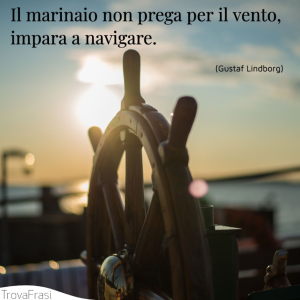
I FERRI DEL MESTIERE
Il marinaio di un tempo teneva una varietà di piccoli attrezzi e oggetti personali. La maggior parte di questi strumenti erano primitivi ma altamente funzionali - anche piuttosto belli - e spesso realizzati dallo stesso individuo che li usava.
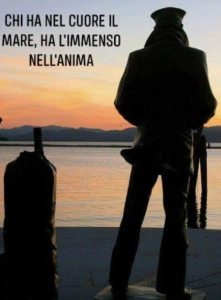
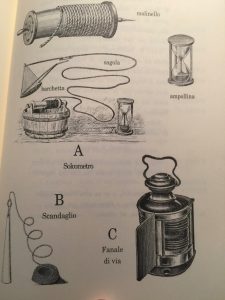



MUSEO MARINARO TOMMASSINO ANDREATTA DI CHIAVARI
Guardamano per cucire le vele
Italia, primi del ’900
Dimensioni: cm 12×7
Materiali: tela olona e ferro
Donazione Elio Costanzo
M.M.T.A. – Invent. n. 218

Apparteneva al nostromo Andrea Schiaffino.
Veniva indossato per proteggere la mano durante la cucitura delle vele. Con la parte metallica veniva spinto l’ago per bucare la tela.

Punteruoli, caviglie, cavigliere, aghi da velaio, pece, bobine di filo per vele
Caviglia è anche il cavicchio conico con cui si divaricano i legnoli, ossia gli elementi ritorti dei quali è costituita una cima, per farvi giunte o gasse impiombate.
TENDI COMANDO dell’autore


Sacchetti porta utensili in tela olona


REPERTI DI CALAFATO - dell’autore

Il calafato, o maestro calafato, è un operaio specializzato, o altra figura specializzata, che fa parte delle maestranze impiegate nelle costruzioni navali e nelle manutenzioni nautiche. Il calafato si occupa di calafatare le navi o, più in genere, le imbarcazioni in legno, con cadenza periodica, o qualora si rendesse necessario.
Sulle imbarcazioni di dimensioni maggiori, il calafato poteva essere imbarcato a bordo insieme ad un maestro d’ascia, mentre le imbarcazioni di dimensioni minori facevano riferimento a maestri d'ascia o maestri calafati che operavano a terra.
L'opera del calafato è un lavoro difficile e di precisione, tanto che anticamente ci volevano 8 anni di apprendistato per diventare maestro calafato mentre ne bastavano 5 per diventare maestro d’ascia.
Purtroppo di queste maestranze storiche, altamente qualificate, se ne trovano pochi nei cantieri navali più longevi d’Italia, essendo un mestiere di tramando generazionale che va via via scomparendo.
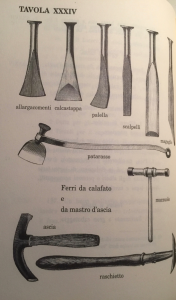
Gli attrezzi del Maestro d’ascia e del Calafato non hanno età
Soltanto visitando i Musei Marinari possiamo “gustarne” tutte le varianti tenendo presente che ogni Mastro d’ascia, così come il Calafato, costruiva i suoi attrezzi a misura dei propri arti: spalla, braccio, gomito, avambraccio, polso e mano.
GLI ATTREZZI DEL CALAFATO
MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA - CHIAVARI

Asce, pialle, seghe, verine, raspe, magli, scalpelli … per ricordare quelli dai nomi risaputi che, basta citarli, richiamano le loro forme. “Sono di tutte le dimensioni, a misura di ogni intervento (anche per quelli in spazi angusti) e di ogni… braccia. Sì, perché a seconda della loro diversa stazza, a cominciare dalla lunghezza delle braccia, maestri d’ascia e calafati si costruivano l’attrezzo specifico, di cui erano gelosi”, racconta Giorgio, ultimo dei maestri d’ascia rapallini, che ne puntualizza il valore: “Ogni attrezzo corrisponde ad un antenato, che qui continua idealmente a vivere … questi attrezzi sono intrisi del suo sudore, del suo sangue, del suo pensiero …” Ecco spiegata la sacralità del luogo!




CALDARO DA PECE

MARMOTTA
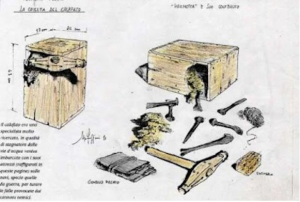
Gli attrezzi del calafato sono il maglio, martello di legno a due teste rinforzato da cerchi di metallo; la mazzola più corta e tozza; vari ferri tipo scalpelli di diverse dimensioni, privi di affilatura ma con il bordo piatto, alcuni con scanalatura, per non recidere la treccia, chiamati palelle o calcastoppa.
GLI ATTREZZI DEL MAESTRO D’ASCIA
MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA – CHIAVARI
Il maestro d’ascia é un professionista le cui origini affondano nell’antichità più remota. Purtroppo di questi mitici personaggi, a metà tra l’artigiano e l’artista, ne rimangono pochi e sono introvabili. Costruire uno scafo preciso al millimetro presuppone anni di fatica e tanto amore per la costruzione navale. Esperienza, perizia e competenza sono tutti elementi che maturano nel corso del tempo, sotto la guida di maestri d’ascia più anziani, spesso nonni e padri che tramandano l’abilità nell’adoperare l’ascia da una generazione all’altra.




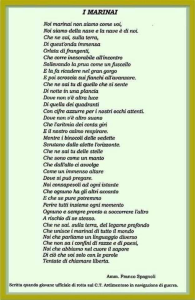
Un po' di letteratura...
IL VECCHIO E IL MARE
ERNEST HEMINGWAY

Tutto in lui era vecchio, tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti.
CHARLES BAUDELAIRE

Umo libero, tu amerai sempre il mare! E’ il tuo specchio il mare! Contempli la tua anima nell’infinito svolgersi della sua onda e non è meno amaro l’abisso del tuo spirito.
JOSEPH CONRAD
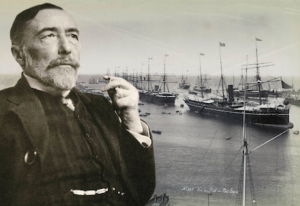
Il mare non è mai stato amico dell'uomo. Tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza.
ANONIMO
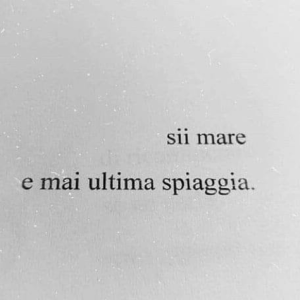
POESIA ANTICA
Vuga t'è da vugâ prexuné
E spuncia spuncia u remu fin au pë.
Vuga t'è da vugâ turtaiéu
E tia tia u remmu fin a u cheu...

CONCLUDO
A scuola ero incazzato nero perché dovevo studiare lavagnate di formule trigonometriche ...
Era il mio primo viaggio e, superato l’Atlantico quel giorno, con incredibile precisione, mi trovai davanti a New York!
Mi emozionai alla vista della grande MELA con i suoi grattacieli, ma ancor di più quando mi resi conto che quelle “bagasce" di formule analitiche antiche non le avevo studiate invano…
Carlo GATTI
Rapallo, 4.8.2022
LUPO DI MARE
LUPO DI MARE
Navigando qua e là sul web….


LUPO DI MARE: il termine lupo di mare a bordo degli antichi velieri di un tempo era affibbiato al NOSTROMO, il marinaio più anziano, rozzo ma molto autorevole. Abile e coraggioso, era temuto per la sua austerità e capacità di comando della ciurma. Era certamente il più esperto tra i marinai di bordo e colui che sentiva e vedeva tutto, non era sensibile alle lodi e alle critiche. Prendeva molto dal carattere e dall’aspetto dell’animale lupo e, come questo, accomunava in sé la forza e la determinazione.
LUPI DI MARE
Qualcuno sostiene che il “detto” nacque negli ambenti marinari degli angiporti. In questo caso “la bocca del lupo” era una specie di lavagna dove i capitani che arrivavano alla Giudecca (VE) registravano il loro arrivo e la quantità di uomini e merci portati a casa. L’espressione significava quindi augurare di fare una buona navigazione e di tornare salvi in porto. “In Bocca al Lupo - che il Dio del mare ti ascolti”.
Il STV Enzino GAGGERO ci ha donato la
C’è anche un’altra versione più realistica:
Nei mari della Groenlandia il “lupo di mare” è un pesce comune
Questa espressione si usa con significato solo leggermente differente. Infatti serve per indicare un marinaio che ha molti anni di esperienza in fatto di navigazione, e proprio per questo gode di rispetto tra i suoi colleghi.......
Viene usato come AUGURIO:
“Buon vento a tutti coloro che oggi possono spiegare le vele"!
Ecco tre foto del pesce nordico LUPO DI MARE




In francese: Loup de mer
In inglese: sea dog
In tedesco: sea wolf= Der Seewolf
In spagnolo: Lobo marino
In svedese: Havsvarg
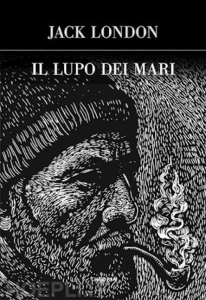
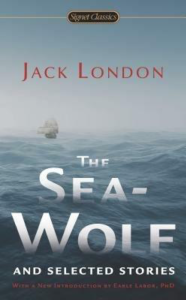

Ancora un esempio del termine marinaro
BOCCA DI LUPO (nodo)
La bocca di lupo era conosciuto fin dal Primo Secolo dal medico greco Heraklas, che lo descrisse in una monografia dedicata ai nodi ad uso chirurgico.
Perché si dice in bocca al lupo?

Numerose sono le interpretazioni di questo modo di dire dalla valenza scaramantica, dal folklore, all’etologia, passando per la storia di Roma.
Il lupo, l’abbiamo già detto, è un archetipo più che un animale. Nel corso della storia numerose sono state le “visioni” di questo animale, nella tradizione medioevale era visto come l’incarnazione del pericolo e del male, nelle antiche tradizioni nordiche evocava invece conoscenza e rivelazioni epifaniche. In letteratura l'epifania è, secondo Joyce, un'improvvisa rivelazione spirituale, causata da un gesto, un oggetto, una situazione della quotidianità, forse banali, ma che rivelano inaspettatamente qualcosa di più profondo e significativo.

Numerose sono le interpretazioni del proverbio “in bocca al lupo”. Espressioni simili si ritrovano anche in altre lingue europee.
Oggi, dopo aver rischiato l’estinzione negli anni Settanta, il lupo è tornato, scende in collina e spesso si fa anche fotografare. Purtroppo stiamo assistendo ad un nuovo tentativo di demonizzare questo elusivo e prezioso predatore. Il lupo è così radicato nella nostra cultura che è presente anche in numerosi proverbi e modi di dire. Su tutti l’augurio “in bocca al lupo”, ma cosa significa veramente? Ecco alcune interpretazioni di questa locuzione.

Funzione apotropaica
L’interpretazione più accreditata dell’origine del detto è quella della funzione apotropaica (ovvero una formula che allontana o annulla un’influenza maligna) della locuzione, “capace di allontanare lo scongiuro per la sua carica di magia”, sostiene l’Accademia della Crusca. Questa versione prevede la risposta: “crepi”, sottintendendo il lupo, e sarebbe nata come frase di augurio rivolta a chi si appresta ad affrontare una prova difficile. L’origine dell’augurio viene attribuita sia a pastori e allevatori, che consideravano il lupo un nemico, sia ai cacciatori, che vagavano di villaggio in villaggio mostrando carcasse di lupi e pretendendo una ricompensa per il servizio reso.
La lupa di Romolo e Remo
Questa spiegazione si basa sul simbolo della città eterna, la lupa che ha salvato Romolo e Remo nella storia dell’origine di Roma. I gemelli, figli del dio Marte e della vestale Rea Silvia, vengono allattati dalla lupa che salva loro la vita, il senso dell’augurio cambia dunque radicalmente e il lupo diviene sinonimo di protezione. La risposta “crepi” non avrebbe pertanto senso.
Al sicuro nella bocca di mamma lupa
Questa, anche se può essere storicamente inesatta, è probabilmente l’interpretazione più romantica. Il significato è simile alla spiegazione precedente e propone una lettura etologica del proverbio. Mamma lupa è solita trasportare i propri cuccioli in bocca in caso di pericolo, in una situazione così non c’è posto più sicuro della bocca del lupo, augurare quindi a qualcuno di trovarsi tra le fauci di questo animale è un modo per auspicare che sia protetto. In questo caso la risposta non è “crepi”, ma un più pacifico “lunga vita al lupo”, o “evviva il lupo” o “grazie”.
“Lupo di mare” nei testi
The Dubliners - la Irish Rover
ma presto il tormento dovra’ finire;
dell’amore di una donna non ha mai paura
il vecchio lupo di mare della Irish Rover
Giuseppe Ungaretti - Allegria di naufragi
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare.
Đorđe Balašević - Il marinaio della Pannonia
o meglio come capitan Cook
In questa piana tra i campi perdo la speranza
un lupo di mare arenato in un campo di grano
Joan Manuel Serrat - Incubi per telenovele
che gli sorrideva ad un palmo dal naso
e gli offriva una tazza di caffè
con la voce di un lupo di mare gli diceva:
“Loro hanno dormito bene, signora, signore?
Marco Sbarbati - La mia casa alla fine del mondo
Fra le tue dita si posa l'estate
Chiedimi ancora se so dove andare
Fammi sentire un lupo di mare
Meglio seguire la stella polare
Le Piccole Ore - Piccola strega
Ti sei aggrappata al mio cuore
Credevo di esser forte ed insensibile
Un vecchio lupo di mare
El Presi - Pescatori Asturiani
Lastres, Guijón, Avilés y Tapia de Casariego.
Soltanto un lupo di mare
sopporta la solitudine
Massaroni Pianoforti - Lupo di mare
Hai il dono raro di una bellezza elegante
Perfino se indossi un berretto discutibile da marinaio
Quando mi hai detto "Lupo di mare"
La tua promessa è come una stella da guardare e mai seguire


Non avete udito mai parlare di mastro Catrame? No?…
Allora vi dirò quanto so di questo marinaio d’antico stampo, che godette molta popolarità nella nostra marina: ma non troppe cose, poiché, quantunque lo abbia veduto coi miei occhi, abbia navigato molto tempo in sua compagnia e vuotato insieme con lui non poche bottiglie di quel vecchio e autentico Cipro che egli amava tanto, non ho mai saputo il suo vero nome, né in quale città o borgata della nostra penisola o delle nostre isole egli fosse nato.
Era, come dissi, un marinaio d’antico stampo, degno di figurare a fianco di quei famosi navigatori normanni che scorrazzarono per sì lunghi anni l’Atlantico, avidi di emozioni e di tempeste, che si spinsero dalle gelide coste dei mari del nord fino a quelle miti del mezzogiorno, che colonizzarono la nebbiosa Islanda e conquistarono il lontano Labrador, quattro o forse cinquecento anni prima che il nostro grande Colombo mettesse piede sulle ridenti isole del golfo messicano.
Quanti anni aveva mastro Catrame? Nessuno lo sapeva, perché tutti l’avevano conosciuto sempre vecchio. È certo però che molti giovedì dovevano pesare sul suo groppone, giacché egli aveva la barba bianca, i capelli radi, il viso rugoso, incartapecorito, cotto e ricotto dal sole, dall’aria marina e dalla salsedine. Ma non era curvo, no, quel vecchio lupo di mare!
Procedeva, è vero, di traverso come i gamberi, si dondolava tutto, anche quando il vascello era fermo e il mare perfettamente tranquillo, come se avesse indosso la tarantola, tanta era in lui l’abitudine del rollio e del beccheggio; ma camminava ritto, e quando passava dinanzi al capitano o agli ufficiali teneva alto il capo come un giovinotto, e da quegli occhietti d’un grigio ferro, che pareva fossero lì lì per chiudersi per sempre, sprizzava un bagliore come di lampo. Ma che orsaccio era quel mastro Catrame! Ruvido come un guanto di ferro, brutale talvolta, quantunque in fondo non fosse cattivo: poi superstizioso come tutti i vecchi marinai, e credeva ai vascelli fantasmi, alle sirene, agli spiriti marini, ai folletti, ed era avarissimo di parole. Pareva che faticasse a far udire la sua voce, si spiegava quasi sempre a monosillabi e a cenni, non amava perciò la compagnia e preferiva vivere in fondo alla tenebrosa cala, dalla quale non usciva che a malincuore. Si sarebbe detto che la luce del sole gli faceva male e che non poteva vivere lontano dall’odore acuto del catrame, e forse per questo gli avevano imposto quel nomignolo, che poi doveva, col tempo, diventare il suo vero nome.
Chi aveva mai veduto quell’uomo scendere in un porto? Nessuno senza dubbio. Aveva un terrore istintivo per la terra, e quando la nave si avvicinava alla spiaggia, lo si vedeva accigliato, lo si udiva brontolare, e poi spariva e andava a rintanarsi in fondo del legno. Di là nessuno poteva trarlo; guai anzi a provarsi! Mastro Catrame montava allora in bestia, alzava le braccia e quelle manacce callose, incatramate, dure come il ferro e irte di nodi, piombavano con sordo scricchiolio sulle spalle dell’imprudente, e i mozzi di bordo sapevano se pesavano!
Per tutto il tempo che la nave rimaneva in porto, mastro Catrame non compariva più in coperta. Accovacciato in fondo alla cala, passava il tempo a sgretolare biscotti con quei suoi denti lunghi e gialli, ma solidi quanto quelli del cignale, a tracannare con visibile soddisfazione un buon numero di bottiglie di vecchio Cipro, alle quali spezzava il collo per far più presto, e a consumare non so quanti pacchetti di tabacco.
Quando però udiva le catene contorcersi nelle cubìe e attorno all’argano, e lo sbattere delle vele e il cigolare delle manovre correnti entro i rugosi bozzelli, si vedeva la sua testaccia apparire a poco a poco a fior del boccaporto e, dopo essersi assicurato che la nave stava per ritornare in alto mare, compariva in coperta a comandare la manovra.
Sembrava allora un altro uomo, tanto che si sarebbe detto che invecchiava di mano in mano che si avvicinava alla terra e che ringiovaniva di mano in mano che se ne allontanava per tornare sul mare. Forse per questo si sussurrava fra i giovani marinai che egli fosse uno spirito del mare e che doveva esser nato durante una notte tempestosa da un tritone e da una sirena, poiché quello strano vecchio pareva si divertisse quando imperversavano gli uragani, e dimostrava una gioia maligna che sempre più cresceva, allora che più impallidivano dallo spavento i volti dei suoi compagni di viaggio.
Da che cosa provenisse quell’odio profondo che mastro Catrame nutriva per la terra? Nessuno lo sapeva, e io non più degli altri, quantunque mi fossi più volte provato ad interrogarlo. Egli si era contentato di guardarmi fisso fisso e di voltarmi bruscamente le spalle, dopo però avermi fatto il saluto d’obbligo, poiché mastro Catrame era un rigido osservatore della disciplina di bordo.
Del resto tutti lo lasciavano in pace, mai lo interrogavano, poiché lo temevano e sapevano per esperienza che aveva la mano sempre pronta ad appioppare un sonoro scapaccione, malgrado l’età, e qualche volta anche faceva provare la punta del suo stivale. Gli uni lo rispettavano per l’età, gli altri per paura.
Lo stesso capitano lo lasciava fare quello che voleva, sapendo che in fatto di abilità marinaresca non aveva l’eguale, che poteva contare su di lui come su d’un cane affezionato, sebbene ringhioso, e che valeva a far stare a dovere l’equipaggio anche con una sola occhiata, né mancava mai al suo servizio.
Una sera però, mentre dai porti del Mar Rosso navigavamo verso i mari dell’India, mastro Catrame, contrariamente al solito, commise una mancanza che fece epoca a bordo del nostro veliero: fu trovato nientemeno che ubriaco fradicio in fondo alla cala!… Come mai quell’orso, che da tanti anni aveva dato un addio ai forti liquori che tanto piacciono ai marinai e che mai una volta si era veduto barcollare pel soverchio bere, si era ubriacato? Il caso era grave; ci doveva entrare qualche gran motivo, e il nostro capitano, che voleva veder chiaro in tutto, ordinò un’inchiesta, su per giù come fanno le nostre autorità quando accade qualche grosso avvenimento.
E la nostra inchiesta approdò a buon porto, poiché si constatò con tutta precisione che mastro Catrame si era ubriacato per errore! Qualche burlone aveva mescolato fra le bottiglie di Cipro una di rhum più o meno autentico, e il vecchio lupo l’aveva tracannata tutta senza nemmeno accorgersi della sostituzione.
Un mastro che si ubriaca durante la navigazione non la può passar liscia, e tanto meno doveva passarla mastro Catrame, che era così rigido osservatore delle discipline marinaresche. Quale brutto esempio, se lo si fosse graziato!
Il capitano con tutta serietà ordinò che si portasse il colpevole sul ponte appena l’ebrezza fosse passata, e avvertì l’equipaggio di tenersi pronto per un consiglio straordinario. Dopo due ore mastro Catrame, ancora stordito da quella abbondante libazione, che avrebbe potuto riuscire fatale a uno stomaco meno corazzato, compariva in coperta torvo, accigliato, coi peli del volto irti. I suoi occhietti correvano dall’uno all’altro marinaio, come se volessero scoprire il colpevole di quella brutta gherminella.
Il capitano, appena lo vide, gli andò incontro, lo prese ruvidamente per un braccio e lo fece sedere su di un barile che era stato collocato ai piedi dell’albero maestro. Con un cenno fece radunare attorno al colpevole l’equipaggio, poi, affettando una gran collera che non provava e facendo la voce grossa per darsi maggior importanza, disse:
– Papà Catrame, – lo chiamava così, – sapete che i regolamenti di bordo condannano il marinaio che si ubriaca durante il servizio?
Il lupo di mare fece un cenno affermativo e barbugliò un “fate”.
– Quest’uomo è colpevole? – chiese il capitano, volgendosi verso l’equipaggio, che rideva sotto i baffi, sapendo già come doveva finire quella commedia.
– Sì, sì, – confermarono tutti.
– Se tu fossi più giovane, ti farei chiudere nella cabina coi ferri alle mani e ai piedi; ma sei troppo vecchio. Ebbene, io cambio la pena condannandoti a sciogliere quella lingua, che è sempre muta, per dodici sere.
– Orsù, papà Catrame, taglia i gherlini che la tengono legata, accendi la tua pipa e narraci dodici storie, le più belle che sai – e ne devi sapere, veh! – e tu, dispensiere, reca una bottiglia del più vecchio vino di Cipro che troverai nella mia cabina, onde la lingua del vecchio orso non si secchi. Avete capito?
Una salva d’applausi accolse le parole del capitano, a cui fece eco un sordo grugnito di mastro Catrame, non so poi se di contentezza per essere sfuggito ai ferri o di malcontento per dover sciogliere la lingua.
EMILIO SALGARI
[da Le novelle marinaresche di Mastro Catrame]
Concludo:
Non sono un Agente di Viaggi, tuttavia, essendo stato a Cipro due volte… in qualche modo mi sento di consigliare quella meta in particolar modo a chi ama la natura, la storia, l’archeologia, la religione e la buona cucina! Sarete sorpresi!
Il vino di Cipro, tra storia e leggenda
https://patatofriendly.com/vino-cipro-storia-leggenda/
AGGIUNGIAMO A QUESTA RICERCA I CONTRIBUTI DEI NOSTRI AMICI E SOCI:
- STV Enzo GAGGERO:
Mio padre (classe 1916) aveva fatto il servizio di leva nella Regia Marina, proprio a Venezia ed ero a conoscenza della lavagna Bocca di lupo e del suo significato nella marineria veneziana.
Mi è gradito inviarti il simpatico "In bocca al lupo" che distribuiamo ai visitatori delle serate astronomiche.
Com.te Mario T. Palombo
… il tuo inserimento "LUPI DI MARE " mi ha fatto venire in mente mio padre che, pur essendo un Padrone Marittimo e avendo comandato bastimenti a vela, a motore e fatto tanta gavetta, quando arrivava a Camogli e con il suo Nettuno entrava in porto con le mareggiate, la gente rimaneva sbalordita per la sua abilità, sicurezza e coraggio. Un vero lupo di mare.
Com.te Ernani Andreatta
NOSTROMO: "Uomo rozzo e buzzurro che con urla e fischi conduceva la ciurma all'arrembaggio, l'unica persona a cui era ammessa la bestemmia".
Questa è la descrizione storica del Nostromo, figura importantissima della Marineria sia militare che mercantile.
https://www.marinaiditalia.com/public/uploads/2012_7_30.pdf
Sub Giancarlo Boaretto

"… che bello leggere qualcosa sui lupi di mare, mi hai fatto ricordare di quando mi imbarcai per la prima volta, ma non come marinaio, bensì come sommozzatore, e dal 1968 al 1995 imbarchi ne ho fatto qualcuno... Non mi sono mai sentito un "lupo di Mare" come di fatto non lo ero, ma soltanto ospite in una piccola città galleggiante, dove non sempre eravamo ben visti dai marinai, perché moltissime volte stavamo a guardarli mentre loro sfacchinavano e quando la nave non era operativa in attesa di nuovi materiali inerenti la costruzione delle piattaforme petrolifere, noi andavamo a pescare in apnea attorno alla stessa; tornando al primo imbarco, io ero già un Lupo, ma di montagna."
La modestia di Gianca è nota! Ma noi conosciamo come pochi il suo lavoro di un tempo sui fondali freddi del Nord Europa per cui ritengo che in lui si sommino: due LUPI, quello di mare e quello di montagna.
Anch'io ho ancora qualcosa da aggiungere:
ATTACCO A BRANCO DI LUPI

L'U-190, che partecipò agli attacchi ai convogli HX 229 e SC-122
Branco di lupi (Wolfsrudeltaktik in lingua tedesca) è il nome dato alla tattica di guerra sottomarina adottata dai sommergibili tedeschi nella Seconda guerra mondiale.
La tattica del "branco di lupi" (Rudeltaktik) venne utilizzata per la prima volta nel settembre e nell'ottobre del 1940, con effetti devastanti. Il 21 settembre, il convoglio HX-72 di 42 navi mercantili venne attaccato da un gruppo di sottomarini, che affondarono 11 navi e ne danneggiarono due.
Scopo primario della tattica del "branco di lupi" era quello di rendere possibile un obiettivo nemico comune a più sommergibili. Lo sforzo tattico consisteva nel trovarsi a sopraffare il nemico in battaglia. Per questo il momento ideale per l'attacco comune era la notte, poiché in quel frangente l'U-Boot, che si trovava a sufficiente distanza dal convoglio al di sotto dell'orizzonte, a causa della sua stretta silhouette, era difficile da individuare da parte del nemico. L'attacco veniva incominciato da un U-Boot, che il nemico, idealmente costituito da più bersagli potenziali, non attaccava per non richiamare altri sommergibili. Un gruppo di U-Boo toperante con la tattica del "branco di lupi" poteva comportarsi in due modi diversi. Grazie alla segnalazione di un sommergibile di pattuglia o di un aereo, potevano venir comandati più sommergibili nella stessa zona di mare. Di gran lunga più frequentemente un tale gruppo di U-Boot però si raccoglieva "al tavolo verde" a seguito di avviso ufficiale: per esempio a seguito dell'informazione su un convoglio e del corrispondente ordine di recarvisi.
In caso di una tale ricerca di prede ogni U-Boot, a distanza di circa 8 miglia nautiche uno dall'altro, "batteva" una determinata zona del mare. Quando uno di loro aveva individuato un convoglio nemico, avvertiva agli altri con un breve segnale di 20 caratteri, indicando tempo atmosferico, punto, rotta, velocità, numero di navi e scorta del convoglio, informandoli anche sulla disponibilità di carburante da parte sua. Queste informazioni venivano ripetute dall'U-Boot in questione ogni due ore e teneva così il contatto, mentre gli altri U-Boot accorrevano in direzione del convoglio.
Carlo GATTI
Rapallo, 2 Agosto 2022
IL BAULE DEL MARINAIO - ARTE E MARE - 2
IL BAULE DEL MARINAIO
ARTE E MARE - 2
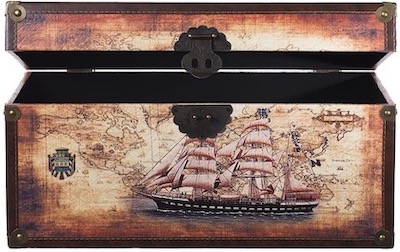
“Con cinque bambini piccoli, essi salirono su un veliero portando tutto ciò che avevano in un piccolo baule”
La cassetta è il baule che il marinaio porta sempre con sé. Rappresenta la sua identità, il passato e il futuro che appena si intravede fra le condizioni variabili del presente. Può essere di legno intarsiato o povero, solido o deteriorato, non importa, ogni navigante ha la sua cassetta, il senso ben custodito di quel girare apparentemente folle intorno al mondo. Una volta abbandonata la navigazione, chiuso il rapporto professionale con il mare, la cassetta perde la sua attitudine raminga, si distende, comincia ad assorbire vita, esperienza, per diventare archivio e potenzialmente materia narrativa.
Dopo questa premessa, che è la vera definizione letteraria del BAULE del marinaio, devo confessare che forse inconsciamente, attribuivo l’uso del baule del marinaio a quel periodo leggendario legato all’epopea della vela o, tutt’al più, ai primi del ‘900 quando i primi sbuffanti vapori solcavano i mari con tre alberi pronti ad issare le vele di fortuna in caso di avaria alle “novelle” macchine alternative. Si trattava, com’è noto, di una messa in scena degli armatori dell’epoca per tranquillizzare i facoltosi ed elegantissimi passeggeri che, ancora un po’ diffidenti verso i nuovi sistemi propulsivi navali, sfidavano l’ignoto. Il baule carico di prestigiosi vestiti all’ultima moda era il biglietto da visita identitario della Belle Époque. Si dice di esso: quel periodo che va da fine ‘800 allo scoppio della Prima guerra mondiale e che fu caratterizzato da euforia e frivolezza. Bella Epoca perché a seguito di una serie di progressi ed invenzioni si modificò lo stile di vita delle classi borghesi; da qui prese inizio l’idea di viaggiare per fare turismo d’élite. L’ esempio tipico è il TITANIC, una nave di lusso inglese della “WHITE STAR” che si fece simbolo della “BELLE ÉPOQUE” in quanto era grande, moderna e veloce. Un oggetto di lusso per persone molto ricche.

Tutto questo mi affiora alla mente trascinandomi un ricordo che solo ora rammento di non averlo mai scritto.
Da sinistra, VULCANIA e SATURNIA a Genova
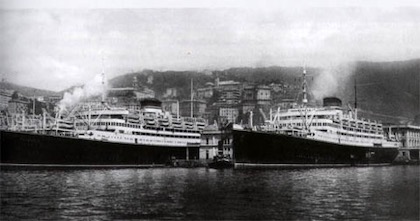
Era il 1961. Dopo un imbarco di quasi un anno da Allievo Ufficiale di coperta su una petroliera, ebbi la fortuna d’imbarcare sulla nave passeggeri SATURNIA con il grado di Allievo Ufficiale Anziano. Eravamo in partenza da Trieste per il mio secondo viaggio sulla linea Trieste - Venezia - Napoli - Palermo - Palma de Majorca - Gibilterra - Lisbona -Punta Delgado (Azzorre) - Halifax - Boston - New York.
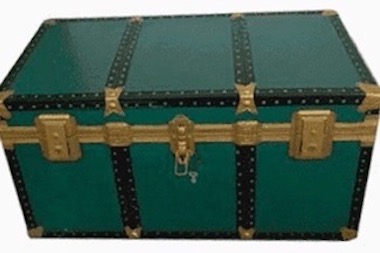
Mi trovavo tra le scartoffie della segreteria di Coperta, quando percepii un trambusto nel corridoio: due “piccoli di camera” stavano “camallando”, si fa per dire, un ingombrante baule da marinaio verde scuro, bordi e angolari rinforzati con borchie metalliche dorate. Ricordo d’aver detto ai due giovani che quel baule era destinato, probabilmente, ad essere “stivato” nel bagagliaio di bordo.
“Ma no sior, ghe zè una targhetta sul lucchetto: Alloggio Ufficiali – M/n SATURNIA”.
Poco dopo vidi avvicinarsi, col suo inconfondibile “piede marino”, un mio caro amico camoglino Baj Schiaffino che avevo lasciato qualche mese prima al seguito della mia squadra di pallanuoto di cui era un fervente tifoso.
“Hoo belin, ma cosa ti ghe fae a bordo. Vanni SÛBITO a casa che a squaddra ha l’à bezêugno de ti …”
Baj aveva ragione, avevo lasciato la squadra per una nave passeggeri su cui avevo sempre sognato d’imbarcare… e quella fuga, Baj non me lo perdonò per tutto l’imbarco.
“Dove u l’è u mae beûlo?”
– Il dilemma era risolto – Il baule era proprio il suo!
Baj discendeva da quel ramo degli Schiaffino de Camoggi che da secoli avevano battuto i mari di tutto il mondo. Già, in quella Camogli dei Mille bianchi velieri su cui la tradizione “voleva” che il giovane s’imbarcasse da Allievo e sbarcasse da Comandante: in un solo lunghissimo imbarco. La rottura con la terraferma doveva essere TOTALE per dimostrare innanzitutto a sé stesso amore e dedizione solo per il MARE. Avete capito bene! Da ultimo di bordo a Capitano al comando e in seguito anche Armatore dei velieri di famiglia.
Baj era rimasto “intrappolato” nel solco di quella tradizione old fashion che lui continuava a vivere, come se la marineria fosse tuttora ancorata a quello spirito d’avventura senza tempo che unisce tutti i marinai del mondo da sempre e per sempre avendo per letto il mare e per soffitto il cielo. Baj continuava a vagare sui bordi insieme a tutti gli Schiaffino de Camoggi, ovunque si trovasse, e come loro si muoveva, non solo nel portamento oscillante, ma nel guardare sempre fuori, verso il mare per controllarne l’umore e la forza del vento sulle vele, con quel suo sorriso sempre generoso, ma furbo: “Amîa che no sòn miga nescio!”
Non gli chiesi mai nulla di quella anacronistica presenza do beûlo al seguito… non volevo profanare le sue antiche consuetudini familiari di cui evidentemente andava molto fiero: esibendo quella specie di carta d’identità che solo pochi potevano permettersi. E poi cosa c’era da spiegare ad un giovane come me, al secondo imbarco che il mondo della vela l’aveva conosciuto soltanto di striscio sugli STARS nel golfo Tigullio facendo bordi rischiosi solo per strappare un sorriso alle ragazze straniere… magari dell’entroterra! Questo avrebbe pensato Baj che di Riviera se ne intendeva!
Beh! Qui forse Baj si sbagliava! Anche il suo giovane amico proveniva da una stirpe di naviganti e armatori: i Gazzolo di Ge-Nervi - 25 velieri impiegati sulle rotte del GUANO tra il Cile e Perù ed il Nord Europa. Già! Ognuno ha il suo retroterra spirituale da rispettare e quindi il suo naturale destino da seguire; ma se oggi ricordo ancora quel BAULE della tradizione marinara ligure significa che nel sangue avevamo entrambi gli stessi ricordi ancestrali.
Baj è mancato di questi tempi un po’ di anni fa, ed ho voluto ricordarlo con la scusa do beûlo che racchiude tanti ricordi che in seguito ci hanno legati da Amicizia vera nella sua Camogli:

Società
CAPITANI E MACCHINISTI NAVALI
CAMOGLI
Arrivati al giro di boa, non mi rimane che segnalare un bel libro di Dario PONTUALE:
IL BAULE DI CONRAD
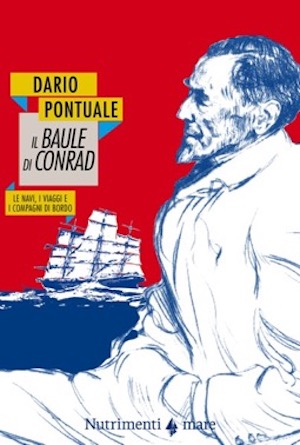
Una cassa di legno lunga un metro, alta cinquanta centimetri, con tozze zampe quadrate e la base più larga per resistere ai rollii. In passato ogni marinaio degno di tale nome solcava le acque del mondo accompagnato da questa specie di baule, chiamato in gergo “cassetta”, dove riporre i propri effetti personali i beni i ricordi.
Tra le molte sopravvissute agli attacchi del tempo, ne esiste una appesantita dagli anni e dagli oggetti, che riporta su un fianco una sigla incisa con la forza di un coltello, “JTKK”, e una data, “1894”. La sigla altro non è che l’abbreviazione del nome del suo proprietario: Józef Teodor Konrad Korzeniowski, ufficiale della Marina Mercantile Britannica. Il 1894 è l’anno in cui la cassetta è stata calata per l’ultima volta dal ponte di una nave: il battello a vapore Adowa, che avrebbe dovuto salpare per il Québec con a bordo quell’ufficiale di origine polacca, in realtà non ha mai lasciato il porto a causa di un impedimento burocratico.
Un finale in sordina per un uomo irrequieto che fin dall’adolescenza attraversa mari e oceani su ogni barca che gli conceda un incarico, una possibilità, una sfida. Vent’anni di vagabondaggio nei luoghi più selvaggi e remoti del globo, dalle Indie Occidentali alla Malesia e fin dentro il cuore oscuro dell’Africa. Dopo aver affrontato tempeste e bonacce, commerci e intrighi, in quel 1894 Józef Konrad cambia definitivamente il proprio nome in Joseph Conrad, il marinaio esce di scena e cede il testimone allo scrittore.
Con vivace ritmo narrativo, sempre affiancato da uno scrupoloso lavoro di ricerca, questo libro racconta la vita in mare di uno dei maggiori autori di ogni tempo: le imbarcazioni sulle quali Conrad navigò, gli uomini incontrati, le rotte seguite e le avventure fonti di ispirazione per i personaggi, le ambientazioni e le vicende che hanno popolato storie immortali come Cuore di tenebra, Tifone, La linea d’ombra e molti altri capolavori conradiani.
UN PO’ DI CONRAD
Mi si chiede di descrivere brevemente, qui, quest'opera.
Per come la vedo io, questo libro rappresenta lo sfogo di un marinaio che ha visto, praticamente, tutto il mondo, naturalmente dalla parte del mare, in quanto all'epoca viaggiavo già fin troppo per mestiere, da avere voglia di farlo anche da turista.
Ho visto tante cose: Cose antiche, cose moderne, cose affascinanti dal punto di vista naturalistico.
E poi, ancora, ho visto il mare in bonaccia, giorno dopo giorno, per decine di giorni, in oceano, e mi è sembrato la manifestazione della bontà divina.
Poi ho visto quello stesso mare furibondo di rabbia, roba che chi non l'ha visto non può arrivare a crederci, ed anzi adesso, che gli anni sono passati, non riesco più a crederci neppure io, se non facendo uno sforzo mentale, alla fine del quale ancora mi vengono i brividi.
Tutto questo l'ho messo, in questo libro. Ma, soprattutto, ho visto l'uomo.
L'uomo bianco, l'uomo nero, l'uomo giallo, l'uomo rosso.
Ho visto il Cristiano, l'Islamico, l'Ateo, l'Ebreo, lo Shintoista, ed anche altri.
Ho visto l'uomo ricco e potente, ed ho visto l'uomo povero, umile.
Di uomini umili e poveri ne ho visti di più, perché tali erano quelli che popolavano gli ambienti del porto, e delle sue vicinanze.
Ho parlato con quegli uomini. Ne ho osservato il comportamento, ascoltato i discorsi, ed alla fine ho capito che sotto la scorza del colore della pelle, della religione, della lingua, gli uomini, tutti gli uomini, sono abbastanza simili, per lo meno quelli sani di mente, vogliono tutti le stesse cose, che si riassumono poi nel diritto a mantenere la speranza di potere condurre una vita decorosa, migliore di quella vissuta dai loro padri, e di poterne offrire di ancora migliori ai propri figli.
Tutti, a parte i pazzi, vogliono vivere in pace, sognano di vedere riconosciuti i propri diritti, curate le malattie, assicurata la vecchiaia.
Vivono nel terrore che qualche pazzo scatenato decida di portarli in guerra, loro e i loro figli, e trasformi le loro mogli in vedove, le loro madri in vecchie in gramaglie.
In questo libro ho messo anche questo.
Poi, ho tirato giù i miei ragionamenti.
Tranquilli: A parte che il fatto che io, come tutti noi occidentali, sono stato formato nella cultura cristiana, nella qual cosa, tra l'altro, non vedo nulla di male, non ho fedi politiche, e neppure religiose. Ho il cuore, ed ho il cervello. Tutto quanto leggerete, se vorrete, viene dritto da lì: Dal cervello e dal cuore.
IL BAULE DEL MARINAIO
Una carrellata nella storia

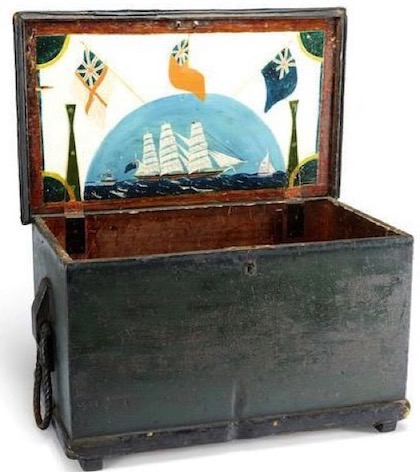
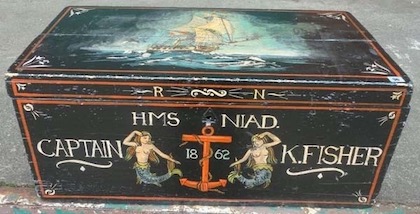



Carlo GATTI
Rapallo, 28 Novembre 2021
IL VELARIUM DEL COLOSSEO
IL VELARIUM DEL COLOSSEO
ALCUNE NOTE STORICHE
Il COLOSSEO, situato nel centro di Roma, è il più grande anfiteatro mai costruito al mondo. La struttura era in grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e 87.000 unità (di cui 45.000 seduti), ma è anche il più imponente monumento dell’antica Roma che sia giunto fino ai nostri giorni.

L’Anfiteatro Flavio, (é stato primo nome del COLOSSEO) fu iniziato da Vespasiano nel 70 d.C. e terminato da Tito nell’80. Ulteriori modifiche furono apportate durante l’impero di Domiziano nel ‘90. I lavori furono finanziati, come altre opere pubbliche del periodo, con il provento delle tasse provinciali e il bottino del saccheggio del tempio di Gerusalemme (70 d.C.).
La sua costruzione durò appena 2 anni e 9 mesi. Nella cerimonia di apertura vennero uccise oltre 5.000 belve in un’unica giornata. Per l’inaugurazione dell’edificio, l’imperatore Tito diede dei giochi che durarono tre mesi, durante i quali morirono circa 2.000 gladiatori e 9.000 animali. Per celebrare il trionfo di Traiano sui Daci vi combatterono 10.000 gladiatori.
Conosciuto molto più tardi (nel Medioevo) col nome di COLOSSEO dalla “colossale” statua in bronzo di Nerone (di oltre 30 metri di altezza - Realizzata tra il 64 ed il 69 d.C. per mano dello scultore Zenodoro) che un tempo era stata eretta in prossimità dell’Anfiteatro, che fu il primo ad essere costruito in pietra a Roma il quale, nonostante il suo crudele scopo, rimane uno dei prodigi architettonici del mondo.
Il COLOSSEO è un edificio di forma ellittica, dalle grandi dimensioni di 188 m di lunghezza, 156 m di larghezza e 48 m di altezza. Risulta in più punti gravemente danneggiato, ma conserva ancora l’originaria struttura.
La sua struttura è composta in effetti da due Anfiteatri greci semicircolari messi l’uno contro l’altro, che avevano però dimensioni minori.
Gli ultimi combattimenti tra gladiatori sono testimoniati nel 437, ma l’anfiteatro fu ancora utilizzato per le venationes (uccisione di animali) fino al regno di Teodorico il Grande: le ultime vennero organizzate nel 519, in occasione del consolato di Eutarico (genero di Teodorico), e nel 523, per il consolato di Anicio Massimo.
Il COLOSSEO, con la sua maestosità unica, rivela il genio degli architetti romani per gli effetti spettacolari ed esercitò una grande influenza sugli edifici dell’Europa più recente e, a proposito di effetti speciali, passiamo subito al tema che ci è tanto caro.
IL VELARIUM DEL COLOSSEO
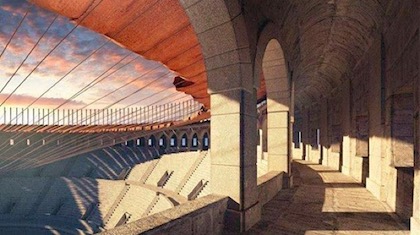
A questo punto vi chiederete: Ma cosa c’entra il COLOSSEO con la tradizionale linea cultural-marinara di MARE NOSTRUM RAPALLO?
Ve lo spiego subito! Si tratta solo di mettere a fuoco un “particolare MARINARO” di questa opera gigantesca che si chiama VELARIUM che ancora oggi viene studiato dalle maggiori facoltà d’Ingegneria e Architettura navale del mondo nell’intento di capirne la progettazione, l’installazione ed il funzionamento.
Per dare un’idea della complessità del problema, gli storici antichi ci hanno tramandato questa informazione:
Il VELARIUM era una magistrale opera di ingegneria. Il suo posizionamento, estremamente complicato, veniva svolto dai migliori marinai del distaccamento della Classis Misenensis.
Secondo stime di oggi il VELARIUM aveva un peso complessivo di circa 24 tonnellate e veniva manovrato da 1.000 provetti marinai abituati all’uso di cavi e cime di ogni calibro e lunghezza, di cui ognuno era destinato ad una precisa funzione.
Mare Notrum Rapallo ha dedicato un saggio a questa famosa Base navale.
CAPO MISENO - LA PIU’ POTENTE BASE MILITARE DELL’ANTICHITA’
Carlo GATTI – Storia Navale – Sito Mare Nostrum Rapallo
Lo scopo principale del VELARIO era quello di riparare gli spettatori dai raggi solari, ma anche dalle intemperie. Plinio, dopo aver narrato delle vele di vario colore adoperate nelle flotte di Alessandro Magno, e di quelle purpuree che aveva la nave con cui Marco Antonio andò ad Azio con Cleopatra, dice:
"Postea in theatris tantum umbram facere”; le quali parole c'insegnano che, abbandonato nelle navi l'uso di vele colorate, passarono queste a far ombra ai teatri.
Anche Lucrezio fa menzione di siffatto lusso nei velari: “Et vulgo faciunt id luten intenta. Theatris. Per malos vulgata trabesque trementia flutant”.
Dalla sommità del COLOSSEO partiva un complesso sistema di cavi/cime/catene, lungo le quali venivano distese enormi "vele" sospese sull'ARENA che consentiva la copertura della caveae (l’insieme delle gradinate in muratura dove prendevano posto gli spettatori).
La struttura presentava un anello al centro che favoriva l'aerazione dell'anfiteatro; inoltre, per attenuare possibili odori sgradevoli, durante gli spettacoli venivano sparsi tra il pubblico getti d'acqua odorosa ed essenze profumate (sparsiones).
“Il peso della struttura, che altrimenti sarebbe precipitata verso l'interno, era controbilanciato ancorando altre funi su dei cippi di pietra, collocati a raggiera all'esterno della zona anulare pavimentata in travertino ”.
Alcuni cippi sono ancora visibili sui lati nord ed Est, e il loro posizionamento equidistante fa presumere che in origine fossero in tutto ottanta.

Questa immagine (sopra) ricostruita al Computer, ha una eccellente funzione didattica sulla quale occorre fare riferimento per comprenderne la funzionalità e la dinamica operativa. Ad esempio, in primo piano si notano, (meglio con l’immagine ingrandita), che a sostenere il gigantesco tendaggio: il VELARIUM del Colosseo - vi erano 240 pali (colore scuro) di sostegno e sporgenti, inseriti in altrettanti fori quadrangolari, in corrispondenza di 240 mensole sporgenti di pietra, che si vedono in primo piano. (Vedi immagine sotto).
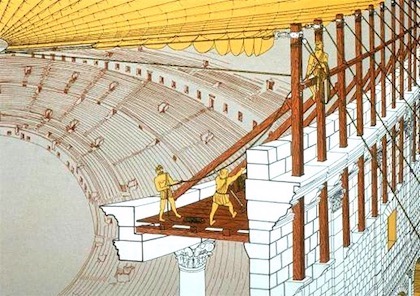
Il velarium era una copertura mobile in tessuto composta da più teli (o vele) di canapa, che veniva utilizzata nei teatri e negli anfiteatri romani per garantire agli spettatori un’adeguata protezione in caso di maltempo o nelle giornate di gran caldo.
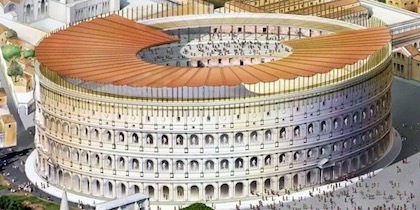

I fori a sezione circolare presenti sulla vela dell’arena di Verona databile all’anno 80 d.C.

Le mensole e i soprastanti fori quadrangolari sull'ordine superiore del Colosseo
Plinio, a proposito del VELARIUM scrisse: «uno spettacolo più stupefacente dei giochi stessi».
Alla legittima domanda: perché proprio i marinai erano necessari al funzionamento del VELARIO DEL COLOSSEO?
Rispondiamo con questa fotografia che spiega, senza l’aiuto di tante parole, chi sono e cosa possono inscenare i marinai “da cattivo tempo”.
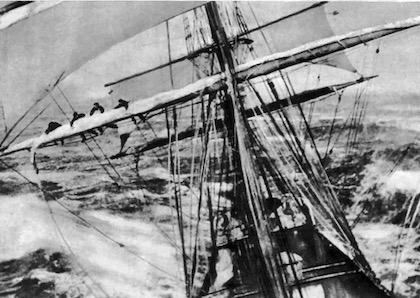
I marinai “annusano” le tempeste in arrivo e sono addestrati ad affrontarle in tempo per limitarne i danni. Ve lo immaginate se a causa di un groppo di vento* improvviso fossero cadute 24 tonnellate di vele con tutte le varie attrezzature metalliche sulla testa di 70.000/80.000 spettatori?
A questa domanda possiamo rispondere così: IL NUMEROSO EQUIPAGGIO DEL COLOSSEO ERA COMPOSTO DI VERI MARINAI E SOLO LORO ERANO IN GRADO DI GARANTIRE LA NECESSARIA SICUREZZA E FUNZIONALITA’ DELL’INTERO IMPIANTO.
*groppo di vento In meteorologia, perturbazione consistente nell'improvviso destarsi di venti con mutevole intensità e direzione, accompagnati da forti acquazzoni e turbini di grandine o di neve; dura in genere pochi minuti.
ANEMOSCOPIO DEL PALATINO
La pietra rinvenuta sul Palatino nel 1776, ora ai Musei Vaticani e ritenuta dagli archeologi un anemoscopio, era capace di valutare la direzione e, in qualche modo, anche l’intensità dei venti che potevano interessare il Colosseo. Questo strumento dimostra come i Romani tenessero monitorata questa FORZA per decidere, in base alle norme sulla sicurezza di allora, l’apertura o la chiusura del VELARIUM.
Plinio scrive che in presenza di un vento di notevole intensità si era spezzato un cavo del velarium e che la vela sbattendo faceva un suono che copriva quelli dello spettacolo in atto nella cavea (Colagrossi).
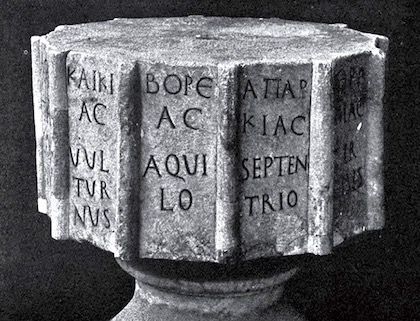
Lo strumento è datato al II - III secolo d.c. ed è ora in Vaticano (IG XIV, 1308). Ha etichette latine e greche dei venti. Il libro di Liba Taub "Ancient Meteorology" (Sciences of Antiquity) e riguarda gli antichi metodi di meteorologia che si sono confrontati a Roma tra l'Esquilino e il Colosseo,
ALCUNI REPERTI ARCHEO-MARINI FOTOGRAFATI DALL’AUTORE NEL MUSEO DELLE NAVI ROMANE
LAGO DI NEMI - LE NAVI DI CALIGOLA
Carlo GATTI – Articoli di Storia Navale

MUSEO DELLE NAVI ROMANE – LAGO DI NEMI

Nelle due foto (dell’autore) sopra e sotto, appare la ricostruzione di una delle due ‘Postazioni del Timoniere’ situate a poppa (a dritta) della prima nave, su cui sono state posizionate le copie bronzee delle cassette con protomi ferine.

Lo scavo dei relitti permette, seppur parzialmente, di conoscere l’attrezzatura delle imbarcazioni anche se la fonte principale per le sovrastrutture e la velatura proviene dalle rappresentazioni delle navi antiche (iconografia). Fortunati sono i casi di rinvenimento dei bozzelli in legno delle manovre delle vele oppure di frammenti di cime e cordami. Tra gli attrezzi più comuni, che spesso però viene ritrovato isolato, ricordiamo lo scandaglio che, munito nella sua parte inferiore di una cavità riempita di resina, serviva per conoscere natura e profondità del fondale nonché a seguire la rotta e a riconoscere i migliori luoghi di ancoraggio. L’ancora era lo strumento di bordo più importante e, di solito, ogni nave ne possedeva più di una di diverse dimensioni. In età romana, era costruita in legno con ceppo di appesantimento in piombo oppure interamente in ferro.

Noria a manovella originale di bordo

Pompa a stantuffo originale
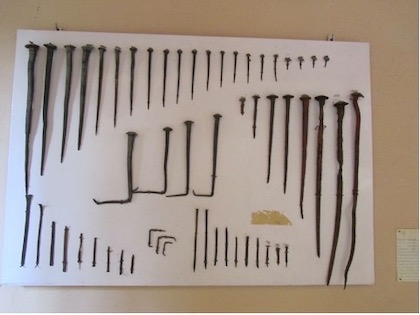
Alcuni esemplari dei chiodi utilizzati sulle due navi, di vari tipi e dimensioni: da pochi centimetri a oltre mezzo metro; dal tipo di sezione quadrangolare e capocchia piramidale a quello con testa schiacciata fornita di piccole protuberanze che servivano a far meglio aderire le lamine plumbee di rivestimento dello scafo.
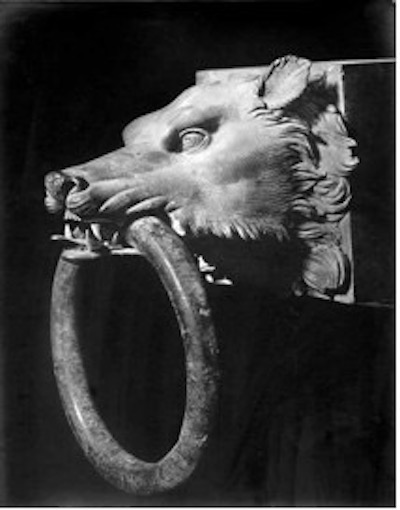
Una famosa protome ferina dalla forma di testa di felino che stringe tra i denti un anello che in marina si chiama ‘golfare’ ed é usato tuttora nei porti per ormeggiare imbarcazioni, ma anche per sollevare pesi.
E poi, ancora rulli sferici e cilindrici, paglioli, cerniere, filastrini in bronzo, tubi di piombo, ancora tegole di rame dorato, laterizi di varie forme e dimensioni, frammenti di mosaici con abbellimenti in pasta di vetro, lamine di rame ed altro.
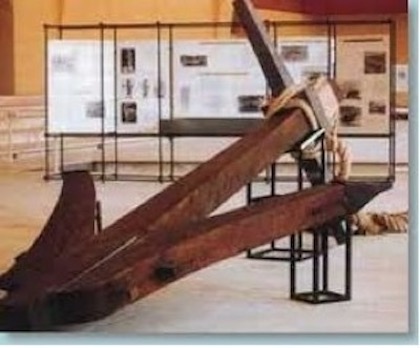
Ancora tipo “Ammiragliato”
MUSEO DELLE NAVI ROMANE – FIUMICINO
https://www.marenostrumrapallo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=260;fiumicino&catid=36;storia&Itemid=163
Carlo GATTI - Articoli di Storia Navale

All'interno delle vetrine sono esposti i materiali recuperati durante lo scavo delle imbarcazioni tra cui: tubi di piombo, rubinetterie, oggetti in bronzo, ceramica, resti organici e elementi dell'attrezzatura di bordo. Tali reperti sono esposti insieme a materiali rinvenuti durante scavi e recuperi nelle aree vicine.
In conclusione, per gli appassionati di questo tema (VELARIUM), suggerisco la lettura di uno STUDIO realizzato su basi matematiche e scientifiche, inerente le varie soluzioni legate all’uso (progettazione e realizzazione) del VELARIUM nella romanità di 2.000 anni fa.
http://amsacta.unibo.it/6307/1/Velarium%2007-01-2020%2B.pdf
Il velarium del Colosseo: una nuova interpretazione
Eugenio D’Anna e Pier Gabriele Molari
già docenti nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna
Bibliografia:
L’Anfiteatro Flavio – Marziano Colagrossi
L’Italia Antica e Roma - German Hafner
Le Strade di Roma
La Storia di Roma Antica – Michael Grant
Il Velarium del Colosseo - AMS Acta
Carlo GATTI
Rapallo, Giovedì 21 Ottobre 2021
STRETTO DI MESSINA-CACCIA AL PESCE SPADA
STRETTO DI MESSINA
SECONDA PARTE
LA CACCIA AL PESCE SPADA
LO SCHERMITORE DEL MARE

Il leggendario Stretto di Messina, di cui ci siamo occupati nella PRIMA PARTE, è da secoli l’ARENA naturale in cui si svolge l’eterna lotta tra gli uomini dello Stretto e il Pesce Spada. Una lotta in cui entrano in gioco elementi antichi che trasudano misteri, superstizioni, canti propiziatori e personaggi mutuati da favole e leggende che risalgono ad Omero, Polibio e Strabone. Lo "lo achermidore del mare" sempre stato un bottino ambito dai pescatori, non solo per il suo elevato potere nutritivo, ma anche per le sue dimensioni, che possono raggiungere i 4,5 mt di lunghezza per più di 400 kg. Queste caratteristiche, però, sono combinate ad una forza fisica, una resistenza e una furbizia tali da rendere questo pesce una preda difficile da catturare.
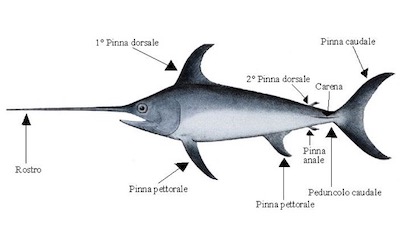

La caratteristica FELUCA usata nello Stretto di Messina per arpionare i pescespada. A prescindere da come le dimensioni e l’allestimento delle barche adibite alla caccia al pesce spada siano variati nel tempo, la tattica di base è rimasta una costante: avvistare il pesce, inseguirlo o attenderlo, lanciargli un arpione addosso e lottare fino alla resa. Con le moderne feluche questa resa è quasi sempre dell’animale, ma anticamente il duello terminava spesso con quella del pescatore, che rischiava addirittura la morte.
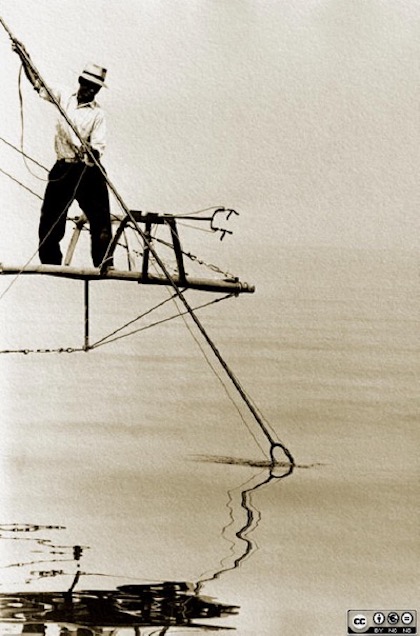
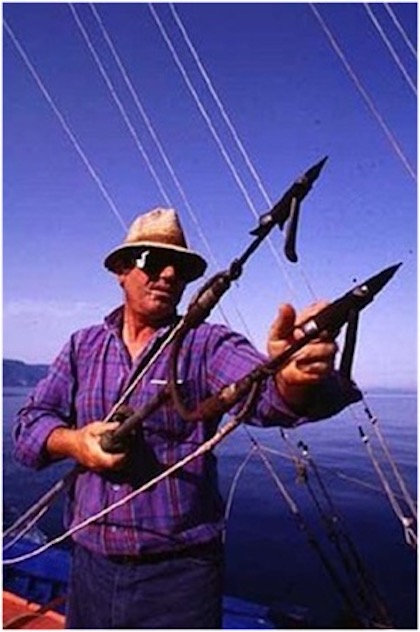

La pesca con l'arpione per la cattura del pesce spada è ancora praticata nello stretto di Messina. Questa pesca avviene nel periodo della riproduzione che nello Stretto di Messina va da maggio ad agosto, quando gli esemplari si avvicinano alla costa.
Si tratta di una “caccia” che nei secoli ha visto cambiare le imbarcazioni, la propulsione e l’attrezzatura ma non il coraggio e la personalità di chi, per affrontare un mostro potente e velocissimo di 4/5 metri, deve conoscerlo nella più profonda intimità per affrontarlo, vincerlo e catturarlo. Ciò avviene ancora oggi, ma solo sul piano di strategie antiche che non s’imparano nei manuali di pesca e neppure servendosi di strumenti moderni super tecnologici. Nulla di tutto questo!


Il duello è regolato dall’intelligenza e dall’astuzia dei contendenti che prima s’individuano, poi si studiano come due pugili che s’inseguono sul ring senza toccarsi, infine, s’affrontano ognuno con le proprie armi sino alla fine del confronto che non è mai scontato.

IL PESCE SENTIMENTALE - Non si lega facilmente, se si innamora è per sempre. Con la spada difende la compagna a costo della vita
A questo punto ci viene in mente Domenico Modugno quando nel 1954 portò sulle scene della neonata Televisione un brano che racconta questa incredibile storia: LU PISCE SPADA
“…..E pigliaru la fimminedda, drittu drittu ‘n tra lu cori, //E chiangia di duluri.//Ahai ahai ai.
E la varca la strascinava //E lu sangu ci curriva, //E lu masculu chiangiva, Ahai ahai ai…..”
La femmina del pesce spada viene arpionata al cuore, il maschio cerca di liberarla dalle reti. Le sta accanto fino all’ultimo istante offrendosi di morire insieme a lei, allo stesso modo.
Impazzisce il pesce spada che per bocca di Modugno urla che “si tu mori, vogghiu murìri ‘nzemi a ttia”.
Morirà anche lui arpionato dall’uomo che dalla lunga passerella della “feluca” non lo perdona ma ogni volta si commuove inchinandosi a questo cavaliere romantico, avversario coraggioso che merita rispetto e ammirazione perchè si fa uccidere per amore.
Non è una storia inventata. E’ una storia maledettamente vera che nel basso tirreno si ripropone intatta da millenni. Lo sanno bene i pescatori dello Stretto di Messina, tra Scilla, Bagnara Calabra, Palmi e Torre Faro.
Purtroppo la legge di natura non è così romantica: è sempre la femmina del pesce spada che va colpita per prima, non solo perché di dimensioni più grandi, ma perché in questo modo si potrà essere certi di catturare anche il maschio, che mai abbandona il suo amore.
UN PO’ DI STORIA
Le prime fonti che c’informano sulla pesca del pesce spada di cui abbiamo accennato all’inizio, risalgono al II secolo a.C. Le imbarcazioni erano di dimensioni ridotte ed erano per così dire “pilotate” da terra, da una rupe alta a sufficienza per avvistare la preda. Ciò avveniva specialmente sulla sponda calabrese più alta della dirimpettaia costa pianeggiante della Sicilia. L’avvistatore segnalava gli spostamenti del pesce spada con diversi sistemi: con bandiere o a voce.


Tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500, si realizzò l’idea di affiancare al luntru una barca accessoria che, opportunamente zavorrata e ormeggiata vicino o lontano dalla costa, fungeva da “osservatorio galleggiante”, con la stessa funzione di vedetta delle rupi calabresi.


La feluca è una barca piccola, lunga dai 5 ai 7 metri, senza chiglia, alla quale veniva richiesta la massima stabilità, con un equipaggio di cinque rematori e un arpioniere. Questi cambiavano a volte disposizione, ad eccezione del quinto uomo che saliva sull'albero maestro per avvistare la preda.
Questa nuova imbarcazione di origine messinese, venne denominata Feluca e considerata una barca da posta, proprio per la sua mansione. Per adempiere al suo compito, l’avvistatore necessitava di una posizione più elevata possibile: per questo motivo, a centro-nave, venne innalzata una torretta (detta ‘ntinna) alta dai 15 ai 22 m e dotata di opportuna scaletta, dalla quale era facile segnalare la posizione del pesce agli uomini dei luntri associati. Essi, rimasti in attesa del segnale, si lanciavano veloci all’inseguimento della preda utilizzando la stessa collaudata tecnica dei pescatori calabresi. Solitamente le feluche da posta erano due o tre, ancorate su zone diverse, in modo da ricoprire un più vasto campo d’avvistamento.
Dovendo fungere da osservatori fissi, le feluche non necessitavano di un proprio mezzo propulsivo; i luntri corrispondenti, quindi, le rimorchiavano sulle posteprestabilite.
Luntru GANZIRRI

“Il luntru, partendo dalla base delle pendici calabresi, si dirigeva rapido verso il pesce indicato, grazie a 4 rematori in piedi (introdotti a fine 800); una caratteristica di questa fase (inseguimento) era l’avanzamento di poppa del natante, il quale presentava ottime capacità manovriere anche contro corrente. I 4 remi erano, infatti, di grandi dimensioni in proporzione allo scafo: i due remi a poppavia erano lunghi entrambi 4.68 m; quelli a pruavia 5.46 e 5.72 m.
L’efficacia dell’inseguimento era garantita da un altro pescatore che, al vertice di un piccolo albero (detto farere) alto 3÷3.5 m e posto a centro-nave, dirigeva i rematori e il lanzaturi munito di fiocina”.
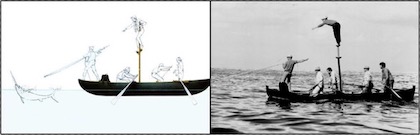
Questa bellissima foto scattata ai primi del ‘900, non ha bisogno di tanti commenti in quanto riprende il LUNTRE, una barca lunga 5,49 mt. larga 2,44 mt. ed alta 1,22 mt., al cui centro vi era un albero La FARIERA con tanto di fermapiedi, dove in piedi il VARDIANO stava di vedetta e IL LANZATURI era appostato di prora. L’imbarcazione, originariamente, era a remi, ed il suo equipaggio era costituito da 6-8 marinai.
Ci spiegano che per issare a bordo il pesce spada catturato, servivano un paio di uncini ed una corda; l’armamento era costituito anche da due “cannistri”, vari tipi di coltelli, e il cosiddetto “bumbulu” per conservare l’acqua utile ai marinai per rinfrescarsi.
Tuttavia per entrare nello spirito vero di questa antica “caccia” al pesce spada, non possiamo che affidarci al racconto di chi VIVE da vicino la mattanza nel rispetto delle tradizioni e degli antichi rituali.
Da alcuni prestigiosi siti web locali riportiamo:

… ad esempio, nelle ultime sparute antiche palamitare, sopravvive l'uso di porre a prua un'asta con alla sommità una palla azzurra o rossa in legno, su cui erano dipinte le stelle dell'Orsa maggiore, separate da una fascia bianca, con probabile riferimento alla cultura fenicia.
Un rituale ormai svanito, anche se molte parole permangono nell'espressione dialettale, era quello di accompagnare la pesca con cantilene in greco, perchè la superstizione voleva che se si fosse cantato in altra lingua il pesce sarebbe andato perduto.
Meno intellettuale è il rituale della "runzata", che consisteva nel fare urinare le reti dai bambini, per augurio di una buona pesca.
Un altro rituale, che è divenuto col tempo una specie di diritto territoriale, era quello di suddividere le zone di mare in aree (posta) da assegnare agli equipaggi e in cui pescare.
Lo schiticchio o scialata era un pranzo o una cena abbondantissima che i padroni delle barche offrivano ai marinai nelle feste dei mesi invernali, per sopperire, specie nei tempi in cui la fame si faceva più sentire, alle necessità alimentari della famiglie, che potevano, fra l'altro, rifornirsi per un po' di tempo con il cibo non consumato. Era anche l'occasione per contrattare gli uomini dell'equipaggio per la stagione successiva.
La tradizione dello schiticchio permane ancora oggi, ma al solo scopo di incontrarsi con gli amici in uno spirito di convivialità.
Cardata da cruci


La tradizione vuole che uno dei pescatori, ed esclusione del lanzaturi, cioè di colui che ha lanciato l’arpione, faccia la “cardata da cruci”, segni cioè con le unghie della mano, quattro croci accanto al foro dell’orecchio destro del pesce appena issato sulla barca. Si ritiene fosse un segno augurale, di prosperità o una sorta di riconoscimento “dell’onore delle armi” al pesce per il suo nobile valore di combattente.
In relazione alla cattura, la carne attorno al punto in cui si è conficcato l'arpione (botta) andava al ferraiolo (mestiere pressoché sparito), in qualità di proprietario dell'attrezzo, che veniva dato in affitto. Il taglio del ciuffo spettava invece al fiocinatore.
Ancora adesso, se si avvista una parigghia (un maschio e una femmina), la tradizione vuole che il primo pesce ad essere fiocinato sia la femmina, in modo che si possa fiocinare successivamente il maschio, in quanto questi resta nei paraggi nella ricerca della compagna.
Anche la nomenclatura volgare del pescespada è legata in qualche modo alla stagionalità della pesca, tanto che i pescatori, con un po' di fantasia, riescono ancora distinguere diverse varietà. Così c'è un ipotetico pisci i jùsu, un pisci 'i San Giuvanni, un pisci niru e addirittura un pisci invisibili.
Se per molto tempo non si riusciva a pescare pescespada, il rituale era quella della benedizione della barca da parte di un prete o nei casi più ostinati bisognava fare ricorso a formule magiche e pozioni le più disparate. Se la pesca tardava ancora ad essere proficua una ragazzina doveva fare la pipì sulla prua (questa pratica era in auge specie in Calabria).
In entrambe le sponde dello Stretto (Sicilia e Calabria), si era soliti ringraziare, una volta pescato il pesce, il Santo protettore del “faliere” gridando “San Marco è binidittu”. Un ulteriore antico “rituale” era quello di tracciare con le unghie un croce quadrupla sul pesce spada, precisamente sulla guancia destra, simbolo di benedizione, di scongiura al malocchio, e di una pesca fruttuosa. Alcuni pescatori posizionavano nella bocca del pesce un pezzo di pane, mangiando delle parti crude dello stesso pescato.
Come si evince, si credeva molto al malocchio: anche i colori dell’imbarcazione, nero, verde e rosso, erano scelti come forma di scongiura.
PRIMI ANNI ’60 – LA SVOLTA
Evoluzione ed innovazione della feluca spadara:
La passerella

Quando il pesce spada veniva avvistato veniva segnalato da urla e sbandieramenti, diventava proprietà dell’equipaggio che l’aveva individuato, e la barca guadagnava così il diritto di “sconfinare” nei settori assegnati alle altre barche, fino alla eventuale cattura. Fino agli anni 50’ per la pesca al pesce spada si usava, come abbiamo visto, il “luntre”.
Oggi nello stretto e lungo la costa Calabra del Tirreno, per la pesca del pescespada si usano barche a motore che hanno un traliccio alto 20-25 m, alla cui sommità si trovano avvistatori e timonieri, e una passarella molto lunga, alla cui estremità va il fiocinatore (fureri).
FELUCA SPADARA MODERNA

1. dall’alto della ‘ntinna l’avvistatore individua il pesce spada e lo comunica sia al resto dell’equipaggio, che si trova sulla barca, sia al lanciatore a prua (sul luntru era poppa) appostato sulla passerella. Grazie ad un sistema di trasmissione, l’avvistatore manovra la feluca, potendo disporre di tutti i comandi necessari direttamente sulla cima della torretta (marcia avanti/indietro, acceleratore, timone). Quindi egli si occupa sia dell’avvistamento che dell’inseguimento del pesce spada, motivo per il quale il luntru ha lasciato il posto.
2. in perfetta armonia con l’azione dell’avvistatore (dettaglio non scontato), il fiocinatore si prepara al lancio dell’arma, spostandosi sulla passerella. Quest’ultima, a differenza dello scafo, risulta invisibile al pesce, grazie ad una struttura a traliccio (non genera ombra), e alla posizione emersa dall’acqua. Ciò permette al pescatore di avvicinarsi o addirittura trovarsi perfettamente al di sopra della preda.

Nel 1952 il pescatore Antonio Mancuso inventò la passerella per l’arpionaggio, un’innovazione che ha completato definitivamente l’aspetto funzionale della feluca, la barca moderna che ancora oggi si può ammirare in azione sullo stretto di Messina od ormeggiata sulla riviera dell’antico borgo di Torre Faro (Messina).
Con l’introduzione della passerella e l’avvento del motore, le tre fasi della strategia sono oggi tutte eseguite da un’unica imbarcazione. Poiché essa assume non solo il ruolo originario di barca da posta, ma anche di luntru aumentando il profitto globale dell’attività.
La ‘ntinna, un traliccio metallico, è stata elevata fino a 30÷35 m, dotata di collegamenti e leve di controllo del timone e del motore (dagli 80 ai 350 CV) ed equipaggiata di una coffa, dove si apposta l’avvistatore-timoniere.
Come a simulare la spada del pesce, la passerella(traliccio metallico orizzontale) si estende a pruavia della feluca per una lunghezza di 35÷40 m . Essa è in parte retrattile, sicchè può essere ritirata in caso di necessità.
Riguardo l’installazione dei due tralicci tra essi ortogonali, sono saldamente collegati tra loro e allo scafo tramite cavi d’acciaio e tiranti. Con questo complesso sistema di funi, i due oggetti si bilanciano, garantendo l’equilibrio strutturale del natante.
La lunghezza dello scafo della feluca spadara è di circa 25 m (esclusa la passerella) ed è ancora realizzata in legno. Rispetto al luntru, i colori scelti sono più vivaci (tradizionalmente il verde, il bianco, il rosso e l’azzurro). La feluca, quindi, si rivela essere un’incredibile macchina da pesca ed un simbolo della storia marittima siciliana.

Elenco dei siti consultati
L’antica pesca del pesce spada nello Stretto di Messina.
L’ecodelsud.it
Caccia al pesce spada, una tradizione della Costa Viola
Un viaggio tra Calabria e Sicilia alla scoperta delle antiche usanze dei pescatori
Rituali nella pesca del Pescespada nello Stretto di Messina
https://www.colapisci.it › Cola-Ricerca › Luoghi › Ritua...
La prima, veloce e maneggevole, era per la pesca diurna e veniva chiamata luntru. Luntru - Ganzirri. Luntru con il classico equipaggio. Il luntro aveva un ...
Ricerche correlate
pesce spada stretto di messinafeluca pesce spadabarca per pesce spada
pesce spada periodo di pesca 2020pesca al pesce spadapasserella pesce spada
Pesca del pesce spada nello stretto di Messina - Taccuini ...
https://www.taccuinigastrosofici.it › antica › usi-costumi
Gli originari posti di avvistamento (torrette che si trovavano specie sulla costa calabra) sono stati, quindi, abbandonati e la caccia al pesce spada, dopo ...
La caccia al pesce spada nello Stretto di Messina
https://www.edas.it › Collana Messina e la sua storia
BATTUTA DI CACCIA AL PESCE SPADA - PAN Travel ...
https://www.pantravelsolution.com › servizi › servizio-1

Ringrazio sentitamente gli Amici siciliani che ci hanno concesso la divulgazione al NORD di questa meravigliosa AVVENTURA!
Carlo GATTI
Associazione MARE NOSTRUM RAPALLO
Rapallo, 7 Settembre 2021
STRETTO DI MESSINA-ULISSE - MITI E LEGGENDE
STRETTO DI MESSINA
PRIMA PARTE
ULISSE - MITI E LEGGENDE
Lo Stretto di Messina (u Strittu), chiamato nell'antichità Stretto di Scilla e Cariddi, è un braccio di mare che collega il Mar Ionio con il Mar Tirreno, separa la Sicilia dalla Calabria e l'Italia peninsulare dal continente.
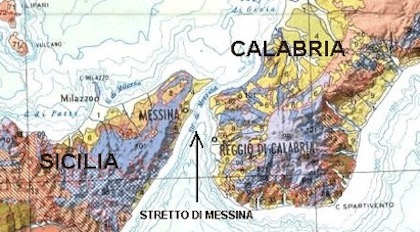
Perché parlare di ULISSE nel 2021?
Perché il difficile passaggio dello Stretto di Messina, appartiene alla storia dell’eroe omerico, al suo mare minacciato da Scilla e Cariddi, dalle Sirene e dai Mostri che oggi portano nomi scientifici, ma sono ancora il retaggio di superstizioni vive che ci riportano all’Ulisse uomo di mare che ancora ci illumina come un faro.
ULISSE è uno dei personaggi più amati della letteratura di tutte le epoche, uno dei pochi “miti” capace di passare da un’opera all’altra nella perenne “odissea” della vita, tanto che questo celebre nome è diventato sinonimo del “viaggio” terreno dell’umanità tra le infinite difficoltà che incontra ogni giorno. E si può ancora dire che dai secoli di Omero, 800 avanti Cristo fino al Terzo Millennio, Ulisse c’è, e sta ancora viaggiando perché è dentro ognuno di noi!
La sua fama, così duratura nel tempo, è indice della sua innata modernità imbevuta di malizia, individualismo e intelligenza. Il suo sempre attuale carisma è il riflesso di tante capacità che entrano in gioco nei momenti più difficili: sopportazione, curiosità, diffidenza, pazienza, coraggio e astuzia militare. Non solo! Perché Ulisse è l’emblema dell’ingegno, della calcolata freddezza che gli permette d’uscire sempre indenne dalle tempeste della vita usando qualsiasi mezzo, anche estremo.
Ma prima di immergerci nelle “acque infide dello Stretto” ci è caro fare una breve premessa da uomini di mare ...
Chi ha navigato nello Stretto di Messina più volte nelle due direzioni, in tutte le stagioni e con qualsiasi tempo, sa quanto possano sembrare "impressioni di realtà" le leggende che avvolgono quel passaggio. Oggi, naturalmente, quelle leggende hanno una spiegazione scientifica che vieta ogni riferimento ai mostri marini, alle sirene, ai miraggi ed altro, tuttavia i pericoli nello Stretto ci sono sempre e si chiamano vortici, scontro di correnti di marea, differenza di temperatura tra il mar Ionio ed il Tirreno che tra poco approfondiremo, infine c’è il traffico intenso di navi che incrociano da tutti i quadranti della bussola e che oggi, nonostante il transito sia regolamentato e controllato, è più sicuro ma non per questo è privo di pericoli.
Per entrare ancor più nell’attualità dell’argomento, chi scrive può testimoniare d’aver perso il controllo del governo di una petroliera di 30.000 tonnellate nell’attraversamento dello Stretto per almeno 30 lunghi secondi, a causa dei vortici di Cariddi. In un’altra occasione, per la stessa causa, sempre risalendo lo Stretto da Sud a Nord, con a rimorchio una nave da carico, con il cavo ridotto a 600 metri, perdemmo il controllo della rotta e fummo costretti ad issare i fanali rossi di non governo, ad emettere un Avviso radio di Sicurezza circolare a tutte le navi in transito ed infine a compiere un cerchio in un momento di traffico intenso…
Chi conosce la realtà dello Stretto ha le sue avventure da raccontare…
Posso inoltre confermare che molti Comandanti stranieri che navigano in direzione Suez-porti tirrenici e viceversa, preferiscono evitare il transito dello Stretto per motivi di sicurezza.
Non so esattamente quante siano state le collisioni avvenute nello Stretto nel tempo, ma ormai da parecchi anni, ogni nave si stazza superiore alle 15.000 tons deve prendere obbligatoriamente il Pilota di Messina per il transito nelle due direzioni.
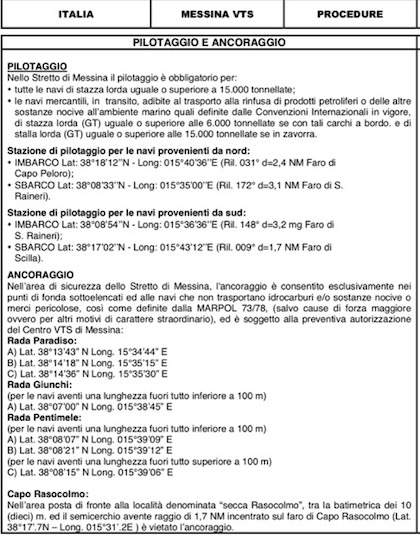
Un po’ di Storia…
Lo Stretto era probabilmente praticato in epoca preistorica dai Sicani e poi dai Siculi, che in tempi diversi dovettero passare dal continente nell’isola. Dopo l’VIII secolo a.C., in seguito alla conquista dei Greci, lo Stretto divenne più noto, perché transitato dai fondatori di Cuma e di altre città. In seguito gli Ioni, fondatori di Zancle (Messina), vollero che sulla riva opposta sorgesse una città sorella, in modo da controllare questo vitale passaggio. Gli Etruschi ottennero il libero transito finché, dopo la sconfitta subita a Cuma (474 a.C.), perdettero il dominio del mare. Subito dopo lo Stretto divenne oggetto di fiere contese tra Reggio e Siracusa, alleata di Locri. In seguito alla distruzione, da parte dei Cartaginesi, di Messana (396 a.C.), rapidamente risorta e divenuta siracusana, la questione dello Stretto, che per tre secoli aveva indotto le città achee a trovarsi scali sul Tirreno attraversando i monti, venne finalmente risolta da Dionisio il Vecchio dopo che questi ebbe conquistato Reggio (387 a.C.). Nel III secolo a.C. fu Roma a mirare alla padronanza dello Stretto (Fretum Siculum), per la lotta contro Cartagine e il possesso della Sicilia. Con il predominio romano del Mediterraneo, l’importanza dello Stretto diminuì, rimanendo però sempre notevole, anche nel medioevo, per i commerci col Levante e per le imprese militari, allorché la Sicilia passò via via ai Bizantini, agli Arabi, ai Normanni e agli Svevi.
Guida d’Italia. Basilicata e Calabria, Touring Club Italiano, Milano 1980
Ma ora ritorniamo ad ULISSE e alla sua STORIA mitologica
Uno degli episodi più celebri è raccontato nel libro XII, dell’Odissea di Omero, quando Ulisse e la sua ciurma, provenienti dall’Isola di Circe (Circeo) navigano verso Sud per ritornare ad Itaca. Lo Stretto si mostra dinanzi ai loro occhi, e per proseguire il viaggio devono attraversarlo; tuttavia, sulla sponda sinistra, sopra uno scoglio, si erge un terribile mostro a sei teste, Scilla, (lato Calabria) mentre sul lato destro risiede un letale mostro marino, Cariddi (lato Sicilia).
La necessità di percorrere la via di mezzo, o quasi, è diventata proverbiale: infatti, quando si afferma di ‘essere tra Scilla e Cariddi’, s’intende il trovarsi in una posizione problematica.
Ulisse sa (perché la maga Circe glielo aveva rivelato) che sebbene Scilla possa attaccarlo con le sue sei mostruose teste (ognuna delle quali contiene tre file di denti aguzzi), e quindi afferrare e uccidere sei dei suoi uomini, Cariddi rappresenta una minaccia ancora più letale, poiché essere risucchiati dai vortici marini che il mostro marino provoca tre volte al giorno, si rivelerebbe fatale per l’intera nave e tutti gli uomini a bordo.
Perciò Ulisse deve navigare nel mezzo, consapevole che se ci dovesse essere un margine di errore sarebbe meglio tendere leggermente a sinistra, verso il lato di Scilla, piuttosto che a destra, poiché in quest’ultimo caso andrebbe incontro alla distruzione totale. Emozionante! Questa difficile situazione è senz’altro una metafora della vita stessa.
“Da una parte ci sono rupi aggettanti, contro cui si frange
con grande fragore l’onda di Anfitrite dagli occhi scuri:
gli dèi beati le chiamano Le erranti.
Di lì non passano neppure gli uccelli, né le trepidanti
colombe, quelle che a Zeus padre portano ambrosia.
Sempre qualcuna ne toglie la roccia liscia,
e il padre un’altra ne manda che ristabilisca il numero.
Di lì mai sfuggì nave di uomini che vi fosse giunta,
ma tavole di navi e insieme corpi di uomini trascinano via
le ondate del mare e i vortici di fuoco funesto.
Una sola nave di lungo corso di lì è riuscita a passare,
Argo da tutti celebrata, che tornava dal paese di Aieta”.
Lì dentro abita Scilla dal latrato inquietante:
la sua voce è pari a quella di una cagnetta poppante,
ma essa è invece un mostro malvagio, e nessuno
a vedersela di fronte gioirebbe, nemmeno un dio.
Dodici sono i suoi piedi, e tutti malformati,
ha sei colli lunghissimi, e ciascuno ha una orrida
testa, e in ognuna ci sono tre file di denti,
moltissimi e fitti, pieni del nero della morte.
Per metà sta sprofondata nell’antro profondo,
ma dal terribile baratro tiene fuori le teste.
Qui pesca, frugando lo scoglio all’intorno,
delfini, pescicani e mostri più grandi, se càpita,
afferra, quanti innumerevoli nutre la mugghiante Anfitrite.
Di lì con la nave nessuno si vanta di esser fuggito
indenne da morte; con ogni singola testa un uomo si prende:
lo afferra da sopra le navi dalla prora scura.
L’altro scoglio vedrai, Ulisse, molto basso, l’un all’altro
vicini: un tiro di freccia la distanza percorre.
Su di esso è un gran fico selvatico, fiorente di foglie.
Sotto, Cariddi divina risucchia l’acqua scura.
Tre volte al giorno emette, tre volte risucchia,
terribile. Che tu non sia lì quando inghiotte:
nemmeno l’Enosictono ti salverebbe da morte.
Accòstati molto allo scoglio di Scilla e presto
porta fuori la nave. Molto meglio sei compagni
piangere sulla nave che non piangerli tutti’.
“Solcavamo gemendo l’angusto passaggio:/ da una parte era Scilla, dall’altra Cariddi/ divina, che l’acqua salata inghiottiva del mare/ con suono tremendo, che poi rigettava di fuori/ e tutta in gorgoglio travolta bolliva/ come una caldaia sul fuoco che arde:/ la schiuma in alto lanciata giù ricadeva/ battendo le cime d’entrambi gli scogli./ E quando di nuovo l’acqua salata inghiottiva/ del mare pareva sconvolgersi dentro;/ […] lo sguardo era fisso a Cariddi, fisso alla morte./ Fu allora che Scilla ghermì dalla nave/ concava sei dei compagni, i più forti;”
Ulisse (Odisseo) tenta di superare i mostri Scilla e Cariddi. Scilla mangia sei volte sei compagni di Ulisse, mentre Cariddi risucchia le acque. Dopo aver affrontato i due mostri, Odisseo, approdato con i suoi compagni sull'isola di Trinacria, non riesce a frenare la voglia dei compagni di banchettare con le invitanti mucche di Elio (altre versioni dicono di Era o Apolo). Per questo Odisseo racconta di essere stato per nove giorni in balia di terribili tempeste scatenate da Zeus, con la nave e i compagni uccisi da Scilla.
Ulisse riesce così ad evitare il naufragio dell’intera nave sacrificando però sei dei suoi compagni, e tristemente continua il suo viaggio fino a Itaca.

In realtà, proprio dove il mito si fonde con la leggenda e dove i racconti antichi trovano poi riscontro, ecco che ci si chiede: ma chi erano Scilla e Cariddi?
Due ninfe diventate mostri

Le statue di Scilla e Cariddi scolpite da Giovanni Angelo
Montorsoli sulla fontana di Orione a Piazza Duomo.
Ci sono diversi racconti popolari tradizionali che hanno fatto nascere molte leggende attorno a Scilla e Cariddi, ma è certo che prima di essere tramutate in due mostri, esse erano due bellissime ninfe del mare.
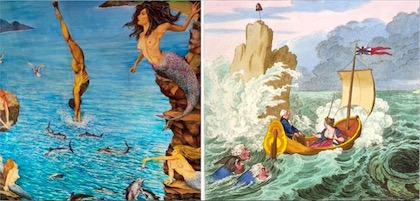

SCILLA
Scilla, dagli occhi azzurri, era figlia di Forcis e Ceto, figlia di Gea e Ponto, anch’esso un mostro simile ad una balena. Secondo il mito, Scilla vive presso le rive di Zancle, in Calabria, e lì che incontrò Glauco, figlio di Poseidone, che s’innamorò perdutamente di lei.
Ciò nonostante la ninfa respinse il dio marino e quest’ultimo chiese aiuto a Circe, per conquistarla. La maga, però s’innamorò di Glauco e gli chiese di diventare il suo compagno, ma egli rifiutò, perché era completamente rapito da Scilla. Allora la maga trovò il modo di rifilare alla bella ninfa un filtro, che la trasformò in un essere mostruoso, dalle molte gambe serpentine, alle cui estremità si trovano delle bocche con cui divorava i marinai. Scilla, allora, si rifugiò in una grotta, nello stretto di Messina, insieme a Cariddi. Una immagine spaventosa che ha alimentato la loro fama.
La storia è diversa per Cariddi, una naiade figlia di Poseidone e di Gea, ma a differenza della prima, lei era dedita alle rapine prima di diventare un mostro, ed era nota per la sua voracità. Zeus, dopo che ella rubò dei buoi a suo figlio Eracle e a Gerione, il gigante a tre teste, decise di punirla gettandola in mare e trasformandola in un mostro orrendo, simile a una lampreda.
Si dice che per risucchiare le sue vittime, Cariddi creava dei veri e propri vortici nel mare, dove le navi affondavano e lei poteva soddisfare la sua voracità. Lo stesso avvenne poi nei racconti narrati nell’Odissea, dove lo stesso Ulisse si trovò ad affrontare i due terribili mostri.



Geograficamente Cariddi è collocabile sulla punta messinese della Sicilia, a Capo Peloro.
Scilla è sulla spiaggia calabrese, da Punto Pizzo ad Alta Fiumara.
OMERO - ODISSEA
SCILLA E CARIDDI
L’altro scoglio, più basso tu lo vedrai, Odisseo, / vicini uno all’altro, / dall’uno potresti colpir l’altro di freccia. / Su questo c’è un fico grande, ricco di foglie; / e sotto Cariddi gloriosamente l’acqua livida assorbe. / Tre volte al giorno la vomita e tre la riassorbe / paurosamente. Ah, che tu non sia là quando riassorbe.
A rendere un’Odissea il passaggio nello Stretto, sin dai tempi in cui Messina era una perla della Magna Grecia, erano soprattutto le correnti irregolari e imprevedibili, capaci di raggiungere una velocità di svariati km/h e di generare vortici letali. Fra questi, due in particolare avevano le sembianze mostruose di esseri ultraterreni, Cariddi (“Colei che risucchia”) sul versante siculo, nei pressi di Torre Faro, e la dirimpettaia Scilla (“Colei che dilania”), nello specchio d’acqua su cui si specchia Cannitello, fra Alta Fiumara a Punto Pezzo.
Figlia di Poseidone (dio il mare) e di Gea (dea la terra), Cariddi. Punita da Zeus per la sua insaziabile voracità e trasformata in un mostro marino, funestava le imbarcazioni in transito sullo Stretto, ingoiando tre volte al giorno un enorme quantità d’acqua per poi sputarla, “deglutendo” barche e marinai. A parlare di Cariddi sono Omero, nel canto XII dell’Odissea, Virgilio, nell’Eneide, e anche Dante, che nell’Inferno si serve dell’immagine del mostro marino per descrivere l’eterno scontrarsi degli avari e dei prodighi: era una delle Naiadi (ninfe che presiedono a tutte le acque dolci della terra) che secondo alcune versioni avrebbe prima rubato e poi divorato i buoi.
(«Come fa l’onda là sovra Cariddi, / che si frange con quella in cui s’intoppa, così convien che qui la gente riddi»).
LA LEGGENDA DELLA FATA MORGANA


Stretto di Messina - La leggenda di Fata Morgana
Una illusione Ottica
di Carlo GATTI
LINK
Dalla costa reggina molto di rado, per breve tempo e di solito in giornate calde e con aria e mare calmi, si produce il noto fenomeno di miraggio detto fata morgana, che dà l’impressione di un avvicinamento della costa sicula, gli edifici della quale si prospettano in mare o nell’aria con immagini stranamente allungate, deformate, sempre nuove, simulando città fantastiche e anche schiere di uomini in moto.
La leggenda ci tramanda che, dopo aver condotto suo fratello Artù ai piedi dell'Etna, Morgana si trasferisce in Sicilia tra l'Etna e lo stretto di Messina, dove i marinai non si avvicinano a causa delle forti tempeste, e si costruisce un palazzo di cristallo.
Sempre in base alla leggenda, Morgana esce dall'acqua con un cocchio tirato da sette cavalli e getta nell'acqua tre sassi, il mare diventa di cristallo e riflette immagini di città.
Grazie alle sue abilità, la Fata Morgana riesce ad ingannare il navigante che, illuso dal movimento dei castelli aerei, crede di approdare a Messina o a Reggio, ma in realtà naufraga nelle braccia della fata.
Guardando da Messina verso la Calabria, si vede come sospesa nell'aria l'immagine di Messina e, viceversa, guardando da Reggio Calabria verso Capo Peloro, si vede Reggio nello stretto.
RIENTRIAMO ORA NEL TERZO MILLENNIO
Siamo nel 2021 e dobbiamo precipitosamente ritornare con i piedi sulla terraferma per rivolgerci alla SCIENZA che ci spiega in breve cosa succede da sempre nello Stretto:
Il braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia è largo oltre 3 chilometri a nord, fra Torre Cavallaro e il Capo Peloro, e 16 chilometri circa a sud, fra la Punta Péllaro e il Capo d’Alì; nel senso della lunghezza si estende per 33 chilometri. La profondità varia da 120 a 150 metri nel punto più stretto. Contrariamente all’opinione, diffusa nell’antichità dai filosofi greci, che lo Stretto fosse stato aperto da un terremoto o dalla furia del mare agli albori della storia, i moderni studi geologici hanno dimostrato ch’esso esiste da tempi molto remoti: per lo meno dall’epoca in cui ebbero luogo quei movimenti della crosta terrestre che furono alla base della struttura dell’Appennino; lo Stretto, anzi, doveva essere più largo di oggi. La navigazione in esso fu ritenuta pericolosa fin dall’antichità e in effetti presenta difficoltà soprattutto per le correnti rapide e irregolari e per i venti che vi spirano violenti e talvolta in conflitto.
La corrente principale, dovuta al livellamento dei bacini tirrenico e ionico attraverso lo Stretto e al relativo flusso, va da sud a nord col nome di rema montante; quella determinata dal riflusso, con direzione opposta, si chiama rema scendente. Queste correnti toccano una velocità massima di oltre 9 chilometri all’ora e si alternano di sei in sei ore; di norma raggiungono l’intensità massima dopo 4 ore dall’inizio e diminuiscono fino a mezz’ora prima della corrente opposta. Ogni corrente ha ai lati i bastardi, cioè controcorrenti, che si sviluppano in località note circa un’ora dopo l’inizio della corrente. Nei punti d’incontro di correnti opposte, oppure dove una corrente trova notevoli differenze di fondo, si formano vortici detti garófali o réfoli, di cui i principali sono quelli chiamati dagli antichi Scilla e Cariddi, che si formano con la montante, il primo sulla costa calabrese da Alta Fiumara a Punta Pezzo, il secondo alla spiaggia del Faro. I due famosi vortici derivano dall’urto delle acque contro la Punta Torre Cavallo e il Capo Peloro. Cariddi talvolta è accompagnato da un rimescolio delle acque così violento da mettere in pericolo le piccole imbarcazioni. Notevole è anche il vortice che si forma, con la scendente, davanti al faro di Messina e con i venti sciroccali e in giorni di luna piena o nuova rende il mare agitato tra la Grotta e le acque di San Ranieri. Altri garófali sono a Sant’Agata, Punta Grotta, San Salvatore dei Greci, Punta Pezzo e Catona.
Le acque dello Stretto con la montante si abbassano di circa 15 o 20 centimetri; con la scendente si alzano di altrettanto, con un dislivello massimo di mezzo metro. Le depressioni maggiori si hanno in agosto, le elevazioni massime in novembre, dicembre e parte di febbraio. Nei giorni di maggior forza delle correnti, la montante è sempre più violenta della scendente e riesce a strappare dal fondo erbe e alghe. Quando è rafforzata da particolari condizioni meteorologiche getta sulle spiagge di Ganzirri, del Faro e anche di San Ranieri, pesci abissali dagli occhi atrofizzati, con organi produttori di fosforescenza e di forme inconsuete.
Si conclude così il nostro breve viaggio virtuale nello STRITTU che ci ha portato a ritroso nel tempo, quando il breve tratto di mare era “popolato” da mostri, divinità e strane creature, fra misteri, prodigi e fenomeni atmosferici (all’epoca) inspiegabili. Una leggenda siciliana che ispira la fantasia e ci riporta alla memoria viaggi e avventure che hanno reso l’attraversamento dello Stretto di Messina una prova di coraggio nell'immaginario collettivo.
Possiamo definirlo lo Stretto del Mito, reso immortale da alcuni dei più grandi scrittori di sempre, affascinati dalla suggestione di un luogo che nei secoli ha terrorizzato viaggiatori e marinai a causa soprattutto della sua variegata fauna e del perenne scontro fra lo Jonio e il Tirreno.
Millenni di storia e leggenda in un luogo unico al mondo.
Carlo GATTI
Rapallo, 1 Settembre 2021
DAL GARUM ALLA COLATURA DI ALICI DI CETARA
DAL GARUM ALLA COLATURA DI ALICI DI CETARA
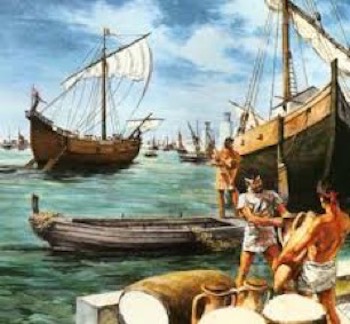
Porto di Pompei
Con il termine garum si designava quel particolare condimento ottenuto dalla macerazione e dall’auto digestione enzimatica di alcune varietà di pesci. Il sale che veniva aggiunto aveva la funzione di conservante. Le sostanze proteiche degradate dagli stessi enzimi presenti nelle interiora del pesce avevano la funzione di creare aminoacidi liberi, grassi polinsaturi e lipidi essenziali.
Nel porto di Pompei arrivavano anche mercanzie da ogni luogo del Mediterraneo Abbiamo ampie prove di questi traffici commerciali che venivano regolati dalle esigenze di mercato. Presso il Museo Archeologico di Boscoreale sono esposti alcuni esempi di anfore per il trasporto del vino, dell’olio e del garum. La differente morfologia delle anfore, i bolli di fabbrica e le iscrizioni dei contenuti ci fanno comprendere come questi prodotti tipici dell’industria locale venissero trasportati attraverso il mare anche a terre lontanissime.
Il garum di Pompei era servito sulle tavole delle ricche dimore da Leptis Magna a Sidone, da Argo a Tarros, da Gibilterra a Cipro. Un commercio fiorentissimo che connotava rotte e guidava l’economia verso prodotti tipici e oggettivamente validi.
La nostra salsa aveva probabilmente un gusto acidulo ed odoroso di mare. Un forte carattere la distingueva, soprattutto se associata a pietanze quali le cacciagione, i crostacei, ed anche le stesse zuppe di pesce. Nella lingua greca oggi alcuni tipi di pesci piccoli e saporiti e le stesse alici si definiscono con il termine “gavros” ossia ΓΑΥΡΟΣ. Possiamo pensare quindi che le stesse radici gastronomiche di questo condimento, già esistevano tra i popoli del bacino orientale del Mediterraneo. Lo stesso sale ad esempio, utilizzato come conservante naturale delle proteine era noto nel mondo egizio, dove veniva utilizzato miscelato ad altre sostanze per formare il natron.
Navigando qua e là per il WEB mi sono imbattuto, per una strana duplice coincidenza.
GARUM MARE NOSTRUM

La prima è che il Garum é una mia vecchia conoscenza di quando mi capitava di visitare i musei di archeologia marina; la seconda é Mare Nostrum, nome che conosco “abbastanza” bene…
Ho pensato quindi di passare la parola a questi nostri Amici di Viareggio che non conosco, ma che sento in qualche modo vicini ai nostri ideali. Non è quindi un caso che il nostro Presidente Agostino Lertora, oltre ad essere un provetto nuotatore e pescatore subacqueo, abbia pure una certa fama di cuoco specializzato in piatti di pesce, come gli amici di F/b ben sanno. La sua fama, per dire il vero, abbraccia anche l’arte pittorica di quel settore, come dimostra la foto che segue:

La parola agli esperti!
“Negli ultimi anni la nostra associazione, nell’ambito dei suoi progetti di ricerca e di studio , sta operando per la valorizzazione delle qualità nutraceutiche del pesce, ed in particolare del pesce azzurro, comunemente identificato con l’appellativo di “pesce povero”.
L’interesse per questa iniziativa è motivata dalla scarso gradimento che i bambini e le bambine hanno nei confronti del pesce, e della scarsa conoscenza delle sue qualità salutistiche.
Il nostro progetto sul pesce coinvolge i pescatori dei nostri mari, ed è condotto con la collaborazione di enti pubblici, fra i quali il Comune di Viareggio, dove è presente la più importante realtà di pescatori della Toscana; la Regione Toscana, che da alcuni anni sostiene progetti legati alla valorizzazione dei prodotti locali nell’ambito delle filiere corte e della ristorazione scolastica.
Nel lavoro di studio e di ricerca sulla tipicità, sulle tradizioni e sul nostro patrimonio alimentare legato al pesce, abbiamo intercettato il garum, un condimento a base di pesce azzurro, fra i più noti dell’antichità e che i romani adoravano e producevano in grandi quantità nell’area del Mediterraneo.
Dai nostri studi e ricerche abbiamo rilevato che questo condimento con molta probabilità prende il nome da un pesce “Garos”, da cui è derivato il nome “Garon“ usato dagli antichi Greci, e il nome “Garum” usato dai Romani.
A partire dal II sec. A.C. questa salsa di pesce, usata prevalentemente come condimento ebbe un successo crescente. La qualità del garum veniva indicata con lettere dipinte sulle anfore ed assicurava anche l’anno di produzione. Le migliori salse erano denominate Garum Excellens (ottenuto con alici e ventresche di tonno); Garum Flos Floris (ottenuto con sgombri, alici, sardine); Garum Flos Murae (ottenuto dalle murene). Il garum prodotto nelle colonie romane dell’Africa settentrionale, della Spagna, veniva chiamato Garum Sociorum. Una delle più importanti officine per la produzione del garum si trovava a Pompei.
Il garum veniva utilizzato sia come condimento, sia come ingrediente di cottura. Con il garum si insaporivano i funghi e le uova, mescolato all’aceto o ad altre erbe aromatiche, costituiva una salsa di condimento delle carni o del pesce alla brace.
Le sue qualità medica mentali erano altrettanto note: efficace disintossicante e antidolorifico. Le sue proprietà energetiche erano utilizzate dagli eserciti per le loro operazioni militari.
Molte sono le citazioni che si ritrovano sul garum in epoca romana, il che confermerebbe la sua larga diffusione in tutta l’area del Mediterraneo e i suoi molteplici usi in cucina e come elemento altamente energetico. Fra le citazioni più note, possiamo ricordare quelle di Apicio nel “De ReCoquinaria”; Marziale; Varrone; Plinio Il Vecchio in Naturalis Historia; Columella nel De Rustica.
Il garum resterà presente nella tradizione gastronomica alto medievale, con fabbriche di produzione a Bisanzio e nell’area adriatica, per avviarsi successivamente verso un progressivo declino. Uno dei principali ed ultimi porti di smercio di questo prodotto è stata la citta’ di Lunae (Luni) in Liguria.
Ai giorni nostri si producono alcune salse a base di pesce, con procedimenti diversi, fra le quali la colatura di Alici di Cetara.
Il progetto di recupero del garum, ed in particolare la produzione del “Garum Mare Nostrum” è iniziato tre anni fa.
Nel mese di luglio del 2011 si è realizzata una prima produzione sperimentale del garum mare nostrum. In particolare gli ingredienti usati sono stati: pesce azzurro (alici, sgombri, sardine) pescato nel Mar Tirreno; sale marino integrale; erbe aromatiche della macchia mediterranea (rosmarino, alloro, timo), seguendo alcune tecniche di produzione e conservazione da noi codificate, con riferimento alle fonti storiche”.
Noi possiamo solo aggiungere che la qualità del Garum in antichità veniva indicata con lettere dipinte sulle anfore ed assicurava anche l’anno di produzione. Nella casa di Paquius Proclus, personaggio in vista nell’ultimo periodo di Pompei, è stata trovata un’anfora contenente Garum stagionato di tre anni: ciò dimostra che questa salsa può essere conservata per lungo tempo.
Esisteva un Garum ordinario e uno di qualità, a seconda dell’utilizzo di residui di pesci di vario tipo o piccoli pezzi di pesce scelto. Il Garum migliore era il gari flos, il fiore del Garum, il più puro, il primo liquido filtrato; il Garum nigrum godeva di grande reputazione e si vendeva in vasetti.
Le migliori salse erano così denominate:
Garum Excellens, ottenuto con alici e ventresche di tonno;
Garum Flos Floris, (tipo extra) ottenuto con diverse qualità di pesci (sgombri, alici, tonni, ecc.);
Garum Flos Murae, ottenuto dalle murene.
Altri tipi di Garum si riferiscono a particolari commistioni, come l’Oxygarum, una sorta di bevanda digestiva con numerose erbe tritate, l’Hydrogarum che era lavorato con erbe aromatiche. L’Halex o Allec era il residuo del Garum, ma poteva essere fatto anche con pesci delicati; Apicio inventò un Allec da fegato di triglia (mullus) che faceva macerare nel Garum, il quale ricorda l’olio di fegato di merluzzo considerato nel passato un potente ricostituente per i bambini.

Tre anfore per il garum
Il miglior Garum veniva prodotto da una cooperativa di Cartagine, il cosidetto Garum Sociorum, che si produceva con il gusto prevalente dello sgombro. Un’anfora di sei litri di Garum Cartaginese costava allora mille sesterzi (circa mille euro attuali). Ottimi e più economici erano i tipi prodotti a Pompei, Antibes (sulla Costa Azzurra) ed in altri pochi centri del Mediterraneo.
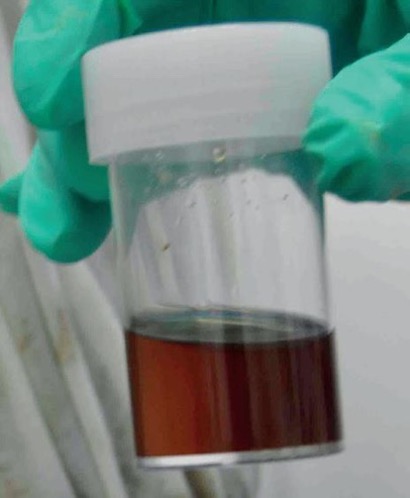
Garum ottenuto dalla riproduzione sperimentale (GARCÍA VARGAS)

“Garum di Pompei” in fase di preparazione
Il garum, nota e famigerata salsa di pesce fermentato, era molto diffuso e apprezzato nel mondo romano; non solo infatti era un metodo, alternativo alla salagione a secco (salsamentum), di conservare il pesce, ma forniva all’alimentazione un buon apporto di sale e serviva a esaltare il sapore di quasi ogni piatto, grazie all’elevata quantità di glutammato (quello che oggi troviamo nel dado da cucina o nella salsa di soia). La lavorazione del pesce, tanto salato quanto in salse, ha origine mesopotamica ed egizia risalente al III millennio a.C., o ancor prima; essa passò poi al Vicino Oriente e fu nota fin dal VII secolo a.C. ai Greci, i quali chiamavano tarichos il pesce salato e garon la salsa, per la quale utilizzavano una specie di piccolo pesce non meglio identificato, il garos. Contemporaneamente, con le loro colonizzazioni, i Greci portarono la produzione in occidente, ma non bisogna dimenticare anche il ruolo dei Fenici, specialmente verso le coste iberiche, che non a caso in seguito saranno i maggiori e migliori produttori. Furono proprio i Fenici a dare inizio a una pesca intensiva, finalizzata alla lavorazione, in particolare nelle aree limitrofe allo stretto di Gibilterra, passaggio obbligato dei tonni nelle migrazioni fra Mediterraneo e Atlantico. Fenicio è il primo impianto di produzione noto, con vasche per la salagione, a Gadir, l’odierna Cadice, risalente al V secolo a.C. Furono, di nuovo, i Fenici a generalizzare l’uso di anfore per il trasporto di questi prodotti, rinvenute in tutto il Mediterraneo. I Romani, poi, recepirono anch’essi queste tecniche e, con l’aumento della domanda, nacque una produzione “industriale”, destinata al commercio anche a lungo raggio, tramite delle anfore specializzate. I centri produttivi romani, detti cetariae, più numerosi e grandi di quelli fenici, si concentrarono soprattutto sulle coste, sia atlantiche che mediterranee, della Baetica, nel sud dell’Hispania. Altri importanti esportatori furono le province dell’Africa settentrionale e la Sicilia, ma Plinio ricorda come centro di produzione rinomato anche Pompei. Una delle cetariae meglio note e studiate è quella di Baelo Claudia, sempre vicino a Cadice. Questi impianti producevano probabilmente tanto il garum quanto il salsamentum e sono caratterizzati da vasche per la salagione, generalmente quadrangolari, ma a volte anche circolari, come alcune di Baelo Claudia che, per le grandi dimensioni, potrebbero essere state destinate a dei cetacei.






La Colatura di Alici è il prodotto principe del borgo marinaro di Cetara, splendida cittadina dell’illustre Costiera Amalfitana. Il liquido di colore ambrato, dalle presunte origini asiatiche e ben noto successivamente agli antichi romani, si ottiene dalla lunga maturazione delle alici sotto sale.
La ricetta venne poi in qualche modo recuperata nel Medioevo da parte dei gruppi monastici presenti in Costiera Amalfitana, i quali ad agosto erano soliti conservare sotto sale le alici in botti di legno con le doghe scollate e poste in mezzo a due travi, dette mbuosti; sotto l'azione del sale, le alici perdevano liquidi che fuoriuscivano tra le fessure delle botti. Il procedimento si diffuse successivamente tra la popolazione della costa, che la perfezionò con l'utilizzo di cappucci di lana per filtrare la salamoia.
La colatura d'alici viene soprattutto utilizzata come condimento di spaghetti, ma anche per insaporire piatti a base di pesce o verdure, come ad esempio la scarola per la pizza ripiena; inoltre con verdure saltate in padella con olio, aglio e peperoncino, quali bietole, spinaci, ecc. Da alcuni è apprezzata anche come condimento per pomodori, olive, persino per panini farciti e uova cotte in vari modi.
“Un prodotto simbolo importante per il rilancio della enogastronomia – dichiara Mauro Rosati, direttore Generale Qualivita – che, data la notorietà che aveva assunto a livello nazionale ed internazionale in questi anni, ora potrà essere tutelato dalle imitazioni”.

Sicuramente abbiamo sentito parlare di Marco Gavio Apicio, un ricco romano vissuto nel I secolo d.C., e del suo “De re coquinaria”, preziosa fonte di informazionI sulle abitudini alimentari degli antichi romani.
Con le sue 478 ricette, alcune delle quali assai stravaganti, ci trasmette la cultura gastronomica del tempo, conosciuta e praticata nelle case dei ricchi, naturalmente. Singolare è la continuità che si riscontra con alcune preparazioni gastronomiche in uso ancora oggi, divenute col tempo vere prelibatezze.
Sembra infatti che Apicio, da grande buongustaio quale era, avesse trovato il modo per ottenere una pietanza simile al moderno foie gras, ingozzando le povere oche con i fichi!
Ma è il garum il vero protagonista della ricca tavola romana, una salsa ottenuta dalla fermentazione di interiora di pesce, il cui solo pensiero sicuramente ci disgusterebbe.
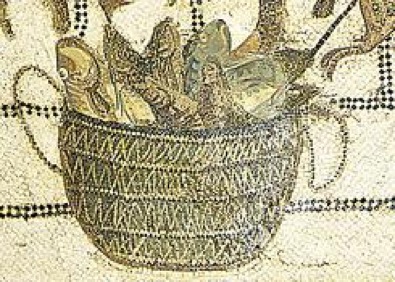
Sorprendentemente esiste un erede del garum nella cucina italiana: la colatura di alici.
Non si produce con interiora, ma con alici eviscerate, ma chissà se la più antica tradizione prevedesse l’uso di alici intere.
Attualmente il borgo di pescatori di Cetara, situato in costiera amalfitana, detiene il primato nella produzione della colatura di alici.
Il garum era preparato mescolando le interiora di pesce con sale e diversi tipi di spezie. Il tutto veniva fatto macerare esponendolo al sole per un paio di mesi.
Il liquido che si formava veniva filtrato, ed era la parte più preziosa, il garum appunto.
la parte solida serviva per la preparazione di un altro tipo di salsa, l’allec.
A Cetara le alici impiegate per la trasformazione sono tradizionalmente quelle pescate tra il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, e il 22 luglio, S. Maria Maddalena.
Dopo essere state pulite (vengono rimosse testa e interiora), le alici vengono prima tenute per una giornata in grandi vasi con abbondante sale, poi poste in botticelle chiamate terzigni, a strati alternati con il sale.






CARLO GATTI
Rapallo, 28 Gennaio 2021