FUOCHI AD EST DI CANDIA - Romanzo storico
FUOCHI AD EST DI CANDIA
Romanzo storico - Di Carlo Giuseppe LUCARDI

Maometto II°, Sultano dell’Impero Ottomano – (ritratto da Gentile Bellini)
Alla morte del padre, Maometto II° salì di nuovo al trono e nel giro di soli due anni arrivò a porre fine all’Impero Bizantino conquistando il 29 maggio 1453 Costantinopoli (che era diventata per lui un'ossessione, tanto che cominciò a paragonarla ad una donna che aveva rifiutato il matrimonio di molti principi musulmani e che doveva diventare per forza sposa). L'assedio fu condotto con enorme spiegamento di forze, usando i più grandi cannoni allora esistenti al mondo e addirittura trasportando decine di navi sulla terra, trascinate a forza di braccia dagli schiavi dal Bosforo fino al Corno d’oro scavalcando le erte alture di Galata, per aggirare la celebre catena che bloccava l'imboccatura del Corno d'oro dal Mar di Marmara. Presa la città, Maometto II ne fece la nuova capitale dell'Impero ottomano col nome di Kostantîniyye, poté così fregiarsi oltre al titolo di "Sultano" anche di quello di "Qaysar-ı Rum", ovvero Cesare dei Romei, anche se risulta già attestato in particolar modo a livello popolare l'attuale nome di İstanbul.
Dopo questa conquista, il padişa dei turchi prese anche gli ultimi territori bizantini, il Despotato di Morea nel Peloponneso (1460) e l’Impero di Trebisonda sul Mar Nero (1461) A quel punto, nonostante lo sgomento dilagato in tutto l'Occidente, lo stato ottomano fu definitivamente riconosciuto nel mondo come un grande Impero.
La caduta di Costantinopoli nel 1453 aveva mostrato per la prima volta la vera potenza navale, oltreché terrestre, del nuovo Impero ottomano.
Venezia, sebbene sino all'ultimo fosse alleata con il morente Impero Romano d’Oriente, dopo la caduta dell'antica capitale imperiale si affrettò a mostrarsi compiacente coi nuovi padroni delle vie d'Oriente. Il 18 aprile 1454, l’ambasciatore Bartolomeo Marcello sottoscrisse infatti con il Sultano Maometto II° un trattato di reciproco riconoscimento.
Nonostante le apparenze, si trattò però di una tregua fragile, costantemente minacciata da piccole violazioni che potevano, in qualunque momento, essere sfruttate dai Turchi per scatenare un conflitto. La stessa Venezia, dal canto suo, dichiarava apertamente per bocca dei propri rappresentanti, in un concilio tenutosi a Mantova nel 1460, che l'accordo era stato costituito per necessità di difesa degli interessi in Oriente, ma che, qualora si fosse creata contro il Gran Turco una lega cristiana, Venezia sarebbe stata disponibile a parteciparvi.
In questa situazione veramente ingarbugliata, Venezia - Repubblica Marinara si trova a percorrere rotte difficili e insidiose per la sopravvivenza della stessa SERENISSIMA e delle sue basi medio-orientali.
Gli storici di professione, quando suggeriscono libri per l’approfondimento di un argomento di rilevanza storica, del tipo che stiamo trattando, raccomandano sempre la lettura di un Romanzo Storico che, sapendosi calare nella realtà del tempo, arricchisce e facilita la comprensione degli avvenimenti attraverso i personaggi di quel tempo che rispecchiano i fattori ambientali, politici, religiosi, linguistici, psicologici e comportamentali che ben poco hanno in comune con gli attuali parametri di valutazione in nostro possesso.

Ed ecco venirci in soccorso il romanzo storico di CARLO LUCARDI
Carlo Giuseppe Lucardi, nato a Genova il 21 maggio 1953, é un medico ex-ospedaliero, con la passione per la scrittura fin dai tempi dell’Università.
Carlo é socio di Mare Nostrum Rapallo da circa un anno e fa parte del gruppo:
Il suo libro, di cui ci occupiamo oggi, verrà presentato il 1°di febbraio dagli SCRITTORI IN RIVA AL MARE presso la Biblioteca di Rapallo. Seguirà la locandina.
La trama:
Il Sultano Maometto II° ha conquistato l’impero romano d’Oriente.
La sua fama d’invincibilità terrorizza tutto il mondo cristiano. Venezia deve concludere una pace svantaggiosa con lui per conservare le terre e i commerci che ancora possiede. A sugello del trattato il Sultano pretende che un carico d’armi da fuoco gli sia venduto in cambio di oro e gemme.
Maometto II pensa che coi rivoluzionari Hachen-Buchse (archibugi) a pietra focaia gli sarà facile togliere di mezzo i cavalieri di Rodi che gli impediscono la conquista di Roma.
Per essere sicuro del risultato, affida l’operazione al suo migliore fiduciario, Misha Pasha il Crudele.

Caracche a 3 e 4 alberi.
I veneziani chiedono che lo scambio avvenga in mare e caricano le armi su una caracca genovese-provenzale, la Dalfin.
Poseidone, Colui-che–scuote–il-mare, scatena una tempesta che disperde le navi, sicché la Dalfin viene catturata dalla galea del cavalier Vendramin.
(Cavaliere dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, detti anche Cavalieri di Cipro, Cavalieri di Rodi e noti come Cavalieri di Malta), è un ordine religioso cavalleresco nato intorno alla prima metà dell'XI secolo a Gerusalemme).
Giovanni, figlioccio del cavaliere, ne assume il comando e fa vela su Rodi, sfidando le squadre del Pasha.
Un laido vecchio imbarcato sulla nave (medico oscuro dei Savi di Alessandria), trama per impedirglielo, e la sua bellissima schiava–strega irretisce il giovane comandante. Tutto sembra perduto, ma l’Egeo degli antichi Eroi ancora una volta mischia le carte…

L’archibugio può essere considerata la prima vera arma da fuoco portatile capace di garantire una certa precisione nel tiro. Evoluzione del più primitivo e pericoloso “scoppietto”, anche noto come "cannone a mano" (handgun in lingua inglese) l'archibugio trovò poi sviluppo nel moschetto, dando origine al fucile moderno.
Data di produzione: 1450-1650
Un romanzo rosso come le fiamme degli Hachen-Buchse e verde come il mare delle isole greche.
Il primo di un ciclo di storie di mare fra l’Oriente e il Rinascimento, il Magnifico Lorenzo e Maometto II°, i corrotti cardinali e la magia oscura dei Savi di Alessandria.
L’autore del romanzo ha fatto una scelta precisa: quella d’imbarcarsi, di volta in volta, come cronista, sulle navi in cui si svolge un’azione bellica. A noi ricorda un novello Pigafetta che descrive la storia che vive in prima persona e che ci riferisce puntualmente con il linguaggio di bordo, talvolta rozzo e crudele, talvolta raffinato a seconda del palcoscenico che può essere turco, veneziano, genovese, ma anche misto…anzi molto eterogeno! Quindi ci s’imbatte in termini assolutamente veri, pittoreschi, rocamboleschi, ironici che ancora ora rifioriscono e risuonano negli angiporti più famosi del Mediterraneo.
Il vocabolario usato dallo scrittore é molto ampio… non solo nelle simpaticissime imprecazioni che non risparmiano neppure gli dei di varie provenienze…, ma dilaga persino nella terminologia tecnico-nautica che si estende ai bordi veneziani, genovesi, turchi, arabi, levantini ecc…
Lo stesso tipo di linguaggio, talvolta esilarante, é usato anche per illustrare le armi e persino istruendo il lettore sull’uso delle stesse durante le battaglie navali che sono descritte puntigliosamente sulla base di strategie studiate e praticate con estrema efficacia!
La presenza dell’autore a bordo dà al lettore la strana sensazione di essere imbarcato e guidato nelle varie esperienze di bordo e, i personaggi che via via incontra appaiono a prima vista meno strani, anzi più umani del previsto. Talvolta é persino più facile capire come oggi, rispetto al 1400, non sia cambiato così tanto il senso della vita, dell’umanità, del dolore, dell’onore, del bello e del brutto. Infine, anche la simpatia e l’antipatia dei personaggi di queste imbarcazioni “rinascimentali”, che sono spesso espressioni dell’ignoranza profonda mista a superstizione, diventano funzionali alla genialità che essi sanno esprimere nei momenti difficili. E’ l’epoca nello stupore per le nuove invenzioni che rendono il mondo pieno di speranze e gli uomini in arme validi attori sulla scena della modernità.
La lettura del romanzo é molto scorrevole anche se, a prima vista, potrebbe essere apprezzato come un testo esclusivo per appassionati di storia, un libro di nicchia per studenti di liceo ed anche universitari. Ma non é così, il romanzo é indubbiamente “erudito” emergendo in modo inequivocabile la preparazione culturale di alto livello con cui l’autore si é avvicinato a questo progetto storico profondamente marinaro, sia nelle descrizioni particolari delle caracche, delle galee di vario tipo, ma anche nella conoscenza del linguaggio di bordo, che passa dal veneziano all’arabo, dal turco a quello usato dai Cavalieri di Rodi, ma non é tutto perché ci desta altresì meraviglia anche l’esatta descrizione delle armature del tempo, l’uso delle armi bianche, ma anche di bombarde, colubrine, basilischi e soprattutto dei micidiali archibugi veneziani al loro esordio nella storia.
L’autore tratta con molta competenza il debutto della CARACCA genovese, una torre molto alta sulla superficie del mare, figlia della COCCA con le murate e le estremità progettate per cavalcare le onde atlantiche. Ricordiamo che la cocca genovese fu progettata per uscire da Gibilterra e raggiungere i mari del Nord Europa.
La storia ci ha insegnato, e lo fa tuttora, che la nazione con la tecnologia più avanzata in materia di costruzioni navali e di armamenti é candidata alla vittoria finale.
Venezia, nella realtà del XV secolo possiede l’Arsenale militare più famoso e potente del mondo di allora. Da quella realtà, come ci spiega più volte l’autore, escono le migliori navi e le migliori armi navali che sono il frutto di secoli di studi, d’esperimenti e di grandi innovazioni in tutti i campi da parte di celebri ingegneri, fonditori e navigatori.
Tuttavia il nemico che ha di fronte rappresenta la più forte potenza militare del mondo di allora. Come finirà questa storia?
Buona lettura!

Piccola caracca - ill. del XVI secolo.

Caracca - particolare da Caduta di Icaro di Pieter Bruegel il Vecchio (circa 1558)

Battaglia navale tra caracche e galee.

Il “galeone” NEPTUNE ormeggiato nel porto Antico di Genova é finto, ma rende l’idea e soprattutto l’atmosfera marinara di un’epoca ormai lontana che il nostro capoluogo non ha dimenticato. Forse, anche il nostro amico Carlo LUCARDI n’é stato “contagiato”??Chissà! Ce lo racconterà a voce… Per il momento gli rivolgiamo i nostri sinceri complimenti per la sua opera che potete trovare presso qualsiasi libraio.
Carlo GATTI
Rapallo, 23 Gennaio 2020
ATTENTI A QUEI DUE...!
ATTENTI A QUEI DUE.....!
Il motto era: " Sempre amici anche in tempo di guerra..."
Era il 1958, frequentavamo il IV Nautico Macchinisti. Un pomeriggio, in occasione di un ricevimento delle famiglie, si sono incontrati mio padre e la madre di Terrenzio. A quel tempo, si rientrava quasi tutti i giorni a scuola di pomeriggio e quindi per mangiare, a pranzo, si andava avanti a forza di panini, sempre se non li avevi finiti prima… Parlando di questo disagio, i due genitori pensarono di farci mangiare almeno due volte la settimana al Ristorante: l'unico di Ortona, sito a metà della via principale, il Corso, di ottima qualità.

Ortona - Il corso
Approfittarono così per parlare subito con il proprietario. Queste erano le condizioni: il pranzo normale costava 600 Lire, una cifra importante all’epoca, ma siccome noi non avremmo preso vino e caffè e siccome si trattava di un abbonamento, si pattuì per 500Lire a Pranzo. I clienti erano pochi: un commesso di stoffe che periodicamente si fermava ad Ortona e un nostro Insegnante, ex Uff.le di Marina, single, proprietario di una fornace ai Saraceni. Questo per inquadrare la quasi esclusività del locale. In precedenza, andavamo qualche volta dai genitori di un nostro compagno di classe, Mariani, i quali gestivano una cantina e, quando cucinavano qualche piatto per loro che a noi andava bene, ci univamo alla famiglia. Ricordo, per esempio, dell'ottima pasta e piselli. Trionfavano gli odori di vino e tabacco. Tutto era avvolto in fitta una penombra dovuta alle volte del locale che erano 'a cielo di carrozza'. Per intenderci, si mangiava con sole 120 Lire.

Da destra: Nunzio, Terrenzio, e "Porcellino"
Le prime settimane andammo regolarmente al ristorante e molte persone restavano stupite di questo trattamento che avevamo.., eravamo considerati miliardari! Ma in uno di quei giorni in cui quando suonava la sirena ed eravamo già un po’ lontani c'era il rito di posare la borsa per terra e, con tutta calma, fare il gesto 'dell'ombrello', arrivavamo sotto il faro alla testata del porto, dove a volte ragionavamo sui 'massimi sistemi', ci chiedemmo se era il caso di continuare a spendere tutti quei soldi 'inutilmente'. In effetti avevamo anche altre spese vive giornaliere come le sigarette, qualche rivista il giovedì, e altro tenuto conto che la legge Merlin non era ancora in vigore. Si convenne allora di rallentare la frequenza al ristorante per disporre di moneta 'frusciante'.
Solo che un giorno, mio padre, mentre andava alla Banca sita nei pressi del ristorante, vide la proprietaria sulla porta e si fermò. Dopo averla salutata, chiese dei ragazzi e del loro comportamento. La Signora rispose la verità: "veramente in questo ultimo periodo li stiamo vedendo poco, forse non sono contenti del trattamento!" al che mio padre rispose: "Signora, mi faccia la gentilezza, lei prenda un quadernino, quando viene mio figlio a pranzo, gli faccia apporre la propria firma e poi quando passo io, regoleremo il conto, se vuole, le anticipo i soldi." “Va benissimo! Ossequi.”
Quando tornai la sera a casa, mio padre al solito, non disse nulla, solo: "Quando vai al ristorante, non serve dare i soldi. Metti solo una firma sul quaderno che ti porge la Signora.” Cazzo, ci aveva fregato! E la faccia di mio padre non mi piaceva affatto…
Ore 7.00 del mattino successivo. Monto sull'Auto Forlini, posto riservato da Terrenzio: rimorchio, sedili davanti, carte già mischiate, le mie tre già pronte, allegria di sempre… Arrivo, guardo il mio amico con una faccia veramente diversa e lui: "ca success frà??"
E io: "che t'a vist Sciannapupa?", soprannome affibbiato a un professore perché il poveretto quando camminava ondeggiando a destra e sinistra sembrava uno che culla un bambino.
"No pecchè oggi avem da parlà!" il prof. Nominato viaggiava con lo stesso nostro auto e quel giorno, martedì, avevamo compito in classe!!! Quel giorno non si giocò a carte.

Veduta aerea del porto di Ortona
Arrivati a Ortona, prendemmo la solita via del porto, ma in un angosciante silenzio. Arrivammo sotto il faro, accesa la sigaretta, si inizia con la relazione del fatto e la discussione sui provvedimenti da prendere. Alla fine si decide di parlare con la Signora in questi termini: "Causa cambiate condizioni economiche del mio amico figlio di commercianti, e lei può ben capire i manrovesci della fortuna, verremo a mangiare in due. Io metterò la firma e lei ci darà due primi. Poi lei vedrà se è possibile un solo secondo ed eventualmente la somma da integrare volta per volta. Se le va bene è così, altrimenti io non verrò più perché non posso lasciare un amico fraterno con un panino mentre io me la scialo al ristorante!!!”
All'ora di pranzo, ci presentiamo al ristorante ed esponiamo il problema alla Signora, la quale solo a vedere la faccia di circostanza di Terrenzio, disse: "Ma si, non vi preoccupate, va bene così.., purtroppo il commercio è così.." Neanche a farlo apposta il Ristorante si chiamava per l’appunto "Il Commercio"...

Nunzio a sinistra e Terrenzio con la gambetta ...
Era fatta! Avevamo contante sufficiente per tutto. Potevamo fare anche qualche opera di bene a qualche amico e abbiamo potuto constatare che non sempre a fare del bene se ne riceve altrettanto.
Il giovedì pomeriggio, spesso durante le ore di officina, con la complicità del buon 'Bob', dopo l'appello, uscivamo dalla finestra per andare a vedere la Rivista. Portavamo con noi, spesso, Vittorio Bisignani, con il quale conservo tutt’oggi un contratto stipulato su carta igienica, in cui si impegnava a portare i libri tutti i giorni per lire 50 al mese. Quando eravamo davanti al cinema, noi gli dicevamo: "Dai Vittò, n'nte preoccupà: ce stà la polvere!" e lui era un po’ restio dicendo: "ma mo' pecchè avet da paà vu!"... "E dai!” lo prendevamo per un braccio e lo portavamo dentro!"

Avevamo dimenticato che proprio dirimpetto a noi, a 20 mt. di distanza, da dietro la tendina, DON ANTONIO ci osservava. Era il nostro Insegnante di Religione, il quale abitava lì e credeva che Vittorio non volesse cadere in tentazione. Quindi risultava che noi lo inducessimo al peccato. Così, quando entrava in aula, con i suoi giri di parole ci faceva sempre capire che eravamo dei degenerati…
E poi vai a fidarti di fare del bene!!!
Nunzio CATENA
Rapallo, 8 Febbraio 2018
ASEPOTESSI - Favola
ASEPOTESSI
Questa è la storia vera di un bambino scontento.
Guardava la TV e pensava: “Ah, se potessi andare in bicicletta!”.
Se un amico gli prestava la bicicletta smetteva di pedalare dopo tre minuti e sospirava: “Ah, se potessi giocare a calcio!” E così via.
I giorni passavano monotoni e grigi tra un sospiro e un’esclamazione: “Ah, se potessi…”
Parenti ed amici lo soprannominarono Asepotessi e questo rimase il suo nome.
Un giorno Asepotessi era a scuola alle prese con un problema che non gli veniva ed esclamò, come al solito: “Ah, se potessi essere sulla spiaggia, invece di star qui a faticare!”
Lo sentì una fatina, di solito occupata in casi più seri, e decise di accontentarlo o, se non ci fosse riuscita, di raddrizzarlo, per non essere più disturbata dai suoi sospiri.

Detto fatto Asepotessi si ritrovò disteso su una sabbia dorata e luccicante come solo le fate possono trovare ormai. Passarono pochi minuti e già sospirava: “Ah, se potessi fare il bagno e rinfrescarmi, ma non so nuotare.”
La fatina esaudì il suo desiderio e Asepotessi fu immerso in un mare limpidissimo, e sapeva galleggiare!
L’euforia di saper nuotare durò poco, presto sostituita dalla fatica. “Ah, se potessi riposarmi su una barchetta, allora sì che sarebbe bello.”
Ciaf, ciaf una barchetta apparve per incanto. Asepotessi vi si issò e si lasciò trasportare per le invisibili strade delle correnti.
Dopo un po’ incominciò a soffrire il mal di mare. “Ah, se potessi…”
La fatina non gli lasciò neanche terminare la frase. Ormai aveva deciso di aiutarlo e con le buone o con le cattive voleva farlo maturare.

Asepotessi si ritrovò così in costume da bagno e scalzo in un fitto bosco di castagni tappezzato di ricci.
Per la prima volta in vita sua doveva pensare alla sopravvivenza, a ripararsi dal freddo, a trovarsi un rifugio. Alla meglio si confezionò sandali di corteccia e una tunica di foglie. Quanto alla fame si accontentò degli avanzi di un pic-nic.
Incominciava ad imbrunire ed il silenzio del bosco si animava di mille rumori: fruscii, gridi, battiti, tonfi. Era giunto il momento della paura.
Il nostro povero amico era così occupato a cercarsi un rifugio, che neanche una volta gli sfuggì la solita frase: “Ah, se potessi!”
Si arrampicò su un albero facile facile, si abbandonò tra i rami divaricati ed, esausto, si addormentò.
Sognò di essere a scuola, di saper risolvere il problema e di passarlo a qualche compagno vicino. Si sentiva felice di scrivere, di faticare, di vivere. E nel sogno sorrise.

La fatina decise che la prova era stata superata e Asepotessi poteva tornare alla vita normale. Ormai era cambiato.
Lo sollevò e lo portò a scuola, dove tutti erano così impegnati che non si erano accorti della sua assenza.
Asepotessi ricordava tutto, ma non era sicuro di aver vissuto quell’esperienza magica e si convinse di averla solo immaginata.
Aveva però fastidio ad un piede. Che fossero spine conficcate? Riccio di mare o di bosco? Sorrise al ricordo e vi assicuro che da quel giorno Asepotessi non fu più né noioso, né annoiato.
ADA BOTTINI
Rapallo, 17 Dicembre 2017
LA FAVOLA DI ANDREA LIMONE
LA FAVOLA DI ANDREA LIMONE
Questa è la storia vera
del bambino Andrea
prima della cura
che fece sulla scura
sabbia di Framura

Tutti dicevano che Andrea era livido e acido come un limone.
I più benevoli gli dicevano: “Dai, ridi un po’, la vita è bella.” E lui se era in vena, tirava le labbra con un sorriso, che pareva una smorfia e lo faceva sembrare ancora più triste. Altri lo prendevano in giro e non lo chiamavano più con il suo nome, l’avevano soprannominato “Limone” e lo lasciavano in disparte.
A vederlo con il suo colorito pallido e olivastro, le occhiaie sotto gli occhi scuri e spenti, le labbra livide sembrava davvero che nel suo corpo circolasse spremuta di limone invece che sangue.
Un giorno, mentre se ne stava seduto su un muretto davanti al mare, le gambe penzoloni che, battevano ritmicamente contro il muro, arrivò sulla spiaggia una bambina un poco più grande di lui.

Non l’aveva mai vista a Framura, però gli piaceva. Decise allora, seguendo le sue tendenze negative, di essere particolarmente antipatico con lei. Lei alzò la testa, lo vide e subito sorridendo, gli chiese “Ciao, come ti chiami?”
“Che te ne importa?”
Lei non ci fece caso e imperterrita continuò: ”Io sono Luisella, e tu?”
“Io Limone, ti va bene così ‘?
“Che strano nome. E’ uno scherzo” fece lei ridendo.
“Non è uno scherzo. Mi chiamano Limone, perché io sono un limone, faccio bruciare gli occhi e la lingua e, se non mi lasci in pace, ti tiro anche una pietra.”
Come se non lo avesse sentito lei piegò la testa da un lato e disse: “Sai, ti devo fare una confidenza, a me i limoni piacciono moltissimo, li mangerei mattino, mezzogiorno e sera. Stai attento: se sei un vero limone, a merenda ti mangio.” Concluse ridendo.
“Ah, ah la spiritosa, non mi fai ridere neanche se mi faccio il solletico.” Rispose lui sbuffando.
Scese dal muretto e se ne andò.
Il giorno dopo però era ancora lì e c’era lei.
“Ciao Limone, giochi con me? Guarda, ho portato una palla, perché speravo che venissi anche tu sulla spiaggia oggi.”
“Oh, che originalità. Una palla. E’ un gioco vecchio come il cucco” rispose lui.
“A me piace sempre, ma se ne sai uno migliore insegnamelo. Io ci sto.” disse lei mentre palleggiava con abilità.
“Va beh, dai non ho voglia di pensare. Tira.”
Per un po’ giocarono e si divertirono poi, stanchi, si sedettero sulla spiaggia a riposare.
Luisella ricominciò a chiacchierare:”non ho capito se ti piace chiamarti Limone oppure no?” Gli chiese.
Andrea non ci aveva mai pensato. Gli altri, quando parlavano con lui, gli davano ordini o consigli. Non gli chiedevano mai il suo parere.. Dopo qualche minuto di riflessione disse:
”Sì, mi piace. Voglio essere acido. Non mi piace piacere. “Che discorso complicato e falso. Chi t’ha detto “che il limone non piace a nessuno? A me piace moltissimo, te l’ho già confidato”.
“Come fa a piacerti una cosa che fa digrignare i denti e venir la saliva in bocca, appena l’assaggi?”
“Sai perché? Tu parli del limone acerbo. Anche tu forse sei un po’ acerbo. Se verrai qui tutti i giorni a parlare e a giocare con me sulla spiaggia e prenderai tanto sole, diventerai un bel limone e… i limoni maturi sono una bontà”
Andrea non rispose, ma fece quello che gli aveva suggerito Luisella, non perché credesse alla sua teoria, ma perché gli piaceva molto stare con quella bambina si sentiva anche meglio come se il gelo che aveva dentro si sciogliesse al sole.
In capo a un mese era irriconoscibile: Abbronzato, sorridente e irrobustito. Insomma un bel limone maturo pieno di vitamine e sali minerali.
Sarà stato il sole, il mare, la spiaggia di Framura o Luisella, chi lo sa?

Fatto sta che dopo la cura la filastrocca suona così:
Questa è la storia vera
del bambino Andrea
dopo la cura
che fece sulla scura
sabbia di Framura
dove divenne
solare e biondo
come un bel limone
luminoso e tondo.
ADA BOTTINI
Rapallo, 7 nivembre 2017
IL VIAGGIO DI CIRO
IL VIAGGIO DI CIRO
Ciro abita in Abruzzo. E’ figlio e nipote di pastori. Il suo nome fu scelto dal padre prima che lui nascesse. Suo padre aveva ascoltato la storia di Ciro, imperatore persiano, una notte d’estate, quando è bello incontrare i tra pastori sotto le stelle e raccontare, ascoltare. Il giovane pastore ascoltava il vecchio sardo che, a modo suo, gli raccontava di battaglie e vittorie, di giardini e città, di popoli schiavi e liberati.
Quella notte Pietro decise che se avesse avuto un figlio, l’avrebbe chiamato Ciro.

Gruppo della Maiella-Abruzzo
Ciro abita in un paesino ai piedi della Maiella, vive in una casa modesta con la mamma, la nonna e altri due fratelli. Il padre e il nonno passano mesi sulle montagne ad allevare pecore e capre e scendono solo d'inverno quando buio e freddo costringono al riparo uomini e animali.

Due Pastori della Maiella a braccetto…
Ciro vive bene nel suo ambiente: è un bambino sereno con una grande mancanza e un grande desiderio: è cieco e vuol vedere il mare. Come gli sia nato questo desiderio nessuno sa spiegarlo. Fatto sta che spesso chiede alla mamma: - Mamma, quando andiamo a vedere il mare? .- E la mamma brusca gli risponde : - Ma che vuoi vedere e vedere, cosa credi che sia il mare? Una grande pozzanghera ecco cos’è! Come d’inverno qui davanti a casa, quando si scioglie la neve e non puoi uscire senza bagnarti i piedi.-
Ciro non si fa scoraggiare facilmente, torna alla carica, allora la mamma sbuffa: - Siamo poveri noi, non si può viaggiare. Smettila con questi capricci, va fuori a giocare. -
Ciro ha imparato a rivolgersi alla nonna che lo ascolta un po’ di più. Il bambino ha tanto insistito che la povera donna è contagiata dal desiderio di Ciro e quasi quasi anche lei vorrebbe vedere il grande mare. Lo ha già visto in Tv e le fa anche un po’ paura, ma per amore del nipotino un bel giorno si decide a dire di sì.
- Zitto, Ciro, non insistere più. Ti porterò a vedere il mare, ma non parlarne quando ci sono il nonno e il papà in casa. Ci prendono per matti e poi incominciano a sbraitare quei due.-
- Davvero nonna mi ci porti? – chiede Ciro sorpreso.
- Sì, sì a primavera quando gli uomini vanno al pascolo e le galline fanno più uova. –
- Cosa c’entrano le galline, nonna? –
- C’entrano, c’entrano. Fanno le uova e io posso venderne un po’ e risparmiare qualche soldino. Ma, zitto, ci penso io. E’ un segreto tra noi due. Quando sarò pronta partiremo. -
La nonna ha davvero deciso di portare il bambino a vedere il mare, anche se sa che non lo vedrà. Sa però, che potrà conoscerlo in qualche modo. Ogni giorno la vecchia pensa a racimolare qualche soldo per il viaggio: le uova, una piccola risorsa, ma insufficiente, le verdure dell’orto sì anche quelle possono aiutare, ma ci vorrebbe ci vorrebbe qualcosa di più prezioso.

Ecco, le viene in mente il velo, il velo al tombolo, un regalo di nozze, l’unico pezzo importante del suo guardaroba. Lei l’aveva sempre tenuto da parte, bene incartato nella velina con un bigliettino: “Perché mi accompagni nell’ultimo viaggio” e qualche volta aveva immaginato sé stessa morta, le mani giunte sul rosario e il velo a incorniciarle la testa e il viso. Era orgogliosa di questa sua scelta, ma ora decide di venderlo per realizzare il sogno del nipote.
Un giorno di primavera si prepara di buon mattino con il vestito della domenica, il cesto con le uova e la verdura e una vecchia borsetta al braccio.
- Dove andate, mamma? – chiede la nuora impensierita
- Giù al paese grande. C’è mercato oggi e devo fare commissioni mie - risponde lei senza troppo concedere.
- Ma che novità è questa, avete forse bisogno del dottore e non volete dirlo? -
- Mai stata così bene. Non sono una bambina, so badare a me stessa. -
La nuora alza le spalle: - Buon viaggio allora. -
- Eh viaggio, viaggio, questo non è un viaggio - sospira la vecchia che incomincia a spaventarsi per il viaggio che dovrà affrontare. Ha le idee chiare però. Giunta al paese venderà al miglior prezzo la sua merce, compreso il prezioso velo. Garantirà uova e verdura fresca una volta alla settimana al negozio del centro, una coperta all’uncinetto in lana grezza alla moglie del sindaco che gliela chiede da una vita e poi la cosa più difficile per lei, andrà alla stazione e chiederà qual è il paese di mare più vicino e il costo del biglietto. Deve fare tutto da sola, ha deciso di non confidarsi con nessuno per non essere distolta dal suo progetto.
- Nonna, come è andata? – bisbiglia alla sera Ciro, quando sono in camera da soli.
- Tra un mese potremo partire. Tutto a posto. Ma non ti far scappare neanche una parola, altrimenti siamo rovinati.–
Il bambino si addormenta felice sognando il rumore del treno che lo porterà al mare.
Arriva il grande giorno. E’ l’alba quando la nonna e Ciro vestiti di tutto punto bussano alla camera della mamma.
- Noi partiamo, andiamo a vedere il mare. Non ti preoccupare, per sera saremo di ritorno.-
La povera donna è frastornata, le sembra ancora di dormire, accenna un :- Ma..-
La porta si è già richiusa sulle sue obiezioni.
Ancora prima di arrivare a Francavilla Ciro, affacciato al finestrino, sente un profumo diverso di piante aromatiche e di sale. - Nonna, ecco il mare – grida entusiasta.
- Ancora no, ma ci siamo vicini. - risponde la nonna con lo stesso entusiasmo. Quel bambino la fa tornare indietro nel tempo e scopre voglie assopite, mai realizzate.
Appena usciti dalla stazione la nonna decide di non dirigersi verso il centro. Vuole essere sola con Ciro nel momento che incontreranno il mare. I due camminano a lungo, finché una strada sterrata sulla sinistra appare invitante.
- Di qua, Ciro, di qua. – dice la nonna prendendolo per un braccio.
E là in fondo, attraente, un triangolo verde tra due dune ricoperte di cespugli.
La nonna tace, ma inavvertitamente stringe la mano del bambino, che si mette a correre.
- Eccolo, nonna. Lo sento, lo sento. – grida Ciro leccandosi le labbra, già insaporite di sale.
- Aspettami, Ciro. – e i due per mano corrono verso il mare vicinissimo e vociante.
Al di là delle basse dune il mare appare in tutta la sua immensità.
- Nonna, com’è? – chiede Ciro con un filo di tristezza nella voce.

Parco Nazionale della Val Grande – Abruzzo
- Più grande del pascolo di Valgrande, sai quello che ci metti tutta la mattina per attraversarlo, ma adesso, leviamoci scarpe e calze, se vogliamo conoscerlo meglio.- Esclama la nonna, tornata bambina imprudente.

I due ripongono calze e scarpe sotto un cespuglio e poi per mano si avvicinano al mare.

La spiaggia di Ortona (Abruzzo) (Foto Rossana)
Prima lentamente gustando la sabbia fresca sotto ai piedi, poi sempre più veloci. Ridono, annusano, sguazzano, gridano, assaggiano, sputano, saltano, spruzzano. E’ un’esplosione di energia gioiosa, di vita.
In quest’eccesso di movimento Ciro perde l’equilibrio e cade in mare. Di colpo la nonna sente tutti i suoi anni, l’ansia, la prudenza.
- Dio mio, Ciro, che ti ho fatto!-
Ma lui ride, ride a crepapelle e tra un colpo di tosse e una risata dice : - Un regalo, un regalo mi hai fatto. Ti voglio bene, nonna.
La nonna lo tira fuori dall’acqua e se lo abbraccia stretto, come non aveva mai fatto prima. Così ora sono bagnati tutt’e due. Per fortuna c’è un gran sole in quel giorno di maggio. I vestiti di Ciro sventolano su un cespuglio, mentre lui in mutande si diverte a fare orme e tracce sulla sabbia e poi a toccarle con le mani, la nonna , strizzata la grande gonna nera, cammina avanti e indietro sulla spiaggia per farsi asciugare gli abiti umidi che ha addosso.
- E’ l’ora di mangiare – chiama dopo un po’, e tira fuori dalla grande borsa: polpettone, frittata, formaggio, pane e frutta. Ciro non è mai stato un gran mangione, ma quel giorno divora tutto, mentre chiacchiera senza pause.
- E’ stato bellissimo. Sentivo il mare che si muoveva intorno alle mie gambe, avanti e indietro, avanti e indietro. E’ tiepido, non è come il fiume. E poi così saporito. E la voce!. Mamma mia quanto parla. Adesso senti nonna, ha cambiato voce, parla più piano.-

Ortona Mare (Abruzzo) – Spiaggia al tramonto
(Foto Rossana)
- Sì, è diminuito il vento – sospira la nonna. Lei si riempie gli occhi dei colori del mare, come vorrebbe che anche Ciro vedesse.
Lui come se avesse letto il suo pensiero le chiede di botto: - Di che colore è il mare, nonna? Anzi, te lo dico io come me l’immagino. Ecco, qui dove fa più caldo deve essere color pomodoro, qui proprio all’inizio dove mi bagna il piede dev’essere… bianco, quasi come il sapone, quando mi lavo le mani, e più avanti, nel mezzo… non lo so, ma lontano lontano dev’essere color melanzana, sai quelle lunghe, lisce che mi fai fritte d’estate-
- Bravo, Ciro, hai indovinato tutto- esclama la nonna commossa – Ora che abbiamo visto il mare possiamo tornare a casa.-
- Ci torneremo?-
- Sì, ogni anno a maggio. – risponde risoluta la nonna.
- E i soldi, nonna, dove li trovi? –
- Ah, questa volta so io dove trovarli. Tuo papà, ogni anno deve regalarti una pecora e se non lo farà, se non capirà, vorrà dire che gliela mangerà il lupo. - conclude ridendo la nonna.

Il Giglio di mare cresce tra le dune della
spiaggia di Ortona
Nonna e nipotino, infilate calze e scarpe, voltano le spalle al mare portandosi dietro il suo ricordo, che li accompagnerà per un anno.
Ada BOTTINI
Le foto sono state inviate dal socio Com.te Nunzio CATENA
Rapallo, 8 Settembre 2017
IL REZZAGLIO DEL MIO AMICO "COCOLA"
RACCONTI IN RIVA AL MARE
IL REZZAGLIO DEL MIO AMICO ENNIO detto "COCOLA"

Pubblicazione che riporta le foto di Cocola che seguono


Ennio "Cocola" in attesa

Cocola in azione...

Splendido scatto! che rende l'idea dell'ampiezza del rezzaglio lanciato da Cocola

Cocola aggiusta la sua arma...

Nunzio Catena a lezione di rezzaglio da "Cocola"
Per quanto riguarda il rezzaglio, come si può vedere dalla foto, bisogna raccogliere la rete in una maniera ben precisa e tenerla nella mano destra, mentre una parte dei piombi della circonferenza va sul braccio ed un'altra viene lanciata con la mano sinistra per far aprire la rete.. Questa è una pesca che per avere buon esito va fatta ad una profondità massima di un metro, se maggiore, per il tempo che la rete tocca il fondo, il pesce, con un colpo di coda, è già fuori. Per questi motivi non viene pescata dalle vostre parti.
Quella che 'Cocola' faceva per vivere, è una pesca molto sportiva, innanzi tutto ci vuole abilità a lanciarlo perché il pesce, che veloce cerca di entrare nel fiume, vede noi come noi vediamo lui, perciò la rete deve essere lanciata quasi rasente la superficie del mare altrimenti se troppo alta, per quando i piombi toccano il fondo, ha tutto il tempo per fuggire.. Diversa è la pesca in acqua torbida, quando viene lanciato a caso, nel qual caso gioca la fortuna, oppure si lancia un sassolino, se ci sono cefali nei dintorni, questi dapprima si allontanano ma poi, siccome sono curiosi, tornano per vedere cos'è, cercando di calcolare i tempi, può andare anche bene. Purtroppo dove era Cocola, questi ultimi tipi di pesca non potevano essere effettuati e l'unico punto dove i cefali e qualche spigola convergevano, era la foce del fiume, dove la corrente uscente del fiume, 'urtando' l'onda del mare si alza e in quella trasparenza si riesce a vedere il pesce che veloce cerca di entrare.
Anche io ho imparato da piccolo a lanciarlo con una rete proporzionale alla mia 'stazza' e pescavo i pesci piccoli vicino a Cocola (che lui non pescava). Da bambino andavo lì perché papà aveva un 'trabocco' da 6 mt. di lato, al fiume, proprio vicino alla foce.
È stato proprio un bellissimo 'rezzaglio' il regalo che mi aveva fatto Marilena appena dopo sposati, perché spesso mi lamentavo di quello che avevo...Lo aveva fatto a mano il Sordo. A mano, perché spesso lo fanno raccordando diversi pezzi di rete, invece quello era fatto aumentando per ogni giro di rete un certo numero di maglie in modo che dalle poche maglie che formavano il cerchietto centrale (attraverso il quale passavano i fili che servivano per tirare l'armatura con i piombi), si doveva arrivare ad una circonferenza di circa 15 mt. Mi piaceva da matti quella pesca, che più propriamente era una 'caccia', anche perché i cefali pescati erano commestibili e non come quelle 'petroliere' pescate nei porti, dove si vedono riuniti in gran numero che boccheggiando sembrano aspirare il petrolio come per purificare l'acqua.

La casa paterna di mio padre era molto vicina al fiume ed insieme ai fratelli hanno avuto anche prima della guerra un 'trabocco' che poi hanno ricostruito al ritorno di uno zio dall'America che da pensionato amava passare le giornate in quel tipo di pesca.
A proposito del rezzaglio, chi viveva di quello, era proprio Cocola, che era sempre alla foce del fiume Foro, in attesa di prendere qualche cefalo che cercava di entrare nel fiume. Purtroppo, Cocola non era da solo, ed allora era una lotta a chi prima poteva lanciare la rete; quando Cocola tirava la rete e vedeva nel cavo dell'onda che il cefalo era dentro, restava fermo, immobile, quasi in catalessi per alcuni secondi, chissà, forse la gioia di aver pescato qualcosa da vendere e portare casa qualche soldo.
Nel dopoguerra il REZZAGLIO era ancora molto praticato vicino alla foce dei fiumi e dei torrenti. Era un tipo di pesca molto redditizia, ma allo stesso tempo dispendiosa di energie, sia per il peso del piombo posto alle basi, sia per il fatto che la rete una volta bagnata diventava sempre più pesante.
Nel periodo che va da Ottobre a Dicembre con il passaggio di cefali, spigole e orate che migravano verso il mare si ottenevano risultati eccezionali, pescando soprattutto spigole di grosse dimensioni.
Un tempo il rezzaglio veniva costruito (sarebbe meglio dire autocostruito) in canapa o cotone, ora viene utilizzata la tortiglia di polyester o il nylon. Anticamente cucita a maglia sempre più fitta mano a mano che la rete si allontanava dal centro del cerchio, adesso viene cucito a fasce di diversa grana, mano a mano più fitta. Esistono infatti diversi tipi di grana a seconda della dimensione dei pesci a cui un rezzaglio è destinato.

Lungo il bordo inferiore del rezzaglio vi è una corda ricoperta di piombi (la funaia) che trascina la rete verso il fondo. La circonferenza della rete varia tra i dodici e i quindici metri.

Dal bordo partono circa venti cordicelle (i ramiglione) che passano all’interno della galla e confluiscono verso la corda del giacchio, lunga più di tre metri. Alle estremità della corda vi sono due occhielli (cappiole).
In alcuni modelli i ramiglione a circa venti centimetri dalla funaia si biforcano, questa deviazione è detta femmenella.

Ma come si usa? La barca si avvicina in modo lento e silenzioso verso la zona individuata. Il lanciatore si sposta verso la prua e posiziona la tavola del giacchio tra le sponde.
Il pescatore comincia serrando la corda intorno al polso (o infilando l’anello della corda al mignolo) così da non perdere la rete. Raccoglie con una mano la parte superiore del giacchio per circa metà della sua lunghezza. Con l’altra mano afferra il lembo rimasto libero.
Il pescatore ruota il busto all’indietro e, subito dopo, fa seguire un movimento in avanti. L’abilità del pescatore sta nel coordinare questi movimenti e nel lasciare andare la rete al momento giusto, facendo in modo che, grazie alla rotazione impressa, si apra completamente in aria prima di toccare la superficie dell’acqua.

Quando cade in acqua il rezzaglio deve essere disteso, così da coprire la maggior area possibile. Il peso dei piombi lungo la funaialo fa scendere rapidamente verso il fondo, imprigionando i pesci che incontra inabissandosi.
Il rezzaglio viene recuperato tirando lentamente con piccoli colpi la corda del giacchio e poi il fascio dei ramaglione. Mentre la rete viene raccolta, il perimetro della funaia si stringe e i piombi si avvicinano tra loro scorrendo sul fondo così da non far uscire i pesci.
Al pescatore non resta che issare il rezzaglio a bordo, posando la rete sulla tavola dove la libera del pescato.

Nunzio CATENA- Carlo GATTI
Rapallo, 2 agosto 2017
"ACQUA ALLE CORDE!" ... Domenica delle Palme
ACQUA ALLE CORDE !!!
<aiga æ corde!> (in sanremasco)
<Ægua a-e corde> (in genovese)
DOMENICA DELLE PALME

Ancora una volta l’esperienza acquisita in mare è tornata utile, anzi salvifica, anche in terra, come nel caso dell’Obelisco di Piazza San Pietro.
Siamo nel 1586 a Roma, la città che ne conserva più di tutte al mondo, alcuni egizi veri e altri fatti dai romani.
Andiamo con ordine. L’obelisco di cui parliamo, vecchio di più di 3200 anni, era nel 37 d.C. ancora posizionato ad Heliopolis, importante città egiziana, nota per la sua venerazione a Ra, il Dio Sole. lo volle a Roma, utilizzando una nave appositamente attrezzata e carica di lenticchie ove adagiarvelo, ce lo ha scritto Plinio, l’Imperatore Caligola che lo posizionò ad una estremità del Circo di Nerone, area su cui, dopo 1500 anni circa, verrà edificata la basilica di San Pietro. A seguito della posizione della nuova Chiesa l’obelisco si venne a trovare sul retro della stessa: per dargli dignità l’energico Papa Sisto V, francescano e molto stimato da San Filippo Neri e Sant’Ignazio di Lojola, decise di traslarlo sul davanti, dove ancora oggi lo ammiriamo ogni qual volta imbocchiamo Via della Conciliazione.
A dire il vero a quella dislocazione ci aveva già pensato 150 anni prima Papa Nicolò V, visto che sarebbe bastato spostarlo di soli 250 metri, ma le difficoltà tecniche, insormontabili all’epoca, non consentirono di realizzare il progetto. L’obelisco infatti è alto 25 metri e pesa 350 tonnellate; originariamente terminava con un globo dove la credenza popolare, poi smentita, asseriva vi fossero conservate le ceneri di Cesare. Il Papa, una volta preso atto che il globo era vuoto, lo fece togliere sostituendolo con la croce che ancor oggi si può ammirare e fece incidere in latino sul basamento questa dedicatoria <Sisto V Pontefice Massimo fece porre con immenso sforzo l’obelisco vaticano di fronte all’ingresso. Esso era stato originariamente dedicato a divinità pagane attraverso cerimonie profane. Anno 1587 secondo anno del pontificato>.

Disegni tecnici dell'architetto Ticinese Domenico Fontana
Per attuare il suo progetto, Papa Sisto incaricò dello spostamento l’Architetto Ticinese Domenico Fontana. Si costruirono argani, impalcature e carrucole impiegando 900 uomini e 140 cavalli. Tutti questi dati si ricavano dagli Archivi Segreti Vaticani che, minuziosamente, hanno appuntato tutto ciò che veniva speso per qualunque opera afferente il Vaticano. Si pensi che hanno anche la documentazione di quanti alberi furono comprati per approvvigionare il cantiere durante la costruzione della Basilica di San Pietro: interi boschi nel Lazio e nella bassa Toscana o quanti soldi costò far affrescare da Michelangelo la Capella Sistina. Credo sia l’archivio più dettagliato e puntuale del mondo, ante-computer.

Il Cantiere
Finalmente il 10 Settembre 1586, terminati i lavori di traslazione dell’obelisco in Piazza, iniziarono i lavori per erigerlo. Data la pericolosità e l’impegno per compiere quel difficile lavoro, fu diramato l’ordine di osservare il più assoluto silenzio a che gli ordini impartiti giungessero forti e chiari a chi doveva operare. Per chi avesse trasgredito c’era la pena di morte seduta stante: il boia e la forca erano già pronti.
Essendo già stata allestita una gigantesca impalcatura attorno all’obelisco a formare una specie di strada pensile su cui fare scorrere grazie ad uno scivolo il monolite, e realizzato pure il basamento su cui metterlo una volta raddrizzato grazie ad una serie di carrucole e rinvii. Per preparare il tutto ci lavorarono da Aprile a Settembre tutti quegli uomini, i cavalli, 44 argani e una infinità di paranchi appositamente costruiti, coordinati dal Fontana che si era fatto costruire un grande trespolo dall’alto del quale poter vedere i lavori, impartendo ordini che per giungere chiari a tutti, venivano tramutati in squilli di tromba, o rulli di tamburi o segnalazioni con bandierine. Da qui si capisce il perché dell’obbligo all’assoluto silenzio. Siccome i curiosi potevano solo assistere ma da lontano, si volle far capire che il silenzio imposto era assoluto e per meglio convincere gli eventuali riottosi, come abbiamo detto, si allestì sulla Piazza la macchina della forca: a buon intenditor poche parole.
I lavori finali furono suddivisi, diremmo oggi, in 52 “steps”, alla fine dei quali lo si raddrizzò. Una volta raddrizzato bisognava alzarlo e posizionarlo sul predisposto piedistallo. Lì fu il momento più delicato; le corde a causa dell’attrito cominciavano a fumare per poi certamente rompersi, pericolo non avvertito da chi le doveva controllare, impegnato come era a guardare dove e come posizionarlo. Quando se ne accorsero l’allarme arrivò all’Architetto; questi, uomo di terra, si paralizzò non sapendo che fare.

Fu allora che dalla folla ammassata tutto attorno dove poi sorgerà il colonnato, si levò un grido con voce abituata a superare anche l’ululare del vento, che risuonò chiaro <aiga æ corde!>. Come capita a chi sta per annegare che istintivamente si aggrappa al primo oggetto che gli galleggia vicino senza controllare cosa sia ne attendere oltre, così avvenne in quella occasione. Prima che arrivassero gli ordini per via gerarchica, gli addetti ai lavori eseguirono istintivamente quel perentorio ordine risuonato nella Piazza, bagnando subito le corde che, così come capitava a bordo, si raffreddarono e si contrassero ritendendosi, evitando l’inevitabile dramma. Era il frutto dell’esperienza maturata in mare quando si utilizzavano gli stessi canapi.

Il Papa, che seguiva i lavori da un balcone del Palazzo Apostolico, aveva capito che quel trasgredire la norma aveva evitato una tragedia e diede ordine che l’uomo che era stato appena arrestato, gli fosse condotto davanti. Arrivato, quello si qualificò come Comandante marittimo Benedetto Bresca di San Remo.
Invece di condannarlo, come la solita ottusa burocrazia avrebbe fatto per aver fiatato ignorando il divieto, gli concesse larghi privilegi assegnandogli una lauta pensione ed il diritto di issare sulla sua nave il vessillo Pontificio. In compenso il Bresca, sollecitato per ottenere una ricompensa, chiese l’onore per se e i suoi discendenti, di fornire alla Basilica di San Pietro i rami d’ulivo e tralci di palma, i <Palmureli>, per la Settimana Santa, a imperituro ricordo di quanto fece lui, sanremese. Questo impegno viene onorato ancor oggi dai suoi discendenti coadiuvati dal Consorzio “il Cammino” di San Remo, dal Centro Studi e Ricerche per le Palme, dalla Regione Liguria che è subentrata alla ex Provincia di Imperia e dai comuni di Bordighera <Città delle palme> e da San Remo <Città dei fiori>, il tutto sotto gli auspici della Fondazione Bambino Gesù.
Invece la fornitura dei rami di ulivo avviene a rotazione fra le Regioni dove lo si coltiva (quest’anno tocca alla Sardegna) mentre i tanti elaborati palmureli occorrenti, alti un metro e mezzo, vengono distribuiti, oltre che al Papa, anche ai Cardinali e ai Vescovi partecipanti alla cerimonia. Per garantirne la fornitura si è coinvolta anche Bordighera dove esiste il palmeto più settentrionale d’Europa.
Anticamente i palmureli venivano recapitati via mare; quando l’imbarcazione che le trasportava arrivava alla foce del Tevere, godeva del privilegio di avere la precedenza su tutti i natanti e, per farsi riconoscere, ne innalzava uno sull’albero di maestra.
Per la storia, all’Architetto Fontana furono commissionati altri quattro recuperi di obelischi in Roma
Ed ora permetteteci un po’ di campanilismo: se il Comandante fosse stato genovese per impartire l’ordini di dare <acqua alle corde> avrebbe urlato <Ægua a-e corde> e non <Aiga æ Corde>; ma lui era sanremasco !
Renzo BAGNASCO
Foto e consulenza di Carlo Gatti
Rapallo, 31 Marzo 2017
ASCOLTA IL DELFINO
ASCOLTA IL DELFINO
Vivono nel mare, insieme alle balene e alle meduse, anche la Verità, la Vita, la Sapienza.
Lungo i secoli molti marinai, pescatori, bambini le hanno incontrate, ma nessuno ha mai creduto ai loro racconti. Così, ancora oggi, molti ignorano questi tesori del mare.

Un bambino viveva su un’isola del Mediterraneo con il suo papà, che faceva il guardiano del faro. La mamma non aveva resistito a quella vita solitaria ed era ritornata al suo lavoro in città.
Sull’isola non abitava nessun altro, ma il guardiano del faro aveva molti amici. Spesso venivano a trovarlo.

A Carlo, il bambino, piaceva vivere sull’isola. Passava il tempo nell’orto del papà o sulla spiaggia in amicizia con gli animali e la natura. L’unico suo cruccio era la nostalgia della mamma. Quando questo sentimento lo assaliva con più forza, si sedeva sulla spiaggia a buttare pietre in mare e a leccarsi le lacrime, che non riusciva a trattenere.

Un giorno, mentre era in questo stato d’animo, apparve davanti a lui un’onda altissima e trasparente come cristallo.
- Chi sei? – chiese il bambino.
- Sono la Verità- rispose l’onda.
- Allora dimmi, la mia mamma mi vuole bene? – domandò Carlo.
- Sì, non sa neppure lei quanto – disse di rimando l’onda.
- E come faccio a farglielo capire?-
- Io sono la Verità. So come sono le cose e le persone, ma non so cambiarle. – rispose l’onda appiattendosi.

Prima che l’onda scomparisse del tutto, Carlo vide un delfino trapassarla ed agitare la coda in segno di saluto.
- Ciao delfino. – gridò Carlo.
Poco dopo il mare cambiò di nuovo aspetto. Proprio lì, davanti al bambino, si formò una chiazza, un laghetto quasi. Questo specchio d’acqua appariva sempre diverso: liscio e piatto come una lamina d’acciaio, poi increspato e azzurro, verde agitato, blu profondo, trasparente e leggero come aria.
- Come sei bello, mare! – esclamò Carlo.
- Io sono la Vita. Sono mutevole. Ricordati che mi hai trovato bella. Se non cambierai idea, io ti darò molto. – disse la Vita, mentre continuava a cambiare faccia.
- Io rivoglio la mia mamma. – disse Carlo quasi piangendo.
- La riavrai – disse il delfino balzando fuori dallo specchio della Vita.
- Come?- gridò Carlo, ma il delfino e lo specchio della Vita erano già scomparsi.
Tutto rimase tranquillo per un certo periodo, mentre Carlo stava ancora sulla spiaggia. Rifletteva su quanto aveva visto e non si decideva ad andarsene.
Ecco di nuovo il mare mutare. La superficie si appiattì, il colore s’ intensificò in un turchese denso e consistente. Era veramente bello, ma intimoriva quasi: l’acqua sembrava marmo.
Il colore parlò a Carlo: - Io sono la Sapienza. Abito il mare e gli uomini non mi amano. Cosa vuoi da me, Carlo?-
- Io vorrei il ritorno della mia mamma – rispose il bambino intimidito – Mi manca solo questo.-
- E’ un bisogno vero – sentenziò la Sapienza – Non stancarti di ripeterlo alla mamma e al papà. Capiranno. Ricordati, non stancarti, sii tenace. Concluse la Sapienza inabissandosi con il suo colore, mentre il delfino la seguiva verso il fondo.
Carlo tornò al faro contento e agitato. Non vedeva l’ora di raccontare tutto al suo papà, che quella sera aveva a cena parecchi amici.
Appena il bambino incominciò a raccontare, gli adulti si scambiarono occhiate d'incredulità e derisione.
“Bella fantasia” disse uno, “Diventerà un romanziere” aggiunse un altro.
- Dai, Carlo, smettila – gli intimò infine il papà.
Carlo, però, si sentiva forte e sicuro e continuò il suo racconto senza farsi intimidire. Alla fine alcuni amici avevano l’aria seria e preoccupata.
- Questo bambino sta troppo da solo. Devi provvedere, Maurizio. Meglio un collegio, di una vita così isolata.-
I consigli si susseguivano, quando un lampo squarciò le tenebre della notte e sul mare apparvero insieme la Verità, la Vita e la Sapienza, con il delfino che nuotava da una all’altra. Fu un attimo, il tempo di un fulmine, ma tutti zittirono, videro e , forse, qualcosa capirono.
- Domani, telefonerò alla mamma e parleremo di te. – disse il papà a Carlo.

La mamma non vedeva l’ora di essere cercata: il lavoro da solo non le bastava.
- Ho già in mente la soluzione – disse al marito – Tornerò sull’isola. Posso lavorare con il computer e, una volta alla settimana, io e Carlo andremo insieme in città per organizzare il mio lavoro e fare la spesa. Forse così funzionerà. – concluse.

Carlo era felicissimo della decisione della mamma, il suo papà anche.
Stavano correndo insieme sulla spiaggia per festeggiare, quando apparve il delfino.
- Ciao delfino, grazie. – disse Carlo.
- Io ti ho salvato – rispose il delfino – Tu, crescendo, salva il mare.-
- Lo farò, se m'insegnerai – gridò Carlo, mentre il delfino spariva.
E questa volta sentì anche il suo papà.
ADA BOTTINI
Rapallo, 26 febbraio 2017
UN AFFRESCO DEL MONDO DEI BARCACCIANTI
UN AFFRESCO DEL MONDO DEI BARCACCIANTI

Il m/r TORREGRANDE in un dipinto di Marco Locci
In piena notte fui svegliato dalla voce assonnata del Capitano d’Armamento della Società Rimorchiatori Riuniti. Ero convocato d’urgenza sull’ormeggio di Ponte Parodi (Porto di Genova). La petroliera inglese SANTORINI, 40.000 tonnellate di stazza lorda, si era arenata sulla costa sud orientale della Sardegna. TORREGRANDE e CASTELDORIA erano stati scelti per l’operazione di disincaglio.

Molo Giano-Anni ’60 – Nella foto si nota la prora di un rimorchiatore portuale guarnita di “paglietto” (parabordo) usato soltanto in porto per spingere sul fianco di una nave nella fase finale dell’ormeggio in porto. Il paglietto veniva tolto in navigazione d’altura. Sullo sfondo la Torre Piloti ricostruita nel 1947 dopo essere crollata due volte durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. La struttura esiste tuttora ed è assegnata ad altri servizi nautici.

Porto di Genova. M/r SVEZIA – Ultima generazione Voith Tractors. Notare la versione moderna del “paglietto” di prora.
“Abbiamo provveduto al rinforzo dell’equipaggio – m’informò il dirigente con un certo rammarico, consapevole dello spostamento forzato delle mie ferie. - Ho fatto togliere il “paglietto” di prora dalla squadra d’emergenza. Abbiamo provveduto a fare il pieno di bunker. Troverete pronto tutto l’occorrente, comprese le provviste per tre giorni. Contatterete la nostra Agenzia di Olbia che provvederà a mandarvi un mezzo con le provviste che gli ordinerete via radio. Lei sarà il capo convoglio”.
Pur essendo abituato a quel giro di chiamate, sempre notturne, sempre in inverno e con il mare che monta la diga, l’adrenalina mi entrò in circolo rapidamente senza rendermene conto. Durante il veloce viaggio da Rapallo a Genova, elencai mentalmente tutte le operazioni necessarie che non sarebbero mai venute in mente a chi non era interessato “direttamente” al disincaglio. Mi concentrai sulle carte della Sardegna orientale, sulla scelta del personale di rinforzo: 1° ufficiale di coperta, 1° ufficiale di macchina, marinaio, mozzo, marconista, sommozzatore, bombole, cavi nuovi, materiale per tamponare le falle ed infine i documenti per la “pratica di partenza” in Capitaneria.

Anni 2000 - Porto di Genova – Sulla testata di Ponte Parodi sono ormeggiati prora a terra i rimorchiatori in attesa della chiamata operativa. Sullo sfondo é visibile: l’entrata della Vecchia Darsena e parte del “nuovo look” del Porto Antico.
Era il 1969. Giunsi a Ponte Parodi tra il lusco e il brusco. Buona parte della “Terza Flotta” (così chiamata la flotta RR di allora) era nervosamente in movimento, sovrastata da nuvole di vapore. Quattro navi stavano pendolando in rada nell’attesa del pilota e gracchiavano in VHF chiedendo istruzioni.

Il TORREGRANDE (in primo piano) visto da un passacavi di bordo
Il Torregrande era ancora al suo posto, con la prora a terra, nella stessa posizione in cui l’avevo lasciato la sera prima. Il suo “naso” senza paglietto gli restituiva eleganza, ma senza quella bardatura medievale, perdeva aggressività come se, improvvisamente, fosse stato relegato a compiti di retrovia.
Per salire a bordo i marinai avevano sistemato una stretta passerella di legno dondolante che non prometteva nulla di buono...
La prua del Torregrande era molto più alta della banchina, ma nessuno aveva pensato a collegare, forse per la premura, uno scalandrone più decente.
Di solito si saliva sulla prora del rimorchiatore a filo banchina, e poi si trasbordava saltando da una coperta all’altra sino a giungere a destinazione. Ma quella mattina ancora buia, i rimorchiatori portuali avevano lasciato l’ormeggio per l’imboccatura e il “bestione d’altura”, alto, maestoso e senza “damigelle” legate al suo fianco, era legato di punta a Ponte Parodi, in solitario e con poche cime sottili.
Mi avviai con fare sbrigativo sull’asse di legno, con il solito sacco di tela olona che usavo per le trasferte brevi. Purtroppo sottovalutai la potente “smacchinata” dell’ultima “barcaccia” (rimorchiatore in tono affettuoso...) in partenza che diede un colpo di maglio sul fianco del Torregrande che si traversò facendomi perdere l’equilibrio. Il sacco cadde in mare insieme all’asse di legno che avevo sotto i piedi. I miei 30 anni mi permisero di rimanere appeso ai maniglioni del paglietto finché giunse il nostromo Zeppin richiamato dalle mie imprecazioni... Per fortuna mi stava aspettando sulla prora, ansioso di dirmi tante cose... e appena percepì il pericolo chiamò rinforzi e in tre riuscirono a sollevarmi sul copertino e a recuperare con la gaffa il mio sacco “galleggiante”.
“Belin Comandante! Voî pe pöco cazeîvi in mâ comme u Fiesco”
(per poco cadeva in mare come il Fiesco)”. Borbottò preoccupato il mio fedele nostromo.
“Vorrai dire come un belinone..”. – risposi trafelato - ma felice come fossi giunto in zona medaglie al bordo della piscina - Grazie per il salvataggio. Fatemi sapere chi é quel tanghero ... lo ringrazierò a modo mio, con la stessa moneta.”
Il tempo “maneggevole” ci mise tutti di buon umore e, allontanandoci da tanti occhi indiscreti, mi sentii finalmente “libero” di decidere e risolvere i problemi imminenti alla mia maniera.
Il marconista Gino si mise subito in contatto con la nave in difficoltà, e seppi che in seguito ad un blackout del motore, la SANTORINI aveva scarrocciato verso la costa andandosi ad appoggiare con la prora sulla scogliera che scendeva a picco su una spiaggia di sabbia. Il resto dello scafo sembrava libero e non incagliato.
Il direttore di macchina Silvan giunse sul ponte di comando per avvisarmi che il motore era a pieno regime. Alla nostra abituale velocità di 13 nodi, potevamo coprire la distanza di 310 miglia in 25 ore.
Con quella bonaccia, prima ancora d’entrare nel clima della “spedizione”, l’equipaggio si radunò spontaneamente sul ponte di comando. Capii che l’idea prevalente era di tornare sulla scena del delitto: il Comandante appeso come un salame al posto del paglietto di prora...
Giocai d’anticipo e chiesi al nostromo: “Zeppin, ma com’è la storia del Fiesco?”
Il nostromo Zeppin era il più anziano di bordo ed anche il marinaio più esperto. A lui spettava di prendere la parola, anche perché la frase: “per poco facevi la fine del Fiesco” sembrava una delle numerose frasi del suo repertorio, un po’ sibilline e tanto storpiate che erano destinate a fare il giro di tutti i bordi di Ponte Parodi suscitando ilarità e commenti sui marinai carlofortini dei quali, per la verità, nessuno osava mettere in dubbio le qualità marinaresche, lo spirito di servizio e l’inesauribile laboriosità.

“Leudi Surairi” (zavorrai) alla foce del Torrente Petronio a RIVA TRIGOSO. A prua si nota la passerella molto stretta su cui i marinai transitavano in equilibrio con la coffa colma di sabbia e pietrisco sulle spalle. I leudi adibiti a questo tipo di trasporto erano chiamati SURAIRI in dialetto rivano, ed i suoi marinai FROISCIU. Tra i vari tipi di Leudi, a detta degli esperti, il “Zavorraio” aveva la linea più ELEGANTE rispetto ai Vinacceri e ai Formaggiai.
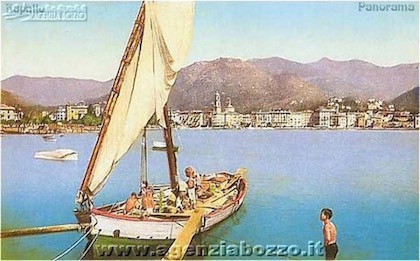
Leudo a Rapallo
E’ un modo di dire nella marineria di Carloforte. – precisò Zeppin - Da ragazzo navigai parecchi anni sui leudi “vinacceri”, “formaggiai” e “zavorrai”. Con questi ultimi si trasportava sabbia di fiume destinata all’edilizia dei costruttori del Tigullio. Il leudo pescava poco, si dava fondo la “zappa” (ancora) di poppa e si portava la prora a pochi metri dalla spiaggia dove si caricava. Il collegamento tra la prora e la battigia era un asse di legno lungo e molto flessibile. Scendere a terra con una coffa di sabbia sulle spalle, a parte il peso, era una specie di danza, ma se si perdeva il ritmo, era facile cadere in mare con la coffa in testa. Quanto capitava, la reazione del Capitano era sempre la stessa: pe pöco t’andavi in mâ comme u Fiesco. Ma mai nessuno mi spiegò il significato di quella frase. Forse non lo sapeva nessuno, così l’abbiamo sempre ripetuta a memoria come le scimmie”.
Radio cucina diffuse prontamente in genovese i suoi “giornali radio”…
Zeppin: (nostromo) Chi à premûa vadde adaxo.
(Chi ha premura vada adagio)
In effetti il Comandante aveva premura si partire…
Zagallo: De nëutte tûtti i gatti son bardi.
(Di notte tutti i gatti sono grigi)
Il cognome del Comandante era noto…
Zagallo (lo spiritello dispettoso): No te lasciâ di pê se ti no é attaccôu de man.
(Non lasciar andare i piedi, se con le mani non sei attaccato)
Per fortuna ero attaccato…
Bobby: (1° Uff.le) Se i belinoin avessan e äe, saieva de lungo nûvio.
(Se gli sciocchi avessero le ali sarebbe sempre nuvoloso)

Quando giungemmo in vista della SANTORINI, mi accorsi sul radar che la nave era staccata dalla scogliera. Si era disincagliata da sola. Chiamai il Comandante e chiesi se avesse ancora bisogno di noi.
“Abbiamo a disposizione pochi giri di macchina – rispose preoccupato – Ho bisogno che il vostro sub s’immerga di poppa per farmi una perizia su eventuali danni subiti dal timone o dall’elica. Temo che non sia tutto in ordine. Sentiamo forti vibrazione che da poppa arrivano fino al ponte di comando.
“OK Comandante. Stia tranquillo! Dugga, il nostro esperto sommozzatore, si é fatto cinque anni di guerra, quasi tutta sott’acqua. Il Mediterraneo é un cimitero di navi, ha fatto tanto allenamento! Andrà subito a poppa, ma poi gli farò ispezionare tutto lo scafo.
“Molto bene faremo così. Poi decideremo insieme il da farsi”.
Dugga rimase in acqua circa un’ora ed il suo rapporto fu impietoso per il Comandante della nave, ma molto vantaggioso per la nostra Società.
La petroliera UK era andata per scogli... Due pale dell’elica erano completamente piegate. Del timone era rimasta soltanto la parte alta appesa ad un solo agugliotto.
Più brevi del previsto furono gli accordi intrapresi tra gli armatori delle due unità. L’ordine mi venne confermato con un telegramma che m’invitava a prendere immediatamente la nave a rimorchio con destinazione Genova.
Mi recai sul Ponte di Comando della nave per concordare la rotta, l’assetto e le comunicazioni. Con me salirono a bordo il D.M. Guido Bianchi per carpire notizie sull’avaria del motore, il 1° Ufficiale di coperta Giorgio Ghigliotti che insieme al nostromo Zeppin si recarono a prora per occuparsi degli attacchi da rimorchio che avevo predisposto.

Il Comandante greco di nazionalità inglese parlava, come tutti i levantini, un ottimo italiano-marinaro. L’incaglio ed i danni che ne sono derivati, sono sempre vissuti da chi é al comando, come una sconfitta personale che potrà pesare in qualche modo sulla sua carriera. L’armatore e le Assicurazioni gli chiederanno molte spiegazioni sul suo operato di marinaio.
Il suo sguardo triste mi spinse a dargli tutto il mio appoggio morale e tecnico per ciò che rimaneva del viaggio. Ricordo che durante la navigazione, ogni due ore ci sentivamo sul Walky-Talkye e, dopo le prime conversazioni esclusivamente tecniche sulla navigazione in corso, prendemmo confidenza e si passò a parlare di sport, di musica, e poi delle nostre rispettive famiglie.
Il viaggio si concluse felicemente e con Capitan Lazzare diventammo amici......
P.S. Sul sito di Mare Nostrum Rapallo, nella Sezione NAVI E MARINAI-Saggistica Navale, il lettore può trovare il saggio:
QUANDO I FIESCHI FINIRONO A BAGNO...
Carlo GATTI
Rapallo, 10 Febbraio 2017
MACAIA e CALIGO
MACAIA e CALIGO
A Primavera in Rapallo si terrà il Raduno Regionale dei suonatori di campane, organizzato dall’Associazione Campanari Liguri, che sta tornando a rivivere per merito dei suoi associati, coinvolgendo sempre più giovani, indispensabili campanari di domani. In Liguria poi abbiamo addirittura un “suonare alla ligure” ed i campanari utilizzano per farlo, i “pestelli”, che battono su robusti tasti; pare siano rimasti gli unici ad usarli.

I nostri campanili si evidenziano in quanto sono sproporzionatamente alti rispetto alla Chiesa cui appartengono.

Li hanno costruiti così svettanti perché il loro suono, anche quando scandivano le ore, doveva essere facilmente udito da tutti, compreso i contadini sparpagliati a coltivare l’avaro terreno lungo le strette valli; per tutti era l’”orologio” che ritmava le varie fasi della giornata. Solo così l’onda, piovendo dall’alto, poteva giungere il più lontano possibile.

Non tutti sanno però che di analoga funzione ne fruiva anche chi andava per mare; fungevano da faro senza luce, da bussola e da “radar” in un’epoca nella quale pochi avevano l’orologio, se non lavoravano nelle ferrovie e nessuno possedeva gli altri due supporti: oltretutto il radar ancora non esisteva.

Abbiamo accennato a quanto il campanile rappresentasse anche una indispensabile sicurezza per chi era impegnato nella pesca a breve e medio raggio, sino a divenire vitale se si era colti dall’improvvisa foschia, il terribile <caligo>, che con la sua densità ovattata faceva perdere totalmente l’orientamento, così come erano indispensabile in certe notti che, divenendo improvvisamente buie e tempestose, era vitale localizzarne i rintocchi, unico sistema per dirigersi verso terra; così le torri campanarie sono state utilizzate per secoli.
Ed è a questo punto che entrano in scena “macaia” e “caligo”.
Edoardo Firpo nella sua < Mattin de frevâ > così canta il ‘dopo maccaja’:
A tramontann-a de vei
al’à scorrio a maccaja
e netto o çê a l’à lasciòu.
In sce-a cianùa marinn-a
sciorte de nuvie perfette.
E case i schêuggi a collinn-a.
son serræ dentro un cristallo.
Dai limpidiscimi monti
nasce unna strana creatua,
leggera leggera, ch’a dua
appena-a o tempo de moï.
Traduzione: La tramontana di ieri ha scacciato l’umidore e limpido cielo ha lasciato. Sulla pianura del mare escono nuvole perfette. Le case, gli scogli,la collina son chiusi in un cristallo. Dai limpidissimi monti nasce una strana creatura ,leggera leggera, che dura appena il tempo di morire.

In effetti la “maccaja”, così la si scrive in dialetto, è parola ligure di probabile origine greco/latina’ malacia’; sta ad indicare una singolare condizione meteorologica che si verifica in particolare nel Golfo di Genova, quando spira vento di scirocco, con cielo coperto e tasso di umidità elevato.

Di lei ha scritto Cristiano De Andrè nella sua Notti di Genova < Genova apriva le sue labbra scure/ al soffio caldo della maccaja>, la stessa che rende inutilizzabili i bicchieri se non ben lavati.
Tutt’altra cosa e assai più pericoloso è invece il <Caligo> ovvero la ‘nebbia di mare’.

La nebbia, spesso presente altrove, da noi si forma improvvisamente solo quando giunge il flusso mite dell’anticiclone africano e trova un mare ancora freddo: scorrendovi sopra fa condensare rapidamente le goccioline appena evaporate, rendendo invisibile tutto attorno. Si forma preferibilmente in Aprile e Maggio, mesi in cui il mare, che funziona come un condensatore, ha ancora una temperatura invernale; mai in autunno, quando il mare è ancora caldo dall’estate.
Oggi il caligo non gode più della triste fama di un tempo, perché a bordo tutti hanno una bussola quando non anche il radar ma, un tempo, in loro mancanza, era provvidenziale l’intervento delle campane.
In quei frangenti, le donne dei pescatori, sempre in eterna ansia, correvano dai Parroci, svegliandoli se di notte o allertandoli se di giorno, affinché suonassero le campane con uno suono cadenzato seguito da un certo silenzio prima di riprendere, così che chi era in mare potesse percepirne il caratteristico segnale e verso di esso orientarsi, perché il caligo è come un materasso di fitta nebbia, adagiato per uno spessore non eccessivo sul mare, ma talmente avvolgente da far perdere l’orientamento specie ai sottili e bassi gozzi. Quel suono ripetitivo e alternato cessava non appena, solo a pochi metri da riva, spuntava dalla nebbia una prua di qualche gozzo che, alla voce, orientava anche gli altri.
Lo so perché sono un “prain” e vedevo le donne, e pesciæ-e, quelle che avrebbero dovuto poi andare a vendere il pesce, raggruppate sulla battigia in angosciante attesa a pregare e scrutare: i capelli arricciati dalla bruma, l’una vicina all’altra, stringendosi nei loro lisi scialli
Ecco perché abbiamo ricordato i campanili parlando di … mare.
A Prà, sino a pochi anni fa centro di pescatori, il piccolo campanile di San Rocco, era praticamente sulla spiaggia perche lì avevano edificato la demolita Chiesetta.
Chiudiamo con questa vecchia filastrocca:
Alto svetta il campanile
Sotto un celo primaverile
Poi scampana allegramente
Per avvisare tutta la gente
Che c’è festa in tutto il mondo
Fin nel mare più profondo
Forte suona la campana
Nella valle più lontana
Per portare in ogni cuore
La certezza dell’amore
Renzo BAGNASCO
Rapallo, Martedì 7 Febbraio 2017

