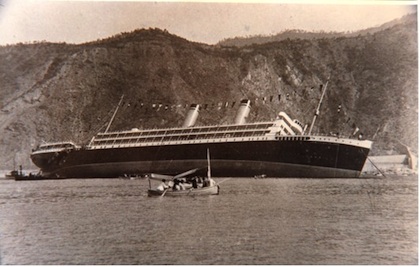TROMBE D'ARIA A GENOVA
LE TROMBE D’ARIA
UN INCUBO PER L’ARCO LIGURE ED IL PORTO DI GENOVA
Le cronache di mezzo agosto 2014 si sono dovute occupare, ancora una volta, di trombe d’aria che si sono abbattute sulla costa genovese provocando gravissimi danni materiali alle strutture del litorale. Per non dimenticare, abbiamo pensato di rievocare, a dieci anni esatti di distanza, i due episodi che misero in ginocchio il porto di Genova paralizzando il settore “containers” per un anno intero. A quei danni ingentissimi, si aggiunse la morte di un portuale genovese che rimase schiacciato dalla gru che doveva proteggerlo.
31.8.1994 - 17.9.1994
Due date che i genovesi non hanno più dimenticato
Il fenomeno meteorologico si ripeté dopo 17 giorni in un’altra zona del porto di Genova: otto gru furono abbattute.
|
Data |
Zona |
Tipo di gru |
Danni Lire |
Mor.Fer. |
31Agosto 1994 |
P.te Rubattino |
Elevatori |
|
1 - 50 |
17 Settem.1994 |
P.te Libia |
Portainer |
Centinaia di Miliardi |
due date |
Su tutto l’arco ligure si scatenarono in quel periodo gigantesche trombe d’aria che portarono scompiglio, allarmi, danni e morte. Forse sarebbe più corretto chiamarli tornado*, perché essi dimostarono la stessa forza distruttiva dei loro parenti americani.

La tromba d’aria si sta avvicinando minacciosa alla diga del porto di Genova.

Ai piedi della Lanterna si consumò questa ennesima tragedia. Di prora alla nave si vede la gru appena abbattuta. La “VECTIS ISLE” di appena 2.330 t. é stata risparmiata dalla tromba d’aria per pochi metri.
Il 1° settembre ’94, l’autore mise in partenza la piccola nave britannica Vectis Isle (vedi foto) da calata Bettolo ponente, a pochi metri dal punto in cui perse la vita lo sfortunato gruista genovese.
L’anziano comandante inglese era ancora sotto schock e raccontò la tragedia al pilota, così come la vide e la visse: “Seguivamo con apprensione la rotta a zig-zag dell’enorme tromba d’aria che proveniva dal mare, mentre eravamo rinchiusi dietro i vetri del nostro ponte di comando. Quando vidi quell’immensa colonna nera puntare decisamente verso il nostro molo, uscii sull’aletta ed urlai al gruista di scendere e scappare. Il portuale si rese conto immediatamente del pericolo, scese e si mise al riparo dietro la gru stessa, che forse, molte altre volte lo aveva protetto da fenomeni atmosferici ben più comuni.

Distruzione e morte. In primo piano la gru che ha investito lo sfortunato portuale. Le gru di Ponte Rubattino erano - “Elevatori Ansaldo IV” – da sei tonnellate costruiti nel 1952.
Nel frattempo il tornado (così lo definì) colpì ed ingoiò brutalmente la prima gru, quella che era posizionata in testata Rubattino, la sollevò e la scagliò come fosse un giocattolo verso la gru più vicina a noi, la stessa che divenne la tragica tomba di quel pover’uomo che vi si era rifugiato dietro.
Non avevo mai visto nulla di più terrificante! Mi creda, anch’io sono all’ultimo imbarco prima del mio “retire”.
Ma oggi sono ancora più triste perché ho saputo dal mio Agente che anche il gruista, la vittima del tornado, era al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.”
Per avere una conferma, ancora più precisa, della forza immensa di queste trombe d’aria, si dovette attendere soltanto diciassette giorni, per assistere esterrefatti alla demolizione di gru alte più di venti metri ed un peso di centinaia di tonnellate.



9Queste gru erano del tipo Portainer, costruite dalle officine Reggiane su licenza Paceco e furono allestite nel 1971. Gru di questo tipo, sono tuttora operative, hanno una portata di 45 tonn. ed uno sbraccio di oltre quaranta metri.
Genova ed il suo porto dovettero attendere circa un anno, prima di vedere rimarginate quelle ferite che tante perplessità avevano suscitato non solo negli addetti ai lavori, ma soprattutto nell’opinione pubblica, tuttora incredula, dinanzi a ciò che razionalmente, è fuori statistica e si chiede:
“come è possibile che nel nostro organizzatissimo porto si possano verificare due identici e tragici incidenti, in tempi così ravvicinati”?
COME SI FORMA LA TROMBA D’ARIA?

L’insorgere di questo genere di fenomeni e’ strettamente legato alle condizioni atmosferiche. Quando si e’ in presenza di correnti d’aria calda negli strati inferiori e di correnti d’aria fredda negli strati piu’ alti, possono innescarsi fenomeni turbolenti. A causa della differenza di peso, l’aria calda degli strati sottostanti tende a salire verso l’alto, mentre quella fredda e’ spinta verso il basso. Se le condizioni delle correnti lo consentono, questo movimento di masse d’aria puo’ provocare un cilindro d’aria rotante intorno ad un asse perpendicolare al terreno. Processo di formazione di una tromba d’aria: la continua spinta delle correnti d’aria calda verso l’alto, puo’ allungare il cilindro d’aria verso l’alto creando appunto la tromba d’aria.
*Dalla grande enciclopedia “IL MARE”:
TORNADO: colonna d’aria posta in violenta rotazione, apparentemente sospesa alla base di un cumulolembo. Il terribile vortice presenta in genere un diametro di alcune centinaia di metri; ruota in senso antiorario e produce vento stimato da 100 a 300 km orari. La sua traiettoria è governata dalla sua nuvola madre. Il tornado che non è una per turbazione tropicale come uragani o tifoni, può verificarsi anche in Italia (Venezia 11 settembre 1970), ma raggiunge le massime frequenze in Australia e negli Stati Uniti dove se ne contano fino a 200 l’anno, specialmente nelle grandi pianure dei Fiumi Missisipi, Ohio e Missouri.
Carlo GATTI
Rapallo, 10 Ottobre 2014
COSTA VICTORIA - SOCCORSO IN ATLANTICO
COSTA VICTORIA
SOCCORSO IN OCEANO ATLANTICO

Al comando della Costa Victoria, (nella foto) il pomeriggio del 27 novembre 1998, partimmo da Genova, salutando come sempre con i fischi della sirena e con tanta tristezza nei cuori i nostri famigliari che continuavano a farci segno dalla banchina, sino a quando la nave era in vista. Le traversate atlantiche erano crociere che stavano diventando sempre più richieste. I nostri ospiti erano per il 50% italiani e per il resto di varie nazionalità; i porti più o meno erano sempre gli stessi. Questa volta, per avere una navigazione più confortevole e una minore onda lunga atlantica dopo Gibilterra, la nave fece scalo a Casablanca e, a seguire, a Santa Cruz de Tenerife per poi raggiungere i Caraibi.

St.Marteen
Partimmo da Tenerife con un forte vento in poppa, diretti al primo scalo dei Caraibi, la bella isola di St. Maarten. Il vento si manteneva teso, la nave superava tranquillamente i 21 nodi e i passeggeri si godevano la splendida giornata sui ponti esterni rinfrescati da una lieve brezza che dava un senso di piacere a chi si stava crogiolando al sole.

Stavamo navigando tranquillamente da due giorni, quando, sul tardo pomeriggio, avvistammo all’orizzonte una barca a vela (nella foto) lunga circa 18 metri. Poco dopo fummo chiamati dall’imbarcazione che ci segnalava di avere delle difficoltà: stava procedendo a vela, ma utilizzava soltanto il fiocco in quanto il forte vento dei giorni precedenti le aveva spezzato il boma, si erano scardinati i perni della connessione del giunto con l’albero e lo stesso giunto era danneggiato. Secondo l’equipaggio della barca a vela - tre donne e quattro uomini di nazionalità francese - il danno sarebbe stato riparabile se avesse potuto avere assistenza. Mi feci dare le generalità: erano due coppie intorno ai 50 anni, con tre figli, due ragazzi e una ragazza di oltre 20 anni. Tutti appassionati di vela, avevano intenzione di proseguire verso l’isola di Antigua. Dal nostro ufficio security di terra, al quale chiedemmo di controllare le generalità avemmo conferma della veridicità delle informazioni ricevute. Per ridurre i tempi di avvicinamento diedi agli occupanti della barca la rotta sulla quale dovevano procedere per venirci incontro. Non appena fossimo stati a circa due miglia di distanza avrebbero dovuto ammainare il fiocco e non tentare alcuna manovra di contatto con noi. Gradatamente cominciai a ridurre la velocità, mentre il nostro personale era al portellone principale, pronto alla manovra.

Fermai la nave quando la barca era a una distanza di circa cinque metri al nostro traverso. La barca che ci apprestavamo ad assistere era veramente bella e comoda, ricordo che si chiamava “La Belle Etoile”. Data la vicinanza il lancio delle nostre cime a bordo fu facile. Comunicai via radio a Louis, che stava al timone, di utilizzare il motore e mettersi con la prora al mare, tirare le cime e affiancarsi, assicurandolo che i nostri parabordi avrebbero protetto l’imbarcazione. La manovra riuscì perfettamente, l’onda lunga causava un po’ di beccheggio, ma l’ormeggio sottobordo era sicuro. Gradatamente, utilizzando le eliche di manovra, mi traversai al mare lungo, proteggendo ulteriormente la piccola imbarcazione dall’onda lunga. Il nostro carpentiere e l’operaio meccanico salirono a bordo e verificarono che per la riparazione erano necessarie almeno due ore, in quanto si doveva ricostruire un pezzo solido di rinforzo in acciaio, fattibile con i nostri mezzi. Avvertii i passeggeri della situazione; molti di essi avevano già filmato con le cineprese la manovra ed erano curiosi di sapere che cosa avremmo fatto. Nel frattempo, dal nostro portellone, su gentile richiesta di Louis, provvedemmo a completargli il rifornimento di gasolio e a fornirgli due grossi sacchi di provviste alimentari di ogni genere. Il lavoro fu completato in oltre due ore, nel corso delle quali il nostro personale aveva effettuato una riparazione permanente. Sicuramente, in quel punto, il boma non si sarebbe più rotto, neppure con vento forte. La gioia dei francesi fu immensa, si sentivano ora sicuri di poter continuare il loro viaggio. Era loro intenzione trasferire l’imbarcazione ad Antigua per poi ritornare in patria in aereo perché i ragazzi frequentavano l’università; successivamente, in estate, avrebbero visitato tutte le isole dei Caraibi.
Dopo circa 20 giorni ricevetti, tramite posta elettronica, la conferma del buon esito del loro viaggio con molti ringraziamenti per la nostra assistenza ed efficienza. I francesi aggiungevano di aver fotografato la “Costa Victoria” dalla loro barca, e di averne fatto una foto gigante da tenere in ricordo di quella loro esperienza in mare.
I nostri passeggeri si erano entusiasmati nel seguire l’operazione di soccorso ed avevano ascoltato con interesse dal direttore di crociera, la sera, in teatro, tutti i dettagli dell’intervento, esposti nelle varie lingue straniere. Avevano apprezzato molto il nostro gesto e ricevetti numerose lettere lusinghiere di complimenti, specialmente dagli ospiti francesi. Il nostro viaggio proseguì tranquillo sino all’arrivo, dopo aver effettuato gli scali più belli e interessanti dei Caraibi.

Una nave di "Costa Crociere" in uscita da Port Everglades
Domenica 13 dicembre entrammo in porto a Port Everglades (Florida), concludendo ancora una volta con successo e gradimento degli Ospiti la traversata atlantica.
C.S.L.C. Mario Terenzio PALOMBO
COSTA VICTORIA
Dati Tecnici:
Consegnata alla Costa Crociere nel 1996 dal cantiere Lloyd Werft (Bremerhaven- Germania), dove è stata costruita. (DESIGN Italiano – progettata da uno studio di ingegneri italiani). Ho avuto l’onore di seguirne l’allestimento e assumerne il comando.
Le dimensioni della nave erano state studiate dall’armatore sulla base di parametri logistici e commerciali, perché potesse transitare lungo il Canale di Panama, passare sotto i ponti più importanti del mondo e operare tranquillamente in quasi tutti i porti del Mediterraneo.
La “Costa Victoria” è lunga 253 metri, larga 32.2, GRT: 75.176, (Stazza lorda) potenza apparato motori 30.000 KW, (propulsione diesel elettrica) capacità massima passeggeri 2370, equipaggio 790. E' dotata di tre eliche di manovra prodiera da 1.700 KW ciascuna e 2 poppiere da 1.700 KW ciascuna, due timoni attivi tipo “Becker” che danno alla nave un notevole effetto evolutivo.
Webmaster Carlo GATTI
Rapallo, 28 Agosto 2014
COSTA CONCORDIA - Un incubo da ricordare....
COSTA CONCORDIA
Un incubo da ricordare, tra superstizione e realtà.
Si sono spenti i riflettori sulla Costa Concordia e il mondo intero ha tirato un sospiro di sollievo.
Il TEAM del Giglio, composto da tecnici di 26 nazionalità, suddivisi in numerose specializzazioni, ha avuto ragione di esultare e lasciarsi andare a manifestazioni “liberatorie” contro un nemico insidioso che era presente sin dalla nascita della nave: la sfortuna! Le navi, come le persone, hanno un destino e se “il buon giorno si vede dal mattino”, la rituale e ben augurante bottiglia di champagne, come molti ricorderanno, non andò in frantumi al momento del varo. Un segno premonitore? I marinai sono superstiziosi e quel giorno non pochi si coprirono gli occhi per non vedere la fine del varo… osarono troppo? Ma non ebbero tutti i torti. I marinai e le navi hanno dei riti da rispettare, come tutte le cose antiche, materiali e spirituali di questo mondo.


Il relitto della Costa Concordia é finalmente ormeggiata sulla diga del porto di Voltri. Sullo sfondo una Maersk sta scaricando i suoi containers. (foto J.C.Gatti)
La nave è una creatura modellata dall’uomo che le ha dato una struttura, la forma, lo slancio, la velocità, il movimento, persino il “mugugno” quando soffre, quindi ha una sua personalità.
Il relitto attraccato alla diga di Voltri non è la Costa Concordia vista da lontano sugli schermi di casa nostra, mentre certi commentatori esultavano ed esaltavano la magia dei tecnici, come se questi avessero potuto ridare un volto umano all’oggetto di quel macabro funerale che lentamente procedeva verso la meta finale. Oggi, nulla di tutto questo è percepibile. Chi è stato a bordo a contatto con le sue strutture dilaniate, ci ha raccontato dell’odore acre, pungente del relitto tirato sul da fondo, d’aver visto un ammasso di strutture deformate dalla sua caduta sul fianco e uomini senza sorriso e senza volto alla ricerca affannosa di un naufrago ancora mancante e delle membra di altri passeggeri identificati soltanto in parte.
Diciamocelo con sincerità: la più grande sfortuna della Costa Concordia fu l’imbarco di un capitano che non era all’altezza di tanta grandezza ingegneristica, innovativa architettura e superba tecnologia e con un equipaggio addestrato, nonostante le “malignità diffuse”. La nave era talmente up-to-date da poter navigare come un drone telecomandato da terra. Magari gli armatori avessero osato tanto…!
Il Comandante di un veliero oceanico, fino alla seconda metà dell’800, aveva a bordo soltanto un collaboratore: lo scrivano, un 1° ufficiale ante litteram che aspirava al comando senza interferire nel “magistero” del suo superiore considerato dall’equipaggio: secondo soltanto a Dio.
Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, le navi furono motorizzate e le responsabilità del Comandante cominciarono a dividersi con il Direttore di macchina e gli ufficiali macchinisti. Per non essere da meno, furono imbarcati anche gli ufficiali di coperta che avrebbero garantito giorno e notte la guardia sul ponte di comando. Con l’emigrazione verso le Americhe e l’Australia, le responsabilità del Comandante aumentarono e si divisero con quelle dei Commissari di bordo. Con l’avvento della Radio, ci furono immediati vantaggi per la sicurezza dei viaggi oceanici, ed anche i Radiotelegrafisti diventarono protagonisti di salvataggi accanto al Comandante. In seguito, con l’imbarco dei Medici di bordo ed oggi con gli ufficiali Periti-Elettronici, il Direttore di Crociera e gli Ingegneri addetti al controllo delle strutture portanti della nave, il Comandante è diventato il manager che coordina l’insieme di questi settori, sebbene egli stesso, sia tenuto ad emettere gli ordini e le procedure che la legge gli impone.
In quella lunga notte del naufragio all’isola del Giglio, emerse inoltre una nuova “struttura di comando” che opera da terra: l’Unità di Crisi della Compagnia, istituita per supportare il Comandante nei momenti di grave difficoltà.
A questo punto la domanda che sorge quasi spontanea è la seguente:
“Ma cosa è rimasto a bordo dell’antico carisma del Comandante?”
Qualcuno potrebbe rispondere: “Nulla o quasi nulla!”
Eppure, in quel “quasi” solitamente pronunciato con tono sommesso e rassegnato, si nasconde l’elemento più importante della questione: l’EQUILIBRIO.
La nave ha bisogno di un Comandante che sia dotato di grande equilibrio, di grande personalità, ma soprattutto di tanta esperienza. Un uomo che conservi lo stile del vecchio Comandante di velieri, ma che sia anche padrone assoluto delle insidie nascoste nella tecnologia del nuovo millennio.
La nave moderna è ancora più “sensibile” delle navi di vecchia generazione. I timoni sono molto più reattivi di un tempo e basta un nonnulla per “esagerare” un’accostata. Per questo motivo è erroneo ed insensato scaricare colpe su un modesto timoniere che in manovra, ancor più che in passato, deve essere assistito ed affiancato da un ufficiale di coperta che ripeta gli ordini e ne controlli le esecuzioni, nello stesso modo in cui fu esercitato per secoli su tutti i ponti di comando del mondo, fin dai tempi più remoti. Le moderne eliche propulsive e di manovra sono in grado di garantire una velocità rotatoria vertiginosa, che è simile a quel giocattolo elettronico che ogni bimbo manovra in modo perfetto sotto i nostri occhi, senza avere - naturalmente - 4.000 persone a bordo.
Allora ci si chiede: Per quale recondito motivo quel tizio passò al comando? In fase dibattimentale emerse, fra l’altro, il contenuto di certe “note caratteristiche”, non proprio esaltanti, che furono stilate nei suoi confronti. Cosa sia successo in seguito? Non ci é dato sapere. Forse il vero responsabile di tanta imperizia lo si può immaginare inserito in quella lista “epurata” da Carnival subito dopo la tragedia.
Rimane da affrontare un ultimo punto: la formazione dei Comandanti.
Lo psichiatra Gian Paolo Buzzi, socio di Mare Nostrum, nonché studioso della materia e membro di Commissioni USA per la formazione di Comandanti di navi e di aerei, ci ha raccontato che da circa un decennio queste categorie sono sottoposte a TEST e controlli molto innovativi sulla soglia di reazione al pericolo, con la valutazione di parametri operativi come il coraggio, la freddezza, la determinazione, la capacità organizzativa nei momenti di grave difficoltà ecc… Possiamo solo augurarci che questa terribile esperienza della nostra marineria abbia scosso tutti gli ambienti decisionali del settore che, secondo le ultime statistiche, è diventato tra l’altro l’unico elemento realmente trainante dell’economia italiana.
Completiamo il senso di questo articolo con una fotografia che circola sul web e che certifica, più di tante parole, la pericolosa tendenza di certi comandanti-esibizionisti, sostenuti da armatori senza scrupoli, nel regalare EMOZIONI ai passeggeri in modo del tutto gratuito...
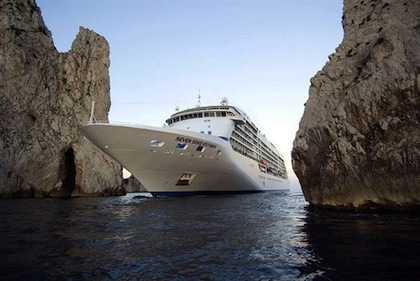
Lasciamo al lettore i commenti su questo incredibile passaggio tra i faraglioni di Capri di una nave di 20.000 tonnellate.
Carlo GATTI
Rapallo, 12 Agosto 2014
PRINCIPESSA JOLANDA. Un errore di Percorso...
IL VARO DELLA PRINCIPESSA IOLANDA
Un errore di percorso...
Nell’arco del 1800, quasi ogni paese della Riviera di levante ha ospitato un cantiere navale di piccole o grandi dimensioni, in un angolo del proprio litorale. Molti furono, quindi, i velieri, i pinchi, le tartane, i leudi e i gozzi che nacquero sotto gli occhi dei nostri nonni per opera dei “mastri geppetto” che, da queste parti, si chiamano maestri (mastri) d’ascia. Il loro ricordo, per fortuna, si perpetua ancora attraverso qualche raro figlio o nipote che professa questa arte, quasi di nascosto, con la stessa maestria di un tempo.

Foto Archio Pietro Berti
F.1 In questa rara fotografia si può notare la bellezza e lo slancio del brigantino a palo ISIDE, un’autentica opera d’arte.
Nel suo libro ‘Capitani di Mare e Bastimenti di Liguria’, lo storico camogliese Giò Bono Ferrari ci racconta del Cantiere di Rapallo che fu attivo dal 1868 fino allo scoppio della Prima guerra mondiale.
“... proprio ove ora s’erge, fra una gloria di palme, di pinastri e di fiori, il bronzeo monumento ai Caduti, sorgeva allora il sonante cantiere navale, dal quale scesero in mare maestosi bastimenti da 1000 e più tonn. La strada delle Saline, quella dalla tipica porta secentesca, pullulava a quei tempi di calafati e maestri d’ascia. E v’erano i “ciavari” con le massacubbie ed i ramaioli, nonché i fabbri da chiavarde per commettere i “cruammi” (corbame). E gli stoppieri, i remieri e il burbero Padron Solaro, socio del camogliese De Gregori, che aveva fondachi di velerie, d’incerate e di bosselli. I costruttori che s’alternarono sull’arenile di Rapallo furono dei più valenti in Liguria: G.Merello, il Craviotto e l’Agostino Briasco. E i clienti più affezionati di quel Cantiere furono i camogliesi”.
Tralasciando i nominativi delle imbarcazioni minori destinate al cabotaggio: Tartane, Golette, Scune, Leudi, elenchiamo i seguenti bastimenti di oltre 1000 tonn. che erano destinati alla navigazione oltre i Capi (Horn, Buona Speranza, Leewin) da sempre considerati i “CAPI” dei continenti che guardano verso Sud.
ISIDE – nave, costruttore G.Merello, Armatore Cap. Rocco Schiaffino
ESPRESSO – nave, costruttore Craviotto, Armatore F. Ferrario
GENEROSO C. nave, costruttore A.Briasco, Armatore Cap. A. Chiesa di Ruta. Questo veliero affondò nella Sonda di Montevideo, l’anno 1874. La figlia dell’armatore signora Luisa Chiesa, sposa del capitano del barco Filippo Ogno, si salvò con parte dell’equipaggio, dopo di tre giorni di lotta con il mare in tempesta.
FERDINANDO – nave, costruttore G.Merello, Armatore F. Schiaffino di Camogli
NICOLETTA - nave, costruttore G.Merello, Armatore A. Felugo di Camogli
SIFFREDI - nave, coStruttore G.Merello, Armatore A. Siffredi
GIUSEPPE EMANUELE – nave, Armatore cap. Filippo Denegri di Camogli
CACCIN – il maestoso e ammirato alcione di ben 1.500 tonn. marca “Stella”. Che il Briasco ideò e costruì per l’armatore G.B. Cichero di Recco.
Oggi si stenta ad immaginare che la zona descritta da G.B. Ferrari, sia stata il cuore pulsante dell'industria e del commercio di Rapallo, quando anche la lingua, intrisa di termini marinareschi e mestieri ormai scomparsi, odorava di pece, catrame e rimbombava di echi medievali, ultimi sibili di un'era legata al prezioso legname da costruzione navale.
Il Congresso di Vienna (1815) diede il primo “colpo di timone” al pianeta- mare, e dai riformatori, intellettuali e docenti vennero regole moderne ed una forte spinta a creare una ‘Nuova Marina Mercantile’, che doveva unificare tutte le tradizioni marinare del Paese e trasformarle secondo una formula tanto breve quanto efficace: “L'arte del navigare va accompagnata da una scienza del navigare stesso”.
A metà ‘800 si passa, quindi, dal romanticismo dei “Capitani Coraggiosi” ad una classe di professionisti. Cantieri e Scuole Navali sorgono dirimpettai, perché legati ai “bisogni” della nuova industria marittima che sente avvicinarsi il rombo del motore della Rivoluzione Industriale e quindi la necessità di essere pronti al passaggio epocale dalla marineria velica a quella moderna.
La transizione dal legno al ferro
Nella seconda parte del XIX secolo, la marineria mondiale si trovò ad un giro di boa e, per adeguarsi ai nuovi venti di rinnovamento, dovette affrontare una duplice trasformazione, sia in campo militare che in quello mercantile: la transizione dal legno al ferro e dalla vela al motore.
La costruzione in ferro richiedeva la radicale conversione della manodopera ed una nuova organizzazione dei cantieri. In campo militare, invece, il passaggio dalle navi a vela in legno, alle navi a motore in ferro fu più rapido a causa del nazionalismo che premeva sugli Stati europei accelerandone la spinta tecnologica: occorrevano navi sempre più armate, potenti e veloci.
Per rimanere nel nostro ambito regionale, in questo periodo rientrò il progetto e la costruzione, in soli otto anni, dell’Arsenale Militare di La Spezia (1862-1869) e la fondazione della Regia Scuola Superiore Navale di Genova (1871).
Le altre cause che accelerarono lo smantellamento dei cantieri navali minori, furono il progressivo insabbiamento di buona parte del litorale marittimo e, in gran parte, l’incalzante processo industriale che convertì o sostituì progressivamente le aziende a conduzione familiari configurandosi come uno stabilimento di lavoro fra i più complessi.
Più in generale, con l'avvento della propulsione meccanica, le tecniche costruttive dovettero adeguarsi alle nuove esigenze commerciali. Costruire navi non era più esercizio da maestro d'ascia, carpentiere e nostromo, ma diventò una professione tagliata su misura per l’Ingegnere navale. Maturò così a fine secolo il passaggio di consegna dei segreti costruttivi dal Capo Cantiere all’Ingegnere laureato presso le facoltà Universitarie. Il suo bagaglio scientifico era quasi sempre arricchito da esperienze acquisite su scali “furesti”: francesi, inglesi o tedeschi durante le costruzioni di famosi transatlantici di cui riportiamo i nomi più celebri, la Compagnia di navigazione, la data del varo e la stazza lorda.
- GREEK (CHIGNECTO) (Union Castle) 1893, 4.747 G.T – ST. LOUIS (American Line) 1895, 11.269 G.T. – ST. PAUL ( American Line) 1895, 11.629 G.T. - KAISER WILHELM DER GROSSE (Norddeuscher Lloyd) 1897, 14.349 G.T. - BRAEMER CASTLE (Castle Line) 1898, 6.266 G.T. – CARISBROOK CASTLE (Castle Line) 1898, 7.626 G.T. – OCEANIC (White Star) 1899, 17.274 G.T. - FURST BISMARCK (Hapag) 1899, 8.430 G.T. - GLENART CASTLE (Union Castle) 1900, 6.575 G.T. – KRONPRINZ WIHELM (Norddeutsceh Lloyd) 1901, 14.908 G.T. – REPUBBLIC (Hapag Lloyd) 1903, 18.072 G.T. - KAISERIN AUGUSTE VICTORIA (Hapag Lloyd) 1905, 24.581 G.T. – LUSITANIA (Cunard) 1906, 31.550 G.T. – MAURETANIA (Cunard) 1906, 31.938 G.T. – TITANIC OLYMPIC (White Star) 1911 G.T.46,329-45.328
Dal brigantino “disegnato segretamente sulla sabbia dal mago del vecchio cantiere”, ormai in crisi d’identità, si passò alla sala a tracciare: una vastissima proiezione di linee matematiche e analitiche prefiguravano il progetto della nuova costruzione in grandezza naturale.
La ‘sala a tracciare’ era una struttura coperta sul cui pavimento costole, bagli, madieri, venivano disegnati (appunto: tracciati) per poi essere riprodotti in simulacri di legno chiamati seste, da inviare all'officina carpentieri in ferro. Qui, le strutture prendevano forma, tagliando, piegando, forando lamiere e profilati che poi venivano trasferiti sullo scalo, sistemati al loro posto e collegati al resto dello scafo. Lo scafo cresceva così, con un elemento strutturale alla volta.
La “sala a tracciare” era quindi la cella del nuovo tempio, ed il ‘sacerdote’ che officiava il nuovo rito costruttivo era l’Ingegnere navale. La sua professionalità diventò garanzia e marchio di qualità dei nuovi prodotti navali sul mercato internazionale. La concorrenza tra gli stati europei di grande tradizione storico-navale fu molto aspra e, inizialmente, vide primeggiare gli Stati che ben prima di noi avevano investito sulla rivoluzione industriale.
Agli inizi del ‘900 il mercato delle ‘navi di linea’ per il trasporto degli emigranti era in forte espansione e, su pochi ma efficienti cantieri, si concentrò la risposta all’insistente domanda del mercato. Le nostre maestranze costruirono navi di grande qualità ed eccellenza, in particolare, le navi passeggeri crebbero di numero, di stazza e di dimensioni. In questa accanita competizione, l’Italia riuscì a ritagliarsi un posto di assoluto prestigio che, ancora oggi - nel terzo millennio - costituisce l’asse portante della nostra economia.
Ritornando in Riviera...
Rapallo, città turistica già nota all’estero per le sue bellezze naturali e climatiche, fu una delle prime città a scegliersi un destino diverso: il turismo di élite, dotato di strutture alberghiere di altissimo livello. La sua rinuncia alla cantieristica navale fu quindi obbligata dall’impossibile convivenza tra il rumoroso scalo posto sul bagnasciuga e la tranquillità cercata dal turista proveniente dal nord, già pesantemente industrializzato e inquinato dai ‘fumi carboniferi’.
Il tramonto dei velieri rapallesi coincise, quindi, con le crescenti e svariate opportunità che il nuovo secolo andava dispensando. Spesso, i nuovi investitori sul turismo erano emigranti italiani di ritorno dalle Americhe che puntarono sulle località rivierasche, già pubblicizzate nelle Americhe per il clima da sogno, i bagni di mare, le escursioni culturali di arte profana e religiosa, l’arte eno-gastronomica, ma anche per quelle ludiche, con il celebri impianti dei campi da golf, tennis ecc...
Con il primo dopoguerra ripresero, inoltre, a cadenza settimanale, le manifestazioni sportive automobilistiche, nautiche (veliche e motonautiche), ciclistiche natatorie nel Tigullio che proseguirono per tutti gli anni ’60 e giù di lì.
Buona parte della tradizione cantieristica rivierasca si sposta, con caratteristiche del tutto moderne, nella vicina Riva Trigoso.
Riva Trigoso nacque da una favola.....
Una leggenda molto conosciuta in paese narra delle vicende di due giovani rivani, appunto Riva e Trigoso, ai tempi in cui Riva veniva sovente attaccata dai pirati Saraceni.
Si dice che quando Riva Trigoso era un piccolissimo paese di pescatori, vi abitava un giovane molto bello e forte di nome Trigoso, il quale amava la bella e brava Riva, dalle trecce color dell'oro. I due decisero di sposarsi, ma, il giorno delle nozze, durante i festeggiamenti, il borgo fu invaso dai pirati Saraceni, che saccheggiarono il villaggio e rapirono le donne più belle; nel tentativo di difendere la sua amata rapita, Trigoso perse i sensi a causa di uno scontro con i pirati, mentre Riva veniva caricata sulla più grossa delle navi nemiche.
Quando Trigoso riprese i sensi le navi saracene stavano iniziando a prendere il largo e, realizzato quanto era successo, corse in riva al mare dove iniziò a chiamare a gran voce il nome di Riva, ma, non appena i pirati lo sentirono, gli scoccarono contro una scarica di frecce che lo colpirono in pieno petto e lo fecero cadere al suolo morente. Riva assistette alla scena dalla nave e quando vide il suo sposo morire si scagliò contro il capitano della nave, che la uccise con diverse pugnalate al ventre; subito dopo che spirò, alcuni pirati la presero e la buttarono di peso in mare.
Non appena l'acqua si tinse del rosso del sangue, comparve una grossa onda che colpì la nave e da cui fece cadere diversi forzieri e bauli contenenti una gran quantità d'oro. I pirati non riuscirono però a localizzare il punto esatto e, dopo giorni di ricerche, decisero di salpare. La notte stessa degli Angeli discesero dal cielo e collocarono, nel punto in cui Riva era morta, un grande scoglio (l'attuale scoglio dell'Asseu), per ricordare ai posteri la giovane fanciulla. Nello stesso momento, nel punto dove morì Trigoso i ciottoli iniziarono un canto d'amore.
Passarono molti giorni e anche diversi anni, i pirati non tornarono più e intanto il paese si iniziava ad ingrandire e, mentre i ciottoli continuavano imperterriti a cantare la loro canzone d'amore, la baia dove i pirati persero il loro tesoro (presumibilmente al largo dell'attuale spiaggia di Renà) venne chiamata la Baia d'Oro e i pescatori decisero di dare al loro paese un nome per ricordare i due giovani e la loro grande storia d'amore: il nome, appunto, di Riva Trigoso.
A volte le favole si avverano ...
Riva Trigoso ritrovò il suo Tesoro, ma non era quello dei pirati, bensì un grande Cantiere Navale
Per quasi tutto l’800, RIVA TRIGOSO era un modesto borgo di uomini di mare divisi tra coloro che imbarcavano per il lungo corso su velieri mercantili, quelli che sceglievano la pesca a corto e medio raggio, ed infine il terzo gruppo, dedito alla costruzione di leudi, rivani e gozzi, tipiche imbarcazioni locali usate per commercio e trasporto di materiali da costruzione e derrate alimentari come vino e formaggi.
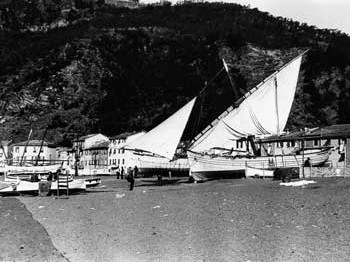
F.2 Leudi sulla spiaggia di Riva Trigoso
Chi ha un po’ di salmastro nelle vene, sa che un rivano qualunque ha dato molto all’Italia sul mare, e dinnanzi al suo patrimonio genetico occorre riflettere e fare chapeau.
Il Cantiere navale di Riva Trigoso, grazie alla sua perfetta location, assorbì sia le maestranze locali citate, sia quelle dei cantieri rivieraschi in via d’estinzione. Questo ‘passaggio di consegne’ garantì, in ogni caso, la sopravvivenza di quel patrimonio di dati tecnici maturato da molte generazioni di costruttori navali. Grazie a questo intelligente connubio, Riva Trigoso diventò in breve tempo uno dei maggiori Cantieri Navali Italiani.

F.3 Il C.L.C. Erasmo Piaggio, Senatore del Regno d’Italia
L’uomo che vide lungo, l’artefice del ‘magic moment’ rivano, fu Erasmo Piaggio (Genova 1845-1932), l’imprenditore-armatore che il 1°agosto del1897 fondò il Cantiere dallaSocietà Esercizi Bacini, costituita dallo stesso senatore per la gestione dei Bacini di Carenaggio dii Genova. Erasmo Piaggio era ancheAmministratore delegato della società Navigazione Generale Italiana (N.G.I), nata nel 1881 dalla fusione delle flotte Rubattino e Florio e rinforzatasi con le flotte Raggio e Piaggio. Sotto la sua direzione questa compagnia si andava imponendo sui traffici internazionali con oltre ottanta unità. Il Piaggio ne curava l'ammodernamento con costruzioni studiate in base alle richieste sempre più esigenti della clientela.
Il progetto del cantiere, nato per assorbire la maggior parte delle commesse della grande compagnia di navigazione, era quello di un grande complesso in cui concentrare ed assolvere le funzioni di costruzione, esercizio e manutenzione. Il progetto non fu, probabilmente, capito dagli altri membri della compagnia che si opposero in nome di interessi diversi. Di Erasmo Piaggio si racconta che alla fine andò per la sua strada, fondando qualche anno dopo una propria compagnia, il Lloyd Italiano che, legandosi al cantiere di Riva Trigoso, avrebbe costruito le sue navi sotto la regìa dello stesso Piaggio.
L’imprenditore-armatore ne affidò la realizzazione alla Società Esercizio Bacini. I lavori iniziarono il 15 giugno 1898 e dopo quattro mesi si approntarono le prime lamiere. Nel febbraio seguente funzionavano otto scali attrezzati con officine e servizi tecnici ed amministrativi su un'area di 30.460metri quadrati. Nel settembre successivo si approntò unafonderia di ghisa, cui seguì quella di bronzo.
Già dal primo anno dalla fondazione, il cantiere diede lavoro a circa 400 persone, delle quali 300 erano di Riva e dintorni. Sullo scalo numero 1 fu impostato un bacino galleggiante in ferro per il porto di Genova, mentre, contemporaneamente furono impostati sugli scali 2 e 3 i piroscafi Flavio Gioia e Amerigo Vespucci della Navigazione Generale Italiana. Sugli scali 4, 5 e 6, sempre per la Navig. Generale, furono impostati l’Isola di Procida, il Sicilia e il Sardegna, mentre lo Zelina e l’Ester occuperanno gli scali 7 e 8.
Elenco cronologico parziale di navi varate a Riva Trigoso dalla sua fondazione fino al drammatico varo della Principessa Jolanda.
. Bacino galleggiante 1899.
• Barca a vapore "ZELINA" 1899.
• Barca a vapore "FLORA" 1899.
• Piroscafo postale "FLAVIO GIOIA" maggio 1900.
• Piroscafo postale "AMERIGO VESPUCCI" giugno 1900.
• Piroscafo postale "SICILIA" 4 maggio 1901.
• Piroscafo postale "SARDEGNA" 15 giugno 1901.
• Rimorchiatore "PROVENCAL I" 1901.
• Rimorchiatore "PROVENCAL II" 1901.
• Nave veliero "IOLANDA" 24 giugno 1902.
• Nave a palo "ERASMO" 18 febbraio 1903.
• Nave a palo "REGINA ELENA" giugno 1903.
• Brigantino goletta "EMILIA" 1904.
• Piroscafo "FLORIDA" 23 giugno 1905.
• Piroscafo "INDIANA" 10 ottobre 1905.
• Rimorchiatore "ALLIANCE" 1905.
• Piroscafo fluviale "DOMINGO" 1905.
• Piroscafo "LUISIANA" 18 marzo 1906.
• Piroscafo "VIRGINIA" 10 settembre 1906.
• Piroscafo fluviale "NATALE" 1906.
• Nave passeggeri "PRINCIPESSA IOLANDA" 22 settembre 1907 (affondata)
Dall'inizio fino al 1915 si costruirono 65 unità mercantili per la N.G.I, per il Lloyd Italiano, per la Transatlantica Italiana, per laSocietà dei Servizi Marittimi, e anche per altri armatori. Si costruirono anche le navi per emigranti del Lloyd e fra queste le due Principesse, figlie dell’allora Re, il Principessa Mafalda, ritenuto il migliorpiroscafo da passeggeri dell'epoca, gemella della Principessa Mafalda, affondata durante ilvaro nel 1907.

F.4 La Principessa Jolanda é sullo scalo. Ultimi istanti di festa e di attesa trepidante prima del VARO.
Il disastroso varo della Principessa Jolanda
Un incidente di percorso!
Comandante Ernani Andreatta, lei ed il suo Museo Marinaro di Chiavari, siete gli eredi, i testimoni e i conservatori dell’attività, ormai scomparsa, dei Cantieri Navali Gotuzzo - Rione Scogli di Chiavari che costruì velieri e imbarcazioni di ogni tipo. Francesco Tappani, responsabile del varo della Principessa Jolanda, era suo cugino, il quale “si era fatto le ossa” imparando il mestiere dal padre Matteo Tappani proprio nel Cantiere Gotuzzo. Nessuno meglio di lei può raccontare per Mare Nostrum come si svolsero i fatti, magari aggiungendo, se possibile, qualche inedito storico.
FRANCESCO TAPPANI, capo del progetto delle due “Principesse Iolanda e Mafalda” nel cantiere dei Piaggio, era mio cugino. Suo padre, Matteo Tappani aveva sposato la sorella GIULIA di mio Nonno LUIGI GOTUZZO. Mia madre era infatti Adele GOTUZZO degli omonimi cantiere navali di Chiavari che vararono, in tre generazioni oltre 120 velieri destinati per la maggior parte a viaggiare su rotte oceaniche. Sul suo titolo di studio si é equivocato parecchio, specialmente da parte di chi, non avendo navigato, non sa che con la parola Ingegnere, s’intende il tecnico di bordo, il macchinista navale. In inglese: engineer, in tedesco: ingenieur, nelle lingue scandinave: ingenjör, in francese: ingeniéur.
Essendo il Cantiere Navale un territorio internazionale per eccellenza, é probabile ed intuibile che il titolo d’Ingegnere gli sia stato attribuito sul campo, senza la sua complicità.
Una leggenda metropolitana, che stranamente sopravvive ancora oggi, tramanda che dopo questo varo il direttore Tappani si uccise.
Si, ne sono perfettamente al corrente, ma ciò è completamente falso. Francesco Tappani, che in seguito divenne emerito Podestà di Chiavari, dal 1932 al 1942, fu un uomo di grande ingegno e di grande perizia tecnica, purtroppo non aveva un solido fondamento teorico. La sua arte era esclusivamente basata sul “genio” e sull’esperienza pratica che aderiva perfettamente alla tendenza dei costruttori navali liguri dell’epoca – e forse non soltanto dei liguri – che rifuggiva da ogni teorica cultura tecnica: “Matteo Tappani, padre di Francesco, era analfabeta”, così afferma un libro inedito del quale sono in possesso, pur essendo valente costruttore, avendo costruito agli “Scogli” di Chiavari velieri in legno che furono considerati di “genio” e giudicati fra i più belli ed efficienti. Il "presunto" analfabetismo di Matteo Tappani, da tutti chiamato "U SCIU MATTE'" non era raro a quei tempi anche se in genere qualcuna di queste persone aveva il genio della matematica. Cioè nel far di conto e di calcolo, Tappani era senza dubbio un genio.
Prova ne sia che firmò i progetti di straordinari velieri come il LUIGIA RAFFO, Il SATURNINA FANNY, L'AUSTRALIA e poi ancora, a Riva Trigoso le navi a palo ERASMO e REGINA ELENA, navi a quattro alberi con scafo in ferro. Queste ultime due furono poi cedute dall'armatore RAFFO di Chiavari e acquistate dall'armatore tedesco Laeiz che, nella vela mondiale, fu uno dei più importanti. Non solo, nel libro del RINA (a quel tempo si chiamava "VERITAS ITALIANO") del 1883 e seguenti, per quanto riguarda la "Nave" MARIA RAFFO, gemello del LUIGIA, vengono riportati i dettagliati piani di costruzione dei legni di questa nave portandola ad esempio come "archetipo" costruttivo al quale bisogna attenersi per ottenere i certificati RINA di navigabilità. Chiaramente c'è scritto " COSTRUTTORE MATTEO TAPPANI". (Chiavari Marinara Pag. 48 e seguenti).
Quindi affermare "tout court" che Matteo Tappani era analfabeta, mi sembra troppo forte e forse assolutamente NON VERO. Però in quel libro (del quale esistono solo due copie al mondo e una è in mio possesso) scritto a macchina e mai stampato che si intitola "APPUNTI DISORDINATI , QUANTO A DATE, IMPRECISI" sulla storia dei CANTIERI NAVALI DI RIVA TRIGOSO, c'è scritto così. In poche parole, non ho il coraggio di pensare che un uomo ritenuto da tutti come "IL GENIO DELLA COSTRUZIONE NAVALE A VELA" fosse analfabeta. Questo è il mio pensiero. Inoltre lo stesso libro parla anche di "DISEGNI COSTRUTTIVI CHE SI FACEVANO SULLA SABBIA", di Matteo TAPPANI restano dettagliati e straordinari piani di costruzione di tutti i generi ancora adesso oggetto di grande ammirazione da parte degli addetti ai lavori. Forse qualcuno disegnava per lui? O forse essendo solo "righe e curve" li tracciava lui stesso? Insomma "il romanzo dell'epoca eroica della vela" nel caso di MATTEO TAPPANI si immerge ancora di più in: "MISTERO ED EMOZIONE" !
Ci fu una punizione per il responsabile del disastroso varo?
No! Francesco Tappani non fu materialmente punito e, non solo conservò il suo posto, ma gli anziani Piaggio lo mandarono a “distrarsi” in un lungo viaggio di studio. Pare accertato che andò in Germania presso un cantiere navale per apprendere eventuali esperienze dall'estero.
Il Cantiere Navale di Riva Trigoso non era certo al primo esperimento...
Il Cantiere di Riva Trigoso, sorto nel 1889, aveva già costruito transatlantici tipo “Florida” nel 1905, dopo di ché si accinse a costruire i tipi “Principessa”, navi lussuose progettate da Rocco Piaggio che avrebbe dovuto costituire la “Coppia Grande Ammiraglia” sulla linea Genova-Buenos Aires.
Che ruolo giocò l’Assicurazione in questa vicenda?
Il disgraziato varo della “Principessa Jolanda” fu dal lato tecnico una grave sciagura, ma lo fu anche dal lato finanziario, in quanto la Società Assicuratrice, basandosi sul fatto che il Direttore del Cantiere, Francesco Tappani, non fosse Ingegnere, invocò la clausola contrattuale del “Fault of skill” (deficienza di capacità) che la dispensava dai suoi obblighi di risarcimento del danno derivante dalla perdita della nave, cosicché l’onere relativo dovette essere sopportato quasi totalmente dalla Società Armatrice. Seguì per i Piaggio un periodo sconfortante. Circa la responsabilità tecnica, i campi erano divisi: i più Anziani della Famiglia Piaggio erano propensi ad ammettere qualche attenuante alle responsabilità di Tappani; Rocco Piaggio, invece, attribuiva a Tappani ogni responsabilità dando rilievo alla clausola invocata dagli assicuratori.
Era tempo di cambiare qualcosa nell’organizzazione del Cantiere?
Rocco Piaggio, sempre fermo sulla dannata clausola assicurativa, insisteva sulla necessità di dare un nuovo e più elevato indirizzo alla direzione del Cantiere. “Bisogna” – diceva – “abbandonare il sistema di fare i disegni sulla sabbia”. (A quei tempi esisteva a Riva Trigoso una splendida e lunga spiaggia di sabbia finissima che si prestava a tracciare sulla stessa scarabocchi da parte di ragazzi). “Il varo” – diceva ancora Rocco Piaggio – “E’ una operazione di funambolismo”.
Sta di fatto che, con la mentalità di allora, non era facile dare istruzioni in lingua italiana piuttosto che in dialetto genovese, mostrando disegni a provetti marinai quali “Sanpee” (San Pietro) e “Gambalesta”, il primo abilissimo attrezzatore velico, l’altro capace pontista acrobata. Entrambi sembravano voler dire – come del resto anche gli altri Capi (capitecnici) – “Siamo nati su questa spiaggia, abbiamo costruito navi, abbiamo sempre fatto così, volete ora insegnarci con i “papée” (disegni)? “
Si trattava dunque di cambiare strategia e dare il giusto valore agli Ingegneri?
E’ qui da osservare che anche all’epoca delle Principesse prestavano la loro opera in cantiere valenti ingegneri – quale ad esempio Quartieri – che però non erano efficacemente utilizzati, anzi erano regolarmente by-passati dal Tappani.
Rocco Piaggio, dopo la drammatica esperienza della P.Jolanda, attenendosi ad un giusto criterio, forse ancora oggi seguito, si faceva segnalare dalla scuola i giovani che dimostravano le giuste attitudini.
Una Storia amara
La Principessa Jolanda venne commissionata dal Lloyd Italiano ai cantieri navali di Riva Trigoso insieme alla Principessa Mafalda, sua nave gemella, in onore delle figlie del re Vittorio Emanuele III. Per le due navi, che avevano ciascuna:
Stazza Lorda: 9.210 tonnellate – lunghezza: di 141 metri, larghezza: 17 metri
due alberi, due fumaioli, due eliche, un apparato motore da 12.000 cavalli e velocità: 18 nodi, erano previsti 100 posti in classe lusso, 80 in prima classe, 150 in seconda e 1.200 posti per gli emigranti.
La Principessa Iolanda e La Principessa Mafalda, costruite per vincere la concorrenza in campo internazionale, erano già state abbondantemente reclamizzate; in particolare la Jolanda, su illustrazioni che la mostravano già navigante prima del varo e vantando inoltre per le due gemelle una trasformazione epocale per quanto riguardava il trattamento e i servizi per gli emigranti. Sarebbe stato quindi un danno d’immagine sul teatro internazionale, recuperarla e rimetterla in funzione come se niente fosse.
Le intenzioni del Lloyd Italiano erano di destinare le due veloci e lussuose navi al servizio di linea per il Sud America, in concorrenza con le società di navigazione straniere di grande prestigio come la Cunard o la White Star Line, la Royal Mail, la Amburghese Sud Americana, il Lloyd Reale Olandese ecc.
La Principessa Jolanda, primo vero transatlantico italiano di lusso, costò sei milioni di lire e venne dotata - fra i primi - di illuminazione elettrica, telegrafo senza fili e telefono in ogni cabina. Rispetto alla Principessa Mafalda, la Principessa Jolanda venne ultimata per prima, e, allo scopo di entrare in servizio il prima possibile, era già stata completamente allestita con attrezzature, motori, arredamenti e suppellettili. Si preferì distruggerla sul posto recuperando tutto quello che si poteva e ricominciare da capo con la Principessa Mafalda che scendeva in acqua l’anno dopo ed era la copia perfetta della Principessa Iolanda.
Il significato del Varo Tradizionale
“Il varo di una nave ha sempre rivestito un fascino particolare, soprattutto nei tempi antichi, quando la navigazione in mare aperto comportava dei rischi e delle difficoltà oggi difficilmente immaginabili.
I marinai, letteralmente, affidavano la propria vita alla nave ed il significato più profondo della cerimonia del varo risiedeva nel legame di assoluta fiducia che gli uomini le assegnavano.
Proprio per questo motivo durante il varo si celebrava la benedizione, per sottolineare la solennità del rito che conferiva alla nave un prestigio senza eguali in altri mezzi di trasporto.”
Fasi del varo:
Prima fase – Dall’inizio del movimento all’inizio dell’immersione in mare.
Seconda fase – Dall’inizio dell’immersione a quando la parte dello scafo comincia a sollevarsi e a galleggiare con una rotazione intorno all’asse trasversale dell’estremità posteriore dell’invasatura.
Terza fase - Quando tutto il sistema liberamente galleggia e si allontana dall’avanscalo.
L’ultimo periodo della seconda fase del varo è fra tutti il più critico, in quanto che la pressione sempre che vada continuamente diminuendo, pur tuttavia si manifesta su una limitata zona di appoggio dello scalo, ciò che può produrre effetti dannosi alla nave ed al piano di scorrimento, il quale può perfino cedere sotto l’eccesso di peso. Per tale
motivo, questa fase va accuratamente studiata, allo scopo di prevenire codesti dannosi effetti.
22.9.1907
Il Varo della “PRINCIPESSA JOLANDA”
Alla presenza di numerose Autorità, la Principessa Jolanda fu varata alle 12,25 del 22 settembre 1907 a Riva Trigoso. Madrina della cerimonia fu Ester Piaggio, moglie del senatore Erasmo Piaggio, presidente del Lloyd Italiano.
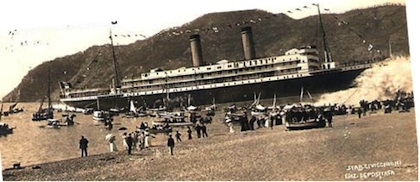
F.5 Questa foto coglie l’attimo dell’inizio del drammatico varo della
Principessa Jolanda.
Il consueto urlo di gioia che si levò dagli operai del Cantiere al momento del varo, fu strozzato da un angoscioso silenzio e dalla paura per la vita del personale imbarcato, da quel momento drammaticamente in pericolo.

F.6 Improvvisamente accadde l’imprevisto ...
La grande nave, madrina la signora Ester Piaggio, scende in mare con le bandiere al vento, contornata da decine di barche e tra le acclamazioni della folla. Subito dopo aver perso l'abbrivio a poco più di cento metri dalla riva il piroscafo comincia a sbandare sul lato sinistro. Il fumo bianco che si vede sotto la prua è dato dall'attrito dei vasi (sostegni di legno sotto lo scafo) che scorrono sullo scalo. Il sistema è stato convenientemente lubrificato il giorno prima del varo.
Appena terminata la corsa sullo scivolo del varo e toccata l'acqua, la nave si piegò su un fianco, iniziando ad imbarcare acqua dagli oblò non ancora montati. Concluse la sua corsa mare ed impiegò circa venti minuti per abbattersi definitivamente sul fianco. Nel frattempo le maestranze diedero inutilmente fondo l’ancora di dritta per controbilanciare lo sbandamento. I rimorchiatori cercarono di trascinarla verso il fondale sabbioso del basso arenile.
La Principessa Jolanda imbarcò acqua e si arrese per sempre ai molteplici tentativi di recupero, messi in opera successivamente, sotto la direzione dell’Ing. Tappani.
Operazioni di Salvataggio
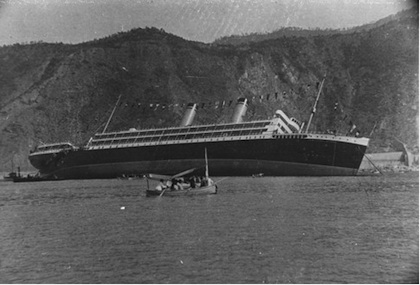
F.7 Nelle due immagini, sopra e sotto, La Principessa Jolanda ha dato fondo l’ancora per contrastare lo sbandamento. Si noti il personale assiepato sullo scalandrone nell’attesa che il rimorchiatore li porti in salvo.

F.8 Un po’ di Buona Sorte
La lentezza con cui la nave si piegò sul fianco, permise il completo salvataggio delle maestranze del Cantiere ad opera delle numerose imbarcazioni che affiancarono la sfortunata principessa.

F.9 Vista sul fianco sinistro, ormai abbattuta di 80°, la Principessa Jolanda imbarca acqua anche dai ponti superiori. Il drammatico sbandamento della nave, ripreso dal lato opposto, contrasta con la festosa esposizione del Gran Pavese
I Danni

F.10 Lo scafo della Principessa Iolanda fu abbandonato ai danni del Cantiere costruttore. La nave fu in seguito demolita sul posto. I motori furono recuperati ed installati su due navi da carico già in costruzione.
Nelle settimane seguenti al naufragio furono molte le visite e le ispezioni al relitto. I tecnici del cantiere navale salirono sulla fiancata della nave, che spuntava dall'acqua, per valutarne la situazione e la possibilità di recupero. Tuttavia, ciò non fu ritenuto possibile. Venne perciò prelevato quanto si poté salvare, mentre il resto della nave fu recuperato, smaltito e venduto ai demolitori.
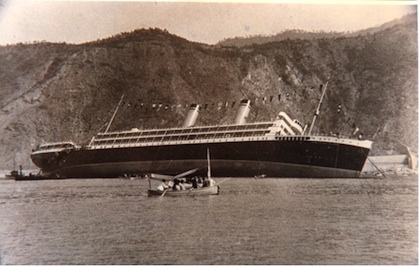
F.11
Cause dell'affondamento
- Il cedimento dell’avanscalo
- Il mancato zavorramento dei doppi fondi della nave
- In via preventiva, non furono chiusi gli oblò dei ponti inferiori della nave.
- A rendere totale la perdita contribuì, con tutta probabilità, un R - A negativo.
Dalle varie fotografie esistenti si nota che il pescaggio della Principessa Jolanda era veramente esiguo e che il baricentro era esageratamente alto. Poiché il carbone non era ancora stato caricato ed era privo di zavorra, bastò pochissimo per dare alla nave lo sbandamento iniziale, che si aggravò di lì a poco. Inoltre, durante la discesa sullo scivolo del varo, mentre la poppa, con una rotazione sull'asse trasversale della nave, aveva toccato l'acqua e aveva iniziato a sollevarsi, la prua premette contro lo scivolo stesso, forse causando una falla sulla chiglia che contribuì all'affondamento.
Alla fine venne stabilito che l'intera responsabilità della perdita del piroscafo era da attribuirsi al cantiere navale, colpevole di errori di calcolo
Molte polemiche sorsero al varo del Principessa Jolanda per il suo rovesciamento avvenuto non appena aveva toccato l’acqua.
Non tutto il male viene per nuocere
E, come si suol dire, “dopo aver toccato il fondo” in quella tristissima occasione, il Cantiere di Riva Trigoso in seguito non sbagliò mai più un colpo.
Il suo prestigio é arrivato a toccare livelli d’eccellenza tecnologica che non ha pari in Europa, specialmente nel campo delle costruzioni militari. Il numero di navi costruito dal Cantiere di Riva Trigoso a noi risulta essere di 185 navi dal 1899 al 2013, ma potremmo sbagliarci per difetto.... Questi dati, più o meno ufficiali, onorano la nostra terra di Liguria, il nostro Paese e le nostre maestranze alle quali AUGURIAMO di superare al più presto l’attuale momento di crisi dell’occupazione.
STABILITA’ STATICA TRASVERSALE
- E’ accertato che gli oblò non erano stati montati; se quindi a nave sbandata, la fila più bassa si é immersa sott’acqua, la nave ha cominciato a imbarcare acqua aggravando ulteriormente la situazione.
- Il cedimento accertato dell’avanscalo, potrebbe aver causato una falla sotto lo scafo, dando inizio alla tragica sequenza.
- La stabilità può essere “stabile”, “instabile”, “indifferente”. Questo dipende dalla posizione reciproca fra il centro di gravità e il centro di carena o di spinta e il metacentro. Il metacentro è il punto d‘intersezione del piano diametrale con la direzione della spinta applicata al nuovo centro di carena a nave sbandata. Man mano che la nave in acqua calma, si inclina, M comincia, sul piano diametrale a scendere verso G. Finché è al disopra di G la nave è in equilibrio stabile, quando coincide con G è in equilibrio indifferente, quando M passa al di sotto di G, l’equilibrio è instabile e la nave si capovolge.
Si consideri una nave liberamente galleggiante in acqua calma e con ponti orizzontali. In queste condizioni il G (baricentro) e il peso P coincidono (spinta verso il basso) e C (centro di carena o di spinta S verso l’alto) risultano allineati nel diametrale. Fig. a sn.
Quando una causa esterna, vento o mare, fa sbandare una nave, mentre G rimane fermo, il C si sposta verso il lato più immerso e la spinta diventa parallela al P formando con essa una coppia di forze raddrizzanti, il cui momento misura, in T per m la stabilità statica trasversale.

F.12 Sagome, pescaggi, dimensioni, angolo di sbandamento, posizione degli oblò sono state ricavate dalle fotografie;
La posizione del centro di spinta (C/S) si ritiene essere abbastanza precisa;
La posizione del centro di gravità (G/P) è approssimata. Apprezzata e desunta in funzione del pescaggio. Comunque anche se G/P fosse stata più in basso la situazione generale non sarebbe cambiata di molto.
Dalle sagome prese in esame risulta che per uno sbandamento di 12°/18° la prima fila di oblò sarebbe già stata sotto il livello del mare.

F.13
Rappresentazione grafica di una nave sbandata sulla dritta. Il metacentro m è basso sotto il baricentro G, la nave ha altezza metacentrica negativa. Questa nave non rimane né in verticale né inclinata. Probabilmente si è capovolta al varo.
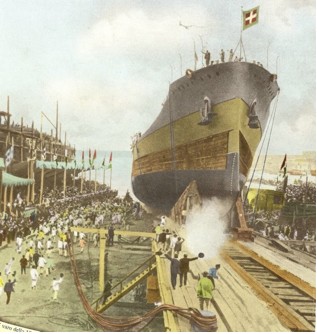
Equilibrio delle forze durante lo scorrimento
B
Bilancio delle forze al momento della rotazione

C
Bilancio delle forze al momento del saluto
Per schematizzare quello che può succedere durante il varo, possiamo immaginare di "congelare" i momenti più importanti: A) - il distacco, quando inizia lo scivolamento dell'invaso sullo scalo; B) - la rotazione, quando la nave comincia lo strapiombamento, quando la prua si solleva dallo scalo con tutto l'invaso; C) - il saluto, quando la prua affonda in acqua prima di lasciare lo scalo.
Cominciamo a descrivere la fase del distacco. La preparazione dev'essere accurata, dato che il varo è un'operazione che in caso di problemi non può essere interrotta o rallentata.
Bisogna trasferire il carico della massa della nave dalle taccate e dai puntelli che l'hanno sostenuta durante la costruzione, all'invaso, una struttura di sostegno costituita da due grandi pattini di legno che dovranno far scivolare, con l'aiuto di un lubrificante, la nave sullo scalo.
Prima di lasciar andare la nave, le taccate di appoggio sullo scalo vanno gradualmente smontate. Le taccate di poppa, che sono le più pericolose poiché sopportano un carico enorme, vanno demolite per ultime, subito prima del varo. Per questa ragione l'operazione di rimozione delle taccate di poppa è sempre stata in passato particolarmente pericolosa e non era facile reclutare personale disposto a compiere l'operazione.
Non sempre l'inclinazione dello scalo è sufficiente a vincere l'attrito iniziale: può essere necessario il ricorso a martinetti idraulici o ad altri mezzi ausiliari per dare l'abbrivio iniziale all'invaso. Una volta che la nave ha iniziato a scivolare verso l'acqua, il calore che si sprigiona dall'attrito fra lo scalo e l'invaso è enorme, addirittura da incendiare il lubrificante sotto i pattini.
Dal punto di vista delle forze agenti sulla nave, dopo il distacco e durante lo scivolamento, sulla stessa agiscono la forza di gravità e la reazione dello scalo. Le due forze non sono in equilibrio, dato che il piano dello scalo è inclinato, e la risultante è proprio la forza che accelera costantemente la nave verso l'acqua (figura A).
A questo punto, tutto dipende dalla lunghezza dello scalo. Se lo scalo fosse di lunghezza infinita non ci sarebbero problemi particolari, infatti la poppa man mano che si immerge riceve una spinta idrostatica sempre maggiore, fino al momento in cui riesce a sollevarsi dall'invaso mentre questo prosegue la sua corsa: questo è il momento della rotazione.
In questo caso (figura B), mentre la forza di gravità rimane invariata, la spinta idrostatica aumenta con l'immersione della poppa, fino al punto in cui:
S x (a+b) > P x a
cioè il momento dovuto al galleggiamento supera quello dovuto al peso e la poppa comincia a sollevarsi dall'acqua.
Quando invece, lo scalo non è lungo abbastanza da immergere la poppa e consentire la rotazione, si verifica il fenomeno opposto: la poppa cade verso il basso con tutto l'invaso (non essendoci più lo scalo a sostenerli) e la prora si solleva nel momento dello strapiombamento.
Se lo strapiombamento è di breve durata non ci sono problemi, altrimenti la stabilità trasversale può risultare compromessa. Il calcolo della lunghezza minima di scalo necessaria ad evitare lo strapiombamento è una delle verifiche più importanti da eseguire prima del varo. Nei casi più critici, si costruisce un prolungamento dello scalo per eliminare o ridurre questo fenomeno.
Schematizzando anche questo fenomeno in termini di forze (figura C) si può dire che si ha lo strapiombamento quando il baricentro si trova sulla verticale della fine dello scalo:
P x a > S x (a+b)
cioè il momento dovuto al peso supera quello dovuto al galleggiamento e la poppa tende a precipitare verso il fondo.
Il momento conclusivo del varo è il sollevamento completo della nave e dell'invaso. Anche in questo caso, se lo scalo risulta corto, l'invaso a prua si trova improvvisamente privo di sostegno e la prua effettua un tuffo verso il basso che si chiama saluto.
Il diagramma delle forze (figura C) ci aiuta a comprendere il saluto se consideriamo quello che accade nell'istante in cui l'invaso lascia lo scalo. Se, quando l'invaso si trova sulla verticale dello scalo, la nave non è già in equilibrio fra peso e spinta idrostatica, cioè: R > 0
allora appena viene a mancare la reazione dello scalo, la prora si immerge in acqua con un tuffo fino a ristabilire il naturale assetto di galleggiamento.
Come nel caso precedente, anche il saluto, se l'altezza del tuffo è piccola, non crea alcun problema al varo, ma tale altezza va accuratamente verificata nei calcoli.
Se (r - a) era Inizialmente minima o addirittura negativa, ciò avrà influito in modo determinante...al rovesciamento della nave.
Se lo strapiombamento è di breve durata non ci sono problemi, altrimenti la stabilità trasversale può risultare compromessa. Il calcolo della lunghezza minima di scalo necessaria ad evitare lo strapiombamento è una delle verifiche più importanti da eseguire prima del varo. Nei casi più critici, si costruisce un prolungamento dello scalo per eliminare o ridurre questo fenomeno.
RINGRAZIO
IL COMANDANTE ERNANI ANDREATTA per l’intervista concessa a MARE NOSTRUM
Il COMANDANTE NUNZIO CATENA per la Revisione scientifica del Varo
L’AIDMEN per lo studio sulla STABILITA’ STATICA TRASVERSALE
Carlo GATTI
Rapallo, 3 Gennaio 2014
La Tragedia TEXACO CARRIBEAN
LA TRAGEDIA DELLA TEXACO CARRIBEAN
La petroliera Texaco Caribbean aveva equipaggio italiano, molti dei quali erano liguri. L’INCIDENTE ebbe luogo l’11.1.1971 nel Canale della Manica, a 13 km dallo Stretto di Dover.



La TEXACO CARIBBEAN aveva una bella linea ed era anche veloce per la sua epoca, ecco le sue Caratteristiche: Anno di costruzione: 1965 Cantiere: Kieler Howaldtswerke AG, Kiel Inc. - Stazza Lorda: 13.604 tonn. Dislocamento: 20875 tonn. lunghezza: 175 m - Larghezza: 23.8 m - Pescaggio: 12.5 m - Bandiera: Panama - Armatore: Texaco Panama. Inquinamento: bunker - fuel oil. Quantità: 600 tonn.


Le tragiche immagini della TEXACO CARIBBEAN in agonia subito dopo la collisione con la nave peruviana PARACAS l’11 gennaio 1971.


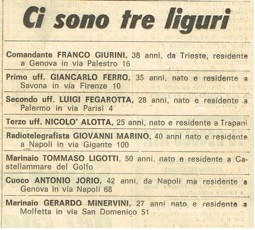

UNA TRAGICA CATENA DI NAUFRAGI
11 gennaio 1971 - Canale della Manica – Nebbia fittissima –
1a COLLISIONE
La petroliera di bandiera panamense con equipaggio italiano: TEXACO CARIBBEAN, partita da un porto olandese e diretta a Trinidad, navigava in zavorra sulla “regolare” corsia discendente del Canale della Manica quando, improvvisamente, fu colpita dal cargo peruviano PARACAS di 12.000 t. che, ignorando le recenti normative sulle ROTTE di SICUREZZA del Canale, navigava contromano sulla rotta più breve, lungo la costa inglese. (Secondo queste disposizioni le navi dirette verso il nord dovevano seguire rotte vicine alla costa francese, mentre quelle dirette al sud si dovevano tenere vicine a quelle britanniche).
La TEXACO CARIBBEAN esplose, fu tagliata in due ed affondò versando in mare 600 tonn. di bunker e acqua di zavorra. Nella collisione, otto marittimi persero la vita mentre ventidue furono salvati dai soccorritori. La PARACAS proveniva dal Perù ed era diretta ad Amburgo con un carico di pescato e olio di pesce. Nella collisione subì seri danni, non tali però da impedire l’aggancio del Rim.re di salvataggio HEROS che la trainò ad Amburgo, dove arrivò il 14 gennaio. La Coast Guard Britannica fece piazzare segnalamenti luminosi sul posto per allertare le navi in transito della presenza del relitto, ma a questo proposito, subito dopo la seconda collisione avvenuta poche ore dopo, si aprì una acerrima discussione tra i responsabili della navigazione nella Manica. Non pochi, infatti, sostennero che la collisione poteva essere evitata se il tratto di mare, dove era affondata la parte anteriore della Texaco Caribbean, fosse stato delimitato da numerosi e potenti segnali di pericolo. Tuttavia, nonostante le ricerche portate avanti fino a tarda notte e rese difficili da un fitto velo di nebbia, non fu possibile localizzare il relitto. Il caso volle che a trovarlo, fosse stato proprio il mercantile tedesco. Per quanto riguarda i superstiti italiani della motocisterna, le speranze di ritrovarli in vita furono fin da subito perdute. Infatti, se gli otto marittimi italiani fossero sopravvissuti all'esplosione, non avrebbero potuto resistere più di trenta ore in un mare ghiacciato. Le ricerche comunque, continuarono, almeno per recuperare i corpi.
2a COLLISIONE
Si era ancora alla ricerca degli otto dispersi della motocisterna TEXACO CARIBBEAN, venuta a collisione con il cargo peruviano PARACAS e spezzatosi in due dopo una tremenda esplosione, quando, quasi nello stesso punto del canale della Manica, accadde l’impensabile: un mercantile tedesco di 2.700 tonnellate, il BRANDENBURG colò a picco urtando contro un troncone della petroliera.
Sette le vittime e 14 marinai dispersi
La tragedia ebbe un epilogo fulmineo - Con lo scafo squarciato da prua a poppa, il Brandenburg affondò in due minuti. Vani risultarono i disperati messaggi SOS del radiotelegrafista tedesco e, di lì a poco, furono avvistati molti corpi inanimati alla deriva, in balia della corrente nelle acque gelide della Manica - I Piloti del Canale denunciarono la scarsa sicurezza del traffico marittimo.
I soccorsi ritardarono di quel tanto che solo 11 naufraghi, su 32 membri dell’equipaggio, furono salvati dai pescherecci locali. Gli altri 14 superstiti furono raccolti dalla Viking Warrior, la stessa unita che aveva soccorso i marinai italiani della Texaco Caribbean. Nelle ore successive al disastro furono recuperati i corpi di sette marittimi mentre dei rimanenti quattordici non si trovò mai più alcuna traccia. Un battello fanale e 5 boe luminose furono aggiunte a quelle già posizionate. Un superstite che volò in mare senza rendersene conto, riferì d’aver udito uno schianto tremendo mentre si trovava sotto coperta e d’aver capito subito che la nave aveva avuto una collisione. Il marconista del mercantile affondato ebbe appena il tempo di inviare un confuso messaggio di soccorso, messaggio che richiamò sul posto decine di imbarcazioni, in particolare pescherecci inglesi, che si trovavano nelle vicinanze.

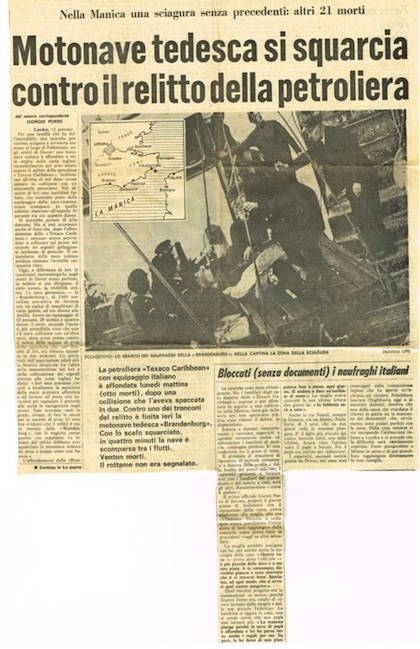
3a COLLISIONE
Nonostante le tragiche collisioni avvenute nel mese di gennaio, il 27 febbraio la nave greca NIKKI proveniente da Dunkerque (Francia) e diretta ad Alessandria d’Egitto, ignorando anch’essa gli “avvisi di sicurezza” emessi dalla Coast Guard, entrò in collisione con il relitto sommerso ed affondò. L’equipaggio della petroliera HEBRIS, che si trovava in quella zona ormai diventata un girone infernale, vide la NIKKI affondare e diffuse immediatamente i segnali di soccorso via radio. La HEBRIS, intravedendo dei naufraghi in mare, si avvicinò al luogo dell’affondamento, ma quando giunse sul posto in mare non c’era più alcun superstite. La NIKKI s’inabissò con tutto il suo equipaggio. Da quel momento i tre relitti rappresentavano un pericolosissimo rischio per le navi in transito, ed un secondo battello fanale fu posizionato all’ancora con l’aggiunta di altre 10 boe luminose. Nonostante i provvedimenti attuati a scopo preventivo, nei due mesi successivi, la Coast Guard fece rapporto a ben 16 navi che avevano ignorato sia i battelli-fanale, che le boe. Per fortuna non ci furono ulteriori incidenti. Le operazioni di sgombero dei relitti della TEXACO CARIBBEAN, DEL BRANDENBURG e del NIKKI durarono ben 18 mesi.
Ciò che é successo nel nord-est dell’Europa, celebre per la sua millenaria storia marinara é a dir poco imbarazzante ...
Il sistema di separazione del traffico navale nel Canale della Manica (TSS, Traffic Separation Scheme) entrò in vigore alcuni anni prima di questa catena di incidenti ma, al momento delle collisioni, diversi Comandanti consideravano ancora “facoltativa” e non “obbligatoria” l’osservanza delle nuove ROTTE DI SICUREZZA.
ALBUM FOTOGRAFICO - TEXACO CARIBBEAN




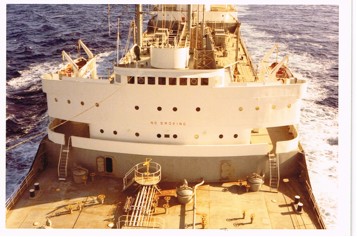
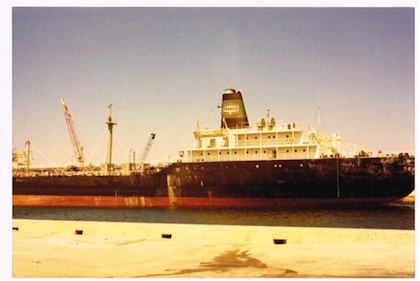
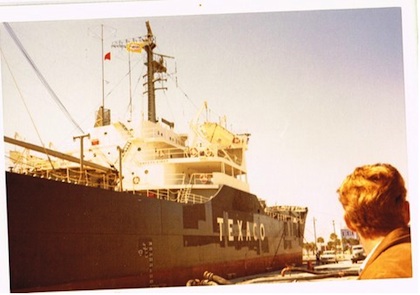
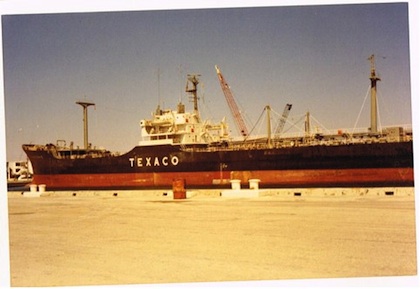

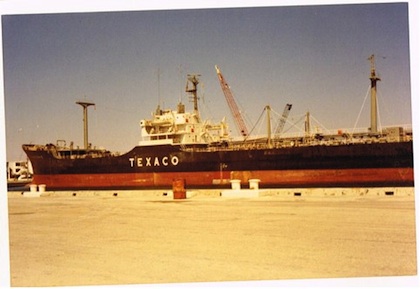
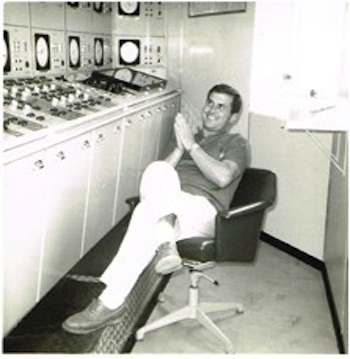
(Nella foto) - Il C.l.C. Ernani Andreatta sbarcato dalla TEXACO CARIBBEAN con il grado di Comandante pochi mesi prima dall’affondamento della petroliera. A lui porgo un fervido ringraziamento per averci fornito il materiale (notizie e foto)
“per non dimenticare”
i nostri cari amici “marittimi” travolti da un tragico destino.
Carlo GATTI
Rapallo, 1 Gennaio 2014
WILHELM GUSTLOFF - Una tragedia dimenticata
WILHELM GUSTLOFF
UNA TRAGEDIA DIMENTICATA
Quando si parla di grandi naufragi si viene catturati quasi sempre da nomi famosi come: Principe de Asturias (500 vittime), Titanic (1.513), Empress of Ireland (1.024), Lusitania (1.152), Conte Rosso (1.300), Andrea Doria (54) e di altri di cui la cronaca si occupa, purtroppo, anche ai giorni nostri. Alcuni di questi “relitti d’autore”, addirittura, riemergono ciclicamente dagli abissi per approdare sugli schermi del cinema sotto forma di fiction che addomesticano la vera storia per un pubblico bisognoso di sogni per esorcizzare il nemico che sta dietro l’angolo.
Ancora una volta prendiamo le distanze da questo mondo virtuale e puntiamo invece il riflettore su una tragedia che, sebbene quasi nessuno conosca, detiene tuttora un tragico primato: l’altissimo numero di vittime.

Si tratta della nave passeggeri tedesca Wilhelm Gustloff (nella foto) che fu affondata da un sommergibile sovietico il 30 gennaio 1945 nel Mar Baltico durante l’ultima fase della Seconda guerra mondiale. Il naufragio causò, secondo le ultime prove documentali, la morte di oltre 10.000 persone, divenendo il più grave mai registrato nella storia navale.
La Wilhelm Gustloff, costruita dalla Blohm und Voss di Amburgo, fu varata nel 1937, per la compagnia Kraft durch Freude (KdF = ”Forza attraverso la gioia”) che era un'organizzazione ricreativa della Germania nazionalsocialista. Aveva la considerevole stazza di 25.893 tonnellate ed era lunga oltre 200 metri. L’inaugurazione della Wilhelm Gustloff ebbe luogo presso il cantiere n.51 della B.&V. Non si trattava di una nave passeggeri particolarmente innovativa, ma rappresentava un efficace strumento di propaganda riunendo l’ideale dell’unità “ariana”, il sogno tedesco e l’affermazione dell’ideologia nazista. Doveva per questo motivo chiamarsi Adolf Hitler, ma le fu imposto Wilhelm Gustloff, capo della sezione elvetica del partito nazionalsocialista che fu assassinato il 4 febbraio del 1936 a Davos dallo studente ebreo David Frankfurter. L’omicidio aveva l’obiettivo di scuotere il popolo ebraico esortandolo a combattere contro l'oppressione nazista.
La Gustloff era la nave ammiraglia della flotta KdF che possedeva numerose altre navi altrettanto grandi e famose, ma la Gustloff aveva un suo fascino particolare e numerose furono le crociere compiute nell'Oceano Atlantico, nel Mar Mediterraneo e nei mari del Nord, alle quali aderirono la ricca borghesia tedesca dell’epoca.

La sua storia bellica inizia come “Trasporto Truppe” (nella foto) nel maggio del 1939, quattro mesi prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale. La Gustloff si affiancò ad altre quattro navi della KdF, la Robert Ley, la Der Deutsche, la Stuttgart, la Sierra Cordoba, ed infine la Oceana (non facente parte della KdF). Tutte queste navi avevano il compito di trasportare la Legione Condor dalla Spagna alla Germania dopo il successo ottenuto dai nazionalisti franchisti contro le forze repubblicane.

Nel settembre del 1939, le forze armate tedesche trasformarono ufficialmente la Gustloff in “Nave Ospedale” (Lazarettschiff D) (vedi foto) assegnandola alla Kriegsmarine. Non poteva trasportare materiale bellico ed era monitorata secondo un rigido protocollo internazionale. Era stata riverniciata di bianco, con una banda verde lungo tutta la carena su entrambi i lati e mostrava numerose croci rosse sul ponte, sul fumaiolo e sui lati. Il primo impiego della nave ospedale fu nella zona di Danzica al termine della campagna polacca. Rimase per molte settimane alla fonda in quella baia per l’imbarco e la cura di numerosi feriti supportando le operazioni di guerra contro i sovietici. Dal maggio 1940 fino al luglio dello stesso anno, la Gustloff operò nella zona di Oslo in Norvegia, come ospedale galleggiante durante la campagna di Norvegia (nome in codice “overlord”). Lasciò Oslo con 560 feriti a bordo e durante l'estate del 1940, le fu ordinato di tenersi in allerta per l’invasione dell'Inghilterra, che fu poi cancellata. Ancora una volta salpò da Oslo con altri 414 feriti. Subito dopo il viaggio terminò il servizio di “Nave Ospedale” e si spostò a Gotenhafen (Gdynia-Polonia) e venne adattata come “Nave Caserma” al servizio della Kriegsmarine affiancando i numerosi U-boot tedeschi. La Gustloff, prima sotto il comando della 1ª Divisione Unterseeboots (sottomarini), e poi della 2ª Divisione Unterseeboots, rimase all'ancora a Gotenhafen per oltre quattro anni.

L’Epilogo. Nel gennaio del 1945 la W. Gustloff rientrò in servizio prendendo parte attiva all'Operazione Annibale che fu la più imponente evacuazione di tutta la storia: 2.000.000 di rifugiati, soldati e feriti furono salvati, trasportati e messi al sicuro dall'avanzata sovietica verso ovest. Tutte le più grandi navi della KdF: Cap Arcona, Robert Ley, Hamburg, Deutschland, Potsdam, Pretoria, Berlin, Goya ed altre vennero utilizzate per l’O.A. nei porti di Danzica e Gotenhafen. Non tutti però riuscirono a salvarsi. Dalle 25.000 alle 30.000 persone morirono, soprattutto in seguito agli affondamenti della Gustloff e del Goya per un totale di oltre 15.000 morti. Considerando il numero di persone trasportate, le condizioni climatiche e il periodo di guerra, tale operazione fu comunque un successo dimostrando l’organizzazione e la determinazione della macchina di soccorso tedesca.

L’atto finale della Wilhelm Gustloff secondo l’interpretazione del pittore Irwin J.Kappes
L'affondamento. Quando la Gustloff uscì dal porto di Gotenhafen il 30 gennaio 1945, il tempo era pessimo: vento molto forte, nevicava e la temperatura era –10° e molte lastre di ghiaccio consistente galleggiavano pericolosamente nel Baltico. In quelle condizioni climatiche, la sopravvivenza per un naufrago erano nulle. La Gustloff, armata solo di qualche arma antiaerea, iniziò il suo ultimo viaggio senza alcuna scorta militare e senza installazioni antisommergibili.

Alle 21,08 del 30 gennaio 1945 il sommergibile russo S-13 comandato da Alexander Marinesko, lanciò tre siluri contro la Gustloff. Il primo colpì la nave a prua sotto la linea di galleggiamento. La nave sbandò subito a dritta. Immediatamente fu lanciato l'SOS e i razzi di segnalazione. Il secondo siluro la colpì sotto la piscina facendo esplodere l’intera struttura, ed infine il terzo siluro colpì la Sala Macchine devastando l'intero scafo. In quelle condizioni, la nave resistette 40 minuti all’invasione del mare dalle numerose falle. Poi si mise in verticale e s’inabissò di prora. La Gustloff affondò nelle acque nere e fredde del Baltico portando con sé oltre 10.000 persone. La più attendibile ricerca sul numero delle vittime é quella di Heinz Schön che riassume il “quadro” delle persone imbarcate secondo il seguente schema: 8956 rifugiati, 918 tra ufficiali e membri della 2. Unterseeboot-Lehrdivision, 373 donne delle Unità Ausiliarie, 173 uomini delle forze navali, 162 soldati feriti per un totale di 10.582 persone.
L'affondamento della Gustloff fu il più grave e spaventoso evento nella storia navale. Nessuna tragedia ebbe perdite di vite umane così pesanti. Ad inizio secolo lo scrittore tedesco Günter Grass ha raccontato il dramma di questo transatlantico nel libro: “Il passo del gambero”. Oggi il relitto della Wilhelm Gustloff é considerato alla stregua di un cimitero di guerra. L’intera area é interdetta a qualsiasi tipo d’immersione in segno di doveroso rispetto verso la più grande tragedia del mare.
Carlo GATTI
Rapallo, 19 settembre 2013
L'URAGANO SANDY affonda il BOUNTY del cinema
L’uragano “Sandy”
affonda il Bounty del cinema
L’imbarcazione era stata utilizzata nel film I Pirati dei Caraibi

Un momento felice del Bounty
Come un film, peggio del peggior film, l’uragano Sandy, la tempesta più prevista e pubblicizzata della storia, capace di tenere in ostaggio 60 milioni di americani, ha fatto due vittime sul mare e ha affondato uno scafo simbolo, un nome storico della letteratura, del cinema e della storia della navigazione: la “replica” del Bounty.

Il Bounty sta affondando
Era una copia della fregata mercantile della Royal Navy britannica, costruita per il film del 1962: 'Gli ammutinati del Bounty', con Marlon Brando nel ruolo di Fletcher Christian, il 'secondo di bordo' che nel 1789 comandò la rivolta contro il capitano William Bligh, e poi guidò gli ammutinati fino all'isola di Pitcairn, dove si stabilirono per sfuggire alla Royal Navy che aveva iniziato a cercarli ovunque. La storia ci racconta che l’inquieto ufficiale imbarcò nel 1787 sul veliero Bounty diretto a Tahiti per un carico di "alberi del pane”. Fu nominato Secondo su raccomandazione del comandante William Bligh, diventandone poi il luogotenente durante la navigazione. Il Bounty raggiunse Tahiti il 26 ottobre 1788 dove sostò per cinque mesi prima di rientrare alla base con il carico il 17 aprile1789. Poche settimane dopo, il 28 aprile 1789, a circa 1300 miglia a ovest di Tahiti, nei pressi di Tonga, Fletcher Christian capitanò il celebre ammutinamento decidendo, tra l’altro, di abbandonare il capitano della nave e i marinai a lui fedeli su una scialuppa in mezzo al mare.
173 anni dopo, nel 1962, Lewis Milestone decide di portare sul set la vera storia dell'ammutinamento, tratta dal romanzo “Mutiny on the Bounty” di Charles Bernard Nordhoff e James Norman Hall. Il film ruota attorno ad un grande Marlon Brando, affiancato sul set da Trevor Howard, Richard Harris, Hugh Griffith e Richard Haydn. Per l'occasione, Hollywood costruì una copia praticamente esatta del Bounty originale che é sopravvissuta 50 anni, forse troppo per un veliero in legno d’epoca, sebbene motorizzato e attrezzato di moderni strumenti e di conforts.
La cronaca di questi giorni ci dice che il veliero “H.M.S. Bounty” non ha avuto scampo contro onde alte 7/8 metri, sollevate dai 50 nodi di vento furioso mentre si trovava al largo delle coste del North Carolina. Impossibilitato a governare, il veliero ha iniziato ad imbarcare acqua, le pompe di sentina sono andate rapidamente fuori uso e, dopo alcune ore, il comandante ordinò al suo equipaggio di abbandonare le nave e di lui non si seppe più nulla. I quattordici sopravvissuti ce l'hanno fatta grazie allo spericolato intervento della Guardia Costiera, prima con un Hercules C-130 da ricognizione, poi con due elicotteri intervenuti in loro soccorso a circa 90 miglia a Sud-Est da Capo Hatteras che hanno issato i naufraghi a bordo con i verricelli di bordo. Poi, nella serata un altro elicottero ha localizzato il corpo "inanimato" di Claudene Christian, 42 anni che, per ironia della sorte, aveva lo stesso cognome del protagonista degli “Ammutinati del Bounty”. Non c'é stato invece nulla da fare per il veliero. Dopo essere stato abbandonato alla deriva, si é poi sfasciato tra le secche di un basso fondale. “Il suo albero di maestra svetta ora tra le onde”, ha riferito l'ammiraglio della Guardia Costiera, Robert Parker.
Il Bounty aveva lasciato il Connecticut giovedì 25 ottobre con a bordo 11 uomini e 5 donne tra i 20 e i 66 anni, tutti consapevoli della pericolosità della traversata. Secondo i sopravvissuti, il comandante avrebbe cercato di aggirare l’uragano, ma dopo due giorni in balia della tempesta si è reso conto che le difficoltà aumentavano: “Credo che ci saremo dentro per parecchi giorni”, aveva scritto in un messaggio sulla pagina Facebook della nave, una sorta di diario di bordo. “Cerchiamo di uscirne prima possibile”.
Lunedì 29 ottobre, il Bounty ha cominciato a imbarcare acqua, i motori sono andati in avaria, la nave si é traversata agli elementi, é seguito il lancio del May Day-May Day, l’abbandono-nave e il si “salvi chi può” sulle scialuppe calate nel mare tempestoso. Al momento dell’arrivo del primo elicottero, una luce stroboscopica era visibile sull’albero di maestra del Bounty ormai semi affondato.
Come vedremo tra poco, la forza distruttrice della natura ha infatti paralizzato parte del Nord America, bloccando letteralmente New York. Metropolitane invase dall'acqua, strade allagate, corrente elettrica saltate, linee telefoniche mute. La Grande Mela si é piegata al passaggio di Sandy.

Una bella immagine del Bounty
Storia della tempesta
L'Uragano Sandy è stato definito un Ciclone Post-Tropicale di fine stagione che ha colpito la Giamaica, Cuba, Bahamas, Haiti, Repubblica Dominicana e la Costa Orientale degli Stati Uniti raggiungendo la zona a sud della Regione dei Grandi Laghi degli Stati Uniti e il Canada orientale. È il diciottesimo ciclone tropicale, la diciottesima tempesta di ‘nome’ e il decimo uragano del 2012.

La rotta a salire dell’uragano Sandy vicino al suo picco di forza il 29.10. 2012
Formazione ........ 22 ottobre 2012
Venti più veloci ........ 175 km/h
Pressione minima ........ 940 mbar
Vittime ................. 182 (110 negli USA)
Danni ................... 50 miliardi $
Aree colpite .............. Giamaica, Cuba, Hispaniola, Bahamas, Florida
Sandy si è sviluppato nel Mar dei Caraibi occidentale il 22 ottobre 2012. È diventato depressione tropicale ed è stato promosso tempesta tropicale sei ore più tardi. La vasta depressione si é mossa lentamente dalle Grandi Antille verso nord rinforzandosi. Il 24 ottobre il fenomeno Sandy, poco prima di investire la Giamaica, è stato classificato uragano. Nel suo vorticoso movimento verso nord, Sandy ha ripreso il mare e nelle prime ore della mattina del 25 ottobre ha investito Cuba come uragano di categoria 2. Durante la tarda serata del 25 ottobre, Sandy si é leggermente indebolito passando a uragano di categoria 1. Nelle prime ore del 26 ottobre, ha investito le Bahamas. Sandy brevemente indebolito a tempesta tropicale nelle prime ore del mattino del 27 ottobre, si é poi di nuovo rinforzato, classificandosi di categoria 1 durante la mattinata. Poco prima delle 8 del mattino del 29 ottobre, Sandy ha accostato a nord-nord-ovest, si é avvicinato verso la costa degli Stati Uniti, mantenendo categoria forza 1. L'impatto di Sandy si é esteso dalla Virginia al New England, con venti fortissimi che hanno raggiunto l’hinterland producendo cospicue nevicate sui monti del West Virginia.
La tempesta tropicale di proporzioni mai viste prima da quelle parti, ha colpito New York city la sera del 29 ottobre allagando subito numerose strade, scantinati tunnel a Lower Manhattan e in altre aree della città. Secondo le stime del Comune, solo nella fascia costiera degli Stati Uniti oltre 4 milioni di persone sono rimaste senza energia elettrica.
CONCLUSIONE: abbiamo riportato appositamente la storia di SANDY per sottolineare che l’emergenza nazionale era già stata dichiarata il 22 ottobre quando si cominciò a monitorare lo spostamento sempre più preoccupante di quella eccezionale massa ciclonica. Da quel momento, l’allerta generale fu diffuso in ogni angolo della terra e fu mantenuta sino al suo esaurimento finale.
Sfogliando l’album dei ricordi, notiamo che già nei primi anni ’60, ogni nave proveniente dall’Europa e destinata ad un qualsiasi porto atlantico degli USA, durante la “rottura dei tempi”, era continuamente bombardata dai “gale warning” locali (avvisi di burrasca molto precisi). Qualsiasi piccola o grande depressione era segnalata, seguita e monitorata. Dopo 50 anni, nel campo della meteorologia satellitare, la tecnologia ha fatto passi da gigante, eppure c’é sempre qualche “belinone” che ne sa una più del diavolo... Questa volta é stato il turno della “replica” del Bounty. D’accordo che era perfettamente funzionante, motorizzata e che veniva impiegata per trasportare passeggeri in cerca di emozioni... ma era pur sempre un “legno” di 50 anni. Tutto ha un limite! L’area interessata alla depressione era di ben 3200 Km. Come pensava il Comandante di aggirarla? Quella sua presenza davanti a Capo Hatteras mentre scendeva dalla Carolina del Nord verso la Florida, per sfidare Sandy nei giorni della sua massima esplosione e potenza, ci appare oggi misteriosa, inquietante, per non dire folle! A questo punto esiste il sospetto, più che fondato, che il delirio d’onnipotenza di certi comandanti della nostra epoca, probabilmente “sniffanti” e in cerca di gloria, debba essere contrastato dalle Autorità prima che un intero settore finisca in malora.
Carlo GATTI
Rapallo, 19 settembre 2013
La caduta della TORRE DI CONTROLLO DI GENOVA
LA CADUTA DELLA TORRE DI CONTROLLO DEL PORTO DI GENOVA
Una Tragedia annunciata?

La vecchia e la nuova Torre di Controllo del traffico del Porto di Genova. Un passaggio di consegne finito in tragedia.
PREMESSA: Le navi che approdano nel porto di Genova vanno “girate” all’arrivo oppure alla partenza. L’allungamento di molti Ponti ed il riempimento di zone portuali strategiche hanno drasticamente concentrato in avamporto questo tipo di manovra.
La cementificazione del Porto di Genova, ha cercato di dare risposte ‘moderne’ alle richieste dello shipping internazionale, ma il suo impianto é medievale, e questi limiti geografici e corografici sono, a nostro modesto avviso, tra le probabili cause della tragedia della Torre di Controllo del Traffico.
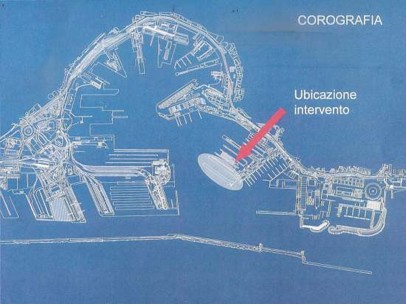
Il disegno schematico evidenzia (nella parte alta) l’allungamento dei pontili nel bacino ad anfiteatro del Porto Vecchio, da sinistra: tombamento del Passo Nuovo e Calata Sanità, modifica di Ponte Assereto e Ponte Colombo, Andrea Doria, Ponte dei Mille ed infine la trasformazione delle Calate interne fino al Molo Vecchio. Nel disegno é anche visibile (nella parte bassa a sinistra) il riempimento di Calata Bettolo. La freccia rossa indica la zona Bacini e la T.C. scomparsa.

Questa bella immagine delle Stazioni Marittime del Porto Vecchio è successiva ai lavori di allungamento di Ponte dei Mille
Premetto che, nel rispetto delle indagini in corso, non mi occuperò della manovra della Jolly Nero, ma piuttosto della situazione che si é venuta a creare in porto, dopo l’operazione di trasformazione e di allungamento di molte banchine per adattarle alle nuove esigenze del mercato navale.
Pochi si sono accorti che queste ‘gettate di cemento’ hanno costretto i piloti a cambiare le “tradizionali manovre”, a causa degli spazi sempre più ridotti, anche a scapito della sicurezza.
La cementificazione iniziata più o meno nel 2001-2002 é andata progressivamente aumentando fino all’anno in corso che, come tutti sappiamo, ha visto la distruzione della Torre di Controllo dei Piloti da parte di una nave in manovra di uscita e, con molto ritardo, questa immane tragedia ha reso un po’ tutti consapevoli dei passi “imprudenti” che sono stati compiuti in oltre dieci anni di affannosa rincorsa dei traffici in fuga dall’Italia.
Come sempre succede dopo un disastro, da più parti, ogni giorno, vengono sollevate obiezioni, supposizioni, accuse e dichiarazioni a dir poco STRANE. In effetti, si continua a trattare le persone come fossero bambini ritardati... ed anziché spiegare le verità nude e crude, si preferisce lasciare l’ultima parola al prete di turno, alla fatalità, alla pietra tombale e così via...
I lavori di ammodernamento del porto iniziati negli anni ’90, videro i primi ‘allungamenti importanti’ nel 2001-2002, e sono poi proseguiti come da note qui di seguito riportate:
Articolo del 2009 - AUTORITA’ PORTUALE
Stato di avanzamento piano delle opere.
- Presentato stamani a Palazzo San Giorgio lo stato di avanzamento del piano delle opere del porto di Genova, già cantierate o in via di cantierizzazione, avviate nel corso del 2009 e di prossimo avvio nel 2010 ...........
- L’intervento darà una risposta lungamente attesa al compendio dove proseguono peraltro i lavori per Calata Bettolo, a cui la seconda fase di dragaggio dovrebbe imprimere un’accelerazione, e dove partiranno a giorni i lavori per il riempimento Ronco-Canepa..........
- Per quanto riguarda invece l’area passeggeri è in fase di assegnazione la gara per la realizzazione grande banchina di Ponte dei Mille con un accosto di 340 metri destinato alla navi passeggeri di ultima generazione.
Articolo del 24/09/2011
Inaugurata la nuova banchina Ponte dei Mille.
Merlo: “Genova raggiungerà 1 milione di passeggeri”

Genova. Da oggi la più bella Stazione Marittima d’Europa ha una nuova banchina. Infatti, è stato inaugurato stamane, alla presenza delle autorità, l’ampliamento del lato di ponente della banchina di Ponte dei Mille.

Calata Bettolo per metà é ormai riempita.
Ampliamento del terminal container di Calata Bettolo.
L'intervento prevede la realizzazione di una nuova banchina a sud dell'esistente Calata Bettolo, a chiusura dello specchio d'acqua tra Ponte Rubattino e Calata Canzio (vedi foto n.4). Il piazzale ottenuto a seguito del tombamento dello specchio acqueo antistante Calata Bettolo costituirà il Nuovo Terminal Contenitori della capacità a regime di oltre 400.000 TEU/anno, in grado di operare su navi portacontainer della settima generazione, con lunghezze di oltre 380 metri e pescaggi di oltre 14.50 metri, grazie ad uno sviluppo di banchina di oltre 750 metri ed un tirante d'acqua di progetto di 17 metri.
E’ inoltre, prevista la costruzione di una unità funzionale, ad est di Calata Olii Minerali, denominata Darsena Tecnica, destinata ad attività di bunkeraggio navale e piattaforma ecologica (vedi foto n.2). La darsena tecnica è a levante e piccole cisterne lavoreranno nella nuova testata Calata Canzio (lungo canale).

Una veduta aerea del Porto di Genova dei primi anni ’90, con i suoi 22 km di lunghezza e le sue quattro imboccature. (Imbocc. di Levante-Fiera; Imbocc. Centrale–Italsider; Imbocc. Porto Petroli Multedo-Aeroporto; Imbocc. di Ponente-Porto Container di Voltri) – Nella foto si nota una nave in entrata davanti alla Fiera, tra poco sarà all’altezza del citato Superbacino ed entrerà in Avamporto. Poco avanti si vede un’altra nave in movimento davanti alla vecchia Torre di Controllo. Tra poco questa seconda nave entrerà nel bacino di evoluzione delle Grazie (tra Calata Gadda e i Bacini di Carenaggio). Sullo sfondo, il bacino ad anfiteatro del Porto Vecchio dove hanno girato il REX, la MICHELANGELO e le moderne navi da crociera prima dell’allungamento dei moli.

04.00 del 26 luglio del 1997 - Partenza Superbacino da Genova. Quattro piloti: Aldo Baffo, Giuseppe Fioretti, Carlo Gatti e Ottavio Lanzola presero posizione su ogni lato del Superbacino......
In questa immagine si vedono chiaramente le dimensioni del manufatto costruito in cemento armato, lungo 370 mt., largo 80 e alto una ventina di metri. Posizionato davanti all’imboccatura di levante del Porto, impediva ai Piloti la visuale del traffico navale. Questa megastruttura, nata e cresciuta in porto, era destinata al raddobbo delle superpetroliere di 350.000 tonnellate di portata, che furono costruite dopo il blocco del Canale di Suez alla fine della Guerra dei Sei Giorni (6.6.67). La sua forma, simile ad un enorme parallelepipedo vuoto e senza copertura, era il risultato dell’assemblaggio di otto elementi che era iniziato con il varo, tutt’altro che facile, del primo pezzo nel lontano 28 aprile 1975.
Questo “ostacolo” fu all’origine della costruzione della nuova Torre di Controllo abbattuta dalla Jolly Nero.
Un po’ di Storia: Verso la metà degli anni ’80, proposi ai miei colleghi piloti ed alle Autorità dell’epoca, la necessità di poter operare da una Torre di Controllo del traffico alta e moderna, che superasse in altezza il superbacino galleggiante che impediva la visuale delle navi in avvicinamento all’imboccatura di levante. Tutti erano consapevoli che all’epoca, in certi giorni della settimana e in certi orari particolari, si doveva gestire l’approaching di 10-15 navi contemporaneamente, oltre a quelle in uscita, in movimento e in attesa di istruzioni. La direzione del traffico era diventato il problema principale per la sicurezza del porto. Il superbacino era inattivo, ed era così alto che dalla vecchia Torre di Controllo, alta quattro piani, i piloti erano completamente ciechi. Il presidente del Porto di allora, Roberto D’Alessandro ci promise la realizzazione di un prototipo di T.C. da parte dell’Italimpianti. Purtroppo, i suoi scontri con il console Batini lo videro sconfitto. Ritornai alla carica nei primi anni ’90, con il Capo Pilota Adriano Macario, sensibile al problema e con alcuni Dirigenti dell’allora CAP, i quali capirono al volo che la realizzazione di una moderna T.C. sarebbe diventata il fiore all’occhiello di un Porto Integrato all’avanguardia, con le sue 4 imboccature (quattro piste d’atterraggio) ecc... Lo studio, la progettazione, la strumentazione, la funzionalità, la logistica ecc.... c’impegnarono per molti anni di duro lavoro. Tutto andò per il meglio, ma la sua “tranquillità operativa” durò solo pochi anni a causa, come si é visto, di una progressiva cementificazione che andò via via a restringere e a ridurre nel tempo il numero dei bacini d’evoluzione dislocati in tutte le zone portuali e che per anni avevano permesso ai piloti di girare le navi contemporaneamente.
Una annotazione importante
Fino ad una decina di anni fa, esisteva in porto la “Consuetudine” che obbligava tutte le navi in arrivo ad ormeggiare con la prora fuori, per essere pronte a sgomberare in caso di emergenza. Va da sé che tutte le navi in arrivo nel Porto di Genova DOVEVANO ESSERE GIRATE in determinati “slarghi”. Oggi le cose sono cambiate: il 40% delle navi in arrivo vengono ormeggiate con la “prora a terra” sia per ridurre i tempi di manovra, sia per la sparizione o diminuzione degli slarghi stessi.
Dove ‘giravano’ le navi prima della cementificazione selvaggia e dove ‘girano’ oggi?
Navi destinate al Porto Nuovo di Sampierdarena, (i cosiddetti pontili a pettine).
Fin dalla sua costruzione (tra le due guerre mondiali), le navi hanno sempre “girato” secondo queste modalità:
- lunghezza 50-100 mt. girano sul posto.
- lunghezza 100-220 mt. girano con la prua a ponente in canale, perché la distanza tra le testate dei pontili e la diga foranea é di 210 metri.
- lunghezza superiore a 220 metri (Jolly Nero), sia in entrata che in uscita (se necessario) evoluivano a CALATA BETTOLO, ormai tombata definitivamente. Questa manovra é stata fatta per circa 90 anni. Oggi queste navi girano in AVAMPORTO
Bacini di evoluzione PORTO ANTICO
AVAMPORTO, lo slargo che s’incontra entrando in porto, ha sempre avuto lo specifico scopo (direi storico), proprio per le sue dimensioni, di ‘agevolare’ gli incontri tra le navi in uscita e quelle in entrata, evitando i passaggi ravvicinati in canale e in altre zone più strette (accesso ai bacini di carenaggio, calata Sanità x grandi n. container, traghetti in transito ecc...).

Questa foto, ripresa sulla T.C. da una delle vittime, vale più di tante parole..............
Con la cementificazione in atto, l’AVAMPORTO é diventato l’unica ZONA DI EVOLUZIONE SICURA, ma di DI MASSIMO PERICOLO PER LA T.C. (vedi foto 7)
Aggiungo, inoltre, che detta pericolosità é stata anche accentuata da altre strutture e banchinamenti costruiti agli Olii Minerali - la zona diametralmente opposta a ponente, della T.C. - già descritta all’inizio.
BACINO PORTO VECCHIO, abbiamo visto che ormai é destinato a ZONA DI EVOLUZIONI SOLTANTO PER I TRAGHETTI e navi similari per l’avanzamento del cemento e la riduzione drastica dell’acqua di manovra.
BACINO CALATA GRAZIE, (vedi foto n.5). Si tratta di un’area di evoluzione che é stata dragata tra i Bacini di Carenaggio e Calata Gadda. Viene tuttora usata quando soffia forte la tramontana, ma presenta altri problemi su cui é inutile soffermarci. Durante i lavori di dragaggio a Calata Gadda, le GRANDI NAVI PASSEGGERI SONO STATE GIRATE PREFERIBILMENTE IN AVAMPORTO. Si preferisce girare queste navi in AVAMPORTO anche durante forti sciroccate e libecciate.
ZONA DI EVOLUZIONE DAVANTI A CALATA SANITA’. Si usa questa zona di evoluzione quando vi é concomitanza di manovre di navi passeggeri destinate alle Stazioni Marittime. (Vedi margine inferiore foto.n.5)

Così si presentava il Bacino Porto Vecchio prima degli allungamenti dei pontili. In rosso i terminal passeggeri di un tempo.
Davanti a Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria evoluì il REX (250 mt.), il CONTE DI SAVOIA e, in seguito, noi girammo la MICHELANGELO-RAFFAELLO (275 mt.) - EUGENIO C. e le grandi navi moderne (eccetto le ultime, ovviamente).
CONCLUSIONE:
All’epoca della progettazione e costruzione della T.C. crollata, nessuno tra gli addetti ai lavori, aveva conoscenza dei progetti che avrebbero fronteggiato il gigantismo navale. Nel frattempo centinaia di Operatori Portuali di tutti i continenti vennero a Genova per studiarne l’ubicazione, l’operatività e quant’altro. Nessuno mosse mai critiche o avanzato progetti per migliorarne la sicurezza.
Tuttavia, oggi sarebbe importante sapere come mai, una volta avviati i lavori di ammodernamento, non siano state prese in considerazione le denunce di pericolose oscillazioni della T.C. a causa del vento e della vicinanza delle navi in evoluzione.
La Torre di Controllo nacque per dare SICUREZZA ALLE NAVI, non per essere essa stessa vittima della mancanza di sicurezza. Non averla protetta dai cambiamenti delle dinamiche navali in atto nell’ultimo decennio é stata una fatale omissione. Si spera che le indagini in corso rivelino le vere cause e individuino le responsabilità di chicchessia affinché i nove giovani operatori della T.C. non siano morti invano.
Dalle dichiarazioni udite in TV subito dopo la tragedia, uno dei massimi dirigenti del porto si é così espresso:
“Quella nave non doveva girare lì, non si é mai visto una cosa del genere!”
Che tristezza! No comment!
Carlo GATTI
Rapallo, 18.5.2013
Riportiamo il commento di un nostro socio ing. A.B. sul crollo della Torre di Controllo dei Piloti di Genova:
"Grazie alle foto scattate durante la costruzione della Torre dei Piloti, la struttura di base é ben visibile.
Si trattava di una costruzione che gravava su semplici colonnine senza rinforzi che rimaneva in piedi grazie alla forza di gravità.
Con un carico di punta senza contrasti laterali é logico che sia crollata come un domino. Le solite "architettate" senza cervello.
Ribadisco: osservando il danno (o per meglio dire il NON danno) sulla nave, ne deduco senza troppo sforzo che al momento dell'urto la nave era già praticamente ferma e si è semplicemente appoggiata.
Le tracce di cemento si estendono al massimo per un paio di metri lungo lo scafo.
L'edificio era così mal concepito da andare giù praticamente con un soffio...
Dico di più, se invece della nave fosse giunto uno scossone di terremoto avrebbe fatto con tutta probabilità la stessa fine.
Continueranno a prendersela con la parte "marinara" della questione cercando errori di manovra, probabilmente per mascherare ben altro...
LEONARDO DA VINCI, da mito a relitto

3.7.1980
INCENDIO E PERDITA
della nave passeggeri italiana in disarmo
“LEONARDO DA VINCI “
Nave |
Bandiera |
Varo |
Stazza l. |
Passeggeri |
Velocità |
|
Leonardoda Vinci |
italiana |
1958 |
33.340 |
1326 |
25.5 |
|
Luogo dell’Incendio:
La nave era ancorata nella rada del porto di La Spezia.
Un po’ di Storia:
Il 5 aprile 1977, la turbonave Leonardo da Vinci fu messa in disarmo, a conclusione di numerosi viaggi di linea per il Nord America. Si chiudeva così un fulgido periodo di grandi tradizioni marinare per l’Italia e la Liguria, legato ad un servizio marittimo ormai compromesso dalla concorrenza dell’aviazione civile mondiale.
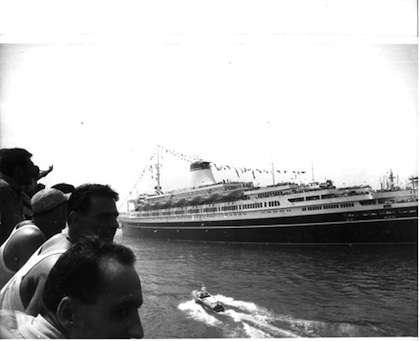
Folla di curiosi assiste alla partenza della Leonardo da Vinci da Ponte Andrea Doria.

La Leonardo da Vinci in uscita dal porto di Genova per il suo viaggio inaugurale il 30.V.1960
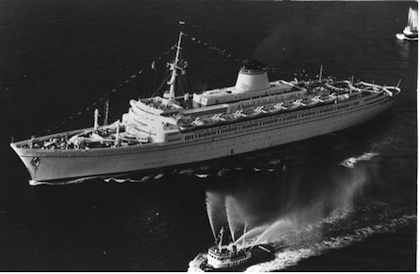
La magnifica linea della Leonardo da Vinci, tipico esempio di Italian Style, in arrivo negli Stati Uniti.
Ci fu quindi una cancellazione totale dei servizi di linea, ma si aprì il grosso problema dell’utilizzo delle unità disarmate e soprattutto del numeroso personale destinato altrimenti alla disoccupazione. La riapertura del Canale di Suez offrì in quel periodo nuove opportunità turistiche e fu decisa la costituzione di una Società a partecipazione mista:
Statale (FINMARE) e Privata (Costa-Magliveras-Elice) per la gestione di navi in attività crocieristiche. Venne così fondata la I.C.I (Italia Crociere Internazionali).
La prima decisione presa dalla nuova Società fu quella di rimettere in servizio La Leonardo che venne destinata ai Caraibi, con base a Port Everglades in Florida. Ma i concetti di costruzione e di servizio delle vecchie navi di linea, erano ormai tutti superati dal nuovo vento tecnologico e manageriale, imposto da una classe emergente di Armatori che aveva previsto in tempo la svolta epocale dei traffici navali. Così che, dopo appena un anno di crociere, la Leonardo rientrò a Genova il 18.9.1978 e la trasferirono dopo pochi giorni a La Spezia in disarmo.

La Leonardo da Vinci in disarmo alla Spezia é devastata da un
improvviso incendio.
Incendio a bordo:

L’incendio é finalmente estinto, ma la Leonardo da Vinci é ormai un relitto.
Fu durante questa sosta forzata che il 3.7.1980 la gloriosa e bella nave genovese andò perduta, a causa di un incendio scoppiato, forse per un cortocircuito e che non fu possibile domare tempestivamente per mancanza di personale, essendo la nave in disarmo e quindi sorvegliata da un numero esiguo di personale.
Per ragioni di sicurezza, la nave fu allontanata a rimorchio fuori dalla diga foraneadel porto, dove continuò a bruciare per tre giorni ed alla fine, a causa dell’acqua imbarcata in funzione antiincendio, sbandò, poi s’inclinò sempre di più sino a coricarsi su un fianco sul basso fondale della rada.
La Leonardo da Vinci fu in seguito recuperata ed avviata definitivamente alla demolizione.

La sezione prodiera della Leonardo da Vinci appoggiata su un fianco
Carlo GATTI
Rapallo, 3 aprile 2013
HELEANNA - Una ferita che brucia ancora
M/n HELEANNA - UNA FERITA CHE BRUCIA ANCORA
Il comandante Dimitrios Anthipas, un pessimo esempio di Comandante
Il 28 agosto 1971, a 15 miglia da Monopoli, un incendio scoppiò a bordo del traghetto greco “Heleanna”. Si trattò della più drammatica e funesta sciagura marittima accaduta in Adriatico nel dopoguerra. La tragedia costò la vita a 25 turisti imbarcati; 16 furono i dispersi, 271 feriti tra i 1089 i superstiti.
Sono trascorsi 42 anni dall’incendio della HELEANNA, ma il ricordo é sempre vivo, specialmente tra coloro che seguirono da vicino le operazioni di salvataggio, ma anche da tutti coloro che ben presto si resero conto che a bordo del traghetto viaggiavano 1174 passeggeri, quasi il doppio dei 620 consentiti, e duecento automobili. A quel punto l’apprensione si trasformò in pura rabbia e la stampa di allora definì “negrieri del mare” il comandante Antypas Dimitrios ed il suo armatore Efthymiadis.

Da dove uscì quel maxi-traghetto con la ciminiera a poppa come una petroliera?

Negli anni ’60 l’armatore greco Constantino S. Efthymiadis comprò quattro petroliere svedesi per convertirle in traghetti passeggeri:
la MARIA GORTHON (rinominata PHAISTOS), nel 1963;
la SOYA-MARGARETA (rinominata MINOS), nel 1964;
la SOYA-BIRGITTA (rinominata SOPHIA), nel 1965;
la MUNKEDAL (rinominata HELEANNA), nel 1966.
Nel 1954 la nave cisterna Munkedal fu costruita dai cantieri Götaverken di Göteborg-Svezia. Ma il suo destino fu segnato dalla chiusura del Canale di Suez* che costrinse le petroliere a compiere il lungo e costoso periplo dell’Africa, linea che sarebbe risultata economica soltanto con l’introduzione del “gigantismo navale”. Così fu, e tutte le stazze minori, tra cui le petroliere svedesi sopra citate, furono messe fuori mercato.
* Nota: Dopo la GUERRA DEI SEI GIORNI del 1967, il canale rimase chiuso fino al 5 giugno 1975).
Da sempre i greci sono considerati validissimi marinai, ma anche un po’ spregiudicati. L’armatore C.S.Efthymiadis era un fedele garante di questa tradizione. La sua intuizione gli permise, infatti, di trasformare e reclamizzare la nuova unità come “il più grande traghetto del mondo”.
Nel 1966, mantenendo il suo aspetto esteriore, la petroliera Munkedal fu ridisegnata al suo interno per la sistemazione di numerose cabine/passeggeri, mentre sulle fiancate dello scafo furono installati portelloni con rampe di nuova concezione per l’imbarco/sbarco di auto al seguito e mezzi pesanti. Rinominata Heleanna, il traghetto entrò in linea sulla rotta Patrasso–Brindisi-Ancona e ritorno.
La cronaca dell’incidente
Al momento del disastro l’Heleanna si trovava 25 miglia nautiche a Nord di Brindisi, a 9 miglia al largo di Torre Canne, più verso Monopoli. Proveniva da Patrasso ed era diretta ad Ancona con 1174 passeggeri e 200 mezzi (auto, tir e autobus).
Tutto ebbe inizio alle 05.30 del 28 agosto 1971 quando una fuga di gas dai locali della cucina, fra la panetteria, la riposteria ed il locale ristoro provocò un incendio a poppa. Si parlò di un corto circuito, forse una manovra errata di accensione dei polverizzatori della cucina, oppure di uno spandimento di gas liquido, ma anche di una possibile fuoriuscita di nafta dalla cassa di alimentazione della calderina.
Alcuni testimoni affermarono che l’incendio prese il sopravvento solo quando il fuoco lambì le bombole di ossigeno facendole esplodere. Poco dopo successe un fatto molto anomalo: in una cala di poppa vicino al timone, scoppiò un’altra bombola d’ossigeno che bloccò istantaneamente l’organo di governo che era, in quel momento, posizionato 15° a dritta. Il traghetto, ormai in panne, ma ancora abbrivato, compì un’ampia accostata in cui il vento propagò l’incendio a tutta la nave.
L’Heleanna aveva in dotazione 12 scialuppe di salvataggio sufficienti per 600 persone, la metà delle persone imbarcate. Le inchieste promosse dalle Autorità dimostrarono che metà delle lance erano inutilizzabili per via degli argani bloccati dalla ruggine. Tra quelle calate a mare, una si ribaltò e precipitò in mare probabilmente per il sovraccarico.
Gli idranti antincendio e i tutti i sistemi di soccorso non erano funzionanti. Le inchieste che seguirono dimostrarono che il traghetto, dal punto di vista della sicurezza, era da considerarsi sub-standard.
Il disastro causò 25 morti, 16 dispersi e 271 feriti, alcuni anche in modo grave. Le vittime erano di nazionalità italiana, greca e francese. Non appena il Comandante della nave lanciò l’SOS, soccorsi aerei e navali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli e Grottaglie.
I soccorsi aeronavali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli, Taranto e Grottaglie, anche con la partecipazione di alcuni pescherecci privati (Laura, Madonna della Madia, Angela Danese, Nuova Vittoria, S. Cosimo) che si attivarono con molta efficacia nella ricerca dei dispersi in mare ed al soccorso dei naufraghi.
L’incendio venne domato dopo molte ore. Il relitto fu rimorchiato verso porto di Brindisi e fu ormeggiato nei pressi del castello Alfonsino.
I feriti sarebbero stati più numerosi se non fosse scattata con grande tempestività l’opera dei soccorritori. Il personale dei rimorchiatori locali della Società Barretta dovette avvicinarsi fino a pochi metri dalla nave per rendere efficace il getto delle proprie spingarde, sfidando temperature altissime e respirando gas di scarico e fumi micidiali, ma dovettero farlo per domare le lingue di fuoco che fuoriuscivano da tutta la nave minacciando di far esplodere i serbatoi di benzina degli oltre 200 mezzi che si trovavano nel garage. Fatto che purtroppo avvenne con tutte le sue tragiche conseguenze.
Anche la città di Monopoli si prodigò per confortare i superstiti, dando una dimostrazione di grande generosità offrendo aiuto e accoglienza ai naufraghi dell’Heleanna.
Il 15 ottobre del 1972 il Capo dello Stato Giovanni Leone conferì alla città la Medaglia d’Argento al Merito Civile in riconoscimento dell’antica tradizione di ospitalità e di civismo della sua popolazione.
“Quando siamo arrivati sul posto” – raccontò il proprietario di un peschereccio – “ci siamo trovati di fronte ad uno spettacolo agghiacciante. Lunghe lingue di fiamme uscivano dalla poppa impedendoci di avvicinarci troppo. Sul ponte del traghetto dilagava il panico. Centinaia di persone tentavano di calare le scialuppe senza riuscirvi, altre che scendevano con le barche liberate, rimanevano poi sospese e bloccate a mezz’aria. Altre barche ancora, arrivavano in mare ma non sapevano come governarle. I più si gettavano direttamente in mare saltando dal ponte. Su decine di corde, calate dalle fiancate, c’erano grappoli di uomini appesi, molti erano senza salvagente. Diversi battellini di gomma, sparpagliati in mare, erano difficili da raggiungere ma anche più difficile riuscire a salirvi dentro. Dalle navi che erano accorse – racconta un altro marinaio – erano state calate delle scialuppe, ma rimanevano vuote perché la gente in mare, sfinita non riusciva a raggiungerle. Allora, molti di noi, si sono buttati in acqua per aiutarli. Mai avevo visto tanta gente disperata, annientata dal dolore per aver perso, magari un attimo prima, un amico, un congiunto. Intanto, sulle banchine dei porti di Monopoli, Brindisi e Bari, viene predisposto un imponente servizio di soccorso”.
Centinaia di privati misero a disposizione i loro mezzi, altri portarono in Capitaneria indumenti e coperte. L’incendio fu domato prima di notte e l’Heleanna fu tenuta prudentemente in rada mentre gli inquirenti tentarono di accertare le responsabilità dell’accaduto.
Pare che nella confusione generale, il Comandante del traghetto sia stato il primo a perdere la testa. Alcuni testimoni, infatti, affermarono che il capitano Anthipas abbia lasciato la nave subito dopo l’allarme, mentre la moglie, che era con lui sul traghetto, sostenne il contrario. Per la verità, un’evidenza ci fu e molti la testimoniarono in diverse sedi: il comandante Dimitrios Anthipas, giovanissimo e senza esperienza, giunse “asciutto” sulla banchina di Brindisi, e il 29 agosto del 1971 cercò addirittura la fuga, ma venne arrestato al varco frontaliero del porto di Brindisi, poco prima d’imbarcarsi furtivamente con la moglie su una nave diretta in Grecia. Il comandante venne arrestato con l’accusa di omicidio colposo e per abbandono della nave.
Dimitrios Anthipas sarà poi estradato in Grecia mentre chi ha perso tutto: auto, bagagli, valori, la stessa vita di moglie, figli, genitori e parenti non sarà neppure risarcito. Gli assicuratori si rifiuteranno di pagare per l’evidente violazione, da parte della nave, delle norme stabilite nelle polizze assicurative.
All’epoca del “sinistro”, le acque territoriali comprendevano una fascia di 6 miglia nautiche (11.112 KM), poi modificate per legge in 12 miglia dal 27 febbraio 1973), per cui il disastro avvenne in acque internazionali. Ma le Autorità italiane dichiararono la loro competenza a processare il comandante della nave poiché alcune vittime del disastro erano perite in acque territoriali italiane ed almeno una era morta in ospedale a Brindisi. Anche le autorità greche furono interessate al processo, in quanto la nave batteva bandiera ellenica.
L’Heleanna in fiamme

Notare la vicinanza del rimorchiatore che punta le spingarde antincendio sulla poppa dell’Heleanna

Targa commemorativa del naufragio a Monopoli

Dopo due anni e mezzo di sosta forzata nel porto di Brindisi, per il relitto dell’Heleanna giunse il momento del congedo, dell’ultimo trasferimento verso un Cantiere di Spezia che aveva il compito di demolirne una parte e trasformarne il resto in una chiatta portuale multipurpose.

Il rimorchiatore genovese ESPERO in navigazione
Rimorchiatore incaricato dell’ultimo viaggio apparteneva alla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova, si chiamava ESPERO, era l’ultimo nato della flotta, 5.000 CV di razza, con una strumentazione d’avanguardia: elica intubata, towing winch(troller) modernissimo, elica di manovra a prora(bowthruster) ed una elettronica up to date applicata a tutti i suoi apparati. Chi scrive, era già stato per sette anni al comando di rimorchiatori portuale d’altomare; per motivi d’anzianità toccò a lui collaudare questo moderno “fuoriclasse”. Come? Per un puro caso, si presentò una duplice occasione.
Si trattava di rimorchiare in successione, due relitti, entrambi da Brindisi a La Spezia che all’epoca era il primo porto nazionale della demolizione navale.
Il primo era la petroliera SAN NICOLA della famosa Società Garibaldi, che aveva subito un’esplosione nella cisterna n.10 che squarciò la coperta della nave dando di sé una immagine terrificante.
La seconda era il traghetto passeggeri HELEANNA di cui ci siamo occupati in questo drammatica ricostruzione.

Lo squarcio in coperta della petroliera San Nicola
Testimonianza dell’autore:
Quando salii a bordo del “traghettone” per controllare la situazione generale e studiare gli attacchi di rimorchio, cercai invano di trovare un metro di lamiera liscia ed intatta.
In pratica, l’interno dello scafo era stato devastato completamente dalle altissime temperature provocate dall’incendio. Le lamiere dei ponti erano ondulate e bugnate come la pelle di un lebbroso. Delle 200 autovetture ancora presenti nel lunghissimo garage, erano rimasti gli scheletri deformati da un fuoco impietoso che era durato a lungo causando, purtroppo, vittime e sofferenze indescrivibili.
Avevo già compiuto un’ottantina di rimorchi in tutto il mondo, ma non mi ero mai trovato davanti a tanta devastazione, desolazione e tristezza.

Manovra d’uscita della HELEANNA da Brindisi
1° Problema
Quando andai sul castello di prora per approntare gli attacchi di rimorchio mi trovai di fronte ad una strana situazione: non sapevo dove attaccarmi. Il copertino deformato aveva piegato le bitte, sollevato il salpancore e indebolito ogni centimetro del castello.
Alla fine decisi di far passare alcune grosse cravatte d’acciaio da quei due passacavi in alto che sembrano
due occhi ai lati del tagliamare (vedi foto). Era come prendere un toro per le narici e vi assicuro che non
c’era altro da fare. Come attacco di riserva presi al “lazo” tutto il castello di prora evitando gli spigoli con coppi di gomma, legno, tanto grasso e sacchi di juta.
2° Problema
In precedenza ho accennato all’esplosione di una serie bombole di ossigeno sistemate vicino al timone
della nave; fu proprio questa la causa che bloccò l’organo di governo 15° a dritta costituendo un grande problema per la navigazione a rimorchio.
La soluzione del problema era nelle mani di un’officina specializzata che avrebbe raddrizzato il timone, ma dentro un bacino di carenaggio che nessuno era disposto a pagare…..
Mi dovetti rassegnare, pur sapendo che avevamo davanti 800 miglia di “navigazione manovrata”.
Infatti, appena allungammo il cavo e ci mettemmo in tiro, il rimorchio accostò sulla sua dritta.
Quando doppiammo Santa Maria di Leuca, il vento rinforzò e ci accompagnò fino all’arrivo.
Riuscimmo a tenere una velocità intorno alle 6 miglia, ma quando il vento aumentava nelle golfate, l’Heleanna ce la vedevamo al traverso e per rimettercela di poppa dovevamo allascare le bozze, far venire il cavo da rimorchio in bando e poi dovevamo ripartire “alla gran puta” per andare a riprendere il toro per le corna e rimettercelo di poppa.
Questa era la navigazione manovrata in cui si rischiava di strappare sia le bozze che il cavo da rimorchio.
Pendolammo per 20 ore a ridosso dell’Isola di Ischia, sia per controllare l’attrezzatura, ma soprattutto per
far scivolare verso Est una forte depressione che spingeva il rimorchio fino a sorpassarci, costringendoci
a vere acrobazie per non farci “prendere per il c…” Un’espressione marinara che rende perfettamente
l’idea di ciò che può succedere quando il rimorchio, non essendo in assetto di navigazione, prende il sopravvento, infrangendo quelle poche ma importanti regole
marinaresche, che si dovrebbero sempre rispettare.
Il 16.2.74 arrivammo finalmente a Spezia, e quando il mio amico pilota Nino Casaretto, il quale aveva subito l'esplosione nella cisterna n.10 che squarciò la coperta della nave dando di sé una immagine terrificante, venne a bordo per la manovra di consegna del relitto ai rimorchiatori locali, mi disse in dialetto:
“Ma non ti vergogni d’andare in giro con questo accidente... attaccato al sedere” ?
“Vergogna no! – gli risposi – A brindisi non vedevano l’ora di levarselo dal sedere e trovarne un altro
disposto al sacrificio. Dicono che nella vita bisogna provarle tutte! Eccomi qui, felice e contento d’essere arrivato!”
APPENDICE:
Rapporto Viaggio

Mi spiace! L'immagine non è leggibile, i numeri sono lì... fidatevi! Purtroppo i morti sono altrove. Che Dio li benedica!
UNO SCAMPATO PERICOLO....
La nostra socia Marinella Gagliardi Santi, notissima scrittrice e Skipper di lungo corso, dopo aver letto questo articolo, ha voluto rilasciarci la sua ESISTENZIALE TESTIMONIANZA. per la quale non possiamo che unirci felicemente a questa fantastica coppia di “marinai” per lo scampato pericolo!
"Il ricordo di quella tragedia mi ha toccato da vicino ancora di più, perché Rinaldo ed io, allora non ancora fidanzati, avremmo dovuto imbarcarci proprio sull'Heleanna! Mi aveva invitato ad andare in Grecia insieme a lui ma gli avevano detto che non c'era posto sull'aereo: al ritorno non ci sarebbe stato alcun problema perché avremmo preso proprio quel traghetto! Così io non sono partita con lui, lui si è imbarcato su un aereo in realtà completamente vuoto, e per il ritorno ha preso nuovamente l'aereo.
Pericolo scampato per un pelo, la sorte ha voluto così!"
Carlo-GATTI
Rapallo, 21.3.2013 / Rielaborato nella nuova versione del sito, venerdì 17 Maggio 2024