CORSARI BARBARESCHI
CORSARI BARBARESCHI
Tutto quello di cui non si parla mai
Dei pirati sappiamo ormai quasi tutto, molto anche infarcito da leggende romanzate. In realtà i “corsari barbareschi”, quelli che imperversavano anche da noi, erano degli abili marinai e ardimentosi predatori mussulmani, nord-africani e ottomani con frammisti anche qualche italiano rinnegato, che svolgeva a proprio vantaggio questa attività di brigantaggio, magari camuffando il proprio vero nome con improbabili nomignoli berberi.
Le basi di appartenenza di questi pirati erano Tunisi, Tripoli, Algeri, Salé, porti localizzati in quella che allora noi europei chiamavamo <Barberia>, storpiando il nome dei Berberi, i veri abitanti dei luoghi.
Poi, per quanto ci riguarda, visto il successo, i pirati si organizzarono creandosi rifugi negli anfratti della rocciosa costa Ligure che permetteva di rimanere nascosti, fare cambusa ed essere però anche pronti a scattare per depredare le ricche e lente navi che costeggiavano per raggiungere Genova e, in mancanza di quelle, assalire i Borghi costieri. I secoli in cui imperversarono furono, soprattutto il XVI e il XVII. Anche allora la religione era un pretesto infervorante.
Tutto nacque dalla potente flotta ottomana che dominò, per un certo periodo, il Mare Mediterraneo, forte anche del fatto che gli Stati europei non furono capaci di farle fronte comune. Quando lo fecero, gli Ottomani si acchetarono e quella flotta, intenta anche a sanarsi le ferite finalmente subite, non veleggiò nel Mediterraneo per lunga tratta. Da allora piccole ed isolate frange, intrapresero la nuova attività non più sotto l’egida del Sultano Solimano, pur inalberando “mezze lune”.
La pirateria fu una vera e propria attività industriale che ogni pirata si gestiva autonomamente. Come ultima ratio, il rapito veniva venduto in Nord Africa, solo se non si riusciva ad ottenere “in loco” un riscatto. Per consentirne il pagamento, lo sventurato veniva esibito in varie spiagge vicine a casa sua sino a che qualcuno non ne avesse pagato il richiesto; con calma, perché nel frattempo veniva messo a lavorare per loro, in primis ai remi. Fra gente tirchia come siamo e poveri come eravamo, non era facile trovare parenti pronti a versare i propri risparmi per “acquistare” la libertà ad un “furesto”, ancorché parente. Invece i beni, le barche o i leudi e i loro carichi appena depredati lungo la costa, venivano rivendute ad acquirenti senza scrupoli, interessati ad averli subito e a prezzi stracciati; c’erano già allora commercianti locali organizzati che offrivano denari per poterli avere. Sembra strano ma la disorganizzazione e la miseria che regnava in tutte le cittadine, non permetteva alle stesse di riprendersi con la forza, quanto era stato loro appena rapito ed offerto a pochi passi da casa.

Isola del Tino (La Spezia)
Basti pensare che il frutto delle malefatte compiute nel golfo della Spezia, veniva poi messo in vendita appena dietro il Tino e così, per tutta la riviera. La merce depredata trovava subito acquirenti ma le persone, se non abbienti o importanti per i signorotti locali che avevano i mezzi per riscattarli, erano difficili da affrancare.
Le scarse e mal pagate guardie, assoldate per difendere i Borghi, troppo spesso di notte dormivano, quando non erano in combutta con i predatori.

Genova - Magistrato per il riscatto degli schiavi
Tutti i paesi sudditi si rivolgevano pungolando l’intervento della matrigna Repubblica di Genova, ma trovarono sempre orecchio da marcante, sino a quando non decise di dar vita, vista l’enorme disorganizzazione dovuta anche alla miseria dominante sulle riviere e per evitare sollevazioni, alla nomina del <Magistrato per il riscatto degli schiavi> (1597). Ma anche lui senza denari poteva far poco e allora si cercò, diciamolo subito <vanamente>, di ricavare le somme ricorrendo ad istituire delle “bussole” per raccogliere le offerte, o devolvere le entrate delle concessioni da parte dei Pontefici di “indulgenze” estese all’intero Dominio della Repubblica a chi avesse donato per il riscatto.


In fine si decise di raggruppare tutti i denari sino ad allora amministrati da molte Opere Pie, Confraternite (oggi ne abbiamo testimonianza nella antiche Casacce) e di Misericordia, incaricate allo scopo per tentare di ragranellare qualcosa. Falliti anche questi tentativi, solo allora, i rapiti venivano inviati ai mercati degli schiavi del Nord Africa dove venivano pagati, data la massiccia presenza, assai meno del richiesto riscatto in loco. Altra cosa che và precisata per sfogliare il “carciofo” della leggenda: questi delinquenti non erano ne lussuriosi ne anticristiani per il fatto che non rispettassero l’immunità dei luoghi sacri, convenzione che invece veniva osservata all’epoca da tutti gli eserciti perché i loro Regnanti non volevano inimicarsi il Papa che era il vero “intermediatore”fra gli Stati. In Chiesa le donne e le giovani (merce di facile vendita) si radunavano pensando di essere protette, portando con se quei pochi valori di famiglia mentre gli uomini, se non fuggiti nelle alture, stavano opponendosi ai pirati. Quindi le Chiese erano i siti più sicuri e facili da espugnare e dove trovare donne in età da lavoro e appetibili, con tutti gli oggetti preziosi della comunità: in un sol colpo si ci impadroniva del meglio di ogni cittadina rivierasca. La miseria, va detto, era tale che neppure le modeste e malandate guarnigioni, ove esistevano, potevano disporre di armi, polvere da sparo e quant’altro. Non parliamo dei cannoni dal costo di acquisto e di gestione proibitivi e che, invece, avrebbero fatto comodo per poter cannoneggiare le navi barbaresche al solo avvistarle all’orizzonte. L’altro modo per evitare le invasioni sarebbe stato che alcune navi armate, battessero la costa così da intercettare e fugare i veloci ma piccoli battelli pirata. Ma anche qui la sola che potesse disporre di simili mezzi era la Serenissima Repubblica di Genova che, se non retribuita, non le inviava.

Molte cittadine si fecero carico, naturalmente a loro spese ma sotto la soprintendenza dei tecnici della Repubblica che in quello “metteva naso”, di costruirsi dei fortilizi sulle cui terrazze alloggiare dei cannoni che avrebbero reso possibile fugare a distanza, le barche barbaresche; ma, una volta costruite le “castella”, non c’erano più fondi per acquistare l’armamento o, quando c’erano, mancava la possibilità di fornirli della polvere da sparo, delle palle in piombo e delle stoppacce per “armarli”. Quindi quei forti servirono più come rifugi inespugnabili per ricoverare la popolazione, che per difesa del territorio. Mentre la popolazione era colà rinchiusa e protetta, i pirati saccheggiavano le case ignorando i fortilizzi. Tutto si svolgeva in poche ore; si iniziava di primo mattino così’ da cogliere nel sonno la maggior parte delle persone, meglio se il mattino dopo di una festa di paese. I tempi veloci erano dettati dalla prudenza di ritirarsi prima che eventuali rinforzi dai borghi vicini, rendessero più rischiose le scorribande. La storia ci dice che questi “aiuti” non avvenissero mai o, al più, tardivi ma, all’epoca, i barbareschi non lo sapevano.
Come si vede in molti non avevano interessi a che cessasse questa situazione perché se ben organizzata e seguendo indirizzi precisi noti a tutti permetteva a molti dei locali di speculare pure su questa situazione inumana, arricchendosi.
Alla prossima puntata vedremo come vivevano i rapiti non riscattati..
Renzo BAGNASCO
Foto del webmaster Carlo GATTI
Rapallo, 12 Giugno 2015
COME E COSA SI MANGIAVA NEL MEDIOEVO
COME E COSA SI MANGIAVA NEL MEDIOEVO
Conoscendo e avendo visto gli Amici del Gruppo Storico Rapallo 1608, mi sono nuovamente appassionato al Medioevo. Tutti sappiamo esserci stato, ma la sua conoscenza non l’abbiamo più approfondita una volta finita la scuola, al di là delle Crociate.
Questo “periodo” lo si fa iniziare nel 472 d.C., V secolo, con la caduta dell’Impero Romano di Occidente, e si può considerare finito nel 1492, XV secolo, con la cacciata degli Arabi da Granada, ultimo loro baluardo in Europa, la contemporanea scoperta dell’America e la successiva Riforma Protestante, iniziata da Martin Lutero che prese spunto, fra l’altro, dalle vendite delle indulgenze per far soldi e poter completare la Basilica di San Pietro, rivelatasi più costosa del preventivato.
Ma, dal punto di vista culinario, è stata, una prosecuzione della gastronomia della Roma imperiale? No: è il frutto di un coacervo di cucine arrivate da tutta Europa che si sono incontrate, assorbendo anche quella Araba, molto presente quando l’Islam era ancora alcune spanne più avanti di noi. Da allora ben poco è cambiato, se si accettano le evoluzioni.

Esposizione di spezie dolci in un Bazar mediorientale

Spezie mediorientali
La prima cosa che mi ha colpito è l’uso delle spezie, quelle dolci però, e della frutta secca. Avendo studiato un po’ l’alimentazione sui velieri antichi si accetta che in mare si usassero le spezie “forti”, per mascherare il gusto del deteriorarsi dei cibi, difficilmente conservabili. Nel Medioevo invece erano una scelta di gusto e una ostentazione di ricchezza. Anche queste spezie amabili arrivavano dall’Oriente ed erano perciò costose. I cuochi, per non affievolirne il tenue sapore, ve le univano alla fine, poco prima di servire; se cotte avrebbero perso il loro delicato aroma. Il problema della conservazione dei cibi a terra non si poneva, perché coglievano solo il necessario da ciò che coltivavano vicino ai villaggi (oggi diremmo a chilometro zero), limitandosi a macellare quello che sapevano poter consumare a breve. Il latte invece, poco usato in cucina perché impossibile a conservarsi per più di un giorno, diventava formaggio e poco veniva usato come legante di intingoli. Una presenza che invece nella loro cucina abbondava, era il grasso animale usato come condimento: poco l’olio perché non presente dappertutto mentre i suini, allevati in casa e macellati, si conservavano a lungo se salati. Il burro era conosciuto e le uova usate soprattutto come coagulante. Diciamo che era un’epoca nella quale, bene o male, mangiavano tutti.
I contadini perché avevano le verdure e gli animali da cortile ma non la selvaggina, di proprietà esclusiva del Principe, ed i ricchi e i Monsignori, perché alimentati con i generi che arrivavano dai loro contadi. I poveri parroci di campagna, come i contadini, si dovevano accontentare di quello che coltivavano attorno alla canonica. Durante i “digiuni”, i primi disponevano di pesce, la “carne della Quaresima”, questi ultimi invece di sola verdura: così andava già il mondo. La classe operaia, intesa come la intendiamo ora, non esisteva. O si era contadini, o si lavorava al servizio del Signorotto, oppure si era Prelati.

Non a caso le Chiese le troviamo sempre collocate in tutti i Borghi Antichi,fra il paesino sottostante e l’entrata al Maniero;

con questo lungi dal pensare che fungessero da “stampella” al Signorotto ma, per conservare quella protetta posizione il Parroco, che “istituzionalmente” sapeva tutto di tutti, come poteva, dal pulpito, stigmatizzare le malefatte del Principe ? Quei pochi che lo fecero vennero bruciati vivi. Non a caso la Provvidenza mandò San Francesco a < sostenere la Chiesa che stava crollando>,, convincendo un riottoso Papa Innocenzo III ad ascoltarlo ed ufficializzarne l’Ordine.

Peasant wedding / peasant Bruegel c.1586; Kunsthistorisches Museum, Vienna
Ma veniamo al tema. Le tavole da pranzo non erano, come adesso, costruite allo scopo. Se da un Antiquario trovate un tavolo d’epoca, diffidate: è fasullo. Solo nelle case umili li usavano per confezionare il cibo, nutrirsene e lavorarci sopra. Nella borghesia e nella nobiltà, che altri non erano coloro che con le loro malefatte si erano arricchiti e riconosciuti “degni” dal Signorotto o dal Principe cointeressato, venivano allestite di volta in volta adagiando delle tavole su cavalletti, poi ricoperte dalle tovaglie. Ogni commensale poteva disporre di: bicchiere col piede ( calice), piatto, stecco in legno appuntito a mò di forchetta ( quella non esisteva ancora e, quando iniziarono ad usarla, fu avversata pure dalla Chiesa perché richiamava il forcone del Demonio) un coltello o stiletto personale, bicchiere e un cucchiaio, solo però se il menù prevedeva <brodetti> (zuppe o minestre). Il resto lo si portava alla bocca con le mani. Il cibo veniva disposto in vassoi posati al centro fra due commensali e ognuno se ne serviva. Il Principe veniva servito dagli infiniti domestici che provvedevano a tutto, compreso disossare le carni e mescere vino. A fine pasto, pressoché tutti si pulivano le mani strofinandole sulle tovaglie, se non troppo belle e linde, altrimenti sui propri panciotti o sui fianchi. La bacinella con acqua profumata era un privilegio riservata a pochi. Molti i caci e i formaggi, parmigiano compreso. Erano presenti vari tipi di ravioli, cotti in brodo di cappone e conditi con spezie dolci e grana, quest’ultimo già noto fin dai tempi della cucina Imperiale Romana. A questo proposito merita ricordare quanto scritto nel Decamerone (1349-53 ) , VIII giornata, 3^ novella, là dove narra del Paese di Bengodi e vi descrive una montagna di parmigiano grattugiato, lungo le cui pendici vengono fatti cadere dei ravioli che, rotolando, si insaporiscono con il solo grana. Ancor oggi se volete sapere se un raviolo merita o no, conditelo unicamente con il formaggio; i sughi ne camuffano le eventuali carenze o li castigano, se buoni.
La carne o era di porco o di ovino o di vitello, perché i buoi erano immangiabili, essendo considerati solo animali da lavoro e quindi dalle carni dure.
Certa frutta era cara perché, nelle zone non vocate, bisognava approvigionarsene, mentre il pesce era, laddove si confinava con l’acqua, facilmente reperibile ma altrove difficile consegnarlo fresco: da lì la conservazione sotto sale. In genere tutti mangiavano a sufficienza, tranne che nelle grandi carestie dovute o alle guerre dove gli eserciti, che si muovevano senza scorte, razziavano tutto per sopravvivere, o alle catastrofi atmosferiche. Lì veramente i contadini soffrivano la fame, obbligati a mangiare di tutto, mentre i Signori attingevano alle scorte. La farina era prodotta macinando tutti i tipi di cereali, ghiande comprese: và da se che quella bianca al Principe e ai suoi cortigiani non mancava mai; le altre, diversificate, mano a mano che si scendeva la scala sociale. Il vino, anche se non alterato dal miele come quello romano, se lo assaggiassimo oggi, non credo lo gradiremmo, mentre l’attuale birra è simile a quella.
In genere, lo abbiamo visto, i cibi non erano piccanti, perché insaporiti con solo spezie aromatiche mentre invece erano “colorati”, perché si badava molto alla cromia dei manicaretti appositamente tinti per ottenere armoniosi effetti; molto usato lo zafferano che, con il suo giallo, richiama l’oro, l’antico mangiare degli Dei, le rape rosse, gli spinaci e lo zenzero (Decamerone,VIII giornata, 6^ novella) anche per il suo valore medicamentoso. La cipolla era molto presente, specie affettata e fritta, così come l’aglio, pur esso anche per i suoi innegabili poteri terapeutici.
Questa massima riportata da F. Sacchetti <Trecento novelle>(1332-1400), fa chiarezza sulle introvabili donne–cuoco: <<Sia buona che cattiva il bastone ci vuole per ogni donna>>. Quanta dura strada ha dovuto conquistarsi “l’altra metà del cielo”, per arrivare ad oggi !
In ultimo va detto che è difficile localizzare un cibo comune a tutta l’Europa, visto che quella civilizzata era organizzata in paesotti, anzi in Castelli con intorno il borgo e utilizzavano principalmente prodotti locali. Gli “Staterelli” prenderanno corpo poco dopo. L’Italia, grazie alla Savoia, comunicava con la Francia, tanto che le due cucine erano e sono rimaste intercambiabili. Quando Caterina de Medici andò a Parigi sposa del Re di Francia, portò con se i propri cuochi fiorentini che si confrontarono con gli autoctoni influenzandosi a vicenda ma, soprattutto, innovando i menù francesi.
Renzo BAGNASCO
Foto del webmaster Carlo GATTI
Rapallo, 12 giugno 2015
VIAGGIO DAL MERIDIANO DEL FERRO A QUELLO DI GREENWICH
VIAGGIO DAL MERIDIANO DEL FERRO A QUELLO DI GREENWICH

Vista satellitare dell’Isola del Ferro

Isola del Ferro, in spagnolo: El Hierro, detta anche Isla del Meridiano, è un'isola spagnola. Si trova nell'Oceano Atlantico, nelle Isole Canarie di cui é la più piccola e la più a ponente dell'arcipelago
Per gli antichi naviganti il meridiano di riferimento era il Nilo al centro del mondo conosciuto d’allora, tuttavia, il PRIMO MERIDIANO CONVENZIONALE per il calcolo della longitudine ha continuato a spostarsi sul mappamondo con le progressive esplorazioni geografiche.
Possiamo sintetizzare la successione geografica in questo modo:
- A ovest delle Colonne d’Ercole fu posto il meridiano, in seguito arretrato alle Canarie (Isole fortunate).
- Copernico lo stabilì a Freudenburgo (Renania-Palatinato)
- Keplero a Uraniburgo (Uraniborg – Osservatorio astronomico gestito dall’astronomo danese Tycho Brahe).
- Mercatore, inizialmente lo stabilì all’isola di Forte Ventura (Canarie), successivamente all’ISOLA DEL FERRO.
- Nel secolo successivo, G.B. Riccioli lo fissò nell’isola di Palma.


Nel 1724, durante un viaggio di studio, fu stabilita l’esatta posizione del meridiano. In molte carte geografiche del 1600 e 1700, il meridiano di ORCHILLA appare come Meridiano 0. Il faro rappresentato in questa immagine, fu costruito sopra la LINEA DEL MERIDIANO 0.
Per mettere un punto fermo che togliesse ogni confusione, ci provò Luigi XIII, con un decreto del 1° luglio 1634 e fissò IL PRIMO MERIDIANO all’Isola del Ferro (Canarie), uno tra più diffusi. Come abbiamo visto nella didascalia, tale meridiano prendeva il nome dall'isola del Ferro (El Hierro), la più occidentale dellIsole Canarie e allo stesso tempo la parte più estrema del Vecchio Mondo.
Si deve sottolineare un particolare importante: il famoso geografo greco Tolomeo definì già nel II Secolo d.C. il meridiano dell'Isola del Ferro come Meridiano Zero. La scelta adottata fu molto fortunata in quanto favorì i calcoli astronomici della cartografia europea dovendosi calcolare soltanto longitudini positive (ad est dell'Isola di El Hierro ).
Verso la metà del Settecento, le nazioni marinare più prestigiose ritornarono a meridiani di riferimento sulla base d’interessi economici ed anche nazionalistici:
- Gli Inglesi a Londra
- I Francesi a Parigi
- Gli Olandesi sul Picco della Tenerifa – considerato il monte più alto del mondo
- Gli Spagnoli alle Azzorre.
Verso la metà dell’Ottocento, L’Inghilterra ed i Paesi sotto la sua influenza, adottarono GREENWICH, mentre gli Stati Uniti e l’Italia preunitaria scelsero Parigi. Finalmente, nel 1881, nel 3° Congresso Geografico Internazionale fu proposto di adottare il MERIDIANO E IL TEMPO MEDIO DI GREENWICH. Il “tempo” non era ancora maturo... Prestigio culturale, Potenze marittime, Spinte azionalistiche ecc... ritardarono l’approvazione ormai nell’aria.
La penultima fase di avvicinamento al traguardo passò per Roma, dove fu organizzata nel 1883 la Conferenza Geodetica Internazionale. E ci fu ancora una spaccatura:
Stati Uniti decidevano di adottare il meridiano del Ferro e la Germania optava per quello dell'Europa centrale, a 15°E da Greenwich, nel 1893 accolto anche dall'Italia.

Osservatorio di Greenwich
Si dovette attendere il Congresso Geografico Internazionale di Washington del 13 ottobre 1884 per stabilire definitivamente quale dovesse essere questo meridiano. In quell'occasione venne definito da 41 delegati provenienti da 25 paesi, alla presenza del Presidente degli Stati Uniti d'America, il meridiano zero, ossia quello che passa per l’Osservatorio di Greenwich.

Meridiano di Greenwich

Meridiano di Greenwich (angolatura per Meridiano)
Qui furono stabiliti i seguenti principi:
1. L'adozione di un unico sistema di meridiani a livello mondiale, in sostituzione dei diversi esistenti.
2. Il meridiano passante attraverso il più importante strumento di controllo del traffico dell'Osservatorio di Greenwich sarebbe stato il primo meridiano.
3. Tutte le longitudini, sia a est sia a ovest sarebbero state calcolate a partire da questo meridiano da 0° a 180°.
4. Tutti i paesi avrebbero adottato la data universale.
5. Il giorno universale sarebbe cominciato alla mezzanotte di Greenwich e misurato su un orologio di 24 ore.
6. I giorni nautici e astronomici sarebbero cominciati ovunque alla mezzanotte convenzionale (di cui sopra).
Sarebbero stati supportati tutti gli studi tecnici finalizzati a regolamentare ed estendere l'applicazione del sistema decimale alla divisione del tempo e dello spazio.
Il 23 febbraio 2007 nei Giardini vaticani fu inaugurata la targa indicante il tracciato del Primo Meridiano d’Italia.
Carlo GATTI
Rapallo, 12 Giugno 2015
MILETO, UN GRANDE COMPLESSO PORTUALE DELL'ANTICHITA'
MILETO
UN GRANDE COMPLESSO PORTUALE DELL’ANTICHITA’

Mileto nell’attuale Turchia

Mileto nei primi secoli a.C. si trovava al termine di un’importante via carovaniera (vedi linea rossa) che collegava la Mesopotamia alle coste del Mar Egeo e alle sue isole.

Baia di Mileto- Evoluzione dei fondali nei secoli. Nella cartina si nota l’ampia vallata del fiume Meandro circondata dai rilievi ferrosi Mycale, Latmos e Grion.

A partire dall'epoca arcaica Mileto fu la principale città della Ionia: punto focale dell’economia, della politica e del pensiero filosofico del mondo occidentale d’allora.
Mileto (Miletos in greco e Miletus in latino) per la sua posizione geografica fu soprattutto un importante polo portuale, su un promontorio alla foce del fiume Meandro che portava le sue acque nel Mare Egeo. Quello che fu un golfo oggi é interrato dai sedimenti portati a valle dal fiume che vi sfocia. Mileto fu fondata da coloni greci fra il 1077 e il 1044 a. C. in una regione allora chiamata Caria. Questa città-stato continuò ad avere un ruolo di primo piano sia durante l’epoca ellenistica che durante il periodo dell’Impero Romano. I coloni greci furono attirati dalla penisola che offriva insenature, altrettanti ridossi, quindi approdi sicuri per le navi. Vi era inoltre una certa varietà di rocce adatte per realizzare edifici e mura; vi era acqua in abbondanza e, dulcis in fundo, l’intera regione era circondata da notevoli quantità di minerali di ferro. I minerali metalliferi furono cercati e sfruttati in un raggio d’azione sempre più ampio, non solo lungo le coste della Ionia (sponde asiatiche del Mare Egeo, ossia le coste nord-orientali della attuale Anatolia) ma anche nel Ponto Eusino (Mar Nero), e ciò spinse i Milesiani a fondare colonie con lo scopo commerciale, ma anche per reperire minerali.
L’insediamento urbano, molto probabilmente, fu stimolato proprio dalla presenza di minerali ferrosi del Monte Mykale (oggi Samsun Dag), del Latmos e del Gurion, ma anche dalla metallurgia del rame, del bronzo e del piombo, con cui venivano realizzate armi e utensili, per il mercato interno e per l’esportazione.
Ad arricchire il già fiorente quadro economico, occorre aggiungere anche il carbon fossile che si trovava nel raggio d’azione dei cittadini di Mileto.
La stessa valle del Meandro costituiva una facile via di penetrazione commerciale verso l’entroterra. I fondatori-commercianti furono pertanto attirati, sia dalla facilità di accesso dal mare, sia da un percorso carovaniero parallelo al fiume per raggiungere i clienti all’interno. Il territorio della città, e in particolare la pianura alluvionale del suo fiume, era esteso e fertile perciò fu anche sede di una redditizia attività agricola, in particolare il grano, che veniva esportato in Grecia. Per concludere, le montagne vicine erano coperte da foreste, il cui legname veniva utilizzato per l’industria navale.

Carta dei processi di sedimentazione del Fiume Meandro nei secoli. I porti di Mileto erano riparati dall’isola di Lade (a sinistra in alto). Si noti il notevole avanzamento della ”linea di riva” fra l’età classica e i tempi attuali, dovuto ai depositi alluvionali del Meandro. Mileto si trovava sul mare mentre oggi si trova a circa 9 km. diventando una città dell’entroterra durante la prima età cristiana.
L’area intorno a Mileto aveva quindi tutte le caratteristiche per essere un polo d’attrazione per moltissime attività commerciali ed economiche e quindi per un insediamento urbanistico di prima grandezza. La sua espansione durò circa un millennio e terminò a causa dell'insabbiamento dei suoi porti, che penalizzò i suoi traffici marittimi. Le attuali rovine di Mileto si trovano 9 chilometri lontani dalla costa.
La causa principale del suo insabbiamento pare sia stato lo sfruttamento intensivo delle foreste con i conseguenti smottamenti e processi erosivi, che le piogge scaricavano a fondo valle sedimentando nella foce del Meandro. Ma ora ritorniamo a quel grande millennio che rese famoso Mileto.
Mileto. Un complesso portuale di primo ordine
Come abbiamo già analizzato, la posizione privilegiata e le cospicue esportazioni di prodotti locali (tessuti, ceramiche, grano, utensili di metallo e armi, ecc.) determinarono il potenziamento del commercio marittimo di MILETO che indusse i Milesiani ad ampliare il numero degli approdi, per cui dal più antico porto, quello di Atena, che era diventato troppo piccolo, si passò al grande porto del Leone. Ambedue erano esposti ad ovest, ma fu utilizzato anche il porto di Nord-Est (di cui non conosciamo il nome) quasi all’estremità della penisola. In tal modo poteva essere scelto il porto più riparato dalle traversie del mare e del vento. La decadenza socio-economica di MILETO si manifestò definitivamente verso il VI sec. d. C., ma in realtà si trattò di un fenomeno che iniziò qualche secolo prima, innescato, come abbiamo visto, da un processo geologico d’interramento progressivo del delta.
Quasi al centro di Mileto c’è una collina, ai lati della quale sono i due porti principali di Ponente: quello più settentrionale “del Leone”, quello meridionale “del Teatro”. Nell’ampia zona centrale che collegava i due porti, sorgevano gli edifici commerciali, religiosi, amministrativi. Le tre zone residenziali si trovavano: una a nord, l’altra sulla collina tra i porti, la terza, più ampia a sud.

La cartina sopra indica:
- Le due AREE COMMERCIALI (due macchie nere con punti bianchi) alle spalle del Porto dei Leoni (la profonda insenatura, in alto a sinistra) e del
Porto del Teatro (la golfata più ampia, sotto a sinistra)
- L’AREA CIVILE (tratteggiata nel verso orizzontale) unisce le aree commerciali dei due porti.
- AREE RELIGIOSE (trattegiate di traverso). Vicino ai porti ed ai mercati, un poco distaccati da essi vi sono le rovine di due santuari, rispettivamente di Apollo Delphinios (a nord sul porto «del Leone»), di Athena (a sud sul porto del Teatro).
MILETO, CENTRO FINANZIARIO E CULTURALE

Il traffico marittimo, l’alleanza con Atene, la cultura filosofica, la vicinanza con la Lidia (alle spalle), ne fanno la città ideale per la prima coniazione monetaria. Nell’Iliade Mileto è ancora una città della Caria e i suoi abitanti combattono contro gli Achei. Secondo la tradizione, successivamente, durante la cosiddetta prima colonizzazione greca, la città fu rifondata da colonizzatori Ioni provenienti dall’Attica e dalla Beozia, (vedi cartina sopra) che sottrassero il territorio ai Carii. Il governo fu esercitato dall’aristocrazia, che fece diventare Mileto un attivissimo centro di scambio. Furono fondati scali commerciali e colonie destinate a diventare importanti, fra cui Abido sullo stretto dei Dardanelli, Cizico sulla costa asiatica del mar di Marmara, Sinope e Histria sul Mar Nero, Naucrati sul delta del Nilo. La politica di Mileto in quel periodo fu ispirata a mantenere buoni rapporti con le grandi potenze mediterranee che avrebbero potuto danneggiare la sua espansione economica.
Particolarmente stretti furono i rapporti con l’Egitto, che Mileto appoggiò contro gli Assiri. Attorno al VII secolo a.C. dodici città della Ionia, tra cui Mileto (la cosiddetta Dodecapoli ionia) si unirono a formare la Lega Ionia, per meglio resistere all’espansionismo dell’Impero Persiano. In quegli anni Mileto era divenuta il centro intellettuale della Ionia: Talete, Anassimandro ed Ecateo le attribuirono, nella storia della cultura occidentale, la prestigiosa condizione di culla della filosofia, delle scienze naturali, degli studi geografici e storiografici. L’alfabeto in uso nella città si estese a numerosi altri centri di cultura e, dopo essere stato adottato da Atene nel 403-402 a. C., divenne l’alfabeto comune a tutto il mondo greco. Si calcola che nel VI sec. a. C. la popolazione di Mileto raggiungesse i 60.000 – 70.000 abitanti. Aristagora guidò un’insurrezione contro i Persiani, conclusasi con la sconfitta navale degli Ioni (e dei Milesi) davanti all’isola di Lade (494 a. C.) e con la distruzione della Mileto arcaica, la cui popolazione fu deportata sul Fiume Tigri. La caduta della città fu accolta in tutto il mondo greco come una sciagura nazionale. Ma dopo la vittoria dei Greci sui Persiani a Mykale (479 a. C.), si decise la ricostruzione di Mileto, il cui piano regolatore fu probabilmente concepito dall’innovatore dell’urbanistica antica, Ippodamo, nativo appunto della città. Il cosiddetto “impianto ippodameo” fu seguito da varie nuove colonie greche. Nel 401 la città fu assediata da Ciro il Giovane e tornò a subire completamente l’autorità persiana, dalla quale la liberò Alessandro Magno nel 334 a. C. - Contesa per due secoli fra i sovrani ellenistici, Mileto entrò a far parte nel 133 a.C., come città libera, della provincia romana d’Asia ma perse del tutto la sua indipendenza dopo il 78 a. C. per essere stata favorevole a Mitridate nel corso della guerra contro Roma. Durante l’ellenismo* e nella prima epoca imperiale romana la città ebbe grandissimo sviluppo, documentato dalla costruzione di imponenti edifici pubblici fra cui la Biblioteca di Celso.
* Il termine Ellenico viene usato a partire dal V secolo a.C. ad indicare le genti di lingua e cultura greca rispetto ad altri popoli.
Il termine Ellenistico indica il periodo storico-culturale in cui la cultura greca si diffonde oltre i confini della Grecia e fu coniato nell’Ottocento per indicare il periodo che va dall’epoca di Alessandro Magno alla definitiva conquista romana avvenuta con la battaglia di Azio nel 31 a.C.
I più grandi centri dell’arte ellenistica rimasero al di fuori della Grecia, in particolare Alessandria d’Egitto, Antiochia di Siria, Rodi, Efeso, Pergamo Laodicea ecc...
L’URBANISTICA DI MILETO


PIANTA DI MILETO: La pianta regolare secondo le idee di Ippodamo di Mileto V secolo a.C.
1 – Teatro
2-3 – Leoni di pietra
4 – Agorà del Sud
5 – Stadio
6 – Agorà
7 – Tempio di Atena
8 – Sito Arcaico
9 – Porta Sacra
10 – Via Sacra (congiungeva Mileto al Tempio di Apollo a Didime)
Mileto – Planimetria generale del promontorio di Mileto. Si noti il tessuto urbano costruito all’estremità di un promontorio, e l’impianto ippodameo della città, secondo un rigido schema ortogonale. Nelle varie epoche si succedettero i vari insediamenti: quello settentrionale fu arcaico, quello occidentale fu ellenistico, e quello meridionale fu greco-romano.
Ciò che maggiormente impressiona, nella divisione dei quartieri, è la pianta disegnata a scacchiera. Gli isolati base misurano mt 29,50 X 51,60 e sono variamente suddivisi nel senso della lunghezza. Le strade, i cui assi coincidono con quelli della penisola, sono larghe mt 4,50; si distinguono tre arterie maggiori, larghe mt 7,50 (una in senso longitudinale, due in senso latitudinale), che servono come vie principali. Una di esse, quella longitudinale, portava dal centro della città verso la porta principale sud (Porta Sacra, che non è perfettamente sull'asse di essa), che immetteva nella via diretta al Tempio di Apollo (extraurbano) di Didyma.
Il sistema costruttivo della città è il risultato dell'adattamento ad uno schema perseguito sin dalla fondazione Mileto e che durò sino alla fine dell'Ellenismo (31 a.C.).
I PORTI DI MILETO

I resti di uno dei due Leoni all’ingresso del Porto
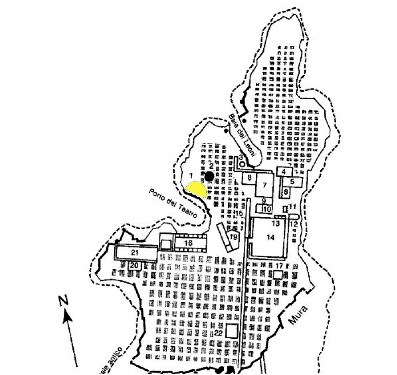
La nuova citta’ ebbe, secondo il progetto di Ippodamo di Mileto, pianta circolare e robuste mura di cinta. Il sistema adottato prevedeva vie parallele che intersecandosi perpendicolarmente creavano una maglia rettangolare adornata da templi, ginnasi, teatri ed altri splendenti edifici. Una cinta, considerata tra le migliori opere difensive dell’epoca, proteggeva la citta’ da ogni incursione nemica. Almeno cinque porti accoglievano nelle loro insenature le navi provenienti da tutto il mondo, riempiendo la citta’ di mercanzie e di ricchezze. L’antica rete urbana della scuola di Ippodamo e’ visibile ancor oggi nell’attuale topografia della citta’, e si estende sia dentro che fuori le mura medioevali della Citta’ dei Cavalieri (1480 d.C.).
Partendo da sinistra: In corrispondenza della freccia indicante il Nord si nota l’ansa del
1) - Porto di Atena; 2) Porto del teatro; 3) Porto dei Leoni; 4) Porto del Nord Est (collina di Kalabak).
–La principale caratteristica del porto di Mileto era la seguente: le navi in arrivo potevano scegliere la baia più ridossata o comunque più idonea dal punto di vista meteo-marinaresco, consentendo alla città portuale di essere operativa tutto l’anno con qualsiasi tipo e forza di vento.
Strabone dice che Mileto aveva quattro porti, ma solo dei tre più importanti si conosce il nome e la posizione esatta.
Il Porto dei Leoni si trovava nell'insenatura più profonda e sicura fra Humeitepe e Kalehtepe.
Il porto del Teatro in quella fra Kalehtepe e la platea dell'Athenaion, che è più ampia ma anche più aperta.
Gli altri due porti probabilmente vanno situati l'uno nell'insenatura a S-O dell'Athenaion lungo cui si estendeva la città arcaica, l'altro nell’insenatura E, accanto all'Agorà Stoà e al centro della città.
La grande cerchia di mura, su cui tacciono completamente le fonti antiche, fu costruita probabilmente alla fine del V sec. a. C. in relazione agli agitati avvenimenti che riportarono Mileto sotto il dominio persiano.
Pare che le mura, scavate però solo in minima parte, seguissero in origine tutto il contorno della penisoletta, includendo anche Kalabaktepe. Le porte principali erano solamente due: la Porta Sacra, da cui usciva la via omonima che portava a Didyma, e la Porta del Leone a S-E, non molto distante dall'agorà S, da cui usciva una strada costiera. Agli inizi del II sec. a. C. il settore S-O della cerchia, compresa Kalabaktepe, fu abbandonata: un nuovo tratto di mura andava dritto dalla Porta Sacra al mare.

Un addio nel porto di Mileto....

Plastico di Mileto - 200 d.C. Museo di Pergamo

Plastico di Mileto - 200 a.C. – Museo di Pergamo
Il porto principale di Mileto (porto dei Leoni), era fronteggiato da una piazza su cui si ergeva il santuario del dio patrono della città. Apollo Delphinios. Il grande recinto porticato (iniziato verso il 470 - 450 a. C.) fungeva anche da archivio di stato, conteneva numerose iscrizioni, rilievi votivi e statue onorarie. Dalla piazza del porto iniziava la grande strada che conduceva al santuario di Apollo a Didima. Presso di essa si trovavano le piazze principali di Mileto, in mezzo a un complesso di edifici pubblici e privati: il vero e proprio centro della città era la piazza in cui sorgeva il Buleuterio (175-164 a. C.), contenente all'interno una gradinata semicircolare capace di ospitare ca. 1200 persone. Dalla piazza del Buleuterio si passava alla vastissima Agorà Stoà, attraverso una porta monumentale, di età antonina, i cui elementi sono stati pressoché interamente trasportati e ricomposti nel museo di Pergamo a Berlino.

MILETO - Il monumento del porto, commemorativo della vittoria di Ottaviano ad Azio nel 31 a.C. Sull’insenatura del porto dei leoni si apriva l’Agorà Sud, prossima al santuario di Apollo Delphìnios, costituito da un cortile costruito intorno all’altare; in questo edificio si custodiva l’archivio della città.

Le rovine del vecchio porto di Mileto
La nuova aristocrazia giunta al potere fece di Mileto una pòlis “moderna”, dove l’ascesa sociale era possibile non solo ai “valorosi” in senso omerico, ma anche a coloro che si rivelavano abili nel “maneggiare denaro”, quindi nel commercio, nell’industria, importazione di materie prime ed esportazione di prodotti finiti.

Asia Greca. Ionia, Mileto. Diobolo, ca. 478-390 a.C.
Protome di leone con la testa volta a destra con le fauci aperte.
Due innovazioni si rivelarono decisive: l’introduzione della moneta di elettro, (una lega metallica di oro e argento) che, oltre a facilitare, “laicizzò” gli scambi commerciali tra i vari popoli svincolandoli da rituali e credenze religiose. Il diffondersi dell’alfabeto greco d’origine fenicia diede corso alla cosiddetta “numerazione ionica” i numeri corrispondono alle lettere dell’alfabeto greco (alfa = 1; beta = 2; gamma = 3.
EVOLUZIONE DELLE SCIENZE NAUTICHE
I naviganti del Terzo Millennio sanno quanto possono essere insidiosi i venti e i mari dell’Egeo e che percorrere in sicurezza le rotte marittime tra i vari empori commerciali richiede una conoscenza approfondita di tutti gli elementi meteo-marini di tutte le zone, compreso i fondali, le secche, le scogliere e i ridossi, durante la navigazione costiera. Ma quando il capitano marittimo dell’antichità era costretto a lasciare la costa che ben conosceva, e metteva la prua verso il mare aperto, dopo aver rivolto una preghiera ad Eolo e Poseidone “Eliconio” (a cui era dedicato il santuario pan-ionio del monte Micale, di fronte al porto di Mileto), le competenze meteorologiche e geografiche non bastavano più. Per “orientarsi” (ovvero fare vela verso “oriente”, là dove sorge il sole) occorreva “masticare” nozioni d’astronomia complesse, derivanti dall’osservazione e dallo studio dei cieli che Caldei, Babilonesi, Egiziani, andavano conducendo da secoli. Quando sopraggiungeva la notte (i viaggi potevano durare anche settimane), i naviganti si lasciavano guidare dalla posizione dalla Stella Polare. Geografia, meteorologia, astronomia, ma anche trigonometria per calcolare, ad esempio, la distanza di una nave dalla costa, sono tutte scienze “positive”, di immediata applicazione pratica, che richiedono tuttavia abilità e precisione nell’osservazione del cielo stellato, dei fenomeni naturali e del calcolo matematico.

Mileto – La zona dell’antico porto

L’Agorà – Gli scavi hanno riportato alla luce i resti pre-persiani (sec.VII a.C.) degli edifici, e inoltre un cospicuo numero di statue virili sedute disposte lungo la Via Sacra risalenti al sec.VI a.C.
L’Agorà (Stoà) di Mileto – Ingresso del tempio greco

La stoà ("eretto") è una struttura tipica dell'Archittetura greca antica, costituita da passaggi coperti o portici per uso pubblico in un edificio di forma rettangolare allungata che presenta uno dei lati lunghi aperto e colonnato, generalmente prospiciente una piazza o una via, mentre l'altro è chiuso da un muro; la copertura può essere a spioventi, a terrazze oppure l'edificio può sopraelevarsi ripetendo lo schema del piano inferiore.

L'Agorà S (foto sopra) era fiancheggiata da grandi porticati. Presso il porto più interno sorgeva un grande complesso termale, donato da Faustina (probabilmente la moglie di Marco Aurelio), che conteneva numerose e preziose opere d'arte; il Teatro, uno dei più grandi dell'Asia Minore (140 m di diametro), iniziato alla fine del secolo IV a. C.; e lo Stadio, rettangolare, lungo 194,5 m, capace di ospitare sulle gradinate ca. 14.000 persone. La via processionale che partiva dalla piazza del porto dei Leoni, passava per il sobborgo occidentale di Panormos e raggiungeva dopo ca. 16 km Didima, la sede del tempio di Apollo Pilesios, uno dei più importanti Santuari Oracolari del mondo antico. Gli scavi hanno riportato alla luce i resti pre-persiani (sec. VII a. C.) degli edifici, e inoltre un cospicuo numero di statue virili sedute, disposte lungo la via sacra, risalenti al sec. VI a. C. L'edificio del tempio, ricostruito integralmente in età ellenistica, era uno dei più imponenti e ammirati dell'antichità: un grandioso tempio ionico diptero, con dieci colonne sui lati brevi e ventuno sui lati lunghi. Fu distrutto da un terremoto verso l'anno 1000.

Mileto - Frontone del Tempio di Serapide
Milesi famosi

• Mileto (mitico fondatore)
• Talete - "primo" filosofo naturale greco; "il padre della scienza".
• Anassimandro - filosofo; allievo di Talete
• Anassimene - filosofo; amico e allievo di Anassimandro
• Leucippo - filosofo; fondatore dell'atomismo e maestro di Democrito
• Eubulide - filosofo; formulò il "paradosso del mentitore"
• Ecateo di mileto - geografo e storico
• Ippodamo di Mileto - architetto e urbanista
• Eschilo Illustrio - cronachista e biografo
• Aristide - scrittore
• Isidoro - architetto
•Timoteo - poeta. Cadmo - storico, forse immaginario

La Porta del mercato di Mileto – E’ un reperto archeologico, Capolavoro dell'architettura romana, attualmente si trova nel Pergamon Museum di Berlino. La porta del mercato è una maestosa facciata costruita intorno al 120 a.C. mettendo insieme l'idea dei propilei a colonnato greco, la porta ad arco e la facciata del teatro romano. Proprio per questa mescolanza di stili la porta è considerata un importante esempio della relazione tra la tradizione costruttiva ellenistica e l'espressione artistica della Roma imperiale.

Il mercato di Mileto-Pergamom Museum, Berlino
Le rovine dell’antica città di Mileto

Resti delle Terme di Faustina (moglie dell'imperatore Marco Aurelio)161-180 d.C. e della Palestra.

Mileto: terme, particolare di statua di leone

Mileto, il teatro, vista d'insieme
Il grande teatro di Mileto visto dalla via del porto. Costruito nel IV sec. a.C. contava 5000 posti nel periodo ellenistico e 25.000 in epoca romana nel II sec. Solo in parte è ricavato nella collina ed un lato appoggia su poderosi muraglioni. La sovrastante rocca bizantina venne edificata anche con materiali asportati dal teatro
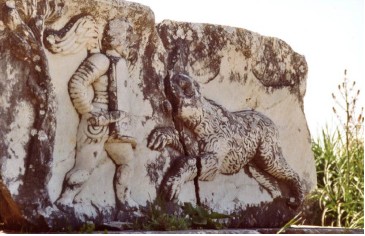
Mileto: Bassorilievo del gladiatore nel teatro

Mileto, la zona dell'antico porto

Procedendo dal teatro verso il porto antico ci s’imbatte nel monumento ancora visibile con le due teste di leone di dimensioni gigantesche. Ciascuno di questi leoni fu posto su ogni lato dell’imboccatura come monito contro eventuali nemici.

Cavea dei gladiatori. La cavea del teatro, ancora oggi ben conservato, poteva contenere 25.000 spettatori.
LA MILETO CRISTIANA - San Paolo si fermò a Mileto nel suo terzo viaggio missionario, sulla via di ritorno a Gerusalemme.
L’apostolo Paolo giunse a Mileto verso il 56. Poiché voleva essere a Gerusalemme per la Pentecoste e non desiderava rimanere più del necessario in Asia Minore. Paolo, che si trovava a quanto pare ad Asso, decise di prendere un battello che non si fermava a Efeso. Tuttavia non trascurò i bisogni di questa congregazione. Da Mileto, senza dubbio per mezzo di un messaggero, mandò a chiamare gli anziani della congregazione di Efeso, distante quasi 50 km. Il tempo necessario perché giungesse loro il messaggio ed essi venissero a Mileto (almeno tre giorni) era evidentemente meno di quello che avrebbe impiegato Paolo se fosse andato a Efeso. Questo forse perché le navi provenienti da Asso che toccavano il porto di Efeso facevano più fermate di quelle che si fermavano a Mileto. Oppure perché le circostanze avrebbero richiesto che Paolo si trattenesse di più se si fosse recato a Efeso.
Parlando agli anziani della congregazione di Efeso, Paolo ricordò il ministero che aveva svolto fra loro, li esortò a prestare attenzione a se stessi e al gregge, li avvertì del pericolo che “oppressivi lupi” si insinuassero nella congregazione e li incoraggiò a restare svegli e a rammentare il suo esempio. Sentendosi dire che non l’avrebbero più visto, quegli anziani piansero “e gettatisi al collo di Paolo, lo baciarono teneramente”; poi lo accompagnarono alla nave.
In un’epoca imprecisata, dopo la sua prima detenzione a Roma, sembra che Paolo sia tornato a Mileto. Trofimo, che in precedenza l’aveva accompagnato da Mileto a Gerusalemme, si ammalò e Paolo dovette lasciarlo.
CARLO GATTI
Rapallo, 11 Giugno 2015
SPRECARE UN SILURO PER UN VELIERO
Sprecare un siluro per un veliero
La notte del primo luglio 1915, il Capitano Nardo Bianchi osservava sereno
l’ultima parte dell’agile navigazione del suo Sardomene (pron. Sardomìn), veliero armato dagli imprenditori camogliesi Mortola e Bozzo.

Entrata della Chiesa di S.Rocco (Camogli): sul pavimento di marmo, uno splendido brigantino classico (brig), dono dell’Armatore Giuseppe Mortola nel 1896 (foto B. Malatesta)
I pensieri del Comandante
Con quella splendida nave a vela, considerata un veloce “clipper“, era partito il 21 febbraio da Bunbury in Australia, con destinazione Liverpool. Portava con sé un carico di legno pesante, il “jarrah”. Quel materiale era usato nel Regno Unito soprattutto all’esterno: travertini, cancelli, recinzioni, pavimentazioni varie, eccetera. Aveva il pregio di indurirsi fortemente una volta maturato, fino al punto di non poter essere trattato da nessun utensile dei falegnami. Bianchi, un trevigiano trentacinquenne, pensava a quanto successo due mesi prima in quelle acque. Il transatlantico Lusitania era stato silurato da un U-Boot tedesco e s’era portato dietro milletrecento persone.

Il Lusitania, colpito a morte, affonda; è il 7 maggio 1915
L’Italia a quel tempo era già in guerra con l’Impero Austro-Ungarico, ma non esisteva di fatto una formale dichiarazione di ostilità tra il nostro Paese e la Germania, alleata dell’Austria. E’ possibile che il Capitano non ritenesse il Sardomene un obiettivo strategico, anche se poche ore prima, una cannoniera inglese l’aveva avvertito della presenza di U-Boot in quelle acque. La stampa alleata di quell’epoca definiva “pirateria tedesca” certe aggressioni alle navi mercantili e il governo aveva assegnato perciò alle inermi unità alcune navi scorta in quell’area. Il vociare multilingue dell’equipaggio lo distolse da quei cupi pensieri.

Gli armatori camogliesi del Sardomene: a sn. Giuseppe Mortola (Sanrocchìn) e a ds. Vittorio Bozzo (Torrixân)
Quegli armatori camogliesi avevano costruito un’azienda grande e florida, che riuscì in seguito a traghettare abilmente il business dei traffici a vela ottocenteschi verso i più moderni piroscafi. Bianchi rifletteva anche sulla stranezza che quella nave non ospitasse nessun membro d’equipaggio proveniente dalla “Città dei Mille Bianchi Velieri”. Ciò era spiegato dalla sua lunga permanenza all’estero: infatti, oltre agli italiani, a bordo lavoravano russi, svedesi, spagnoli e scozzesi.
Il disastro
Ad un tratto, una forte esplosione sconquassa il veliero camogliese. L’equipaggio è in preda al panico, le sovrastrutture e lo scafo cedono, la nave – appesantita dal carico di legno duro – collassa e affonda in pochi minuti. Undici dei ventidue membri d’equipaggio – incluso il Capitano – periscono nella tragedia (fonte: Alfredo Noris, sopravvissuto). I naufraghi vengono salvati dalla nave scorta inglese, ma per gli altri non c’è niente da fare. Il colpo fatale era stato sferrato da un sommergibile tedesco, l’U-Boot U24, comandato dal Capitano Rudolf Schneider.

Un sommergibile della stessa classe dell’U-Boot U24, che lanciò il siluro verso il "Sardomene" (1 luglio 1915)
Sicuramente, mentre affondava, Bianchi si chiedeva perché non venne dato nessun preavviso dell’attacco e perché una nazione formalmente non ostile avesse attaccato un’unità italiana, “sprecando” così un siluro per un innocuo veliero. Va qui ricordato che solo un mese dopo, sarà accordato tra i belligeranti di preavvertire le unità mercantili prima di colpirle.
Il racconto di un superstite
Tra gli italiani sopravvissuti c’era il genovese Alfredo Noris – Primo Ufficiale - che raccontò quegli orribili attimi: “Era circa l'una di notte quando avvistai un periscopio a circa trecento metri a sinistra della prua: l'impressione che tutti ne avemmo fu che il sommergibile si allontanasse dal nostro veliero, che evidentemente non formava un bersaglio che ripagasse la spesa del siluro. Ma fu probabilmente la bandiera italiana che lo invogliò a farci la festa. Fatto è che all'improvviso il sommergibile si voltò, lanciando un siluro verso di noi. Non era neppure il caso di evitarlo: il veliero era impotente a manovrare e poi la distanza era cosi breve che si può dire che avemmo appena il tempo di vedere in acqua il siluro che già ci colpiva giusto al centro. La scossa sembrò sollevare la nostra nave fuori dall'acqua. L'esplosione fu terribile: abbatté di colpo gli alberi, le vele, le sartie, spogliò per cosi dire il veliero, facendolo inclinare fortemente a sinistra. Per l'urto, due marinai stranieri furono sbalzati in acqua dal castello di prua: uno affogò e l'altro fu salvato. Il nostromo, l'irlandese O’Neill, che si trovava al castello di prora, si diresse verso la scialuppa di dritta.

Passando per il ponte, vide due marinai, Francesco Orteghe e un altro, gravemente feriti; capimmo allora che non ci sarebbe stato il tempo di lanciare le scialuppe. Venne dato l'ordine di afferrarsi ai salvagente e di gettarsi in acqua, che ognuno provvedesse a sé stesso e Dio per tutti. Fu allora che vidi per l'ultima volta il Comandante. Il Capitano Bianchi forse non voleva lasciare la nave senza prima aver messo in salvo qualche carta preziosa oppure la cassa: entrò nella sua cabina e non ne usci più.

Posizione del relitto del “Sardomene”
Noi balzammo in acqua: due minuti dopo, il Sardomene colò a picco con gran risucchio, trascinando con sé quanti non erano così lontani da evitare quel vortice. Contammo undici cadaveri in acqua e tanti ne vennero raccolti dalla nave di scorta affrettatasi in nostro soccorso. Due italiani erano stati uccisi dalla esplosione: il cuoco Giorgio Valle e il marinaio Luigi Molla, fra gli scampati, oltre a me e a sei marinai stranieri, lo spezzino Ernesto Capetta e il napoletano Salvatore Molla».
A Camogli
Anche a Camogli l’eco della tragica notizia riempì di tristezza le vie cittadine. In un incontro del Consorzio degli Armatori e dei Capitani di Camogli, il rappresentante Antonio de Gregori inviò formalmente all’Ammiraglio Giovanni Bettolo – a quel tempo parlamentare - una lettera di protesta così da essere inoltrata al Primo Ministro Salandra.

Camogli: la vecchia Scuola di Marina (grafica di G.B. Ferrari, 1925 ca.)
Bettolo affermò che “il Governo ha avanzato adeguate proteste per l’aggressione e che a tempo opportuno speriamo siano dati risarcimenti adeguati”. L’affondamento del Sardomene venne registrato nella storia come la prima perdita di una nave mercantile italiana nel Conflitto 1915-18.
Breve storia del Sardomene
L’unità fu costruita a Southampton nel 1882 per conto della grande flotta Fernie, Henry & Sons di Liverpool, che fu attiva dal 1870 al 1905. Aveva una portata lorda di 1927 tonnellate, lunga ben 92 metri (i brigantini a palo camogliesi erano di circa 65 metri), tre alberi con vele quadre. Aveva lo scafo in ferro, come era d’uso in Inghilterra a quel tempo di transizione tra la propulsione eolica e quella meccanica. Va qui ricordato che molti nostri armatori acquistarono a fine secolo velieri inglesi con struttura in ferro, ovviamente più resistenti alle operazioni marittime e pressochè inesistenti in Italia. Era quindi una grande nave, che sicuramente sarebbe stata più veloce se avesse avuto un albero extra, mettendola così davvero alla pari coi rapidi clipper inglesi e americani adibiti al traffico del tè.

Immagine d’epoca del Sardomene nella Sede della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli (foto B.Malatesta)

L’ultima partenza del “Sardomene” riportata dalla stampa: è il 21 febbraio 1915, da Bunbury, Australia. L’inserto mostra erroneamente come tipo di veliero “barque”, cioè brigantino a palo; in realtà l’unità camogliese era una “ship”, poiché provvista di tre alberi a vele quadre.
Nell’ultimo viaggio, il veliero camogliese partì da Marsiglia il 28 luglio 1914 al comando di Nardo Bianchi con un carico di piastrelle con destinazione Bunbury, nei pressi del porto di Fremantle (Perth), nell’Australia Occidentale. Lì arrivò il 17 gennaio e, dopo le necessarie operazioni portuali, il 21 febbraio partì per Liverpool con 4.000 tonnellate di legno “jarrah”. Da notare, che durante il viaggio Australia-Inghilterra il veliero fece una toccata in Sud Africa per scaricare parte del legname. E’ inoltre possibile che l’equipaggio fosse poco informato sull’entrata in guerra italiana (maggio 2015) poiché la nave era in alto mare; fu sicuramente avvertito quel primo luglio, all’arrivo in acque inglesi.

Splendido dipinto del “Laomene”, unità gemella del “Sardomene”: ha a riva la bandiera bianca e rossa, vessillo della compagnia inglese “Fernie, Henry & Sons” (opera di Antonio Jacobsen)
Il toccante commento della sorella del Comandante Bianchi
La sorella del Capitano Bianchi, ricordò tristemente alcuni episodi di famiglia, affiorati mentre osservava le rovine del suo palazzo nei pressi di Treviso, abbattuto dall’artiglieria austro-ungarica nel Primo Conflitto.

“Sotto le macerie rinvenni la fotografia di mia madre. Sempre bella. Diseppellii pure quella del mio prediletto fratello. Non è bastato al nemico lanciare il perfido dardo, colpire l’innocuo veliero guidato da Nardo nelle isole d’Irlanda e cacciato a fondo con un siluro assieme a quasi tutto l’equipaggio. Ha voluto ancora, quel vile, colpire l’effige del capitano del Sardomene nella sua casa di campagna, fra le pareti domestiche”.
Bruno Malatesta/maggio 2015
Fonti: - Articoli vari locali d’epoca – Biblioteca Civica “N.Cuneo” - Camogli - Pro Schiaffino: I soprannomi degli armatori di Camogli; - G.B. Ferrari: Capitani e Bastimenti di Liguria; - Pro Schiaffino: I 1000 bianchi velieri di Camogli; - Vari articoli liberi da copyright su Internet; - Alcune immagini non originali sono libere da copyright.=
Eventuali precisazioni o ulteriori informazioni sono benvenute. Grazie
USS CONSTITUTION - Una leggenda
USS CONSTITUTION
Una Leggenda
La USS Constitution, detta "Old Ironsides" è una fregata pesante a tre alberi, in legno, della United States Navy. Battezzata in omaggio alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, è la più vecchia nave al mondo ancora galleggiante (la HMS Victory è più vecchia di trent'anni, ma è stata tirata permanentemente in secca).
La Constitution fu una delle sei fregate originali autorizzate alla costruzione dall'Atto Navale del 1794. Joshua Humphreys le progettò per essere le navi capitali della marina e quindi la Constitution e le sue sorelle furono più grandi e meglio armate delle fregate standard dell'epoca. Per un certo periodo alla Constitution venne assegnato il numero di classificazione di scafo IX-21 ("IX" significa "Miscellanea non classificata"), ma venne riclassificata "nessuna" il 1 settembre 1975
La Constitution abbatte l'albero di mezzana della Guerriere. La Constitution venne costruita nel cantiere navale di Edmund Hart a Boston, Massachusetts con assi di quercia virginiana spesse fino a 178 mm. Fu varata il 21 ottobre 1797 ed entrò in servizio il 22 luglio 1798. Il suo primo servizio fu il pattugliamento delle coste sudorientali degli Stati Uniti durante la guerra non dichiarata con la Francia del 1798-1800.
Nel 1803 venne designata come nave ammiraglia dello squadrone del mare Mediterraneo sotto il comando del capitano Edward Preble e servì nel corso della prima guerra barbaresca contro gli Stati barbareschi del Nordafrica che chiedevano il pagamento di tributi dagli Stati Uniti, in cambio del permesso dell'accesso delle navi mercantili ai porti mediterranei. Preble iniziò una campagna aggressiva contro Tripoli bloccando i porti e bombardando fortificazioni. Infine Tripoli, Tunisia e Algeria accettarono di firmare un trattato di pace.
La Constitution pattugliò la costa del Nordafrica per due anni dopo il termine della guerra, per far rispettare i termini del trattato.
Ritornò a Boston nel 1807 per due anni di raddobbi. La nave venne rimessa in servizio come nave ammiraglia dello squadrone del Nord Atlantico nel 1809 al comando del commodoro John Rodgers.
All'inizio del 1812 le relazioni con il Regno Unito si erano deteriorate e la Marina iniziò a prepararsi per la guerra che venne dichiarata il 20 giugno. Il capitano Isaac Hull che era stato nominato ufficiale comandante della Constitution nel 1810 prese il mare il 12 luglio per prevenire il blocco dei porti. La sua intenzione era di unirsi alle cinque navi dello squadrone di Rodgers.
Il 17 luglio la Constitution avvistò cinque navi al largo di Egg Harbor nel New Jersey. Il mattino seguente le vedette avevano determinato che si trattava di uno squadrone britannico che aveva a sua volta avvistato la Constitution e che si era messa al suo inseguimento. Trovandosi in bonaccia, Hull e il suo equipaggio misero in mare le barche per trainarla fuori tiro. Tonneggiando tenendosi sull'ancorotto (tecnica per trainare o far virare una nave usando l'ancorotto) e bagnando le vele per sfruttare ogni alito di vento la Constitution iniziò a guadagnare lentamente vantaggio contro i britannici. Dopo due giorni e due notti di incessante lavoro sfuggì infine ai suoi inseguitori.
Un mese più tardi, il 19 agosto incontrò la fregata HMS Guerriere al largo della Nuova Scozia e ingaggiò battaglia, riducendola dopo 20 minuti ad uno scafo privo d'alberi, così gravemente danneggiata da non valere la pena di essere trainata in porto. Hull usò efficacemente le sue bordate più pesanti e la superiore capacità di manovra della sua nave, mentre i britannici assistettero sgomenti alle loro bordate che rimbalzavano apparentemente senza effetto dalle fiancate della Constitution, che si guadagnò così il soprannome di Old Ironsides ("vecchia corazzata").
Nel dicembre, al comando di William Bainbridge, affrontò la HMS Java, un'altra fregata britannica. Dopo tre ore di scontro la Java era così danneggiata da essere irreparabile e venne data alle fiamme. Le vittorie della Constitution furono di grande sostegno al morale americano.
Nonostante abbia dovuto trascorrere molti mesi in porto, o a causa di riparazioni o a causa di blocchi navali, al comando di Charles Stewart la Constitution catturò altre otto navi prima della dichiarazione della pace nel 1815, inclusi una fregata ed uno sloop britannici che navigavano insieme e che combatté simultaneamente. Dopo sei anni di estensive riparazioni ritornò in servizio come nave ammiraglia dello squadrone del Mediterraneo. Ritornò in porto a Boston nel 1828.
Nel 1830 venne giudicata non in grado di navigare, ma l'indignazione pubblica alla raccomandazione che venisse smantellata (specialmente dopo la pubblicazione del poema Old Ironsides di Oliver Wendell Holmes), spinse il congresso a decidere di ricostruirla e nel 1835 rientrò in servizio. Servì come nave ammiraglia nel Mediterraneo e nel Sud Pacifico e compì un viaggio di 30 mesi intorno al mondo nel marzo 1844.
Negli anni 1850 pattugliò la costa africana in cerca di schiavisti e durante la Guerra di secessione americana servì come nave scuola per gli allievi dell'Accademia navale.
Dopo un altro periodo di ricostruzioni, nel 1871 trasportò beni per l'Esposizione Universale di Parigi del 1877 e servì nuovamente come nave scuola. Venne ritirata dal servizio nel 1882 e servì come nave ricevimenti a Portsmouth nel New Hampshire. Ritornò a Boston per celebrare il suo centennale nel 1897.
Nel 1905 l'opinione popolare la salvò nuovamente dalla demolizione; nel 1925 venne restaurata grazie alle donazioni di scuole e gruppi patriottici. Rimessa in servizio il 1 luglio 1931 venne trainata in un tour di 90 città portuali lungo la costa atlantica e pacifica degli Stati Uniti. Dal 1920 al 1923 venne rinominata Old Constitution, per liberare il suo nome per un nuovo incrociatore da battaglia in corso di costruzione, ma che non venne mai completato.
Più di 4.600.000 persone la visitarono durante il suo viaggio durato tre anni. Essendo ormai un'icona americana ritornò al suo porto di Boston. Nel 1941 venne messa in servizio permanente e nel 1954 un atto del Congresso rese il Segretario della Marina responsabile del suo mantenimento. Attualmente è ancorata nel vecchio cantiere navale di Charlestown a Boston. È aperta al pubblico per visite (per maggiori informazioni vedi il sito indicato sotto).
Dal 1992 al 1995 venne raddobbata e revisionata e riportata alla piena capacità di navigare. La revisione fu molto meno intensiva di quella della Constellation, dato che la Constitution era in forma migliore.
Il 21 luglio 1997 durante le celebrazioni per il suo duecentesimo compleanno la Constitution riprese il mare per la prima volta in oltre un secolo. Venne trainata dal suo ormeggio fino a Marblehead, quindi innalzò sei vele (fiocchi, vele di gabbia e driver) e si mosse senza assistenza per un'ora sparando 21 salve.
Ormeggiata a Boston, il ruolo moderno della Constitution è quello di "nave di Stato". Incaricata di promuovere la marina, viene visitata annualmente da milioni di visitatori. Il suo equipaggio di 55 marinai partecipa a cerimonie, programmi educativi ed eventi speciali, mantenendo la nave aperta la pubblico ed organizzando giri guidati. È ancora un vascello in servizio attivo della US Navy. L'equipaggio è composto da marinai in servizio attivo e l'assegnamento a questa nave viene considerato un incarico speciale nella marina. Tradizionalmente il titolo di capitano viene assegnato ad un capitano in servizio attivo della marina.
Caratteristiche e armamento
▪ Dislocamento: 2.250 ton
▪ Lunghezza: 204 piedi, 175 al galleggiamento
▪ Larghezza: 43 piedi e 6 pollici
▪ Pescaggio: 19 piedi e 2 pollici di prua, 22 piedi e 9 pollici di poppa
▪ Alberi: Maestra 220 piedi, Trinchetta 198, Mezzana 172 e 6 pollici,
▪ Superfice velica: 3967,89 mq con 36 vele; 1135,74 mq con 6 vele nel 1997
▪ Equipaggio: nel 1797 – 23 ufficiali, 273 marinai, 60 marines nel 1821 – 40 ufficiali, 395 marinai, 60 marines
▪ Disegnatore: Joshua Humphreys
▪ Costruttore: George Claghorne
▪ Costruita a: Hartt Shipyard, Boston, Massachusetts
▪ Varata: 21 ottobre 1797 alle 12,15
▪ Prima navigazione: 22 luglio 1798 alle 20,00
▪ Velocità: Record per 1 ora – 14.0 nodi. Record in 24 ore – 10.3 nodi.
▪ Record in 72 ore – 9.2 nodi
▪ Armamento: 1798 – 30 cannoni da 24 libbre, 16 da 18 libbre e 14 da 12 libbre 1812 – 30 cannoni da 24 libbre, 1 da 18 libbre, 24 carronate da 32 libbre
Date essenziali
▪ 21 ottobre 1797 varo della USS Constitution al cantiere Edmond Hartt’s Shipyard di Boston;
▪ Agosto 1798 in azione nella “Quasi guerra” con la Francia; 1803–1806 nave ammiraglia della flotta del Mediterraneo nella guerra contro Tripoli;
▪ 18 agosto 1812 vittoria contro la HMS Guerrière da cui il soprannome Old Ironsides;
▪ 29 dicembre 1812 battaglia contro la fregata Java e altri cinque vascelli inglesi;
▪ Marzo 1844 viaggio intorno al mondo, della durata di 30 mesi; 1931-1934 viaggio che la conduce a toccare 90 città statunitensi e ritorno a Boston;
▪ 1996-1997 sottoposta a un restauro della durata di 44 mesi, con uscita in mare nel luglio 1997;
▪ 21 ottobre 1997 compie 200 anni.
ENTRATA IN BACINO USS CONSTITUTION
La nave USS Constitution è entrata martedì scorso nel bacino della CHARLESTON NAVY YARD BOSTON NATIONAL HISTORICAL PARK per un programmato lavoro di restauro del costo di diversi milioni di dollari. La USS Constitution è la più vecchia al mondo tra le navi militari tuttora in servizio. Essa è stata consegnata alla US NAVY il 21 ottobre 1797. Tuttavia dal 1907 la nave è stata utilizzata come simbolo per preservare la storia della Marina Americana. Il restauro prevede un costo tra i 12 e 15 milioni di dollari, durerà più di due anni e sarà la prima volta che la Constitution viene tirata in secco dal 1992. Il lavoro prevederà: la sostituzione della parte inferiore del fasciame della carena; la rimozione delle 1995 piastre di rame sostituendole con 3400 fogli di rame nuovo che proteggeranno lo scafo sotto la linea di galleggiamento; la sostituzione dei bagli della coperta; la manutenzione ed eventuale sostituzione della parte superiore degli alberi e del sartiame. Durante il periodo di carenaggio la nave resterà aperta alle visite del pubblico.
ALBUM FOTOGRAFICO

















Testo a cura di CARLO GATTI
Album fotografico
A cura di PINO SORIO
Rapallo, 22 Maggio 2015
LUSITANIA, affondava 100 anni fa.
Cento Anni fa
AFFONDAVA IL LUSITANIA
E L'AMERICA ENTRO' NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il 7 maggio del 1915, l'U-boot U-20 tedesco affondò il transatlantico inglese RMS Lusitania (Cunard Line) presso la costa irlandese. Delle 1.195 vittime, 123 erano civili americani. Nessuna tragedia dei mari e nessun episodio di guerra navale ebbero mai una risonanza e delle conseguenze mondiali per l’intera umanità. Intorno alla fine di questo transatlantico, enorme e lussuoso, chiamato "il levriere dei mari", divamparono le polemiche e si addensarono i misteri. Questo evento fece rivolgere l'opinione pubblica americana contro la Germania, e fu uno dei fattori principali dell'entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco degli alleati durante la Grande Guerra, intervento che fu decisivo per la sconfitta della Germania.
L’avviso premonitore che non fu ascoltato...
Nel 1915 la Germania aveva disposto un blocco navale attorno alle coste del paese nemico: la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti, all'epoca, erano neutrali e mentre il Lusitania era ormeggiato nel porto di New York, nell’attesa di partire per l’ultimo viaggio, l'ambasciata tedesca fece pubblicare il seguente avviso sulla stampa statunitense:
«Ai viaggiatori che intendono intraprendere la traversata atlantica si ricorda che tra la Germania e la Gran Bretagna esiste uno Stato di guerra. Si ricorda che la zona di guerra comprende le acque adiacenti alla Gran Bretagna e che, in conformità di un preavviso formale da parte del Governo Tedesco, le imbarcazioni battenti la bandiera della Gran Bretagna o di uno qualsiasi dei suoi alleati sono passabili di distruzione una volta entrati in quelle stesse acque.»
Rimase celebre la risposta del Comandante Turner: “Questa é la più bella battuta che abbia sentito da anni”.
Alle 12,30 del mattino del 1° maggio 1915, il transatlantico Lusitania, orgoglio della marina civile inglese, lasciò il Pier 54 di New York con a bordo milletrecento passeggeri, di cui centocinquantanove americani che, si disse allora, fossero una “garanzia” contro un attacco tedesco. Nulla di più erroneo.
Mentre la Lusitania salpava per l’Inghilterra, il sottomarino U-20 lasciava la base in Germania per la sua più celebre missione. Le due rotte erano destinate ad incontrarsi.

Soltanto un sottomarino doveva colpire il bersaglio, benché gli ordini diramati dalla Kriegsmarine prevedevano la presenza di numerosi U-Boot in agguato in prossimità dei porti britannici e lungo le rotte più battute dell’Atlantico e del Mare del Nord.
Un certo numero di mercantili britannici erano già stati affondati dagli U-Boot, tuttavia, l’annuncio germanico apparso sulla stampa non produsse particolare effetto. Era diffusa la convinzione che nessuna nazione civile avrebbe agito piratescamente contro una nave di linea e che, soprattutto, la Germania non avrebbe corso il rischio di provocare l’intervento in guerra degli Stati Uniti.

Il Comandante inglese Turner
Con questi ottimistici pensieri i passeggeri americani e inglesi, sfidando il destino della nave, mantennero le loro prenotazioni e partirono per l’Inghilterra. Pur non viaggiando alla massima velocità di crociera, il transatlantico si avvicinò rapidamente alle acque europee con calma piatta. All’alba del 7 maggio il comandante Turner del Lusitania, pur sentendo il profumo di casa, era molto teso, ma anche deluso dall’assenza di navi militari di sua Maestà durante l’atterraggio verso l’Europa, come gli era stato promesso alla partenza. I sottomarini tedeschi operativi in quel settore, tra cui l’U-20, conoscevano esattamente la rotta del Lusitania, ma ci fu un imprevisto: giunto in prossimità della costa alle 11 del mattino, la nave incappò in un banco di nebbia che la costrinse a diminuire la velocità a 18 nodi, ma anche a farsi scudo dalle insidie del nemico. A dire il vero, l’Ammiragliato Inglese non si fece vivo con le navi militari di copertura promesse, ma lo fece con un messaggio crittografico con cui si rendeva nota la presenza nella zona di un sottomarino tedesco. Poche ore dopo un altro messaggio raggiunse il Capitano segnalando nuovamente la presenza di un sottomarino. Cap. Turner ritenne di essere ancora lontano dalla zona di agguato dell’U-Boot e, superato l’Hold Head of Kinsale, si preparò a raggiungere rapidamente Liverpool senza prendere particolari precauzioni.
Nello stesso tempo, il comandante del sottomarino tedesco U-20 Walther Schwieger, in agguato proprio nella zona del Kinsale (Mare Celtico), avvistò una nave che procedeva alla velocità di 22 nodi, aveva quattro fumaioli e non poteva che essere il Lusitania, indicata nell’annuario navale come mercantile armato. L’U-Boot modificò la propria rotta per intercettare la nave ed attaccarla.
Alle 14,10 di venerdì 7 maggio 1915, un siluro lanciato dall’U-Boot 20 colpì senza preavviso il Lusitania e quasi subito si udirono due forti esplosioni in successione. Il transatlantico sbandò sulla dritta ingavonandosi di prora. Con questo assetto innaturale e precario proseguì la sua corsa per un breve tratto con le macchine ancora in moto. L’equipaggio, malgrado la confusione provocata dal terrore e dalla disperazione dei passeggeri presenti a bordo, lanciò l’S.O.S e fece il possibile per ammainare le scialuppe di salvataggio ma, nel corso della difficile operazione, parte di queste si capovolsero. Dopo circa 18 minuti il Lusitania s’inabissò di prora.

La poppa del transatlantico emerse per qualche istante sopra il livello del mare, quindi scomparve in un gorgo immenso nel quale, fra rottami e cadaveri, si dibatteva qualche sventurato.
462 passeggeri e 302 marinai furono i superstiti, per un totale di 764 rimasti miracolosamente sulle scialuppe, mentre le vittime inermi ed innocenti del disastro furono 1200. Tra i 123 cittadini americani deceduti, perse la vita il famoso filantropico Alfredo Vanderbilt affogato dopo aver cercato di trarre in salvo molti bambini presenti a bordo. Le operazioni di salvataggio e di recupero dei superstiti iniziarono con l’invio di navi da guerra e civili non appena la richiesta di soccorso del Lusitania fu ricevuta dall’Ammiragliato. Nella giornata successiva un altro gruppo di unità navali fu inviato per il ritrovamento ed il successivo trasporto a terra delle salme dei deceduti. L’U-20 riuscì a rientrare alla sua base senza aver subito danni. Il comandante dell’U-Boot tedesco Walther von Schwieger racconto: “Il bastimento stava affondando con velocità incredibile. Il terrore regnava in coperta. Le imbarcazioni gremite, quasi strappate dalle loro gruette, piombavano in mare... Uomini e donne saltavano nell' acqua e cercavano di raggiungere a nuoto le imbarcazioni capovolte... Non potevo prestare nessun aiuto. Tutt' al più avrei potuto salvare una dozzina di tutta quella gente... Quella vista era troppo atroce: ordinai che ci immergessimo e ce ne andammo via”. Quelle rivelazioni sulle colpe tedesche squalificarono Berlino agli occhi del mondo.
Alle attività di soccorso seguì un’inchiesta per accertare la dinamica dell’affondamento nonché eventuali responsabilità del capitano Turner, sopravvissuto e salvato dopo aver passato più di tre ore in acqua. Secondo la successiva versione dell’ammiragliato britannico, il Lusitania sarebbe stato colpito a 14 miglia al largo della costa irlandese da due siluri. Molti testimoni confermarono la duplicità delle esplosioni, ma dalla lettura del diario di bordo dell’U-20, considerato attendibile e non contraffatto, emerse che il siluro lanciato fu uno solo. Secondo alcune ipotesi, la seconda deflagrazione che provocò come diretta conseguenza il rapido inabissamento del piroscafo fu dovuta allo scoppio successivo e quasi contemporaneo di circa 5.000 proiettili di artiglieria immagazzinati di contrabbando nelle stive della nave.
L’annuncio della perdita del Lusitania giunto sia a Londra sia a New York, produsse orrore, cordoglio ed indignazione impegnando con le notizie del disastro le prime pagine dei giornali. Accuse durissime furono lanciate dall’opinione pubblica contro la Germania per il fatto di aver affondato senza alcun preavviso una nave civile totalmente indifesa e per essere conseguentemente responsabile di una condotta bellica barbara e senza scrupoli umanitari.
La Germania, malgrado le critiche ed il biasimo internazionale, celebrò invece l’avvenimento come una grande vittoria. “La notizia – scrisse la Kolnische Zeitung – sarà appresa dal popolo tedesco con unanime soddisfazione, giacché dimostra all’Inghilterra ed al mondo intero che la Germania é decisa a fare la guerra sottomarina sul serio”. La Kolnische Volkszeitung – giornale cattolico e nazionalista molto diffuso commentò il fatto scrivendo: “Con orgogliosa gioia ammiriamo questa gesta della nostra Marina e non sarà l’ultima”. Furono aperte sottoscrizioni per premiare l’eroico equipaggio e coniata una medaglia commemorativa per ricordare ai posteri l’affondamento del transatlantico.
Indipendentemente dai risultati delle inchieste, dato il coinvolgimento di entrambi i paesi estensori delle conclusioni che ne derivarono, sulla realtà oggettiva dell’accaduto continuarono a permanere dubbi. Si accesero polemiche mentre furono formulate accuse contro l’Ammiragliato britannico giudicato responsabile del mancato invio di navi di scorta al Lusitania almeno nel tratto di mare considerato zona di guerra e nel quale si trovavano, come peraltro noto all’Ammiragliato stesso, U-Boot in attività.
In seguito all'attacco, tuttavia, gli Stati Uniti non entrarono subito in guerra, ma chiesero in maniera decisa la fine degli attacchi U-Boot nell'Atlantico; richiesta alla quale la Germania acconsentì non senza proteste. Dopo alcuni mesi di guerra la Germania - ormai sull'orlo della rovina - riprese gli assalti condotti con sottomarini alle navi in transito nell'Atlantico nel tentativo di ridurre i rifornimenti degli Alleati; ciò pose fine alla neutralità degli Stati Uniti.
Non molti anni fa, un gruppo di sommozzatori ispezionò il relitto del Lusitania e dichiarò: “.... si ritiene che nella stiva del Lusitania giacciano circa quattro milioni di proiettili Remington 303 fabbricati negli Stati Uniti, a una profondità di circa 100 metri”.
Il mondo é passato nel duplice guado di due guerre mondiali, ma il caso LUSITANIA continua a far parlare dei suoi irrisolti misteri.
Carlo GATTI
Rapallo, 4 Maggio 2015
STRETTO DI MAGELLANO
STRETTO DI MAGELLANO
Il diario di viaggio di Luis Sepulveda in Patagonia e nella Tierra del Fuego così ricco di riflessioni, racconti, leggende e incontri che s'intrecciano nel maestoso scenario del Sud del mondo, rispecchia oggi la sintesi dei desideri di molti turisti occidentali che guardano laggiù, dove l'avventura non solo è ancora possibile, ma è la più elementare forma di vita.

Estrecho de Magellanes é la scritta blu che disegna la via d’acqua nella zona centrale della carta (color ocra).
Lo Stretto di Magellano é un canale naturale che separa l'estremità meridionale dell'America Latina dalla Terra del Fuoco e dalle Isole Dawson, Clarence, Santa Inés e Desolación. Lungo circa 600 km, è molto tortuoso. L'entrata, tra il Capo Dungeness e la Punta Catalina, è larga ca. 30 km; a Capo Forward comincia la seconda sezione, con coste ripide, incise da fiordi. L'uscita principale sul Pacifico è a Nord dell'isola Desolación. Le coste hanno scarsi approdi. Lo Stretto appartiene al Cile e prende il nome dal suo scopritore.
Un po’ di Storia
Sulla fine del secolo XV, i portoghesi scoprirono il Capo di Buona Speranza, aprendo in questo modo, la prima rotta marittima verso EST (Asia e Oceania), fonte di ricchezze per il commercio europeo; tuttavia, un altro portoghese Ferdinando Magellano non riuscì a convincere il re del suo Paese di costruire una flotta per cercare un passaggio a Occidente, attraversando il continente americano per raggiungere l’Oriente. Sarà il re spagnolo Carlo V che nel 1518 accetterà la proposta di Magellano.

Ferdinando Magellano in un ritratto postumo (anonimo del XVI o XVII secolo)
Ferdinando Magellano (in latino: Ferdinandus Magellanus; in portoghese: Fernão de Magalhães; in spagnolo: Fernando de Magallanes); nacque a Sabrosa il 17 ottobre 1480 – Morì nell'isola di Mactan,il 27 aprile 1521 è stato un esploratore e navigatore portoghese . Intraprese, pur senza portarla a termine, perché ucciso nelle isole Molucche nel 1521, quella che sarebbe diventata la Prima Circumnavigazione del Globo al servizio della corona spagnola di Carlo V di Spagna. Partendo dall'Europa, fu il primo a raggiungere le Indie navigando per OVEST attraverso il passaggio che oggi porta il suo nome: Stretto di Magellano. La storia del suo viaggio è pervenuta tramite gli appunti di un suo uomo d'arme, il vicentino Antonio Pigafetta, che si adoperò per il resto della sua vita a mantenere viva la memoria di Magellano e della sua memorabile impresa.
Questo fu l’inizio del viaggio più straordinario nella storia dell’esplorazioni europee intorno al globo. Il 20 settembre 1519, la “Flotta delle Molucche” partì dal porto di Siviglia (Spagna), al comando del navigatore Magellano per raggiungere le Isole Molucche (le leggendarie Isole delle Spezie) con ROTTA OVEST. Il risultato principale fu il seguente: partirono con 5 navi e 265 uomini, ritornarono a Siviglia con una nave e 18 uomini. Quegli stessi uomini avevano realizzato la prima circumnavigazione del globo in 3 anni.
Dopo essere arrivati in Brasile, esplorarono minuziosamente il Rio de la Plata che però era solo un fiume... dopo di ché la flotta ripartí verso SUD alla ricerca di una vera via d’acqua che collegasse i due OCEANI. Il 1° Novembre 1520, la Spedizione entrò finalmente nello Stretto che fu subito battezzato: Stretto di Ognissanti e che solo in seguito fu rinominato: “Stretto di Magellano”. Le terre al Nord dello Stretto furono chiamate “Terre dei Patagoni” (Patagonia) e quelle al sud “Terra dei Fumi” (Tierra del Fuego). Ci vollero cinque settimane di navigazione difficile tra montagne, secche, fondali variabili, strettoie e venti ghiacciati, ma alla fine le tre navi superstiti si trovarono davanti un nuovo oceano che parve loro calmo, accogliente, invitante a tal punto da chiamarlo “Mare Pacifico”.
Magellano e i suoi uomini proseguirono per le Molucche, ma l’arrivo fu davvero tragico: durante uno scontro con gli indigeni, proprio il Capo della Spedizione Ferdinando Magellano perse la vita. Il suo pilota, Sebastian del Cano s’assunse il compito di riportare i resti della Flotta in Spagna dopo innumerevoli difficoltá, ma La rotta marittima verso OVEST era stata aperta dalla Spagna.
Altre spedizioni compiute tra il 1557 e 1559 portarono alla ribalta Juan Ladrillero che esplorò le nuove terre partendo da Valdivia (Cile). Ma fu il corsaro inglese Francis Drake che l’attraversó nel 1557-1578 aprendo un contenzioso con la Corona Spagnola e fu, in ogni caso, il primo a rendersi conto che la Terra del Fuoco era un’isola e non un continente che arrivava fino al Polo Sud e fu il secondo a circumnavigare il mondo.
Gli Spagnoli, allarmati dalla presenza degli Inglesi, decisero di colonizzare quei luoghi e nel Settembre 1581 affidarono a Sarmiento de Gamboa il comando della missione che salpò da Siviglia con 23 navi e 3 mila tra coloni e militari.
Un anno e mezzo durò quel viaggio, tra numerosi stenti, naufragi, malattie, sofferenze e morti; alla fine soltanto 5 navi e 500 persone arrivarono davanti all’imboccatura dello Stretto di Magellano. Nei pressi di Punta Dungenes (entrata dello Stretto) Sarmiento fondò una cittá chiamandola: Nome di Gesú e, più a sud, fondò la cittá “Re Filippo” (60 km a Sud dell’attuale Punta Arenas).
Il tentativo di colonizzazione, purtroppo, si era nel frattempo trasformato in un disastro: i coloni e i soldati delle due cittá morirono letteralmente di fame e la Spagna dovette rinunciare per sempre alla colonizzazione dello Stretto di Magellano.
Il luogo sul quale era stata fondata la cittá di Re Filippo fu battezzata: “Port Famine” nome che perdura fino ai nostri giorni per ricordare il “Porto della Fame” e la sua inquietante storia.
UN PASSAGGIO CONSIDERATO ANCORA OGGI DIFFICILE
Per farci un’idea ancora più precisa circa le difficoltà cui sono sottoposti i naviganti in quel tratto di mare, riportiamo un interessante sintesi:
"Il percorso attraverso lo Stretto - scrive Angelo Solmi nel suo libro Gli esploratori del Pacifico (Novara, istituto Geografico De Agostini, 1985, pp. 75-76) - era considerato con timore, e spesso con terrore, dai marinai: i suoi interminabili 565 chilometri, le condizioni meteorologiche avverse, l'intrico degli angusti canali dalle rive anguste e scoscese, il pericolo delle secche, le correnti capricciose, le bufere inaspettate, gli ancoraggi malcerti, crearono intorno allo Stretto di Magellano una fama sinistra. I marinai - non a torto - lamentavano soprattutto che vi mancava la libertà di manovra del mare aperto. Queste terribili difficoltà furono confermate dal tentativo fatto, nel 1526-28, da una flotta guidata da Francisco de Loayasa e da El Cano, per ripetere l'impresa di Magellano; un tentativo così tragico che, oltre a Loayasa e a El Cano, morirono quasi tutti. Negli anni dal 1535 al 1550 sette spedizioni spagnole avevano cercato di compiere la traversata e su 17 velieri 12 erano stati respinti all'imbocco orientale, alcuni erano naufragati e uno solo, comandato da Alonso de Camargo, era riuscito a passare. Soltanto un uomo su cinque degli equipaggi delle navi aveva potuto salvarsi, e ne erano periti più di 1.000, forse 1.500.
"La situazione migliorò un poco dopo la metà del secolo; nel 1558 il capitano Juan Fernandez Ladrillero forzò lo stretto da ovest a est, dal Pacifico all'Atlantico, con una navigazione brillante e avventurosa sulla nave San Luis, partita dal Cile. Ladrillero tornò poi nel Cile riattraversando lo stretto e dimostrando, fra l'altro, che il percorso era possibile anche durante il gelido inverno antartico. Così le squallide rive del passaggio videro, verso la fine del Cinquecento, un certo numero di frequentatori, sia pur relativamente esiguo: ma va anche considerato che, a rendere meno difficile lo stretto, fu lo sviluppo della tecnica di navigazione, la maggior solidità delle navi e la più progredita esperienza marinaresca.
"Fra i più illustri navigatori che compirono la classica traversata furono Drake (1578) e Cavendish (1587), ossia il secondo e il terzo uomo che circumnavigarono il mondo, due anglosassoni. Ma prima che il secolo finisse, a contrastare il dominio marittimo spagnolo, portoghese e inglese, scesero in campo nuovi temibili avversari, gli Olandesi. (…)
"Furono olandesi il quarto e il quinto uomo che, seguendo la rotta di Magellano, circumnavigarono il mondo: Olivier van Noort (1598-1601) e Joris van Spilbergen (1614-17). Il primo dei due, partito da Amsterdam con tre navi, passò lo stretto fra il 25 novembre e l'inizio di febbraio del 1600, attraversò il Pacifico, poi l'Oceano Indiano e rientrò in patria per la via del Capo di Buona Speranza. Attraversando le Molucche, ancora dominate dai Portoghesi, van Noort si convinse che non sarebbe stato difficile scalzare il già vacillante impero coloniale lusitano. Quanto a Spilbergen, partito da Texel nell'agosto del 1614, percorse lo Stretto di Magellano nell'aprile 1615, esercitò una proficua attività piratesca sulle colonie spagnole d'America, attraversò anch'egli il Pacifico e giunse alle Molucche già in parte conquistate dai connazionali."
Tale, dunque, il contesto in cui matura il disegno di Pedro Sarmiento de Gamboa di fortificare lo Stretto di Magellano in modo da chiuderlo con una sorta di catenaccio che impedisse, per sempre, il ripetersi di devastanti incursioni come quella di Francis Drake contro le colonie spagnole sulla costa del Pacifico.
Durante i primi anni del secolo XVII, gli olandesi passavano diverse volte per lo Stretto, finché nel 1616 scoprirono la rotta del Cabo de Hornos. D’allora e durante quasi due secoli, le navi a vela di tutte le nazionalitá preferirono, per lo più, la rotta diretta tra gli oceani del Cabo de Hornos a quella dello Stretto di Magellano. Alcune spedizione scientifiche famose come quella del Commodoro Byron o di Bougainville, passarono per lo Stretto. Grazie alle imprese di esplorazioni idrografiche inglesi di Parker King e Fitz Roy (tra gli anni 1826 e 1834) si riuscì a ottenere Carte Nautiche molto precisa delle coste dello Stretto e degli arcipelaghi della Patagonia e della Terra del Fuoco.

Riproduzione della goletta Ancud (che reclamò per il Cile le terre australi) e scheletro di balena al locale museo.
Nel 1843, il Governo Cileno mandò il Comandante John Williams, a bordo della Goletta Ancud, a prendere possesso dello Stretto di Magellano e a fondare la Colonia di “Fuerte Bulnes” sulla punta Santa Ana vicino al tristemente noto “Porto della Fame”. Nel 1848, il nuovo governatore della nascente colonia, José de los Santos Mardones, abbandonò il Fuerte Bulnes per la mancanza di acqua dolce e il terreno inospite. Il Governatore fondò allora la Colonia di Punta Arenas (18 dicembre 1848) a 60 km. a Nord del luogo conosciuto fino allora come Sandy Point.
Al principio, la nuova colonia di Punta Arenas fu una specie di colonia penale, ma in seguito alcune comunità riuscirono a radicarsi sul territorio, sebbene nel 1851, un ammutinamento dei guardiani militari ridusse brutalmente la popolazione da 436 a 86 abitanti.
Il dinamismo dei suoi abitanti venne tuttavia affermandosi con lo sfruttamento di giacimenti carboniferi, con la vendita delle pelli di animali marini e l’estrazione del legno. La cittá rinacque grazie anche ad un lento ma constante flusso migratorio di “cilotes” svizzeri, spagnoli, italiani, francesi ed altri, che animò e contribuì allo sviluppo della piccola ma prospera cittá che nel 1853 passò da 150 abitanti a 805, nel 1870 a 1095, nel 1898 a 7000.
Alla fine del secolo XIX lo Stretto di Magellano riprese la sua importanza, come principale via di navigazione tra gli Oceani Atlantico e Pacifico.
Punta Arenas si transformò in un porto cosmopolita, sede di ogni tipo di interscambi, affari e commercio. Dopo l’apertura del Canale di Panama (1914), lo Stretto perse, ovviamente, la sua importanza e questa situazione, in un certo senso, perdura fino ai giorni nostri, ma con qualche variante che induce all’ottimismo.

Nel 1877, con l’introduzione dell’allevamento di bestiame lanoso sulle due sponde dello Stretto, si sviluppò un intenso traffico cabotiero regionale e si stabilirono numerosi allevamenti di bestiame, generalmente sulle coste.
Ma fu la scoperta del petrolio, sia nella Terra del Fuego (1945), sia nelle acque dello Stretto, ad avviare un importante industria che si consolidò negli anni ’80 con lo sfruttamento di giacimenti di GAS e la loro trasformazione in Metanolo. Queste attivitá animarono la vita nello Stretto di Magellano. Attualmente, circa 1500 navi all’anno percorrono lo Stretto e quasi un centinaio di navi da crociera arrivano ogni estate nelle città di Punta Arenas-Ushuaia e dintorni.
Nota Storica: 29 Gennaio 1865, una nave militare italiana passa per la prima volta lo Stretto di Magellano

Domenica - Parte da Genova la fregata a elica Principe Umberto al comando del capitano di vascello Guglielmo Acton con 103 guardiamarina per una campagna di istruzione nell’America meridionale con scalo nei principali porti dei versanti atlantico e pacifico, da Rio de Janeiro a Callao, con due attraversamenti dello Stretto di Magellano, i primi di una nave da guerra italiana.
Dal Libro: IL MARE, AMORE E ODIO
dell'amico Cap. Sup. di L.C. ALVARO DEL PISTOIA
2015 - Edizioni Cinquemarzo Via Paladini 72 – Viareggio
(La nave chimichiera di 54.000 t. aveva scaricato in un porto cileno. N.d.r)
Riporto:
“Era l’inizio dell’inverno e la sera faceva fresco. In quei giorni ricevetti l’ordine di andare a caricare a Buenos Aires. Ovviamente passando per lo Stretto di Magellano. I piloti erano due, salirono alla partenza e dopo circa trentasei ore di navigazione in oceano entrammo nei fjordi per lo Stretto. La navigazione era molto interessante ed i piloti mi fecero vedere i ghiacciai dove le navi da crociera si avvicinano per far scendere i turisti a prendere il ghiaccio per metterlo nei bicchieri colmi di whisky e, per questa operazione pagavano circa mille dollari! Ah gli americani!! Avendo passato lo Stretto di Magellano la terza volta, mi fu conferito il diploma di “Magellano Strait Pilot”. Praticamente potevo passare lo Stretto da Punta Arenas ad Evangelista e viceversa (circa otto ore di navigazione) senza l’aiuto del pilota, un altro cimelio che si aggiungeva a tutti i miei certificati”.
Lo Stretto di Magellano, tagliando la “Tierra del Fuego”, consente di risparmiare circa 300 miglia nautiche, ma soprattutto evita di affrontare in mare aperto le tempeste di Capo Horn. L'espressione Quaranta ruggenti (in inglese: Roaring Forties) è stata coniata dagli inglesi all'epoca dei grandi velieri che passavano perCapo Horn.
Poiché la forza del vento aumenta procedendo verso sud, oltre il 50º parallelo gli stessi inglesi parlavano di Furious Fifties (che in italiano viene tradotto conCinquanta Urlanti). Con “Quaranta ruggenti e Cinquanta urlanti” vengono convenzionalmente indicate in marineria due fasce di Latitudini Australi caratterizzate da forti venti provenienti dal settore Ovest (predominanti), le quali si collocano rispettivamente tra il 40º e il 50º parallelo e tra il 50º e il 60º parallelo dell'emisfero meridionale. Tali venti hanno la stessa origine dei venti da ovestdell'emisfero settentrionale, ma la loro intensità è superiore di circa il 40 per cento: ciò è dovuto alla serie di intense depressioni che interessano queste zone, dovute all'incontro tra l'aria fredda dell'Antartide e l'aria calda proveniente dal centro degli oceani, inoltre questi venti sono amplificati dalla relativa scarsità di terre emerse nell'emisfero sud, cosicché soffiando sempre sul mare non incontrano mai terraferma che li potrebbe frenare.

Cartina geografica raffigurante l'area dei Quaranta ruggenti e dei Cinquanta urlanti
ALBUM FOTOGRAFICO

La vecchia Mappa dello Stretto di Magellano

La copia della VICTORIA la prima nave che attraversò lo Stretto
La spedizione di Magellano ed Elcano fu la prima Circumnavigazione del globo terrestre intrapresa tra il 10 agosto 1519 e il 6 settembre 1522 da una flotta di cinque navi capitanate dall'esploratore portoghese Magellano al servizio della Corona spagnola. Dopo la morte di Magellano nelle Filippine nell'aprile 1521 il comando della spedizione venne preso dall'esploratore spagnoloJuan Sebastiàn Elcano. Il viaggio si concluse con gravi perdite: ritornarono solo due navi, la prima (Victoria) nel 1522 e la seconda (Trinidad), che seguì una rotta diversa senza circumnavigare il globo, solo nel 1525. Dei 234 tra soldati e marinai che formavano l'equipaggio iniziale soltanto 36 si salvarono: 18 sulla Victoria e 5 sulla Trinidad, 13 finirono nelle carceri portoghesi nelleIsole di Capo Verde. La storia del viaggio è nota grazie agli appunti dell'uomo di fiducia (criado) di Magellano, il vicentino Antonio Pigafetta.

Foto satellitare dello Stretto di Magellano
Lo Stretto di Magellano è un percorso navigabile del Cile immediatamente a sud della massa continentale delSud America. Si può sostenere che lo stretto sia il più importante passaggio naturale tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico, ma è considerato una rotta difficile da percorrere a causa del clima inospitale e della strettezza del passaggio. Fino al completamento del Canale di Panama nel 1914, lo Stretto di Magellano era spesso l'unico modo sicuro di spostarsi tra l'Atlantico e il Pacifico. Protette dalla Terra del Fuoco a sud e dal continente sudamericano a nord, le navi lo attraversavano con relativo agio, evitando i pericoli del Canale di Drake. Il Canale o Passaggio di Drake è quel tratto relativamente stretto (800 km circa) di oceano che separa Capo Horn (la punta meridionale del Sud America) dall'Antartide , le cui acque sono notoriamente turbolente, e sono frequenti il ghiaccio e gli Iceberg. Fino al completamento del Canale di Panama, lo stretto era la seconda rotta più usata dalle navi che passavano dall'Atlantico al Pacifico (il Canale di Drake era la prima).
L'apertura orientale è l'ampia baia sul confine tra Cile e Argentina. Ad ovest, ci sono diversi punti di accesso dal Pacifico, anche se il più visibile qui è l'estensione di circa 200 km che va dall'Arcipelago della Regina Adelaide (al centro a sinistra) fino al cuore dello stretto (al centro in basso). Le isole e le montagne sono evidenziate dal bianco della neve, mentre le terre meno elevate a nord e a est ne sono libere.
Ferdinando Magellano divenne il primo europeo a navigare lo stretto nel 1520, durante il suo viaggio di circumnavigazione del globo. Poiché le navi di Magellano vi entrarono il 1º novembre, venne chiamato in origine Estrecho de Todos los Santos (Stretto dii Ognissanti).
Il 23 maggio 1843 il Cile prese possesso del canale, che rimane ancora sotto la sua sovranità. Sulla costa dello stretto si trovano la città di Punta Arenas e il villaggio di Poverni.
Questo passaggio venne attraversato dai primi esploratori Ferdinando Magellano, Francis Drake e Charles Darwin, tra gli altri. Anche i cercatori durante la corsa all'oro della California nel 1849 usarono questa rotta.

Punta Arenas-Cile
PUNTA ARENAS é la capitale della regione del Cile, conosciuta come Magellan e Il Cile Antartico. Fu fondata il 18 dicembre del 1848 con il nome di Punta Arenas. La città cambiò nome in Magellanes nel 1927 e poi ritornò al suo nome originale nel 1938. La sua posizione strategica nello Stretto di Magellano, crocevia di rotte commerciali, diede alla città grandi momenti prosperità, specialmente durante il Gold Rush in California. Tuttavia, la sua importanza decadde a partire dal 1914, anno dell’apertura del Canale di Panama, ma la sua prosperità ritornò a livelli eccellenti quando Punta Arenas diventò un centro molto importante per il traffico della lana. Oggigiorno, Punta Arenas vede intensificarsi il fenomeno del Turismo internazionale legato alle Navi da Crociera, di cui si parla all’inizio, il cui polo d’attrazione é l’avventura, il clima, la fauna, montagne altissime, panorami mozzafiato, ma soprattutto la curiosità culturale di trovarsi immersi in un mix di razze, di lingue e di tradizioni che si sono trasferite in Cile dalla vecchia Europa marinara e contadina, per cui ognuno può trovare in Cile qualcosa di sé.

Scorcio panoramico d’intensa bellezza - Cile

Lo stretto di Magellano all’alba

Lo Stretto di Magellano al tramonto
Carlo GATTI
Rapallo, 4 Maggio 2015
WINDJAMMER, il Canto del Cigno della Vela
WINDJAMMER
L’ultima tipologia di velieri commerciali.
Il Canto del Cigno della Vela

Nave a Palo HERZOGIN CECILIE
Nel 1849 avvenne un fatto epocale nella storia della marineria: per effetto della scoperta di ricchi giacimenti d’oro in California, si creò un flusso di emigranti, ricercatori d’oro appunto, che era disposto ad imbarcarsi su qualsiasi mezzo diretto a S.Francisco via Capo Horn; il Canale di Panama si inaugurerà soltanto nel 1914.
Nello stesso periodo gli americani “inventarono” il CLIPPER. Le flotte d’Europa volavano verso l’ovest e fu l’epoca di memorabili gare tra questi “levrieri dei mari”, di brillanti records ed exploits di Comandanti e costruttori che passarono alla storia per la loro abilità e coraggio. Da quel clima “sportivo” di competizioni nacquero anche le scommesse a livello planetario sui Clipper vincitori.
Si scoprì l’oro anche in Australia e giunse l’ora dello sfruttamento commerciale dell’Oceano Pacifico. I grandi velieri commerciali viaggiavano carichi di emigranti e si incrociavano senza sosta lungo la rotta del Capo di Buona Speranza. Le lunghe traversate spronavano i Cantieri Navali inglesi a creare un tipo di veliero adatto alle grandi rotte oceaniche.
Purtroppo, la caccia all’oro non durò molto e, di conseguenza, il flusso migratorio andò scemando, ma il salvataggio dei grandi velieri dal disarmo totale avvenne per opera del guano della costa cilena, il grano californiano, e l’esistenza in Australia di grandi territori da colonizzare. Inoltre, buoni noli erano considerati: il cotone indiano, il carbone inglese, il nitrato cileno (eccellente fertilizzante) e la carne secca della Nuova Zelanda che riempivano le stive dei grandi “carriers” (Windjammer), gli ultimi velieri commerciali che resistevano ancora alla concorrenza dei più lenti, ma certamente più economici mercantili a vapore.
Mentre la nave a vela in legno tramontava definitivamente, il suo posto veniva preso dal veliero in ferro prima, e poi da quella in acciaio. Con l’apertura del Canale di Suez nel 1869, il mondo della vela accusò un ulteriore colpaccio perché solo le navi a vapore potevano utilizzarlo evitando il periplo dell’Africa. Il lento ma costante progresso della nave a vapore ottenne in quegli anni il monopolio del trasporto passeggeri.
Nel 1890 solo il 10% del naviglio varato dai cantieri inglesi era privo di propulsore a vapore: il rimanente alberava imponenti fumaioli tra la persistente selva di alberi e sartiame.
La navigazione a vela, dopo cinquemila anni di universale pratica, veniva lentamente sconfitta dal nuovo mezzo meccanico. Già! Lentamente, perché la lotta fu aspra e durò ancora nel corso della Prima guerra mondiale, quando gli U-BOOT tedeschi ne fecero scempio con il cannone.
Riservate ai velieri d’altomare rimanevano solo alcune rotte, quelle estreme dei collegamenti con le regioni più lontane (Australia e Cile). Regioni troppo lontane per la limitata autonomia della nave a vapore.
Il grande veliero da carico-WINDJAMMER presentava ancora due notevoli vantaggi:
- non doveva fermarsi per caricare carbone
- il vento non costava nulla
Facendo presa e insistendo coraggiosamente su questi due concetti, Francesi, Tedeschi e Scandinavi costruirono velieri sempre più grandi, destinati a caricare una sempre maggiore quantità di merci. Mentre la flotta dei velieri americani andava lentamente declinando, quella inglese divenne la prima al mondo.
Entriamo ora nel mondo della tipologia windjammer usando la classica definizione: “grandi velieri da trasporto che vennero realizzati tra la fine del XIX e l'inizio del XX Secolo”.
La grande novità costruttiva: scafo in ferro, e 3 - 5 alberi armati con vele quadre. Questa configurazione dava loro un profilo caratteristico perché furono le più grandi navi a vela mai costruite, avevano grandi stazze e non pochi vantaggi:
- la costruzione in metallo rendeva sia la produzione sia la manutenzione più economica di una nave a vela in legno di pari dimensioni.
- Lo scafo era più resistente e quindi permetteva il trasporto di un carico maggiore di una nave di dimensioni più grandi.
- Il moderno concetto di costruzione in serie sfruttava i rilevanti vantaggi dati dall’economia di scala.
- Lo stesso materiale: ferro prima, acciaio in seguito con il quale venivano realizzate, era di per sé meno costoso del legno. Inoltre lo scafo risultava più sottile e quindi lo spazio interno era maggiore.
- Il disegno costruttivo tipico del windjammer mostrava una particolarità molto importante per l’impiego dei più recenti ritrovati tecnologici. Le vele erano semi meccanizzate, gli alberi erano profilati in acciaio e, quando possibile, anche le manovre e il sartiame erano in acciaio.
- Lo scafo era affilato e rendeva il windjammer molto veloce e, nonostante il peso di quattro alberi, poteva raggiungere velocità media tra 15 e 18 nodi. La Herzogin Cecilie (vedi foto) aveva raggiunto la fantastica velocità di 21 nodi.
- Ma c’era un altro aspetto economico di grande rilievo: l'equipaggio tipico di un veliero dell’epoca era composto da: comandante, secondo, nostromo, 15 marinai esperti e 5 apprendisti, mentre l'equipaggio richiesto per governare un windjammer poteva essere di sole 14 persone.
- L'armamento e l’attrezzature fornivano prestazioni migliori della goletta e poteva navigare seguendo il vento meglio di una nave a palo, ed infine era più maneggevole di una nave dotata di sole vele quadre. La capacità di carico variava tra le 2.000 e le 5.000 tons. Il tipico carico, come abbiamo già visto, era costituito da guano, legno grezzo, grano e carbone.
- Su questo sito di Mare Nostrum Rapallo, nei titoli degli articoli riportati alla fine del presente servizio, abbiamo dedicato numerose pagine a questa tipologia WINDJAMMER a cui l’Italia diede numerose e celebri Navi a Palo di grandi stazze.

A cinquantotto anni dalla tragedia del famoso veliero-scuola PAMIR è doveroso un ricordo alla memoria del Comandante Johannes Diebitsch e dei suoi ufficiali, marinai ed allievi che perirono nel naufragio, avvenuto nell’oceano Atlantico a causa del violentissimo uragano “Carrie”. Il veliero aveva un equipaggio di ottantasei uomini e solo sei di essi si salvarono. La nave a palo tedesca (windjammer) Pamir, 3.020 di Stazza Lorda, naufragò nel settembre 1957.
Nel suo ultimo viaggio commerciale via Capo Horn, avvenuto nel 1949 sotto bandiera finlandese il Pamir aveva un equipaggio di 34 persone. Gli ufficiali erano cinque (comandante, primo ufficiale, secondo ufficiale, terzo ufficiale e nostromo), 14 marinai esperti, 5 marinai semplici e 5 mozzi di coperta, cuoco, assistente di cucina, cameriere e aiuto cameriere e infine un meccanico. I tempi erano definitivamente cambiati e i grandi windjammer si assunsero il compito di tramandare l’ARTE MARINARESCA velica alle nuove generazioni di marinai e ufficiali di mezzo mondo. Gli ultimi WINDJAMMER sopravissuti navigano ancora oggi con il nome, a tutti noto, di Tall Ships.
Tutte queste innegabili peculiarità del windjammer prolungarono la vita della vela essendo questi scafi molto competitivi (sulle lunghissime distanze) contro le prime navi a vapore che non superavano la velocità di 8 nodi.

Cinque Alberi PREUSSEN
Il più grande windjammer mai costruito fu il PREUSSEN che aveva 5 alberi. Il suo dislocamento era di 11.600 tons. Nella traversata dell’Oceano Atlantico, poteva mantenere una velocità media di 16 nodi.
La produzione maggiore di windjammer avvenne tra il 1870 e 1890 poi, quando la navigazione a vapore incrementò potenze, dimensioni e velocità, cominciò il loro inevitabile declino.
ALCUNE DIFFERENZE TRA IL CLIPPER ED IL WINDJAMMER
Clipper e Windjammer vengono spesso confusi perché somiglianti nello shape, ma si tratta di due tipologie di navi molto diverse. Il Clipper era una nave progettata in funzione della velocità, mentre il Windjammer lo era per la capacità di carico e la maneggevolezza. Molti Clipper avevano una costruzione mista (legno e ferro) e velatura completa, ma una capacità di carico inferiore alle 1.000 tons. I Windjammer erano invece di costruzione interamente metallica ed avevano, come abbiamo già visto, una capacità di carico molto elevata. Al tramonto del favoloso Clipper comparve sulla scena dei sette mari il Windjammer e fu il canto del cigno del mondo della vela da carico.

SEEADLER
Durante la Prima guerra mondiale, la Marina Imperiale Tedesca, utilizzò il Seeadler che stabilì un record come ultima nave a vela partecipante ad un conflitto. L'impiego principale dei windjammer restò però quello commerciale e, sebbene considerati una razza in via d’estinzione, alcuni restarono in servizio commerciale fino agli anni cinquanta del ventesimo secolo. L’avvento del motore DIESEL diede il colpo finale ai windjammer che terminarono la loro carriera occupando una nicchia nel trasporto di merci rappresentata dai collegamenti con quei porti che non disponevano di riserve di acqua o di combustibile e in alcune zone dell’Australia nel trasporto della lana e per le isole più lontane per il trasposto del guano.

Nave a Palo SEDOV
Ai giorni nostri, il più grande windjammer esistente ancora in attività è la nave scuola russa Sedov mentre il quattro alberi Moshulu, che può vantare il titolo di più grande windjammer esistente, è stato trasformato e viene utilizzato come ristorante di lusso a Philadelphia-USA. Spesso è possibile vedere altri esemplari di queste navi durante le principali manifestazioni dedicate alle gare tra le varie categorie di TALL SHIP.

Windjammer PASSAT

Windjammer KRUSENSTERN

Montague Dawson Paintings American Windjammer Under Full Sail

Windjammer KRUZENSTERN

Volle Fahrt voraus: Die "Sea Cloud II" erinnert an die Glanzzeiten der Großsegler.

Nave a Palo FRATELLI BEVERINO
Varato nel 1882 col nome di “Glenorchy” dalla Glen Line di Glasgow, passava alla Casa Beverino che nel 1909 lo vendeva a Gioacchino Lauro passando in Pacifico col nome “Cavaliere Lauro”. Passato infine col nome “Italia” all’armatore Esposito di Meta, di ritorno dal Cile con un carico di nitrato veniva investito da un piroscafo e affondava in pochi minuti.

Nave a Palo EMANUELE ACCAME
È la nave a palo più famosa e longeva di Loano, attiva su tutti gli Oceani. Varata a La Spezia nel 1891, gemella della “Edilio Raggio”, saliva a fama internazionale nella gara del grano sotto bandiera svedese col nome di “G.B.Pedersen”. Due drammatici passaggi di Capo Horn richiamarono il suo nome su tutta la stampa internazionale, quando, alla cappa durante una tempesta, venne salvata dalla collisione di un veliero inglese dall’allarme dato dalla bambina del capitano inglese, che stava a bordo con lui. Nel 1908 veniva a trovarsi a navigare tra i campi di ghiaccio che stavano chiudendosi riuscendo a guadagnare il mare libero all’ultimo momento. Dopo il 1911 veniva venduta alla Norvegia, poi alla Svezia distinguendosi in fatto di rendimento veloce. Nell’aprile del 1937, il grande veliero veniva speronato da un piroscafo ed affondava in 20 minuti ponendo così fine a 46 anni di navigazione.
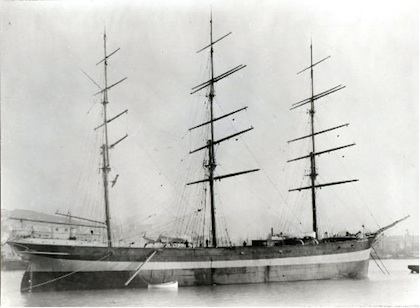
SATURNINA FANNY
Fu realizzata nel 1890 su piani del Tappani nel Cantiere Nicolò Odero di Sestri Ponente dall'Ingegnere Navale Fabio Garelli che ne diresse la costruzione. Scafo in acciaio. Stazzava 1.594 tonnellate. Venne varata il 4 febbraio 1891. Armatori Raffo & Bacigalupo di Chiavari.

“ERASMO” in seguito “Pinguin”
Varato a Riva Trigoso nel 1903 per conto degli armatori Raffo e Bacigalupo di Chiavari, fu unità veloce collezionando primati malgrado le molte tempeste nelle quali ha avuto la ventura d’incappare, in Atlantico e nel Pacifico. Venduto alla Casa tedesca Laeisz, navigava col nome di “Pinguin” e veniva demolito nel 1923 dopo aver alzato anche la bandiera francese.

Nave a Palo “REGINA ELENA” – In seguito: “Ponape” – “Bellhouse”
Armato da Casa Milesi di Genova, veniva varato a Riva Trigoso nel 1903. Allestito con cura sotto la sorveglianza di capitani esperti, condotto in campagne effettuate con passaggi veloci e con carichi di vario genere non escluso il nitrato peruviano e il petrolio in cassette, nel 1912 veniva ceduto alla Casa Laeisz col nome di “Ponape”. Catturato dagli inglesi durante la prima guerra mondiale, navigava col nome “Bellhouse” passando poi sotto bandiera norvegese fino al 1927. Lunghezza 96 metri, larghezza 13,10, pescaggio 7 metri. Scafo in acciaio, stazzava 2.365 tonnellate. Portata 3.500 tonnellate. Era uno dei più bei quattr'alberi italiano. Aveva le vele di belvedere e controbelvedere.

Nave a Palo ITALIA
Scafo in acciaio, stazzava 3.109 tonnellate lorde, 3.030 nette. Lunghezza 98,80 metri, larghezza 14,54. Immersione 7,67 metri. Era armata con doppi velacci, velaccini e belvedere.
Con la sua portata di 4.200 tonn., è stato il più grande veliero costruito dai cantieri nazionali. Varato al Muggiano nel 1903 per conto degli armatori Cavalieri Becchi e Sturlese di Genova, attrezzato a nave a palo con i ritrovati più recenti, con 18 vele quadre, randa e 12 vele triangolari, albero maestro di 50 m. , era una nave splendida alla quale, però, non ha arriso la fortuna, che gli ha decretato la breve vita di 3 anni. Due le campagne, la prima di circumnavigazione del globo; la seconda campagna tra Europa, Australia e nuovamente Europa via Capo Horn. Durante la terza campagna, 1908, diretto allo scalo cileno di Iquique, l’“Italia” arrivava verso sera sotto costa quando veniva a mancare completamente il vento lasciando le vele inerti sicché bisognava ricorrere all’assistenza di uno dei pochi rimorchiatori della zona, che non fu possibile trovare (o giungeva troppo tardi). Il mare lungo che arrivava da Sud Ovest, dagli sconfinati spazi oceanici aperti, complice la corrente, spinsero il veliero sulle rocce della costa che scendeva a picco decretandone la fine per naufragio. Sinistro successo anche ad altre navi perché, essendo il mare molto profondo, era molto difficoltoso fermare la deriva per mezzo delle ancore. L’”Italia” riusciva tuttavia ad effettuare la manovra richiesta ma troppo tardi perché la poppa, ruotando, arrivò con il timone proprio sulle rocce che aprirono una via d’acqua fatale. Non rimaneva all’equipaggio che allontanarsi con le lance di salvataggio, che venivano soccorse da alcuni pescherecci.

Nave a Palo “GABRIELE D’ALI’” gemella della “Principessa Mafalda”
Progettista e Direttore dei Lavori fu l'Ingegnere Navale Fabio Garelli.Scafo in acciaio, stazzava 2.385 tonnellate. Zavorra 800 tonnellate d'acqua.Bastimento bello e dalla linea filante, risultò essere molto veloce anche per l'ampia velatura: gabbie, doppi velacci e controvelacci erano alti uguali sui tre alberi. Tra di essi e tra il contromaestro e la mezzana dotata di randa e controranda vi erano tre vele di strallo che, con fiocco, controfiocco e trinchettina al bompresso completavano l'imponente piano velico.
Fu un’ottima unità della Casa D’Alì di Trapani, il veliero più grande dell’Armamento meridionale italiano, varato nel 1903. Passato indenne tra i pericoli della guerra, veniva demolito a Trieste nel 1923, ultima nave a palo della flotta velica commerciale italiana.
- Si RINGRAZIA l’Archivio Fotografico dell’Agenzia Bozzo di Camogli che ci ha concesso la divulgazione di un pezzo della nostra Storia Marinara.
- Articoli correlati all'argomento WINDJAMMER sul sito di Mare Nostrum Rapallo:
Sezione STORIA NAVALE
- Le vere TALL SHIPS
- The TALL SHIPS’ RACE 2007
- I CLIPPERS, le FERRARI dell’800
- Gli ARMATORI CHIAVARESI
Sezione NAVI e MARINAI
- Nave a Palo ITALIA – C. CONCORDIA, due naufragi a confronto
- Veliero TROYAN e Cap. Filippo AVEGNO, un "Manico di altri Tempi..."
- L' AMERIGO VESPUCCI ha compiuto 80 anni ed é ancora la nave più bella del mondo
Carlo GATTI
Rapallo, 4 Maggio 2005
Il TRATTATO DI TORDESILLAS
IL TRATTATO DI TORDESILLAS
Dall'avventura di Colombo alla nascita del colonialismo

Il 12 ottobre 1492, dopo sessantanove giorni di navigazione, Cristoforo Colombo gettava l’ancora della sua caravella, la Santa Maria, presso l’isola Guanahani (futura isola di San Salvador). Fu così che, nel tentativo di raggiungere via mare il Catai ed il Cipango (le attuali Cina e Giappone) per una nuova e inesplorata via, l’ignaro navigatore fece dono alla Spagna e all’Europa del Nuovo Mondo. Cristoforo Colombo era nato a Genova nel 1451. Eccellente navigatore, si era stabilito in Portogallo, appassionandosi alle esplorazioni e studiando un modo più rapido per raggiungere via mare il Cipango e altre terre sconosciute e colà raccogliere l’oro necessario per una nuova crociata contro i turchi. Intorno al 1484, aveva proposto il suo progetto al re del Portogallo; al rifiuto del sovrano, Colombo si era rivolto ai monarchi di Castiglia e Aragona. Il primo rifiuto dei re spagnoli, nel 1487, non scoraggiò Colombo, che pochi anni dopo, nel pieno fervore della guerra di riconquista cristiana della Spagna, riuscì ad accordarsi con i reali per il finanziamento dell’impresa. Era la primavera del 1492. Il 3 agosto di quello stesso anno Colombo salpava verso Occidente da Palos con tre imbarcazioni: la “Niña”, la “Pinta” e la “Santa Maria”. Dopo una sosta alle Canarie, l’8 settembre la piccola flotta iniziava la traversata dell’Oceano Atlantico.
Dopo il rientro di Colombo in Europa, avvenuto nel marzo 1493, papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia), si ritrovò a dover dirimere le rivendicazioni territoriali dei sovrani iberici: al Portogallo infatti avrebbero dovuto spettare tutte le terre sul parallelo delle Canarie, in base ad un accordo fra quel regno e la Castiglia di una decina d’anni prima. La scoperta delle Indie da parte di Colombo e il nuovo assetto politico della penisola Iberica (dove Castiglia e Aragona s’erano unite nel nuovo regno di Spagna) entravano in conflitto con quel trattato e rischiavano di spaccare la cristianità. Rodrigo Borgia dovette mediare fra le pretensioni di Giovanni II di Portogallo e quelle di Sovrani Cattolici di Castiglia e Aragona, ed emanò una serie di documenti, tra i quali il più importante è la bolla Inter cetera del 4 maggio 1493. Il documento è contenuto nel Registro Vaticano 777 dell’Archivio Segreto Vaticano. La Inter coetera (di cui esistono due redazioni) venne retrodatata, nella sua versione definitiva al 4 maggio, anche se composta, spedita e registrata solo alla fine del giugno 1493. Con quel documento, definito anche “bolla di partizione”, il papa – in virtù dell’autorità apostolica sulle terre occidentali dell’ex Impero Romano, esercitata in forza delle prerogative attribuite ai papi dalla falsa donazione di Costantino – concedeva ai sovrani spagnoli il possesso di tutte le isole e le terre scoperte e di quelle che sarebbero state scoperte in futuro, a Ovest di una linea di confine ideale Polo Nord/Polo Sud, idealmente tracciata a circa cento leghe dalle isole Azzorre e dalle isole di Capo Verde.
Con questo atto il pontefice delimitava il dominio marittimo e coloniale di Spagna e Portogallo. Il papa chiedeva poi ai sovrani di provvedere al più presto all’invio di missionari cattolici che operassero per convertire alla vera fede di Cristo le popolazioni indigene. Nel documento papale s’incontra fra l’altro l’esplicito riferimento alla missione svolta da Cristoforo Colombo (chiamato nella bolla Cristoforus Colon), “uomo particolarmente degno e assai raccomandabile, nonché capace di compiere una così grande impresa”, incaricato dai sovrani spagnoli “di cercare non senza fatiche e pericoli certe isole lontanissime e terre mai scoperte prima”.
L'intervento del Papa nella questione fu giustificato alla luce della Donazione di Costantino. Il documento (di cui è stata peraltro provata l'inautenticità) includeva nel lascito di Costantino alla Chiesa, tra le altre cose, le isole della parte occidentale dell'Impero Romano. All'epoca si riteneva che le nuove scoperte fossero semplicemente delle isole (ci si rese conto solo più tardi che si trattava invece di un nuovo continente): di qui, presupponendo di intendere l'Oceano Atlantico ricompreso nella "parte occidentale dell'Impero Romano", la giustificazione dell'arbitrato papale.
Altra interpretazione vuole invece che l'intervento papale, forte dell'autorità acquisita grazie alla guerra santa di matrice cristiana e alle crociate servisse a legalizzare la posizione di Portogallo e Spagna su territori inesplorati, selvaggi e abitati da pagani , dove la loro pretesa di legittimità era labile: fintanto che le operazioni militari si svolsero nella penisola spagnola, con lo scopo di ripristinare la Christianitas, non fu avvertito minimamente dalle monarchie iberiche nessun bisogno di avallo da parte di un potere superiore, cosa che invece, divenne indispensabile con le nuove scoperte geografiche.
La divisione tracciata dalla bolla, comunque, non fu equa. La Spagna influenzò pesantemente la decisione, che di fatto escluse il Portogallo dall'America (Alessandro VI era di origine spagnola). La ragione per cui la bolla favoriva la Spagna fu individuata nel servizio che la nazione spagnola rendeva, o avrebbe reso, alla Chiesa di Roma. Il dettato della bolla alessandrina fu poi superato dal Trattato di Tordesillas, nel 1494, che spostò la linea molto più ad ovest, permettendo al Portogallo di reclamare il suo dominio sul Brasile.
PREMESSA
La bolla Inter Coetera,* di papa Alessandro VI, scritta il 3 maggio 1493, su richiesta dei Re Cattolici di Spagna, è uno dei documenti più importanti della chiesa cattolica rinascimentale, poiché con esso non solo si sanziona giuridicamente la nascita del colonialismo internazionale dell'Europa occidentale, ma si inaugura anche il moderno colonialismo ideologico e culturale del cattolicesimo romano, allora strettamente legato a quello ispano-portoghese. A dir il vero, la bolla nacque per rivedere un trattato di spartizione imperiale circa le isole dell'Atlantico (isole già conosciute e ancora da conoscere), già stipulato, senza mediazione pontificia, nel 1479, tra Spagna e Portogallo, ad Alcaçovas (in virtù del quale la Spagna poté assicurarsi solo le Canarie).
Con la scoperta dell'America (che allora si pensava fosse la Cina), la Spagna decise di non rispettare quel trattato e, rivolgendosi direttamente al papa, sperava di evitare una guerra col Portogallo e di stipulare un nuovo trattato.
Il Portogallo, infatti, riteneva che proprio in virtù di quel trattato, le terre scoperte da Colombo gli appartenessero di diritto e, poiché la sue proteste presso la corte spagnola non avevano ottenuto alcun risultato, aveva allestito una flotta da guerra che doveva seguire Colombo nei futuri viaggi per occupare con la forza gli eventuali nuovi territori.
La bolla di Alessandro VI è quindi un documento più importante del trattato di Alcaçovas, poiché, essendo scritta dopo la scoperta dell'America, riguarda per la prima volta dei territori planetari, per quanto solo alcuni decenni dopo ci si convincerà dell'esistenza di un nuovo continente. La bolla, d'altra parte, non perderà valore neppure dopo tale acquisizione geografica, benché i successivi trattati di Tordesillas (1494) e soprattutto di Saragozza (1529) costituiranno delle notevoli precisazioni che i portoghesi vorranno fare a loro vantaggio. Saranno piuttosto le nuove potenze europee capitalistiche: Olanda, Inghilterra e Francia, a rendere inutile una qualunque mediazione pontificia.

TRATTATO DI RORDESILLAS
La divisione del nuovo mondo tra spagnoli (a sinistra del meridiano) e portoghese (a destra del meridiano)
Il TRATTATO DI TORDESILLAS fu firmato il 7 giugno 1494 tra i re Cattolici di Spagna e Giovanni II di Portogallo, sotto l'egida del papa Alessandro VI, quindi confermato dal papa Giulio II, fissava una linea di delimitazione circa a 2000 km a Ovest delle isole del Capoverde: i territori situati all'Est di questa linea, conosciuti e sconosciuti, sono attribuiti al Portogallo, quelli dell'Est alla Spagna. Chiamato anche “trattato di ripartizione del mondo”, veniva a regolare, dopo i trattati di Alcoçavas (1479) e di Tolède (1480), la rivalità dei due paesi impegnati “nelle grandi scoperte”.

Versione portoghese del trattato di Tordesillas, folio 1 recto, Biblioteca Nazionale di Lisbona.
Certo è che la chiesa non avrebbe mai prodotto questo documento se il colonialismo portoghese (già sotto la sua "protezione") non avesse avuto concorrenti di sorta: il documento infatti ha lo scopo di dirimere una controversia territoriale emersa tra i due principali paesi colonialisti di quel periodo, che la storia ha voluto fossero cattolici. Esso ha pure lo scopo d'impedire che altri Stati cattolici vogliano diventare colonialisti nelle stesse terre già occupate. La spartizione viene assicurata dalla chiesa non solo sulle terre già scoperte ma anche su quelle da scoprire.
Come disse il gesuita Giovanni Botero, teorico della "ragion di stato", la chiesa romana si sentiva in dovere di riconoscere i possessi coloniali mondiali alle due nazioni europee che più avevano lottato contro ebrei e musulmani, cioè che più avevano manifestato il proprio integralismo politico-religioso.
Se il contenzioso fosse sorto tra un Portogallo cattolico e una Germania protestante, probabilmente non ci sarebbe stata alcuna mediazione pontificia, non foss'altro perché non ne sarebbe stata riconosciuta l'universalità da entrambe le parti. Se invece il contenzioso avesse coinvolto altri Paesi europei di religione cattolica, quest'ultimi, disposti certo a riconoscere l'universalità etico-religiosa della chiesa romana, non altrettanta disponibilità avrebbero manifestato per la pretesa universalità politico-giurisdizionale. E la chiesa post-medievale, dal canto suo, non sarebbe stata in grado di rivendicarla. Gli stessi sovrani iberico-lusitani gliela riconoscevano più che altro in maniera formale, in quanto, sul piano pratico, era la chiesa che doveva adattarsi alla forza delle loro armi. Già ai tempi di Sisto IV, che cercò d'imporre alla Castiglia vescovi di sua nomina, Isabella vi si oppose energicamente, anche se poi accetterà la proposta dello stesso papa di ripristinare l'antico tribunale dell'Inquisizione, gestito dalla corona (1481).
Qui appare evidente che la Spagna intendeva servirsi della mediazione pontificia per darsi una patente di legalità nel caso in cui l'opposizione del Portogallo alla “bolla” avesse dovuto costringerla a dichiarargli guerra.
La storia comunque ha voluto che a legittimare il moderno colonialismo internazionale non fosse un'istituzione laica ma religiosa. Questo a prescindere dal fatto che le successive legittimazioni (laiche o a-cattoliche) conterranno aspetti colonialistici assai più anti-democratici del contenuto complessivo della bolla in oggetto.
Quadro storico
L'Inter Coetera venne scritta in un momento di grave crisi morale per la chiesa di Roma. Le uniche vere preoccupazioni dei pontefici parevano essere quelle di proteggere i loro parenti e di abbellire Roma con edifici prestigiosi.
Sul piano politico invece la situazione sembrava offrire alla chiesa una qualche possibilità di rivalsa, almeno nell'ambito dello Stato pontificio, dopo i 70 anni della cosiddetta "cattività avignonese" e dopo la nascita e lo sviluppo del movimento conciliarista (che negava al papato la priorità sul concilio, trovando, in questo, molti appoggi da parte dei governi laici).
Con grande tempismo politico, la chiesa di Roma seppe approfittare della richiesta bizantina di aiuti militari contro l'invasore ottomano, per imporre alla chiesa ortodossa, nel concilio di Ferrara-Firenze (1438-39), il riconoscimento della giurisdizione universale del pontefice. Il fenomeno conciliarista occidentale sembrava aver perso, d'improvviso, una qualunque giustificazione d'esistere.
Con la fine del "piccolo scisma d'occidente" (1439-49), che fu praticamente l'ultimo tentativo del conciliarismo d'imporsi restando nell'ambito del cattolicesimo, la Curia romana riprenderà totalmente il controllo della chiesa. Centralismo, fiscalismo e mondanità saranno poi le cause che scateneranno la Riforma protestante.
Tuttavia, il decreto d'unione non venne accettato dalle comunità ortodosse, che alla delegazione, rientrata a Costantinopoli, fecero sapere di preferire la dominazione turca a quella latina. Né il papato riuscì a organizzare una potente crociata antislamica, per imporre il decreto, agli ortodossi, con la forza. Ormai i tempi non invitavano più gli occidentali a impegnarsi in crociate neo-medievali. Senza considerare che nei confronti del mondo bizantino, l'occidente cattolico non ha mai nutrito alcuna simpatia.
Questo, benché, proprio a seguito di quel concilio, i teologi, i filosofi e i maestri di greco della delegazione che decisero di restare in Italia, contribuirono non poco allo sviluppo dell'Umanesimo e del neo-platonismo, nonché alla diffusione della lingua greca e a un rinnovato interesse per le tradizioni bizantine. Tanto per fare un esempio, un'opera fondamentale come quella del Valla sulla falsa Donazione di Costantino (1440) sarebbe stata impossibile con i soli strumenti della filologia.
Inoltre, le possibilità di fare affari, per i mercanti, si stavano lentamente spostando verso le nuove rotte coloniali portoghesi o verso il Mare del Nord, dove dominavano le città della Lega Anseatica. In fondo l'obiettivo principale delle crociate medievali (e cioè quello di aprirsi uno spazio autonomo nel mercato mediterraneo, per commerciare in tutta Europa i prodotti orientali), i mercanti l'avevano raggiunto da un pezzo.
E' vero che la parte del leone, in quell'impresa bisecolare che costò immani sacrifici, l'aveva praticamente fatta Venezia (che costringerà Genova a rivolgersi verso il Mediterraneo occidentale e i traffici ispano-portoghesi); ed è anche vero che proprio a seguito della spinta ottomana, Venezia era stata costretta a rivolgersi verso i porti del Nordafrica, della Siria, dell'Egitto. Ma è anche vero che, nel complesso, la borghesia occidentale (si pensi anche a quella, sempre più legata alla manifattura, di paesi come Olanda, Inghilterra e Francia) stava vivendo un momento di crescente benessere. Per cui il papato non poteva più contare sulle stesse motivazioni sociali che nei secoli precedenti avevano spinto migliaia di persone a combattere per la "giusta causa" del colonialismo.
Probabilmente, se dopo la caduta di Costantinopoli (1453), gli spagnoli non avessero avuto il coraggio di attraversare l'Atlantico (emulando, in questo, il coraggio portoghese di scendere sotto l'equatore), la borghesia occidentale (Venezia esclusa) non avrebbe potuto disinteressarsi, con così relativa facilità, dei traffici mediterranei (lo dimostra la discesa di Carlo VIII in Italia, ma gli stessi aragonesi nel Mediterraneo svolgeranno sempre una politica antiveneziana). D'altra parte fu anche l'atteggiamento monopolistico di Venezia (che a questi traffici non vorrà rinunciare neppure dopo il 1453) a indurre le borghesie degli altri paesi a cercare nuovi sbocchi per le loro merci e soprattutto altre fonti (meno costose) per le loro materie prime.
Il papato, quindi, in questa seconda metà del XV sec., deve tener testa a tre avversari di tutto rispetto: 1) la crescente laicizzazione dei costumi e dei valori (soprattutto nell'area di cultura umanistica e rinascimentale: fenomeno, allora, tipico degli intellettuali); 2) l'emancipazione socio-economica della borghesia, che vuole rinnovare profondamente la struttura e l'ideologia della chiesa cattolica (da qui prenderà le mosse il movimento riformistico); 3) l'affermata autonomia politica dei sovrani cattolici, che vogliono agire senza dover rendere conto ad alcun contropotere, senza cioè dover temere che l'arma della scomunica possa bloccare ogni loro iniziativa.
Il papato è ancora potente economicamente, anche se politicamente il suo potere lo esercita soprattutto, in maniera diretta, senza la mediazione del sovrano cattolico, nell'ambito del proprio Stato. Illusosi di aver superato la minaccia del movimento conciliarista, e relativamente soddisfatto della fine dell'impero bizantino, il papato non sospetta neanche lontanamente che tutte le idee conciliariste ed ereticali verranno riprese, di lì a poco, dalla grande Riforma protestante, e che in Europa orientale la Russia degli zar si farà carico di proseguire il conciliarismo della chiesa bizantina.

Alessandro VI (1492-1503)
Papa Alessandro VI rappresenta un esempio davvero illustre (ma i suoi successori, Giulio II e Leone X, non gli furono da meno) del livello di corruzione morale e di prepotenza politica della chiesa romana di quel periodo.
Di origine spagnola, Rodrigo Borgia venne nominato cardinale a soli 25 anni; salì al soglio pontificio per simonia; ebbe cinque figli, tra i quali Cesare e Lucrezia, dei quali erano noti la spregiudicatezza morale e politica; fece di tutto, senza però riuscirvi, a ricavare in Romagna un dominio per il figlio Cesare; dilapidò il patrimonio della chiesa per arricchire i propri familiari, anzi, fu il primo a trasformare la corte pontificia in reggia principesca, strutturata in modo tale da mettere in risalto la venerazione rituale riservata alla dinastia; fu responsabile della morte per impiccagione e rogo del predicatore domenicano Girolamo Savonarola, al quale aveva offerto la porpora cardinalizia pur di farlo tacere. In conflitto con gli aragonesi per i diritti su alcuni feudi nel regno napoletano, preferì prendere le loro difese (perché li considerava più deboli) contro i francesi che con Carlo VIII erano scesi in Italia per occuparla. Si sospetta infine che sia stato avvelenato.
Questo, in sintesi, l'identikit dell'autore della bolla che stiamo per prendere in esame.
Il testo
Il testo, che è il primo di una serie di quattro bolle, dedicate tutte al medesimo argomento: Inter coetera, del giorno dopo, Dudum Siquidem (26.09.1493) e Eximiae devotionis (16.11.1501), esordisce affermando due cose: 1) "la fede cattolica" (e non ortodossa, benché anche questa pretenda di far parte della "religione cristiana") va diffusa in ogni luogo; 2) "i popoli barbari" (cioè non-europei o comunque tutti coloro che non appartenevano a una delle tre religioni monoteistiche: cristiani, ebrei e islamici. "Barbaro" infatti è un epiteto pesante, che la chiesa cattolica riferiva soprattutto ai popoli "pagani", "politeisti" o "idolatri"): questi popoli vanno "vinti" (sottinteso: militarmente) e poi "condotti alla fede" (spada e croce sono indissolubili).
Il testo poi prosegue elencando i fatti e i motivi dai quali la chiesa di Roma può, secondo ragione, far dipendere la concessione del riconoscimento giuridico delle nuove proprietà spagnole in America (che ancora si pensava fosse la Cina).
1) Imparzialità assoluta del pontefice, eletto "col favore della clemenza divina (senza nostro merito)". Questa frase di Alessandro VI, che appare più volte, può essere stata ispirata da due diverse preoccupazioni, non antitetiche ma complementari: anzitutto quella di delegittimare una delle accuse più gravi che a quel tempo gli intellettuali progressisti gli muovevano (e per la quale il Savonarola verrà giustiziato nel 1498): l'accusa di simonia. In questo senso la sottolineatura del pontefice potrebbe anche stare a significare che, essendo la cathedra Petri un'istituzione divina, che prescinde dalla personalità o dalle caratteristiche soggettive di chi la occupa, ogni sovrano, di conseguenza, era tenuto ad accettare la bolla senza discuterla, proprio perché scritta da colui che, attraverso Pietro, rappresentava la volontà di Dio.
Il secondo motivo della precisazione può essere stato invece più etico e meno politico, anche se ugualmente importante. Probabilmente Alessandro VI -essendo di origine spagnola- aveva bisogno di difendersi in anticipo dall'inevitabile insinuazione d'aver compiuto un favoritismo nei confronti dei "Re Cattolici" (titolo, questo, ch'egli conferirà ai sovrani di Spagna nel 1494).
2) Spontanea iniziativa del gesto ecclesiale: la concessione del riconoscimento giuridico viene fatta -dice il papa- "per nostra pura liberalità", "non dietro richiesta", "a titolo di favore". Qui si possono precisare alcune cose: anzitutto, secondo il diritto ecclesiastico allora vigente, tutta la terra (come pianeta) apparteneva al Cristo e, quindi, essendone il vicario, al papa, il quale così poteva concederla in usufrutto ai sovrani di religione cattolica; in secondo luogo, una terra non posseduta da un sovrano cattolico veniva considerata "senza proprietario", anche se essa era rivendicata da un proprietario non-cattolico; in terzo luogo, il principio della "donazione delle terre scoperte" tutti i pontefici precedenti ad Alessandro VI l'avevano applicato alle conquiste dei portoghesi.
3) Il "favore" di cui parla il pontefice non va inteso in senso giuridico ma morale. La concessione veniva fatta riconoscendo ai sovrani cattolici (in particolare Alessandro VI si riferisce a Isabella di Castiglia) i sacrifici ("fatiche, spese, pericoli") sostenuti contro i saraceni. Questo è dunque, per la chiesa, un modo di ricompensare (senza obblighi legali) quella nazione che più si era impegnata, per la fede religiosa, sul piano militare, politico ed economico. La "conquista" del Nuovo Mondo non era che il premio per la "riconquista" cattolica della Spagna.
Alessandro VI, in particolare, afferma che se la Spagna era arrivata "seconda" sulle stesse terre che i lusitani avevano scoperto o conquistato per altre vie (si ricordi che l'America corrispondeva alla Cina), ciò non doveva penalizzarla nella spartizione delle colonie, poiché il ritardo era dovuto a un fattore contingente assai importante: la Riconquista.
4) D'altra parte - dice ancora il pontefice - i sovrani spagnoli non solo hanno desiderio di diffondere la fede cattolica, ma hanno anche l'esigenza di doverlo fare in modo legittimo. Il "santo e lodevole proposito" di evangelizzare tutta la terra (questa espressione viene ripetuta più volte nel testo) è, secondo la chiesa, il motivo principale che giustifica il colonialismo ispano-portoghese. Non c'è ragione, quindi, di non concedere in dono e "in perpetuo", cioè anche agli eredi e successori dei sovrani spagnoli (a prescindere cioè dal tipo o dalla qualità dell'evangelizzazione), il favore in oggetto.
5) Anche il giudizio su Colombo è estremamente positivo. Benché l'avesse conosciuto solo attraverso la Lettera a Santàngel, Alessandro VI lo chiama "nostro diletto figlio": forse per suggerire l'idea, conoscendo la "religiosità" del genovese, che il colonialismo era nato sotto buoni auspici e che avrebbe continuato a dare buoni frutti se l'interesse della corona di fosse strettamente unito a quello dell'altare. O forse il pontefice voleva far leva sull'origine italiana di Colombo per dimostrare che indirettamente la chiesa di Roma aveva concorso alla scoperta dell'America.
Non dobbiamo infatti dimenticare che questa bolla non è solo un documento con cui si concede il favore del riconoscimento giuridico della conquista, ma è anche un documento con cui, in cambio del favore, si chiede un compenso relativo agli interessi della chiesa.
L'interesse della chiesa
Alessandro VI non si era servito solo della Lettera a Santàngel, per scrivere la bolla, ma anche di altre fonti non citate. Nella Lettera infatti non era stato detto che gli indigeni fossero vegetariani. In ogni caso, ch'essi siano così o anche "numerosi", "pacifici" e "ignudi", ciò per Alessandro VI non rappresenta più di una mera curiosità folclorica.
La vera caratteristica che gli preme sottolineare è che il loro "monoteismo" primitivo, ingenuo, istintivo, va perfezionato col cattolicesimo, che, unico al mondo, è in grado di "educare ai buoni costumi". Qui il pontefice dà per scontato che le conversioni degli indigeni siano già relativamente facili.
Il pontefice ricorda anche la guarnigione lasciata da Colombo a Navedad, ad Haiti, e senza volerlo si contraddice laddove afferma, dopo aver parlato di "indios pacifici", che la "torre ben munita" doveva essere difesa dai cristiani contro gli indios.
In effetti, al pontefice non interessava approfondire il discorso sulle civiltà indigene: gli bastava credere (in fede o per convenienza non importa) in ciò che Colombo aveva scritto circa la scoperta di "oro, spezie e moltissime altre cose preziose". Anche per lui era del tutto normale unire profitto e fede.
La chiesa giustificava il profitto in nome della fede; la Spagna lo giustificava servendosi della fede: la differenza era minima. In fondo la chiesa di Roma aveva le stesse esigenze della Spagna: recuperare nel Nuovo Mondo ciò che non poteva più sperare di ottenere (o addirittura di conservare) in Europa, soprattutto sul piano politico ed economico. La Spagna voleva diventare una grande potenza europea restando sostanzialmente feudale, mentre molte altre nazioni stavano diventando borghesi: e ciò la costringerà a cercare uno sbocco "salvifico" nel Nuovo Mondo. La chiesa, che non poteva più contare sulle proprie forze, cercava di ridiventare una grande potenza appoggiandosi al colonialismo della Spagna. Questa si limitava a usare la fede come uno strumento ideologico al servizio della conquista militare e politica; quella invece credeva che la fede, come ideale religioso, potesse sopravvivere politicamente soltanto su nuove basi economiche.
Il papa concesse il favore tracciando una linea retta (raya) dall'Artico all'Antartico, cento leghe a ovest delle isole di Capo Verde (al largo dell'attuale Senegal), assegnando al Portogallo tutte le nuove scoperte a oriente di quella linea, e alla Spagna tutte quelle a "occidente e mezzogiorno".
In cambio di questo favore, il papa chiederà ai Re Cattolici: 1) che istruiscano per l'America dei missionari qualificati, capaci di evangelizzare nel miglior modo possibile; 2) che vietino a chiunque di recarsi nelle Indie "per commercio o altre ragioni" (ad es. per scopi missionari), "senza speciale permesso vostro", altrimenti il soggetto subirà la scomunica latae sententiae, cioè immediata.
La chiesa, insomma, convinta che il sovrano spagnolo non voglia aver a che fare con possibili recriminazioni da parte di altre potenze commerciali e marittime europee, chiede anche che non vi siano, sul nuovo terreno missionario, rivali nella predicazione.
A dir il vero, appena tre anni dopo la pubblicazione della bolla, Enrico VII, re d'Inghilterra, violò la raya cogliendo come pretesto il fatto che nel divieto del papa si erano citati l'ovest e il sud ma non il nord. Convinto che Colombo avesse scoperto un'isola e non le Indie, e che queste potessero essere scoperte con una rotta più settentrionale di quella di Colombo, il re favorì la spedizione del veneziano Giovanni Caboto, che partì da Bristol giungendo in Labrador, Terranova e Nuova Scozia. Anche Caboto sarà però convinto d'aver scoperto una parte dei domini del Gran Khan. Probabilmente non scoppiò una guerra, in quell'occasione, solo perché il successore di Enrico VII, Enrico VIII, si disinteressò dell'America, vedendo che non si realizzavano i profitti previsti. Tuttavia i commerci continuarono, anche se i mercanti inglesi, con capitale a rischio, per un certo periodo di tempo non poterono colonizzare o lasciare depositi stabili nelle colonie.
Piuttosto fu il Portogallo che non soddisfatto della bolla del pontefice, pretese, col trattato di Tordesillas, di spostare la raya di altre 170 leghe a ovest: cosa che poi lo porterà ad annettersi il Brasile.
Grazie dunque ai sovrani cattolici, il papato poté approfittare della situazione per far valere la propria autorità morale e giuridica, mostrando, in particolare, che senza la sua mediazione legittimante, non sarebbe stato possibile proseguire in modo "corretto" la gestione politica ed economica delle colonie acquisite. Il pontefice, tuttavia, doveva essere ben consapevole che se il Portogallo non avesse accettato le proposte indicate in questo documento, una guerra contro la Spagna sarebbe stata inevitabile, poiché egli non avrebbe avuto la forza d'impedirla. La guerra poi scoppierà un secolo dopo e porterà il Portogallo a una disastrosa rovina.

1502 - PLANISFERO DI CANTINO CON IL MERIDIANO DI TORDESILLAS
Il più antico ed importante reperto pervenutoci dall’epoca delle Scoperte Geografiche é la Carta del mondo di Alberto CANTINO, un diplomatico italiano residente a Lisbona che la ottenne nel 1502 dal Duca di Ferrara. Fu interamente copiata senza autorizzazione. Essa comprende le ultime informazioni geografiche basate su quattro serie di viaggi:
Cristoforo Colombo ai Caraibi, Pedro Álvarez Cabral in Brasile, Vasco de Gama seguito da Cabral in Africa Orientale e India, e i fratelli portoghesi Gaspar e Miguel Corte-Real (1450-1501..) in Groenlandia e Terranova. Eccetto C. Colombo, tutti gli altri navigarono sotto la bandiera portoghese.
Contesto: Scoperta dell’America
Trattato: Bilaterale di TORDESILLAS (Spagna) firmato il 7 giugno 1494
Mediatore: Papa Alessandro VI
Firmatari: Ferdinando II d’Aragona, Isabella di Castiglia, Giovanni di Trastàmare, Giovanni II del Portogallo.
Lingue: Spagnolo – Portoghese.
Il caso delle isole Molucche
Spagna e Portogallo continuarono a rivendicare le isole asiatiche delle Molucche sotto la propria rispettiva sfera d'influenza. Le isole ricoprivano una grande importanza nel commercio delle spezie. Questa contesa si risolse nel 1529 con il trattato di Saragozza.
Carlo GATTI
Bibliografia:
- Enrico Gavalotti – Homolaicus – Sezione Storia – Modena
- STORIA in rete
- Tordesillas.webarchive
Rapallo, 8.4.2015
