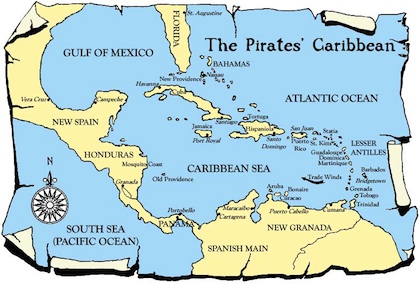COSA MANGIAVANO I PIRATI?
Ma cosa davvero mangiavano i pirati ?

Avendo fatte ricerche, come appare in altra parte, sulla gastronomia caraibica ai tempi dei Bucanieri, i mitici Fratelli della Costa, non vi nascondo che la tentazione di riuscire a sapere cosa realmente ci fosse nei piatti di quei masnadieri, fu forte. Per saperlo con una certa qual certezza e non ricorrendo ai vari Salgari, bisognava però fare delle ricerche, perché sino ad allora non ero mai incappato in qualcosa di attendibile. Persino nei romanzi ispirati a quelle imprese o nei rendiconto, non compaiono mai dei possibili “menu” anche se, ben inteso, non come oggi li conosciamo, cioè una sequenza di portate. Sarebbe stato sufficiente qualcosa che ci descrivesse, anche sommariamente, come erano composti i loro “manicaretti.
Ho fatto allora ricerche presso la prestigiosa Civica Biblioteca “Berio” di Genova, Città notoriamente sensibile alle cose di mare. Nulla. Ho coinvolto anche gli amici della <Fondazione B.IN.G – Bibliotèque Internationale de Gastronomie – Lugano> una delle due più complete raccolte di manoscritti e stampati delle opere di gastronomia dal sec. XIV al XIX, esistenti al mondo: ricerche rivelatesi inutili.
Di cosa mangiavano nelle antiche marinerie “ufficiali” dell’epoca, conosciamo quasi tutto a cominciare dalle derrate imbarcate prima di partire, senza però poi sapere in che modo venissero preparate. Addirittura esiste un dettagliato elenco di cosa imbarcò Colombo prima di partire per la sua avventura; sappiamo persino delle lenze per la pesca segretamente occultate, così da poter essere eventualmente usate per pescare, nello sventurato caso che si esaurissero le scorte per l’imprevedibile non rispetto dei tempi di navigazione ipotizzati, visto che si andava verso l’ignoto; deprecata possibile ipotesi che però un precisino come lui (quella stessa“ostinata” precisione che lo portò poi alla rovina) aveva, pur tenendosela per se, messa in conto.
Con il tempo e il migliorare dell’organizzazione dei vari Ammiragliati, si cominciò a studiare e prendere nota empiricamente della quantità di razioni che dovevano essere servite per sostenere le fatiche di ogni imbarcato (oggi le chiamiamo “calorie”), ma mai come lo si confezionasse. E’ però facile pensare che, mano a mano che le riserve imbarcate si avvicinavano al deterioramento, gli addetti alla cucina le rendessero commestibili in base alle loro personali esperienze e non secondo un menù precostituito: da qui il largo uso delle spezie. Per altro a bordo, data la configurazione dei quei velieri, è da escludere si preparassero zuppe o minestre o cibi liquidi o intingoli, troppo pericolosi su instabili vascelli non idonei, vuoi per la panciuta forma della chiglia che doveva contenere più merce possibile, vuoi per la esigua stazza degli stessi, (le mitiche caravelle oggi verrebbero classificate fra la nautica minore) non certo ideali per attenuare il rollio ed il beccheggio. La presenza del “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco, non garantiva certo la stabilità di cosa vi si stesse cucinando. Il “mulo”, l’incaricato, doveva sempre stare attento a che le “pignatte” non volassero. Questa ipotesi trova conferma nel fatto che in tutti i porti sino agli inizi del ‘900, nell’ora di mezzogiorno, si accostassero sotto bordo, barche che vendevano fumanti zuppe o minestre di verdure, proibite a bordo.
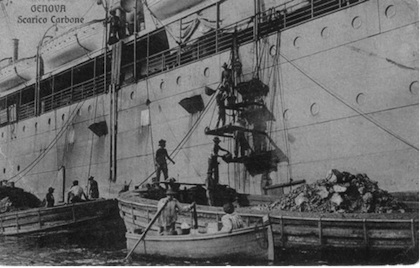
Nel porto di Genova, il "cadrai", italianizzato in cadraio, era quel barcaiolo che portava cibi caldi o meno ai lavoratori delle chiatte o delle navi dalle quali non potevano scendere a terra. Il nome "cadrai" è corruzione dell'inglese "caterer", ossia il fornitore e-o organizzatore di mensa. Nel 1910-11 vi erano nel porto 40 "cadrai" La bellezza della cartolina stà comunque nella retrostante rappresentazione del bunkeraggio di una volta. Archivio P. Berti
A Genova si chiamavano “cadrai” e offrivano minestrone caldo, reso accattivante con l’aggiunta di profumate foglie di basilico spezzettate (il pesto,dato il prezzo dei suoi componenti, era un lusso). Se ne deduce quindi che il mangiare di bordo fosse prevalentemente “asciutto”. So che non è bello auto-citarsi ma per non tediare ripetendo dettagliate informazioni, invito a leggere, a chi ne avesse voglia, ciò che descrivo ampiamente nel mio ultimo volume < LIGURIA amore mio> Mursia Editore.
E’ facile ipotizzare che in quell’ambiente piratesco le “mangiate” vere e proprie avvenissero nelle bettole di terra ferma; in mare era altra musica. Si può pensare che le orge sessual-gastronomiche, quella maramaglia che aveva piena coscienza che ogni volta che andava per mare poteva anche essere l’ultima, le riservasse a quando, venduta la merce rapinata sui velieri depredati, davano sfogo alla voglia di vivere una vita sgregolata che, certo, non offriva loro obiettive prospettive proiettabili a lungo termine. Infatti solo pochi poterono morire nel proprio letto; la maggior parte, se non fatti a pezzi negli arembaggi, finì appesa a un qualche pennone di bordo.
Proprio perché quella vita disagiata comportava sacrifici e rischi ma assicurava un pasto sicuro, da sempre tutti gli imbarcati, anche se semplici componenti la “bassa forza” e in qualunque marineria, venivano assai meglio retribuiti di chi, a terra, svolgeva analogo lavoro e non aveva la certezza di mangiare tutti i giorni.
Solo dei pranzi Regali abbiamo esatti rendiconto, portata per portata. Ma non era certo questo il caso dei “Nostri” presi in esami, la maggior parte dei quali frequentava quella vita, statisticamente ahimé, per un breve arco di anni. Quasi sempre i corsari, perché operanti per un qualche regnante, una volta catturati, finivano nelle galere di chi li aveva fatti prigionieri (meglio conservarli: si sa mai che poi li avrebbero potuti usare per il loro comodo ?) mentre ai pirati, da nessuno protetti, era riservata l’impiccagione.
Scartabellando inutilmente nei volumi riservati alle ricerche che mi stavano a cuore, ho dedotto che nelle Biblioteche italiane, non avrei mai trovato quello che cercavo perché, all’epoca, l’Italia, o meglio le marinerie dei vari Staterelli che la componevano, bazzicavano solo nel Mediterraneo: infatti di tutte queste ho già scritto cosa e quanto consumavano a bordo, a cominciare dalle galere. I Caraibi erano invece solcati da navi spagnole, francesi e inglesi. Queste ultime erano controllate dal più organizzato e puntiglioso Ammiragliato a cui non sarebbe sfuggito alcunché e, quello che conoscevano, lo mettevano per iscritto. Forse, in quel repertorio mitico inglese, ce ne sarà traccia.
Allora ho pensato che, anche se scientificamente non corretto, qualche scrittore anglosassone di avventure piratesche a cui era facile attingere a quel patrimonio, ne potesse aver scritto con la stessa dovizia di particolari che riservava al descrivere il resto di quel mondo.

La scelta non poteva che cadere su Robert Louis Stevenson che nell’800 ne scrisse nel suo famoso < Isola del tesoro > descrivendo nei dettagli gli ambienti degli angiporti e dei pirati del ‘700. Per capirci è lo stesso che ci ha tramandato quel macabro ritornello che tanto ci fece sognare e impaurire da ragazzi:

Quindici uomini sulla cassa del morto
Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum!
Nelle 200 e più pagine del romanzo, gli unici accenni al mangiare sono, nell’ordine: in una taverna <E così mi fu servito ad una piccola tavola un pasticcio di piccione e io cenai di gusto …> più avanti, a bordo <Dopo di che, mangiato il nostro lardo e bevuto ciascuno un buon bicchiere di ponce all’acquavite….> e ancora <<messomi a sedere, per attender che fosse buio, mangiai di gusto la mia galletta> in oltre, a terra <… un uomo ci chiamò perché la colazione era pronta, e tosto sedemmo sulla sabbia, intorno al fuoco, con davanti gallette e lardo fritto> e poi < … avevano sbarcato dall’Hispaniola lardo, gallette e acquavite per il pasto di mezzogiorno > ed in fine < Che cena, quella sera, attorniato da tutti i miei amici; e che pasto, con carne di capra salata … parecchie ghiottonerie e una bottiglia di vino vecchio dell’Hispaniola ! > mentre del rum, farcito dalle bestemmie, ne parla ad ogni piè sospinto.

Da questi sommari accenni ai pasti consumati in navigazione, se ne può dedurre che non ci fossero grandi scelte e conseguenti “menù “: l’importante era sopravvivere. A proposito di rum, ad un certo punto venne “adottato” dalla marina inglese nel tentativo di combattere il micidiale sgorbuto.

Morale: i giovani marinai, con la scusa di prevenire, si sbronzavano e allora decisero di allungarlo con acqua. E’ nato così il noto “grog”
Ma torniamo a noi: anche se mi rendo conto di queste lacune e pur conoscendo cibi antichi, non intendo “inventarmi” manicaretti possibili tanto per accontentare la voglia di scrivere cose insolite, come la romanzata < Olla putrida> dall’etimologia del nome assai sospetta e “ruffiana”. I pirati saranno stati crudeli sanguinari assassini o, a seconda delle circostanze, pacchiani gentiluomini, ma per certo non erano fessi. Questa sorta di zuppa composta da legumi e carne, certamente liquida, è assai improbabile venisse servita a bordo, meno che meno rendendola più “esplosiva” da una “presa” di polvere da sparo, come si narra. E’ un classico esempio di piatto unico “antichizzato” che si presta ad essere romanzato; una analoga gustosissima minestra, ma con un nome meno rivoltante, la si gusta ancor oggi sui Pirenei nel Principato di Andorra.
Se mi capiterà mai di trovare traccia che appaghi questa curiosità, mi riservo di scriverne per colmare questa mia lacuna, della quale chiedo venia.
Mi rendo conto che appoggiarmi ad un romanzo per ragazzi, se pur famoso, non mi fa onore ma, quando l’acqua arriva alla gola, tutto può servire per stare a galla.
A questo punto, e per ora, getto la spugna.

Renzo Bagnasco
Ricerche a cura di Rosa Grazia Allaria
Foto a cura del webmaster Carlo Gatti
Rapallo, 11 Maggio 2014
BUCANIERI, FRATELLI DELLA COSTA E LA GASTRONOMIA "CRIOLLA"
I Bucanieri, i veri Fratelli della Costa
e la gastronomia “criolla”

Un bucaniere rappresentato sotto il titolo Buccaneer of the Caribbean nel libro di Howard Pyle, Howard Pyle's Book of Pirates.
Cominciamo con il dire che una gastronomia di bordo, all’epoca della quale parleremo, non esisteva. Gli unici a mangiare in modo adeguato erano il Comandante e gli Ufficiali; la ciurma si nutriva male e in modo assolutamente inappropriato. Gli addetti alla cucina avevano, per dedicarvisi, tempi risicati in quanto nessuno di loro rivestiva il solo ruolo di cuciniere, perché impegnati principalmente a fare i marinai. D’altra parte il fuoco a bordo non era ben visto: basti pensare a quando pioveva o il mare era mosso. Nel “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco a che non surriscaldasse il legno, la pece, il cordame e i teloni di cui era piena la nave, lo si poteva utilizzare solo se le condizioni atmosferiche lo permettevano. Anche gli orari erano variabili; intanto si mangiava una sola volta al giorno, attacchi ed arrembaggi permettendo. Il migliore fra i vivandieri, abbiamo visto che erano tutti mozzi di bordo, si occupava del Quadrato degli Ufficiali i quali erano gli unici a “sedersi a tavola”; la ciurma per mangiare si appoggiava dove poteva e al rancio provvedevano i meno esperti. Con il passare dei giorni di navigazione, per rendere appetibili i cibi che inevitabilmente tendevano a deteriorasi, dovevano riempirli di aromi e spezie.
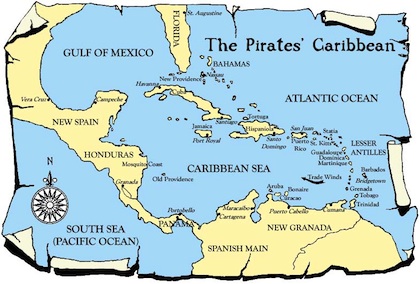
Per fortuna nella zona caraibica gli aromatici “insaporitori” non mancavano. Questo disordine alimentare imperava non solo fra i pirati che bazzicavano la zona del Centro America, ma anche fra tutti coloro che dovevano rimanere in mare a lungo. Era già problematico mantenere “commestibile” la carne dopo qualche giorno dalla macellazione. Non c’erano frigoriferi e il magazzinaggio delle derrate secche in chiglia, luogo deputato allo scopo, non le preservava dall’inumidirsi a causa del trasudare di acqua salmastra, attraverso il fasciame dell’opera viva sempre sconnesso perché, per quanto calafato con stoppa o, più spesso, con fibra di cocco, non restava “fermo” ai primi colpi di mare. Quel sito caldo e umido, non potendo contare su ricambi d’aria, favoriva il deteriorarsi rapido di quanto conteneva.
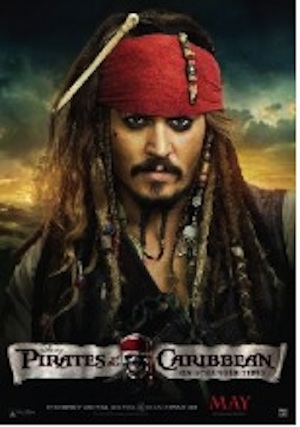
Stessa sorte colpiva anche i “Fratelli della Costa” consorteria di pirati più noti come <i bucanieri della Tortuga> dall’isola caraibica che elessero a loro rifugio nel 1640. Quasi tutti gli equipaggi erano formati principalmente da marinai francesi, inglesi e, in misura assai minore, olandesi. La “bassa manovalanza” era costituita invece da tutti quegli sbandati sopravissuti alle sconfitte nelle guerre, che nel frattempo, qua e la, venivano combattute. A loro risale il Tricorno, che fu adottato da Re Luigi XV che lo volle copricapo ufficiale delle divise militari, subito copiato da diversi eserciti. Quel copricapo non è “pomposo” come quello della Nobiltà e della Borghesia dell’epoca, caratterizzato da alte e divaricanti tese; è scarno, anch’esso in pesante feltro e ha le tre “ali” ripiegate sulla “calotta” per non creare intralci nei combattimenti. Nei mesi caldi veniva sostituto da uno di paglia.
Ma torniamo al tema: la gastronomia “criolla”, cioè creola. Va da se che i “nostri” riuscivano a mangiare come Dio comanda solo quando sbarcavano nei Caraibi; colà si potevano nutrire con cibi più appetitosi e variati, già in allora conosciuti, ma soprattutto di verdura e frutta, beni preziosi e rari a bordo.

Come non riprendere dai cassetti della memoria l’immagine legata indissolubilmente al castello poppiero di un romantico veliero o su di un rabberciato pontile di un porto sotto il sole tropicale, di uomini con il tricorno in testa, la sciabola in mano e gli alti stivali di cuoio?
La pirateria moderna inizia nel XVII secolo nel Mar delle Antille ed in meno di cinquant’anni si estende in tutti i continenti; il Mar delle Antille rimane ad ogni modo il centro della pirateria, sia perché là i pirati riescono a godere di una serie di appoggi e favori sulla terraferma, sia perché le numerose isole presenti sono ricche di cibo e di anfratti, per di più circondate da bassi fondali che impedivano eventuali inseguimenti da parte delle lente e “pescose” navi da guerra; sia in fine perché in quei mari transitavano navi cariche di imbarchi preziosi provenienti dalle appena scoperte Americhe. Tra le cause dello sviluppo della moderna pirateria non va dimenticata l’azione della Francia e dell’Inghilterra che, per contrastare il dominio commerciale della Spagna nel Mar dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari a che saccheggiassero i mercantili spagnoli. La concorrenza commerciale anche allora non andava tanto per il sottile. Successivamente, sia per il venir meno dell’appoggio anglo-francese, sia per una acquisita abitudine allo stile di vita libero ed indipendente, molti corsari divennero …. pirati.
Il potentissimo impero spagnolo, alla metà del diciassettesimo secolo aveva dichiarato il monopolio commerciale delle ricche Antille, tappa obbligatoria dell’oro centroamericano per arrivare nel vecchio continente, il tutto a seguito dell’approdo in loco di Cristoforo Colombo, nel 1493 a St. Croix. I coloni, spagnoli, francesi, inglesi ed olandesi vivevano quasi tutti sull’isola di Hispaniola ( tra l’attuale Haiti e Santo Domingo ). Si specializzarono nella produzione di alimenti a lunga conservazione, come carni essiccate o trattate, indispensabili per i lunghi viaggi in mare. Questo metodo sarebbe stato insegnato loro dagli Arawak, tribù di Santo Domingo. La capanna dove avveniva l’essicazione, su graticole fatte di sottili strisce di legno denominate barbicoa ( dal quale deriva l’attuale termine “barbecue” ) si chiamava boucan: da questo ne derivò il nome di “bucanieri”. Questi erano di diversa nazionalità e non servivano alcun paese anche se in certe occasioni potevano essere sollecitati e supportati. Formarono legami stretti con i coloni ai quali svendevano le merci saccheggiate e dai quali ricevevano la possibilità di entrare nelle città per ogni più varia necessità; queste pullulavano di pirati per via anche delle locande e degli altri “servizi” ad esse correlate. I bucanieri erano presenti nelle navi corsare o pirata anche perché famosi per la loro infallibile mira, allenata da quando erano stati cacciatori. La loro dieta quotidiana, a terra, consisteva in verdura e frutta, come papaia, patate dolci, guaiave e manioca. La mancanza della verdura e della frutta fresca a bordo, uniche fonti di vitamina C, procurava invece il devastante scorbuto. Solo nel 1747 il medico scozzese James Lind intuì sperimentandolo, che bastava mangiare agrumi a bordo per debellarlo. Che fosse poi la carenza di vitamina C, lo scoprirono dopo. Inizialmente la cottura della carne e del pesce avveniva in grandi vasi di un materiale simile alla terracotta, facilmente trasportabile ed immagazzinabile. Trasferitisi sull’isola di Tortuga e a Port Royal, nel 1640 fondarono la Fratellanza della Costa, ( tra di loro i pirati si autodefinivano< Fratelli della Costa> ) smisero di affumicare carne e depredare solo navi: si dedicarono alla predazione dei villaggi lungo le coste, dando vita a quella che noi oggi identifichiamo come “ pirateria”. Redassero un vero e proprio Codice Etico dei Pirati – ( Code of the Brethren States) che conteneva regole di massima che tutte le navi della “Fratellanza” erano impegnate ad onorare: a lui si è ispirato l’Ottalogo, il codice etico degli attuali Fratelli della Costa.
Nei viaggi che solcavano i mari, i pirati avevano a disposizione per lungo tempo solo carne affumicata e rum. Il resto, verdure, formaggi, uova deperiva velocemente ammuffendo e marcendo. Si aggiunsero quindi alla dotazione della dispensa legumi secchi o cibi conservati in salamoia; per i Comandanti anche frutta candita. Polli, ovini e mucche venivano tenuti in vita fino a quando l’approvvigionamento per mantenerli era sufficiente; dopo finivano macellati. Spesso l’impossibilità di conservazione delle carni per il caldo umido dei tropici, ne favoriva la putrefazione. Tutto ciò rendeva carente la qualità e la varietà dell’alimentazione dei viaggiatori del mare. Le erbe e le spezie usate in abbondanza coprivano in parte il sapore degli ingredienti viziati e spesso avariati. La fortunata cattura di una tartaruga marina era motivo di gioia perché fonte di un insperato prelibato pasto. Un caso limite ce lo testimonia Pigafetta nel suo diario di bordo redatto durante la traversata del Pacifico nel 1520, dove si legge << Mangiavamo biscotto non più biscotto, ma polvere di quello con vermi a pugnate perché essi avevano mangiato il buono: puzzava grandemente di orina de sorci e bevevamo acqua gialla putrefatta per molti giorni e mangiavamo certe pelli de bove, che erano sopra l’antenna maggiore ( n.d.r.: strisce di cuoio che rifasciavano le scanalature di testata degli alberi, fungendo da carrucole così da consentire, con un minimo attrito, lo scorrervi delle sartie per issare le vele ) a ciò che l’antenna non rompesse la sartia …..e ancora assai volte segatura di asse. Li sorci si vendevano a mezzo ducato l’uno e se pur ne avessimo potuto avere …>>
Le spezie che trovarono abbondanti e rigogliose in loco, la facevano quindi da padrone. Salse di peperoncino, con l’aggiunta di limone e succo di lime marinavano carne e pesce. Alla cucina caraibica dobbiamo la realizzazione del primo pepatissimo stufato, altro che l’ungherese Gulasch! Oltretutto queste “droghe”un po’ camuffavano i cibi quando iniziavano ad alterarsi, rendendoli ancora appetibili. Così è nato pure il nostro livornese Cacciucco; reso forte per rendere appetibile quel pesce di ritorno, invenduto al mercato. Non esistevano però precise ricette di bordo, in quanto di volta in volta si modificavano e aggiungevano nuovi ingredienti. Importante, lo abbiamo visto, l’utilizzo delle spezie locali, come il curry in polvere, sempre presente sulle carni, dello zafferano peyi , il pepe bianco e nero, il cumino e tutte le varietà di peperoncini.
I nativi della zona, gli Indiani Carib, hanno contribuito a caratterizzare con forte impatto la storia della zona dei Caraibi, tanto che da quella tribù il sito prese nome.
Presto i Caraibi divennero il crocevia del mondo. Venduti dagli europei, arrivarono i primi schiavi provenienti dall’Africa, e con essi nuove “contaminazioni” alimentari. La cucina caraibica si arricchì così con l’introduzione di torte di pesce, manioca, mango, ackee, budini e souse. Ma anche banane e farina di mais.
Gli uomini provenienti dal continente africano erano anch’essi cacciatori nelle loro terre e quindi spesso e per lunghi periodi lontani da casa. Sapevano cucinare carne di maiale piccante su carboni ardenti, e codesta tradizione si affinò maggiormente in Giamaica. Questa preparazione, oggi conosciuta come “jerk”, comporta un lungo processo di cottura della carne. Tutt’ora in molti piatti prelibati giamaicani troviamo ancora il pollo ed il maiale. Dai marinai portoghesi arrivò il baccalà: il riso e la senape, dalla Cina.
Il clima caldo ed in passato anche la scarsità di legname, fecero prediligere metodologie di cottura veloci, quale fritture e grigliate, molto raramente cotture in forno.
La maggior parte dei visitatori che si recano ai Caraibi mai immaginerebbe che gli alberi da frutta così familiari e rigogliosi in queste isole, siano stati introdotti invece dai primi esploratori spagnoli. Da quella nazione giunsero infatti arance, lime, zenzero, banane, fichi, palme da datteri, uva, tamarindi, noci di cocco e canna da zucchero.
Proprio da quest’ultima, si realizzò, attraverso un processo di distillazione, un liquore molto calorico e ad alta gradazione alcolica: il rum, l’indispensabile protagonista del rito finale che chiude sempre gli Zafarrancho (riunione conviviale) degli attuali Fratelli della Costa.
All’America dobbiamo l’introduzione di fagioli, mais, pomodori e patate. Dai Caraibi questi alimenti si diffusero poi nel resto del mondo. Una menzione va anche all’albero del pane dai frutti assai particolari, che ricorderemo presente nel film “Gli ammutinati del Bounty”.
L’elenco potrebbe continuare … Non c’e da meravigliarsi quindi se la Cucina Caraibica sia una commistione così ricca, colorata, creativa e variegata, coacervo di sapori provenienti da ogni dove: Africa, India, Cina, insieme alle influenze giunte dalla Spagna, Portogallo, dalla Danimarca, Francia e Gran Bretagna. I cibi caraibici sono stati influenzati dalle culture di tutto il mondo, ma ogni isola ha assunto ed aggiunto il suo particolare sapore e le proprie tecniche di cottura.
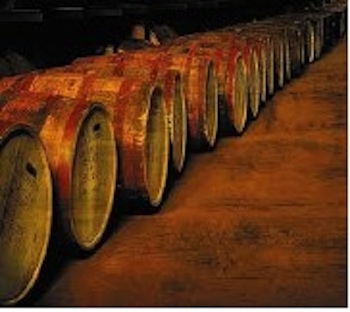
Qualche cenno specifico, luogo per luogo, in una sorta di aggiornato itinerario gastronomico.
Partendo dagli aperitivi non possiamo non menzionare un bicchiere di punch al rum agricole , prezioso distillato e vera istituzione caraibica, parte integrante della cultura delle Antille. E’ considerato uno dei migliori del mondo, l’unico ad aver ottenuto il riconoscimento della DOC locale. Si consuma puro o mescolato a innumerevoli cocktails. Comparve per la prima volta nel 1635 alla “Mardinica”, l’isola dei fiori, antico nome della Martinica. Bevanda regina, possiede un proprio museo sito a Sainte-Marie, dove si può ripercorrere la sua lunga storia.
La cucina Dominicana è prevalentemente di ispirazione spagnola e africana. Molto simile a quella di altri paesi latino-americani, ma con nomi assai differenti. Il piatto-colazione è a base di uova e mangù, diffuso anche a Cuba e Puerto Rico. Può essere accompagnato da fritti di carne e formaggi. Il pranzo è in genere il pasto principale della giornata, e consiste in riso, carne di pollo o maiale, o pesce, fagioli e insalate. La bandera, uno dei piatti tipici, si compone di carne e fagioli rossi su riso bianco. Soncocho è uno stufato cucinato con ben sette varietà di carni. Molte pietanze si realizzano con sofrito, ampia miscela di erbe locali, che ne esaltano i sapori. Ricca la lista dei dolci, dalla torta dominicana ( bizcocho ) ai flan, dulce de leche e cana ( canna da zucchero ). Bevande diffuse birra, rum, batida ( frullato ) e jugos naturales, succhi di frutta appena spremuti.
In Guadalupa, seconda consumatrice al mondo di pesce, troveremo ottime zuppe di vongole, aragoste alla griglia, fricassea di lambis, sorta di conchiglioni locali originari dell’Oceano Indiano. Da quasi 100 anni si rinnova nel mese di Agosto un vero e proprio evento del patrimonio culturale della Guadalupa, la “festa delle cuoche”, ghiotta occasione per gustare prelibatezze preparate secondo ricette ancestrali.
Nel periodo pasquale in Martinica, imperdibili le Fiere dei granchi accompagnate da grandi frittelle ripiene di carne e verdure, o altre farcite con merluzzo e verdure, cuori di palma in insalata, e pollo alle spezie, prelibato ed entusiasmante concentrato della cucina creola. Frutta e verdura locale da scoprire nei variopinti mercati locali, dove si troveranno anche caffè e cacao.
Capitale gastronomica dei caraibi è però considerata Saint-Martin. Straordinari i lolos, sorta di punti di ristoro all’aperto in riva al mare dove è possibile gustare pesce, crostacei di ogni tipo, cucinati si improvvisate griglie e che fanno concorrenza ai tradizionali ristoranti che si incontrano nelle caratteristiche stradine. Imperdibili specialità sono il melone maturato a quel sole ed il caffè caraibico, come pure il “cibo degli Dei”, il cacao, sotto forma di praline e tavolette.
Concludendo questo “breve viaggio” nei paesi sudamericani che si affacciano sul Mar dei Caraibi, dalla storia lunga, sofferta e gioiosa, la cucina caraibica ne esce come unica ed esprime la singolare ed immensa fusione di unione di sapori, colori e profumi che solo la gastronomia di tutti i popoli che vi hanno contribuito, ha saputo portare ad un risultato così stupefacentemente universale.
Un ultimo suggerimento ai possibili viaggiatori: diffidate sempre, se volete mangiare veramente creolo, dei locali che inalberano vistosi riferimenti ai pirati dei caraibi. Sono specchietti per le moderne allodole.

Renzo BAGNASCO
Ricerche a cura di Rosa Grazia ALLARIA
Foto a cura del webmaster Carlo GATTI
Rapallo, 11 Maggio 2014
GALERE GENOVESI: Vita di bordo
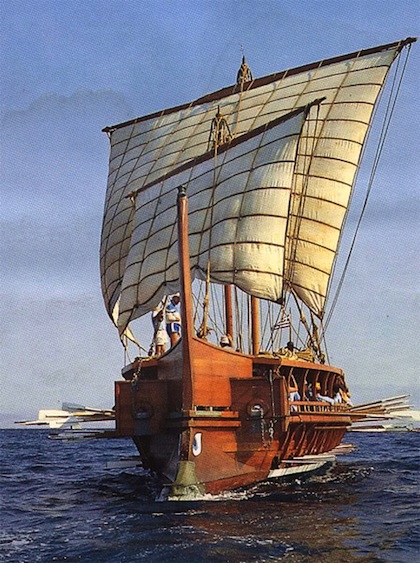
GALERE GENOVESI
VITA DI BORDO


Ciò nonostante imbarcarsi per molti voleva dire uscire dalla disperazione o fuggire dai rigori della giustizia. Fra loro cerano anche ex galeotti che, usciti a fine pena dalle patrie galere non avendo ancora pagato i debiti per i quali erano colà finiti comprese le spese processuali, con l’ingaggio si illudevano di potersi riscattare. Abbiamo detto che non erano incatenati ma ci sono documenti della Repubblica di Genova che puntualizzano << il buonavoglia a termini del suo contratto è esente di giorno dalla catena a differenza del forzato…..ma se commette mancanza può essere condannato per qualche tempo alla continua catena…>>
Circa poi la possibilità di contrarre debiti anche mentre vogavano e quindi impossibilitati a sbarcare sino a saldo effettuato, era abbastanza facile perché << il buonavoglia doveva pagarsi tutti gli extra dall’alimentazione al vestiario, dai medicinali ai debiti di gioco contratti durante le pause>> ad ognuno di questi debiti, di volta in volta, faceva fronte il Comandante che, alla fine, doveva però essere rimborsato; in caso di impossibilità, il disgraziato poteva estinguere l’impegno restando…… ancora a remare.
Come si vede questa gente rappresentavano la feccia dell’epoca; non si capisce come un gruppo di intellettuali di Genova, per dare una mano alla Città, si sia in questi ultimi tempi associato appropriandosi di quel nome. Che abbiano erroneamente interpretato quel tristo ricordo come sinonimo di “spontanea buona volontà”, che è altra cosa?
L’altra volta abbiamo visto come le galere, per mole e carenatura, viaggiassero solo da Marzo ad Ottobre quando il mare è relativamente calmo e le giornate di luce sono più lunghe, con la indispensabile necessità di ridossarsi ogni sera anche per rifornire la cambusa.
Durante gli altri mesi i galeotti venivano rinchiusi nelle apposite galere che all’epoca erano edificate su di uno scoglio nel porto: se condannati, scontavano lì i restanti giorni di pena. Erano però riscattabili “ pagandoli” 400 formaggette l’uno. Valevano ben poco.

Museo Galata Genova
A bordo, incatenati o no, tutti sedevano su dei banchi larghi 25 cm che di giorno fungevano da sedile e, di notte, da giaciglio o, più correttamente, da appoggio per tentare di dormire. Fra banco e banco c’era la “banchetta” ovvero una tavola parallela ai banchi su cui sedevano, ma più in basso di questi e sulla quale i vogatori appoggiavano un piede per puntellarvisi durante lo sforzo della voga.

Una fedele riproduzione di una di queste galere è oggi visitabile al Museo Navale “Galata”, nel porto di Genova.
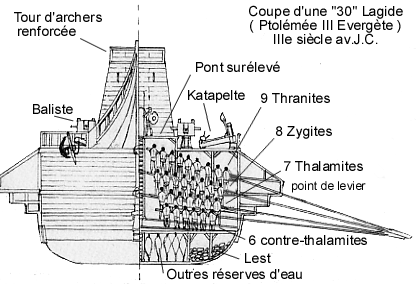
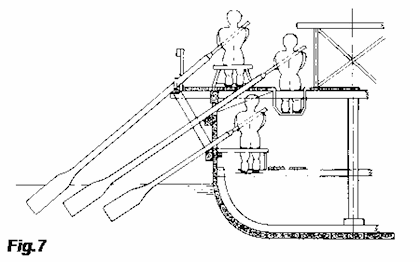
La vita assolutamente disumana che a bordo conduceva la ciurma ci è ben descritta, anche se riferita a galere francesi, da Jean Marteille de Bergerac nobile colà condannato per le sue malefatte. Lo scrive nelle sue memorie edite in Rotterdam nel 1757: suo malgrado fu, all’inizio del ‘700, ospite di una di queste e così descrive la sua esperienza di galeotto << Si immaginino, se possibile, sei uomini incatenati seduti ai loro banchi; (la maniglia del) remo tra le mani, un piede è sulla banchetta, grossa sbarra di legno inchiodata alla panca (banco) e l’altro sul banco davanti. Il corpo allungato, le braccia rigide per spingere innanzi il remo fin sopra il dorso di quelli che sono dopo, intenti nel medesimo movimento (indispensabile rispettare il sincrono). Dopo aver così portato avanti il remo, lo si alza per tuffarlo in mare, e, contemporaneamente, ci si getta o meglio, si precipita indietro per ricadere sul proprio banco, il quale per attutire il colpo di questa pesante caduta, è coperto da un cuscinetto>> e prosegue << E’ vero che una galera non può attraversare i mari con questo sistema, e che ci vuole necessariamente una ciurma di schiavi, ed un còmito che eserciti la sua dura autorità per farli vogare non già per un’ora, né per due, ma persino per dieci, dodici ore consecutive. Rammento di aver remato per ben ventiquattrore, senza un istante di tregua. In questi casi i còmiti e gli altri marinai ci nutrivano mettendoci in bocca un pezzo di galletta inzuppata nel vino e senza che noi togliessimo le mani dai tremi, perché non cadessimo svenuti>> Oggi sappiamo che in quei frangenti veniva somministrato anche dell’hashis e continua << E non si udivano che le urla degli infelici, intrisi di sangue sotto i colpi del flagello; lo schioccare delle corde sui dorsi dei miserabili, le ingiurie e le più atroci bestemmie dei còmiti schizzanti rabbia e minaccia quando la loro galera non andava come avrebbe dovuto o non navigava al pari delle altre>>
E’ vero che la vela ha soppiantato il remo come mezzo di sostentamento del moto, ma il trattamento alla ciurma non variò di molto.
Renzo BAGNASCO
Foto a cura del webmaster Carlo GATTI
Rapallo, 19 Aprile 2014
GALERE GENOVESI: Cosa si mangiava a bordo?
GALERE GENOVESI
COSA SI MANGIAVA A BORDO?
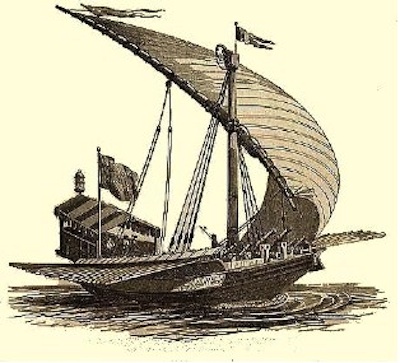
Galea trireme. Bastimento sottile, di circa 50 metri di lunghezza, largo circa 7, con due metri di pescaggio
Siamo nel XV° secolo su di una galera genovese non da guerra, del tutto paragonabile alle altre simili, battenti bandiere di altri Stati. Il nome di questa imbarcazione diventò, ed è tutt’ora, sinonimo di prigione. A bordo c’erano un Capitano, due Gentiluomini di poppa rappresentanti l’Armatore o chi ci aveva messo i soldi, uno scrivano, tre Sottufficiali ( i còmiti), un Pilota, un Chirurgo, un Aguzzino che sapeva ben usare lo staffilo, undici marinai per le vele, trenta marinai per le funzioni più varie, quattro addetti alla manutenzione, e duecentosessanta rematori ai ferri, la così detta “ciurma”.
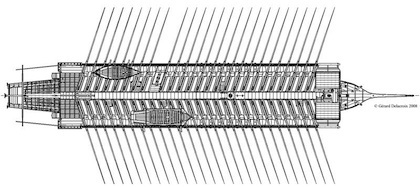
Questa era composta da un 20/28 per cento di schiavi, 35/45% da forzati colpevoli di gravi reati e costì condannati e da un 30/50 % da buonavoglia, disperati che per una misera paga si assoggettavano volontariamente a quella vita d’inferno. Queste imbarcazioni navigavano da Marzo ad Ottobre e solo di giorno perché di notte doveva ridossarsi per dormire e ricaricare le derrate e l’acqua consumate durante il giorno. Barche non adatte a tenere il mare (avevano chiglia piatta) sottocoperta avevano sei gavoni così utilizzati: uno leggermente sopraelevato di poppa per il Capitano ed i Gentiluomini. Subito accanto lo “scandolaro” per contenere le armi, gli assi e i teloni da rapidamente montare per riparare dalle improvvise piogge i vogatori, poi la dispensa (detta “compagna”), il pagliolo, la camera di mezzo ed in fine il gavone per le vele. I sottufficiali e gli altri membri “liberi” dell’equipaggio si arrangiavano a dormire dove potevano;

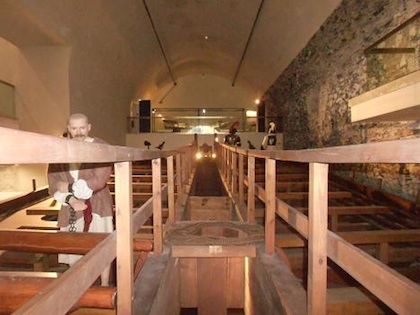
i galeotti restavano in catene e sonnecchiavano sul posto “di lavoro”. Il ponte era tagliato in mezzeria da un camminamento che divideva per il lungo i due banchi dei rematori e su di esso camminava l’aguzzino; al centro il fogon per preparare il rancio, rigorosamente una volta al giorno all’imbrunire. I maligni dicono per non far veder cosa si mangiava.
Già, ma cosa si mangiava?
Gli unici ad avere pasti quasi normali erano il Comandante e i Gentiluomini, il restante equipaggio poteva contare su di un po’ di baccalà condito con un filo d’olio, a volte pasta o riso e un po’ di carne conservata essicata e una razione di vino.

Ai rematori invece era riservato un po’ di “biscotto” le classiche gallette sia nei periodi di voga estivi che quando, d’inverno, erano rinchiusi nella loro galera. Venivano sbriciolate a formare una specie di puré; due volte al mese una minestra di fave, riso e olio e nelle solennità religiose, se non costretti a digiunare secondo il dettato di Santa Romana Chiesa per una specifica ricorrenza, una libbra di carne (300 gr circa) ed un boccale di vino (73 cl); spesso e volentieri, per nascondere il puzzo di “rancido” delle derrate mal conservate (da cui il nome “rancio”) veniva spruzzato con aceto. Questo a Genova.
Il “menù” della Marineria Pontificia invece prevedeva 850 gr di gallette e, tre volte alla settimana, una minestra che veniva però eliminata d’estate. I Veneziani passavano 650 gr di gallette, 4 tazze di vino di “onesta misura”e una scodella di minestra; quattro volte alla settimana 240 gr di carne e tre volte 160 gr di formaggio. Il Mercoledì ed il Venerdì 2 sardelle.
Più parca la Marineria Toscana dava 500 gr di gallette e una minestra di cavoli, rape e fave mentre, solo nelle solennità annuali, era prevista della carne fresca pari a 340 gr a testa, oltre a ½ litro di vino. Le fave saranno rimpiazzate poi dai fagioli portati da Colombo con il vantaggio di essere meno flatulenti e più nutritivi.
Nei momenti in cui era richiesto il massimo sforzo ai remi, è documentato che a volte erano costretti a remare anche per 24 ore consecutive, venivano imboccati dagli aguzzini. Recenti ricerche hanno rivelato che ai rematori, nei momenti sopra descritti, quando ne il vino ne le scudisciate riuscivano a garantire il ritmo infernale imposto, venivano ammannite dosi di hashish, con funzione di sovra alimentatore, un po’ come oggi fanno i turbo nei nostri motori.
E’ stato calcolato che le 3000/4000 calorie ingerite avrebbero potuto essere sufficienti se fossero state dispensate regolarmente. In realtà lo zelo maniacale dei Comandanti a far rispettare i digiuni prescritti dalla pratica religiosa, lo documentano i diari di bordo, era applicato con una meticolosità che è difficile oggi stabilire se per profonda fede o non piuttosto come scusa per risparmiare a proprio favore il <non speso>, rendeva la vita di quei poveri disgraziati, se possibile, ancor più grama.
Durante i turni massacranti ai remi, sotto i colpi delle sferze degli aguzzini, le bestemmie se le potevano permettere solo i vogatori delle galere che battessero bandiera di Stati non cattolici, perché per questi ultimi vigeva la norma << Chi biastamerà Dio over la sua Madre, et Santi et Sante, sel sarà huomo da remo sia frustato da poppa a prua; sel sarà huomo da poppa, dieba pagar soldi cento>>
Forse è per reazione a questo forzato silenzio repressivo del proprio sentire che i liberi marinai di Genova, una volta abolite le galere, poterono contare su di un particolare contratto di lavoro articolato su due diverse paghe che essi stessi potevano scegliere al momento dell’ingaggio per l’imbarco: paga più elevata se si rinunciava, durante il lavoro, al “mugugno” oppure paga sensibilmente più modesta ma con il diritto a “mugugnare”.
I genovesi preferivano, in genere, questa seconda. E poi non vogliamo sentirci dire che un po’ strani lo siamo.
Renzo BAGNASCO
Foto a cura del webmaster Carlo GATTI
Rapallo, 19 Aprile 2014
L'OPERAZIONE "GROG"
L’OPERAZIONE “GROG”
Il bombardamento navale di Genova del 9 febbraio 1941, effettuato dalle unità della “Forza H” al comando dell’amm. Somerville: l’interpretazione britannica del “command of the sea” nel Mediterraneo occidentale e le manchevolezze dello strumento aeronavale italiano poche settimane prima di Matapan.
Nel corso della seconda guerra mondiale, il Mar Ligure ha costituito un teatro operativo quasi di secondo piano: infatti, non sono molti gli eventi navali di rilievo che hanno avuto luogo nel Golfo di Genova e nelle acque limitrofe, e – tra il 1940 e il 1943 – le potenzialità industriali e cantieristiche della Liguria ebbero sicuramente preminenza rispetto ad aspetti più propriamente bellici ed operativi.
In realtà, il 14 giugno 1940, dopo soli quattro giorni dall’entrata in guerra dell’Italia, quattro incrociatori ed undici cacciatorpediniere francesi – usciti da Tolone – erano giunti di sorpresa di fronte alle zone industriali di Savona-Vado e Genova effettuando un breve bombardamento. La pronta reazione delle batterie costiere, dei treni armati della Regia Marina e l’intervento della torpediniera Calatafimi costrinsero al ritiro la squadra francese che, sulla rotta di rientro, fu anche attaccata dai Mas della 13a Squadriglia (1).
L’armistizio tra l’Asse e la Francia, tuttavia, rese le acque liguri molto più tranquille e – nel contempo – la Regia Marina e la Royal Navy furono subito coinvolte nella protezione diretta e indiretta dei propri traffici convogliati, su rotte la cui natura rendeva inevitabile il confronto tra le due flotte nel Canale di Sicilia, nelle acque libiche, nella zona di Malta e nel Mar Ionio (2).
Se allo scontro di Punta Stilo la Regia Marina poteva allineare due sole corazzate (Giulio Cesare e Conte di Cavour), all’inizio dell’autunno del 1940 la squadra da battaglia italiana era forte di sei unità, con il rientro in servizio dell’Andrea Doria e del Caio Duilio successivo a un lungo periodo di lavori di rimodernamento, e la piena operatività delle nuove “35.000” Vittorio Veneto e Littorio.

Il Renown all’ancora a Scapa Flow, all’inizio del 1942. L’incrociatore da battaglia partecipò al bombardamento navale di Genova in questa configurazione di armamento; tuttavia, all’epoca, l’unità era ancora verniciata con il grigio scuro tipo “Home Fleet”, dato che la mimetizzazione fu applicata solamente verso l’estate del 1941, (Foto imperial War Museum)
Questo consistente e omogeneo gruppo di unità maggiori costituiva una notevole fonte di preoccupazione per i vertici della Mediterranean Fleet: fu pertanto pianificato l’attacco contro la base di Taranto nel corso del quale, la notte sul 12 novembre 1940, gli aerosiluranti “Swordfish” della portaerei Illustrious danneggiarono le corazzate Littorio, Duilio e Cavour. I lavori di riparazione del Littorio si svolsero presso l’Arsenale di Taranto, mentre il Duilio – rimesso in condizioni di galleggiabilità ai primi di gennaio 1941 – raggiunse Genova il 28 gennaio venendo subito immesso in bacino per il completamento del raddobbo. Il Cavour, danneggiato molto più gravemente, fu trasferito a Trieste ma – all’atto della proclamazione dell’armistizio l’8 settembre 1943 – i lavori di ricostruzione erano ancora ben lontani dall’essere terminati (3).
Le tre restanti corazzate efficienti (Veneto, Doria e Cesare) furono dislocate prima a Napoli e poi alla Spezia, per allontanarle dalla minaccia costituita dall’aviazione navale inglese, ma i loro movimenti erano seguiti – sia pure con precisione non assoluta – dalla ricognizione e dai servizi informativi della Marina britannica. Verso la fine di gennaio del 1941, difatti, la Royal Navy riteneva che a Genova si trovassero ai lavori il Littorio e il Cesare; in realtà si trattava invece del Duilio e del Cesare, ma quest’ultimo si trasferì alla Spezia ai primi di febbraio, raggiungendo colà il Veneto e il Doria.
Da qualche tempo, considerati gli ottimi risultati conseguiti nella “Taranto Night”, i Comandi della Royal Navy stavano meditando di realizzare una nuova azione di notevole effetto dimostrativo, oltre che militare, contro un obiettivo costiero italiano.
Nei comandi britannici iniziò quindi a maturare la convinzione che convenisse attaccare un porto nel Tirreno per dare l’impressione alla Regia Marina che neppure le nostre basi nella zona potessero essere ritenute sicure, e la città di Genova fu prescelta come obiettivo di un bombardamento navale per molteplici motivi.
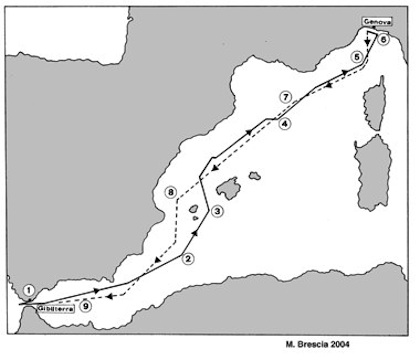
La rotta seguita dalla “Forza H” nel corso dell’operazione “Grog”. Linea continua: rotta di andata – Linea tratteggiata: rotta di ritorno.
1 – Uscita da Gibilterra delle unità inglesi tra le 12.00 e le 17.00 del 6 febbraio 1941
2 – Posizione alle 19.25 del 7 febbraio
3 – Ore 02.00 dell’8 febbraio: i ct. Jupiter e Firedrake vengono distaccati presso le Baleari per effettuare trasmissioni r.t. aventi lo scopo di trarre in inganno le stazioni radiogoniometriche italiane
4 – Posizione alle 20.00 dell’8 febbraio
5 – Posizione alle 05.10 del 9 febbraio
6 – Azione di fuoco condotta tra le 08.14 e le 08.45 del 9 febbraio
7 – Posizione alle 20.00 del 9 febbraio
8 – Posizione alle 14.00 del 10 febbraio
9 – Rientro a Gibilterra della “Forza H” nel pomeriggio dell’11 febbraio 1941
Innanzitutto, le strutture industriali della città ne facevano un obiettivo di grande importanza dal punto di vista economico, militare e psicologico; le difese costiere di Genova risultavano di entità poco temibile e – in ultimo - i grandi fondali del Golfo Ligure, fin sotto la costa, avrebbero permesso alle navi di avvicinarsi a distanza utile di tiro, senza correre il rischio di incappare in campi minati.
La presenza a Genova di due corazzate italiane fu nota a Gibilterra solamente alla fine di gennaio (anche se, come abbiamo visto, dall’inizio di febbraio nel porto ligure si trovava il solo Duilio) e – a differenza di quanto affermato nel dopoguerra anche da una certa memorialistica britannica – non costituì l’elemento principale nella pianificazione di un’azione dalle preminenti valenze emozionali e strategiche, compresa una “dimostrazione di forza” nei confronti della Spagna franchista, allo scopo di farne perseverare la politica di neutralità.
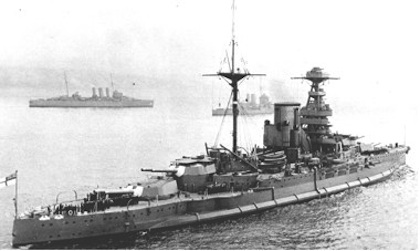
La nave da battaglia Malaya nel 1931/32, probabilmente a Gibilterra, successivamente ai lavori di radicale ricostruzione svoltisi presso l’Arsenale di Portsmouth tra il settembre 1927 e il febbraio 1929. Oltre al miglioramento della protezione e dell’apparato motore, una modifica estetica molto importante riguardò gli scarichi delle caldaie, riuniti in un unico fumaiolo di grandi dimensioni che rimpiazzò i due originari. La Malaya è verniciata con il grigio scuro delle unità appartenenti alla Home Fleet; sullo sfondo, un incrociatore pesante tipo “County” (a sinistra) e – a destra – l’incrociatore pesante York. (Coll. M. Brescia)
La “Forza H”

La portaerei Ark Royal, in una fotografia risalente ai primi mesi della seconda guerra mondiale. L’unità è sorvolata da alcuni aerosiluranti Fairey “Swordfish” che – sebbene antiquati e dalle prestazioni non certo eccezionali – giocarono un ruolo fondamentale nell’attacco contro la base navale di Taranto (notte sul 12 novembre 1940), e nelle operazioni che portarono all’affondamento, in Atlantico, della corazzata tedesca Bismarck (maggio 1941). (Coll. M. Brescia)
Durante la seconda guerra mondiale, e non soltanto per quanto riguarda il teatro del Mediterraneo, la Royal Navy identificò spesso i propri gruppi o “Forze” navali (“Forces”) secondo un metodo alfabetico. Nel tempo, ad esempio, operarono la “Forza K” (da Malta), la “Forza Q”, la “Forza Z” (in Estremo Oriente), la “Forza A”, ecc.; la “Forza H” fu costituita a Gibilterra verso la fine di giugno del 1940 per colmare il “vuoto” navale venutosi a creare nel Mediterraneo occidentale in seguito all’armistizio tra la Francia e l’Asse.
Al vertice della “Forza H” fu destinato l’amm. Sir James Somerville al comando del quale, inizialmente, furono posti l’incrociatore da battaglia Hood, le corazzate Resolution e Valiant, la portaerei Ark Royal, incrociatori e cacciatorpediniere, tutte unità trasferite dalla Home Fleet.
Ancorché di base a Gibilterra (sede di un Comando Superiore navale), la “Forza H” era un reparto autonomo, e l’amm. Somerville dipendeva direttamente dall’Ammiragliato di Londra; questa peculiare situazione era dovuta alla natura strategica della “Forza H” che – per la particolare posizione di Gibilterra – poteva essere chiamata ad operare flessibilmente, come in effetti avvenne, tanto in Atlantico quanto nel Mediterraneo.
Una delle prime uscite operative della “Forza H” fu l’azione contro le navi francesi a Mers-el-Kebir (3/6 luglio 1940) (17). Unità della “Forza H”, che avevano nel frattempo sostituito parte di quelle originarie, furono presenti alla battaglia di Capo Teulada (27 novembre 1940), al bombardamento navale di Genova e alla ricerca della Bismarck (maggio 1941), andando inoltre a costituire la scorta di numerosi convogli in Atlantico e nel Mediterraneo tra il 1941 e il 1942.
La “Forza H” operò attivamente nel corso degli sbarchi in Nord Africa del novembre 1942 (operazione “Torch”) e degli sbarchi in Sicilia e a Salerno dell’estate 1943 (operazioni “Husky” e “Avalanche”). Poco dopo l’armistizio fra l’Italia e gli alleati, venuta a cessare la minaccia costituita dalla flotta italiana, il Comando fu disciolto e le unità che ne facevano parte furono riassegnate alla Home Fleet ed alla Eastern Fleet della Royal Navy.
I preliminari e l’esecuzione di “Grog”

Un’immagine prebellica dell’incrociatore Sheffield, datata 24 giugno 1938, scattata a Portsmouth e proveniente dal noto archivio fotografico “Wright & Logan”. Si noti la linea elegante – ancorché massiccia – dell’unità, con i due hangar razionalmente posizionati ai lati del fumaiolo prodiero. Sui “Southampton”, per la prima volta a bordo di incrociatori britannici, l’armamento principale da 152 mm era sistemato in torri trinate. (Foto Wright & Logan)

La nave da battaglia Vittorio Veneto, a bordo della quale imbarcò l’amm. Jachino durante l’infruttuosa ricerca delle unità inglesi che bombardarono Genova il 9 febbraio 1941. Il Veneto è qui ripreso all’ormeggio alla boa, nel Mar Grande di Taranto, nella tarda estate del 1940. (Coll. A. Fraccaroli)

Tra le unità facenti parte della ”Forza H” il 9 febbraio 1941 vi era anche il cacciatorpediniere Encounter, qui raffigurato nel luglio 1938, in uscita dalla base navale di Portsmouth. Anche a distanza ravvicinata, soprattutto negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale, era piuttosto difficile distinguere esternamente i caccia appartenenti alle classi dalla “A” alla “I”. L’Encounter è verniciato con il grigio scuro delle unità facenti parte della “Home Fleet”. (Foto Wright & Logan, g.c. Biblioteca “A. Maj”, Bergamo, Fondo “Occhini”)

L’ammiraglio Sir James Somerville a bordo del Renown
(D.S.O., K.C.B., K.B.E., G.C.B., G.B.E.)
Comandante della “Forza H” – luglio 1940 / marzo 1942
L’ammiraglio Sir James Somerville era preposto al comando della “Forza H” sin dalla sua costituzione nell’estate del 1940, e – a gennaio del 1941 – coordinò la pianificazione dell’operazione “Grog”, il bombardamento navale di Genova del 9 febbraio successivo.
James Somerville era nato a Weybridge, nel Surrey, il 17 luglio 1882; nel 1897 entrò a far parte – come cadetto – della Royal Navy raggiungendo, nel 1904, il grado di sottotenente di vascello.
Durante la prima guerra mondiale si specializzò nel campo delle radiotrasmissioni sino a diventare uno dei massimi esperti della Marina britannica in questa innovativa materia; capitano di fregata nel 1915, nel 1916 fu decorato con il Distinguished Service Order (D.S.O.) per il servizio prestato a Gallipoli e nei Dardanelli.
Nel 1921 giunse la promozione a capitano di vascello e – in questo grado – seguirono numerose destinazioni di servizio: direttore dell’Ufficio Segnalamenti dell’Ammiragliato, aiutante di bandiera dell’amm. John D. Kelly, istruttore all’Imperial Defence College e comandante dell’incrociatore HMS Norfolk.
Promosso commodoro nel 1932 e contrammiraglio (Vice Admiral) l’anno successivo, tra il 1935 e il 1938 fu il comandante delle Flottiglie ct. della Mediterranean Fleet. Nel 1939, prima del suo ritiro dal servizio attivo (18), all’atto del quale fu decorato con la nomina a Cavaliere dell’Ordine del Bagno (K.C.B.), fu il C. in C. del settore navale delle Indie Orientali con il grado di ammiraglio di divisione (Rear Admiral).
Nel maggio del 1940 l’amm. Somerville fu richiamato in servizio, entrando inizialmente a far parte dello “staff” dell’amm. Bertram Ramsay che pianificò l’evacuazione del corpo di spedizione inglese da Dunkerque. Successivamente – a luglio – con il grado di ammiraglio di squadra (Admiral) gli fu assegnato il comando della “Forza H”, appena costituita a Gibilterra.
In poco meno di due anni, Sir James Somerville portò più volte al combattimento la “Forza H”: Mers-el-Kebir (luglio 1940), Capo Teulada (novembre 1940), operazione “Excess” (rifornimento di Malta, gennaio 1941), bombardamento navale di Genova (febbraio 1941), caccia alla Bismarck (maggio 1941), operazione “Halberd” (un altro rifornimento di Malta, settembre 1941). Per i risultati ottenuti, alla fine del 1941 fu decorato con il cavalierato dell’Ordine dell’Impero Britannico (K.B.E.).
A marzo del 1942 l’amm. Somerville passò al comando della Eastern Fleet della Royal Navy, la cui base principale si trovava a Trincomalee nell’isola di Ceylon: seguì un lungo periodo dedicato al rafforzamento delle strutture logistiche ed operative della Flotta seguito – tra marzo e luglio del 1944 – da numerose operazioni contro capisaldi giapponesi nella zona (Isole Cocos, Sabang, Soerabaya e Sumatra).
Ad agosto del 1944 fu rilevato al comando della Eastern Fleet dall’amm. Bruce Fraser e, nominato cavaliere di Gran Croce dell’Ordine del Bagno (G.C.B.), fu destinato a Washington con l’importante incarico di capo della Delegazione Navale inglese presso il Governo degli Stati Uniti.
A maggio del 1945 Sir James Somerville fu promosso al grado di “Admiral of the Fleet” e, al momento del suo definitivo congedo dal servizio (1946) ricevette il cavalierato di Gran Croce dell’Ordine dell’Impero Britannico (G.B.E.).
Ritiratosi a Dinder House (Wells) nel Somerset, morì il 19 marzo 1949.
I Preliminari e l’esecuzione di “GROG”

Malta, novembre 1937. Un dettaglio della zona centrale di dritta della Malaya, recentemente rientrata in squadra dopo un periodo di lavori (ottobre 1934 / dicembre 1936) nel corso dei quali sono state imbarcate le sistemazioni aeronautiche ed è stato potenziato l’armamento antiaerei dell’unità. Si notino, difatti, la catapulta trasversale e, ai lati del fumaiolo, gli hangar e l’impianto quadruplo per mg. da 40 mm tipo “pom-pom”. Sulla torre “B” è applicata la “fascia di neutralità” blu bianca e rossa che identificava le unità inglesi all’epoca della guerra civile spagnola. (Foto Wright & Logan)
La “Forza H” (costituita dalla corazzata Malaya, dall’incrociatore da battaglia Renown, dall’incrociatore leggero Sheffield, dalla portaerei Ark Royal e da dieci cacciatorpediniere) lasciò Gibilterra il 31 gennaio 1941. Il gruppo navale fece rotta a Sud delle Baleari, con il duplice obiettivo di un attacco alla diga del Tirso in Sardegna con bombardieri ed aerosiluranti (il mattino del 2 febbraio), e del bombardamento navale di Genova il giorno successivo.
Come previsto dal piano di operazioni, otto velivoli dell’Ark Royal attaccarono la diga del Tirso alle 08.00 del 2 febbraio (senza tuttavia conseguire risultati di rilievo), ma le condizioni meteo in forte peggioramento sconsigliarono il proseguimento della missione, e le unità britanniche – sempre transitando a Sud delle Baleari – fecero rientro a Gibilterra nella tarda serata del 3 febbraio.
L’Ammiragliato predispose, con partenza il 6 febbraio, la ripetizione della missione, denominandola “Grog”, in accordo alla tradizione navale britannica che – durante la seconda guerra mondiale – assegnava ad ogni operazione un nome in codice scelto tra un’onomastica quanto mai varia e differenziata (4).
L’operazione “Grog” fu studiata con modalità esecutive che ne garantissero quanto possibile la segretezza e, nella fattispecie, le unità della “Forza H” (le stesse che avevano preso parte all’azione contro la diga del Tirso) furono suddivise in tre gruppi, con finta partenza in ore diurne verso l’Atlantico, simulando la protezione di un convoglio diretto in Gran Bretagna che si stava riunendo a Gibilterra. Tanto all’andata quanto al rientro era previsto il passaggio a Nord delle Baleari, con un itinerario del tutto nuovo e difficilmente presumibile da parte italiana; infine, il bombardamento navale di Genova avrebbe avuto la preminenza, con un attacco secondario degli aerei dell’Ark Royal sulla raffineria petrolifera di Livorno.

L’incrociatore da battaglia Renown nel 1919, poco dopo la fine della “Grande Guerra”. Insieme al gemello Repulse furono le penultime unità di questo tipo immesse in servizio dalla Royal Navy: saranno seguite – nel 1920 – dall’HMS Hood, affondato dalla corazzata tedesca Bismarck a maggio del 1941. (Coll. M. Brescia)
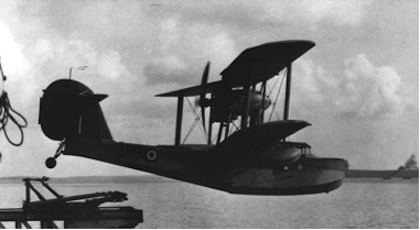
Un idro “Walrus” in decollo dalla catapulta di una nave britannica.

Una nota fotografia del Renown, datata 17 agosto 1943. A fine mese, il primo ministro Winston Churchill e i più importanti capi militari britannici (reduci dalla conferenza di Quebec) imbarcheranno ad Halifax sul Renown, a bordo del quale rientreranno nel Regno Unito. (Foto Imperial War Museum)

L’Ark Royal a marzo del 1939, in entrata a Portsmouth. La struttura cilindrica in testa d’albero alloggia un radiofaro “Type 72” per la guida degli aerei imbarcati; I cavi delle antenne radio sono tesi tra gli alberi a traliccio posti ai lati del ponte di volo. Tali strutture potevano essere abbattute verso l’esterno durante le operazioni di decollo e appontaggio dei velivoli. (Foto Wright & Logan)

Il Duncan verso la metà del 1942, quando – ormai destinato in Atlantico – faceva parte del Western Approaches Command della Royal Navy. Si notino le più significative modifiche apportate, nei primi anni di guerra, sui caccia di questo tipo: ribassamento del fumaiolo poppiero (per migliorare i campi di tiro delle armi antiaerei) e installazione di un radar per la scoperta di superficie tipo “271”, alloggiato nella struttura cilindrica che ha sostituito la d/t sul cielo della plancia. (Foto imperial War Museum A 20158, g.c. Biblioteca “A. Maj”, Bergamo, Fondo “Occhini”)
Le unità britanniche uscirono dalla base di Gibilterra nel pomeriggio del 6 febbraio 1941, apparentemente impegnate nella scorta di un convoglio effettivamente diretto in Inghilterra.
- tra le 12.00 e le 14.00 lasciarono il porto i cacciatorpediniere del Gruppo 2: Fearless (capo squadriglia) (5), Foxhound, Foresight, Fury, Encounter e Jersey, che diressero verso levante come se avessero dovuto effettuare un’esercitazione o un pattugliamento antisom
- Alle 13.30 lasciò la rada il convoglio, composto da 16 mercantili e 9 siluranti, diretto in Inghilterra.
- Alle 17.00 partirono il Renown, il Malaya, lo Sheffield e l’Ark Royal (Gruppo 1), insieme ai cacciatorpediniere del Gruppo 3 (Duncan, Isis, Firedrake e Jupiter).
I cacciatorpediniere del Gruppo 2, dopo aver effettuato una ricerca antisom nello stretto di Gibilterra, diressero verso il punto di riunione con le altre unità della “Forza H”, previsto a Nord di Maiorca per le 08.30 dell’8 febbraio.
Le unità dei Gruppi 1 e 3, una volta entrate in Atlantico, invertirono la rotta, ripassarono isolatamente lo stretto durante la notte e si riunirono circa 55 miglia a levante di Gibilterra verso le 04.00 del 7 febbraio. Alle 19.25 dello stesso 7 febbraio accostarono verso Nord/Nord-Ovest per passare tra Ibiza e Maiorca riunendosi, nella mattinata dell’8 con il primo gruppo di ct.
I caccia Jupiter e Firedrake furono distaccati a levante di Maiorca con l’ordine di effettuare trasmissioni r.t. che, se intercettate e radiogonometrate, avrebbero potuto trarre in inganno i Comandi italiani sull’itinerario realmente seguito dalla “Forza H” (il che, peraltro, non avvenne).
Nelle prime ore dell’8 la “Forza H” accostò verso Nord-Est attraversando, con questa direttrice, il Golfo del Leone per trovarsi, alle 03.00 del 9 febbraio, una cinquantina di miglia a Sud di Hyeres.
Da qui, la rotta delle unità inglesi proseguì per 70° in modo da raggiungere, attorno alle 06.00, una zona a Sud-Ovest del punto medio della congiungente Capo Corso / Genova.
Alle 05.00 la portaerei Ark Royal (scortata dai ct. Duncan, Isis ed Encounter) iniziò a manovrare autonomamente e, alle 06.00 raggiunse un punto equidistante (70 miglia) dalla Spezia e da Livorno e procedette al lancio di 14 “Swordfish” che effettuarono il previsto bombardamento della raffineria di Livorno e il minamento degli accessi al Golfo della Spezia.
Il Renown, il Malaya e lo Sheffield, scortati dai cinque cacciatorpediniere residui, accostarono verso Nord in modo da trovarsi, alle 07.52, ad una dozzina di miglia a Sud del promontorio di Portofino. Dopo aver fatto il punto, le navi ridussero la velocità a 18 nodi e accostarono per 290°. Su questa rotta, tra le 08.14 e le 08.45 del 9 febbraio 1941, avvenne l’azione di fuoco: alcune variazioni di rotta fecero sì che il bombardamento iniziasse ad una distanza di 19.000 metri, terminando a 21.200 metri e passando per la distanza minima di 16.200 metri alla trentesima salva del Renown.
Contro Genova furono sparati 125 proietti da 381 mm e 400 da 114 mm dal Renown; la Malaya sparò 148 colpi da 381 mm (6), mentre 782 furono i proietti da 152 mm dello Sheffield. In totale, circa 200 tonnellate di acciaio ed esplosivo si abbatterono sul capoluogo ligure.
Anche se, come già abbiamo avuto modo di rilevare, l’operazione “Grog” fu pianificata soprattutto con valenze strategiche riconducibili anche a situazioni di “guerra psicologica”, non va dimenticato che la città di Genova costituiva comunque una agglomerato rilevante di obiettivi molto importanti dal punto di vista portuale, cantieristico e industriale.
Innanzitutto lo stesso porto, da sempre fulcro dell’economia cittadina: alle calate ed agli accosti del “Porto Vecchio” e del “Bacino della Lanterna”, all’inizio degli anni Trenta era stato aggiunto il “Bacino di Sampierdarena”, protetto da una diga foranea di nuova costruzione e comprendente i Ponti Canepa, Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia. Nel 1941, come del resto anche oggi, importanti installazioni nell’ambito portuale di levante erano costituite dai bacini nella zona del Molo Giano, dagli accosti petroliferi di Calata Canzio, e dalla centrale elettrica situata ai piedi della Lanterna.
A ponente della foce del Polcevera si trovavano l’area industriale ed i cantieri navali della Società Ansaldo anche se, abbastanza stranamente, questi ultimi non furono colpiti con continuità dal fuoco britannico.
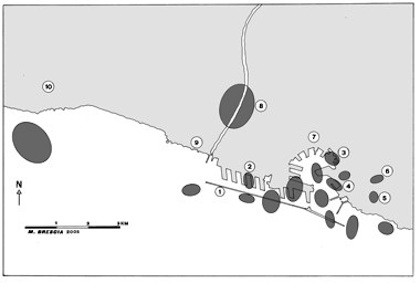
Bombardamento navale di Genova (aree più scure: zone ove registrò una maggior concentrazione dei punti di caduta dei colpi britannici)
1 – Molo Principe Umberto (attuale “diga foranea”)
2 – Ponti Eritrea e Somalia
3- Ponte Parodi
4- Zona Bacini
5- Zona dell’Ospedale Galliera
6- Stazione Brignole
7- Stazione Principe
8- Zona industriale della Valpolcevera
9- Cantieri Navali Ansaldo
10- Batteria “Mameli”
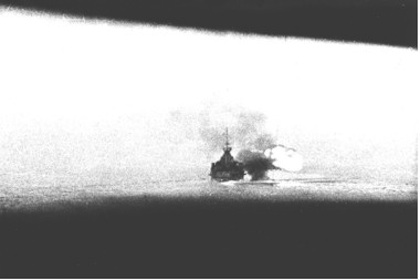
Un’immagine rara ed eccezionale: il Renown, ripreso dall’interno del torrione di comando della corazzata Malaya, mentre apre il fuoco durante il bombardamento navale di Genova. Si tratta, probabilmente, dell’unico documento fotografico raffigurante unità inglesi durante l’azione del 9 febbraio 1941. La formazione era composta dal Renown (capofila e nave ammiraglia), seguito da Malaya e Sheffield, con due cacciatorpediniere di scorta sul lato dritto (verso terra) e tre su quello sinistro. (Foto Imperial War Museum A4046, g.c. Biblioteca “A. Maj”, Bergamo, Fondo “Occhini”)

Uno “Swordfish” appartenente allo Squadron n° 818 e conservato in perfette condizioni di volo, ripreso recentemente in Inghilterra durante una manifestazione aerea. Un “Walrus” e due “Swordfish” osservarono e diressero il tiro delle navi britanniche durante il bombardamento navale di Genova. (Archivio Fleet Air Arm)

Nelle ultime versioni Mk IV e Mk V il “Walrus” venne denominato “Seagull”; qui vediamo il Mk V conservato al museo della RAF a Hendon, nei pressi di Londra. (Archivio Fleet Air Arm

Un palazzo di Piazza Cavour colpito da un proietto da 381mm, in una foto scattata – probabilmente – nel primo pomeriggio del 9 febbraio 1941. (g.c. Archivio !Il Secolo XIX”)
Infine, nella valle del Polcevera (tra Rivarolo e la foce del torrente) erano riunite numerose fabbriche, depositi petroliferi e di materiali, officine ed altre installazioni industriali che, di per se’, costituivano – dopo il porto – il gruppo di obiettivi più importanti dell’ambito genovese, e la concentrazione in una zona sostanzialmente ristretta di queste strutture facilitò sicuramente la conduzione e la direzione del tiro, contro di esse, da parte delle unità britanniche.
Poco meno del 50% dei proietti da 381 e 152 mm cadde in acqua; circa un terzo colpì la città, con particolare addensamento sulle zone del porto e della Val Polcevera. I colpi da 114 mm del Renown furono invece diretti verso la zona del Molo Principe Umberto (7), ma la loro concentrazione nel breve periodo in cui il Renown si trovò a distanze intorno ai 16.000 metri (prossime alla gittata massima dei cannoni di questo calibro) impedì la corretta osservazione dei punti di caduta.
Il bombardamento non colpì obiettivi militari; in effetti, l’unico bersaglio di questo tipo era costituito dalla nave da battaglia Caio Duilio ai lavori nella zona bacini del porto, ma nessun proietto raggiunse questa unità.
I danni subiti dalle unità mercantili presenti in porto furono minimi. Due colpi (di cui uno di grosso calibro) raggiunsero il piroscafo Salpi, che peraltro non affondò; un altro piroscafo – il Garibaldi – si trovava a secco in un bacino di carenaggio e riportò alcuni squarci nella carena; la nave scuola Garaventa (ex incrociatore-torpediniere Caprera del 1894), fu l’unica unità affondata durante il bombardamento navale.
In aggiunta alle industrie della Val Polcevera, nell’ambito portuale i proietti britannici raggiunsero soprattutto i ponti Somalia ed Eritrea, la darsena a levante di Ponte Parodi (attuale zona dell’Acquario), i Magazzini del Cotone e la zona dei bacini al Molo Giano.
Pressochè nulla la reazione delle difese costiere dell’area genovese, come ebbe modo di evidenziare anche l’amm. Somerville nella sua relazione sull’operazione “Grog” (8).
Un bombardamento effettuato in breve tempo, da una distanza non certo ravvicinata, e condotto più “per zone” che per obiettivi specifici non poteva non causare danni anche alle aree residenziali ed abitative della città.
Si dovettero registrare danni, anche gravi, in tutta la porzione del centro compresa tra la foce del Bisagno, la congiungente Brignole-Corvetto e la Stazione Principe; anche Sampierdarena fu colpita, nella zona prospiciente l’attuale Lungomare Canepa.

Un proietto da 381 mm che colpì, senza esplodere, la cattedrale di San Lorenzo. E’ tuttora conservato all’interno della chiesa, con a fianco una lapide commemorativa dell’evento.
Più nel dettaglio, subirono danni di varia natura la Cattedrale di S. Lorenzo, l’Ospedale Galliera e la Biblioteca “Berio”, Piazza Manin e Via Galata. Circa 250 case furono distrutte, e tra la popolazione civile si dovettero registrare 144 morti, 272 feriti e circa 2.500 senzatetto.
Infine, come previsto dal piano britannico, gli aerei (soprattutto Fairey “Swordfish”) dell’Ark Royal attaccarono Livorno e La Spezia. Nella città toscana fu colpita la locale raffineria petrolifera, ma due velivoli – per un errore di rotta – colpirono la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Pisa. I quattro aerei che attaccarono La Spezia sganciarono alcune mine nei pressi delle entrate del Golfo delimitate dai due estremi della diga foranea (9).
Terminata l’azione di fuoco, le navi inglesi diressero per 180° al fine di ricongiungersi con il gruppo dell’Ark Royal circa 35 miglia a Sud di Vesima. Sin qui, i movimenti della “Forza H” che – seguendo sostanzialmente la stessa rotta dell’andata ma passando a Nord di Ibiza – fece rientro a Gibilterra nel tardo pomeriggio dell’11 febbraio.
In precedenza, alle 10.15 del 10 febbraio, i ct. Jupiter e Firedrake – rimasti presso le Baleari – si erano riuniti alla squadra.
Tuttavia, l’uscita delle navi inglesi da Gibilterra il precedente 6 febbraio era stata subito comunicata a Roma dai nostri informatori nella zona (10), con l’esatta indicazione delle ore e dei nomi delle unità e, nonostante che le apparenze facessero prospettare una partenza verso l’Atlantico, Supermarina ritenne – correttamente – che durante la notte il grosso della “Forza H” avrebbe fatto rientro nel Mediterraneo.
L’Ufficio Piani e Operazioni di Supermarina diramò, pertanto, una serie di disposizioni che avrebbero consentito il dispiegamento di numerose unità per fronteggiare un’azione navale inglese, tanto rivolta a colpire obiettivi in Sardegna quanto, eventualmente, posti anche più a settentrione, nella zona del Mar Ligure.
Fu ordinata la partenza da Messina degli incrociatori della 3a Divisione (Trento, Trieste e Bolzano) agli ordini dell’amm. Sansonetti e le tre unità, scortate da altrettanti cacciatorpediniere, salparono alle 07.00 dell’8 febbraio.

La corazzata Andrea Doria a Trieste nel settembre 1940, al termine dei lavori di trasformazione svolti presso i Cantieri Riuniti dell'Adriatico. (Foto E. Mioni, Trieste - collezione Maurizio Brescia.

Ancorché caratterizzato da un diverso disegno dello scafo e delle sovrastrutture, il Bolzano (qui fotografato alla fonda il 10 marzo 1938) replicava alcune caratteristiche negative dei “Trento”. Costruito dopo gli “Zara” (sicuramente tra i migliori incrociatori tipo “Washington” realizzati dalle varie Marine nella prima metà degli anni Trenta), per via delle linee comunque eleganti ed armoniose fu definito, anche negli ambienti ufficiali, “un errore splendidamente riuscito”. (Foto A. Fraccaroli)
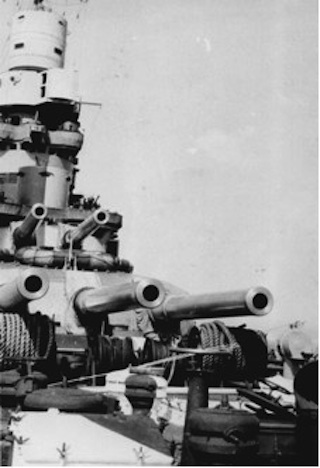
Le volate dei pezzi da 320/44 delle torri prodiere della corazzata Andrea Doria, verso la metà del 1942. (Coll. M. Brescia.
Movimenti navali del 9 febbraio 1941
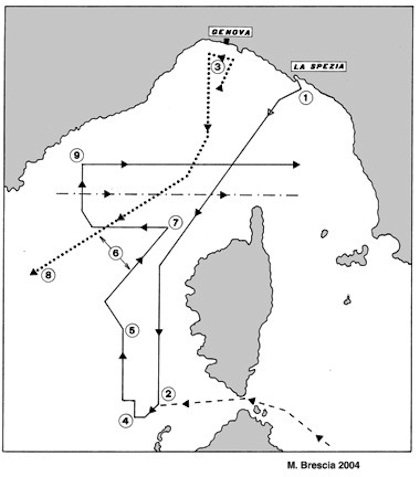
Linea puntinata: rotta della “Forza H” in allontanamento da Genova – Linea tratteggiata: rotta seguita dalla 3a Divisione in arrivo da Messina sino al punto di riunione con la 5a Divisione – Linea continua: rotta del gruppo navale italiano (5a Divisione dalla Spezia, 5a e 3a Divisione riunite a partire dal punto “2”) – Linea spezzata: rotta del convoglio francese.
1 – Uscita dalla Spezia delle corazzate della 5a Divisione (tardo pomeriggio dell’8 febbraio)
2 – Punto di riunione, a Nord dell’Asinara, tra le unità della 5a Divisione e quelle della 3a Divisione (ore 08.00 del 9 febbraio)
3 – Bombardamento navale di Genova, condotto dalla “Forza H” tra le 08.14 e le 08.45
4 – Lancio, tra le 08.55 e le 09.35, degli idroricognitori del Trento e del Bolzano, che effettueranno un’infruttuosa ricerca del nemico ad Ovest della Sardegna
5 – Posizione della squadra italiana alle 12.30; lancio dell’idroricognitore del Trieste che, volando verso Nord-Ovest, passerà a poche decine di miglia dalla “Forza H” senza avvistarla
6 – Ore 14.30: punto di minima distanza (30 miglia) tra le unità inglesi e quelle italiane
7 – Ore 15.50: identificato il convoglio dei mercantili francesi, le navi italiane accostano per 270° nel tentativo di raggiungere la “Forza H”, ma quest’ultima si trova ormai nel punto “8”, a Sud di Hyeres, ad una distanza troppo grande per essere interecettata
9 – Ore 19.00: le navi italiane dirigono per Est
Nella serata dello stesso giorno, le navi da battaglia Vittorio Veneto, Giulio Cesare e Andrea Doria della 5a Divisione (al comando dell’amm. Jachino, comandante superiore in mare) lasciarono La Spezia scortate dai sette cacciatorpediniere della 10a e della 13a Squadriglia.
La Regia Aeronautica e il Comando Marina di Cagliari avevano nel frattempo predisposto, nel corso di tutta la giornata dell’8, una serie di ricognizioni aeree ad Ovest della Sardegna che – tuttavia – non consentirono l’individuazione della “Forza H” la quale, come abbiamo visto, si trovava in navigazione più a Nord.
In assenza di precise indicazioni sui movimenti della “Forza H”, le tre corazzate della 5a Divisione (uscite dalla Spezia) e gli incrociatori della 3a Divisione (provenienti da Messina) si riunirono – insieme a 10 cacciatorpediniere di scorta – a Nord dell’Asinara alle 08.00 del 9 febbraio 1941.
Ebbe inizio, a questo punto, una serie (sotto alcuni aspetti quasi incredibile) di avvenimenti, sfortunati ritardi e inconvenienti che – per i più svariati motivi – non rese possibile l’intercettazione della “Forza H” da parte delle unità italiane, precludendo così la possibilità di uno scontro che, vista la relatività delle forze in campo, avrebbe potuto avere esiti molto favorevoli per la Regia Marina.
Le ricognizioni aeree, innanzitutto, “coprirono” una zona posta più a Sud del Mar Ligure, nella presunzione che la “Forza H” si trovasse in mare per la protezione indiretta di un convoglio in navigazione tra Gibilterra a Malta (11).
Gli stessi idrovolanti del Trento e del Bolzano, lanciati tra le 08.55 e le 09.35 del 9 febbraio, effettuarono una ricognizione al largo della costa occidentale della Sardegna (ammarando poi a Cagliari al termine della missione), quindi completamente al di fuori della zona di operazioni delle navi inglesi.
Le prime notizie sulla presenza della “Forza H” davanti a Genova giunsero a Supermarina tra le 07.40 e le 08.32; alle 09.00 (quando il bombardamento era ormai cessato) il Comando del dipartimento della Spezia informò Roma che era in corso un’azione navale contro Genova. Solamente alle 10.00 fu possibile far assumere rotta Nord al nostro gruppo navale (12) che – sino ad allora – aveva navigato verso ponente ritenendo, in assenza di informazioni, che le unità britanniche si trovassero ad Ovest della Sardegna.
Le navi italiane, giunte poco dopo le 13.00 a ponente della parte centrale della Corsica, accostarono per 30° (Nord/Nord-Est) in quanto alcune segnalazioni della ricognizione della Regia Aeronautica informavano sulla presenza di una portaerei e di altre unità maggiori nel Golfo Ligure indicando, peraltro, posizioni diverse (e nessuna delle quali sufficientemente precisa).
Ne consegue che i messaggi provenienti dalla Regia Aeronautica erano quanto mai contraddittori, e va inoltre considerato il fatto che i velivoli informavano via radio il proprio Comando il quale – a sua volta – “girava” il messaggio a Superaereo: Superaereo informava quindi Supermarina che provvedeva, infine, a trasmettere l’informazione al Comando Superiore in mare. Questo complesso giro di messaggi (per di più cifrati, talvolta sopracifrati, e da decrittare ad ogni passaggio) tra Forze Armate e Comandi diversi rendeva quindi intempestive le segnalazioni dei ricognitori. Gli equipaggi dei velivoli, inoltre, non erano ancora stati addestrati per lo specifico compito della ricognizione marittima, manifestando di conseguenza gravi lacune nel riconoscimento delle unità (tanto nazionali quanto nemiche) e nel corretto apprezzamento dei loro elementi del moto (13).
Alcuni bombardieri Br.20, attorno alle 13.00, individuarono e attaccarono le navi inglesi (peraltro senza danneggiarle), ma l’amm. Jachino non fu informato tempestivamente di questa azione in quanto gli equipaggi degli apparecchi mantennero il silenzio radio ed informarono i propri Comandi solamente al rientro. In precedenza (alle 11.40) un ricognitore CANT Z.506 della 287a Squadriglia aveva avvistato la “Forza H” una quarantina di miglia a Nord-Ovest di Capo Corso, ma era stato abbattuto subito dopo dalla caccia dell’Ark Royal e l’equipaggio, recuperato nel pomeriggio da una torpediniera, poté far pervenire un rapporto di scoperta solamente nella tarda serata, quando il gruppo navale dell’amm. Jachino non aveva più la possibilità di avvicinare le unità inglesi.
L’ultimo “colpo” a questa catena di manchevolezze, eventi negativi e sfortunate coincidenze fu assestato dalla presenza, in zona, di un convoglio mercantile francese diretto da Marsiglia a Biserta e la cui rotta lo avrebbe portato a passare a Nord e – successivamente – ad Est della Corsica.
Alle 15.24, una cinquantina di miglia a ponente di capo Corso, il Trieste avvistò le alberature delle navi da carico francesi e trasmise il segnale di scoperta alle altre unità italiane. Lo scontro con la “Forza H” sembrava imminente, al punto che sul Veneto (ad una distanza di 32.000 metri) il Direttore del tiro diede l’ordine di caricare i pezzi dell’armamento principale.
Fu quindi grande la delusione degli equipaggi italiani quando – alle 15.48 – le unità francesi furono effettivamente identificate come tali (14): a nulla valse far accostare la squadra italiana per 270° dato che, a quell’ora, le navi britanniche, si trovavano ormai a grande distanza (molto al largo della costa francese, a Sud di Hyeres) e sarebbe stato impossibile raggiungerle, anche navigando alla massima velocità.
Alle 18.00 l’amm. Jachino diede ordine di assumere rotta Nord e, un’ora dopo, la squadra della Regia Marina diresse per Est riducendo la velocità. Le navi italiane incrociarono nel Mar Ligure durante la notte; nel corso della mattinata del 10 febbraio, infine, Supermarina ordinò alle corazzate di far rotta su Napoli ed alla 3a Divisione di rientrare a Messina.
Si concluse così, con un “nulla di fatto”, una delle più limpide occasioni mai occorse alla Regia Marina, nel corso di tutto il conflitto, per dare battaglia alla Royal Navy in condizioni di netta superiorità. Ai 14 pezzi da 381 mm e ai 24 da 152 mm (15) delle unità maggiori inglesi, si sarebbero difatti contrapposti 9 pezzi da 381 mm, 20 da 320 mm e 24 da 203 mm delle corazzate e degli incrociatori italiani; inoltre, considerati gli aspetti tattici dell’ipotetica azione di fuoco, la presenza dell’Ark Royal e dei suoi velivoli non sarebbe risultata – probabilmente – determinante.
Con il bombardamento navale di Genova del 9 febbraio 1941, la “Forza H” compì una delle più audaci azioni della guerra navale nel Mediterraneo, degna delle migliori tradizioni della Royal Navy. Per le Forze Navali italiane si trattò, in buona sostanza, di una “occasione perduta” dovuta – in buona parte – alla scarsa cooperazione tra Marina e Aeronautica (per non parlare della mancanza di una vera e propria Aviazione di Marina), reale e più significativo “tallone d’Achille” di tutta la guerra navale italiana tra il 1940 e il 1943.
Tuttavia, va anche rilevato il comportamento non certo combattivo manifestato dalla squadra italiana, al di là delle giustificazioni addotte dall’amm. Jachino nel dopoguerra (19); tutto ciò quando erano ben note le critiche di scarsa propensione all’offensiva mosse da quest’ultimo al suo predecessore Campioni. Peraltro, non bisogna disgiungere questi fatti dalle direttive che contraddistinsero tutta la nostra guerra navale, tese a preservare quanto più possibile l’integrità della squadra da battaglia – tanto per il mantenimento della “fleet in being” quanto essendo ben nota l’impossibilità di sostituire unità maggiori eventualmente perdute o anche solo danneggiate gravemente.
Forse, anche per questi motivi l’operazione “Grog” – a torto – è stata considerata, talvolta, un evento di secondo piano, ma ancora più rilevante sarebbe stato, nel breve, il prosieguo della contrapposizione tra la Regia Marina e la Royal Navy.
Poco meno di due mesi dopo, difatti, con rapporti di forza invertiti (e sulla base, va ricordato, di un’ “intelligence” nemica che aveva in “ULTRA” il suo punto focale) lo scontro di Matapan tra unità italiane e britanniche ebbe purtroppo esiti del tutto opposti, come testimoniato dal sacrificio dei 2.303 uomini del Pola, dello Zara, del Fiume, del Carducci e dell’Alfieri (16) che persero la vita nel corso di quel breve combattimento, nella notte tra il 28 e il 29 marzo 1941.
Maurizio Brescia
Vicepresidente Associazione Mare Nostrum
- L’articolo pubblicato sul n.161 (febbraio 2007) della rivista mensile “STORIA MILITARE” - (Albertelli Edizioni Speciali)
Note:
(1) Si veda: Hervieux, P.: Il bombardamento navale del 14 giugno 1940, in “STORIA Militare” n. 110 (novembre 2002)
(2) La Marina italiana si trovò infatti impegnata con direttrice Nord-Sud per il sostegno logistico del fronte libico, mentre l’attività della Marina britannica era indirizzata sul corso dei paralleli, con operazioni di rifornimento di Malta aventi come punti di partenza Alessandria o Gibilterra, e trasferimenti di unità navali tra queste due basi strategiche.
(3) Si veda: Bagnasco, E.: Perdita e recupero della R.N. Conte di Cavour, in “STORIA Militare” n. 26 (novembre 1995)
(4) Il “grog” è una sorta di “ponce” a base di rum, succo di limone ed acqua calda che a bordo delle navi britanniche – sino agli anni Settanta – costituiva uno dei generi di conforto più apprezzati dagli equipaggi.
(5) In effetti, il Fearless non era attrezzato come capo squadriglia (flotilla leader), ma come capo sezione (divisional leader). Tuttavia, in mancanza di un’unità specificatamente equipaggiata per questo ruolo, operò come capo squadriglia nel corso dell’operazione “Grog”.
(6) Non è noto il numero dei colpi da 152 mm tirati dalla Malaya.
(7) Di fronte a Sampierdarena, ai giorni nostri semplicemente denominato “diga foranea”.
(8) “. . . Il solo contrasto incontrato dalle navi bombardanti fu quello del tiro di una batteria da 152 mm (si trattava della Batteria “Mameli”, posta sulle alture di Pegli – n.d.r.) e del tiro c.a. diretto contro il velivolo osservatore del tiro. In entrambi i casi il tiro fu del tutto insufficiente. Tuttavia, durante una parte del bombardamento, fu disposto che i due ct. posti dal lato della costa facessero fuoco, sia per controbattere il tiro da terra sia per mascherare la composizione della forza bombardante . . .”(da: Fioravanzo, G., Le azioni navali in Mediterraneo dal 10-VI-1940 al 31-III-1941, pagg. 361-363 – op. cit. in bibliografia). L’osservazione del tiro fu effettuata da un “Walrus” dello Sheffield e da due “Swordfish” in versione idro del Malaya e del Renown. Lo stesso Sheffield provvedette, al termine dell’azione di fuoco, al recupero del proprio velivolo nonché di quello del Malaya; lo “Swordfish” del Renown fu invece recuperato dalla portaerei Ark Royal. (Fonte: Macintyre, D., Fighting Admiral, pag. 111 – op. cit. in bibliografia). Il volume del Fioravanzo riporta invece che l’osservazione del tiro fu effettuata da uno “Swordfish” dell’Ark Royal che rientrò sulla portaerei al termine dell’azione di fuoco. A sua volta, M.A. Bragadin (Il dramma della Marina Italiana – op.cit. in bibliografia, pag. 71) indica in tre il numero degli “Swordfish” della portaerei britannica che operarono su Genova durante il bombardamento. E’ tuttavia probabile che la storiografia italiana sia piuttosto imprecisa sull’argomento, dato che – all’epoca della pubblicazione – gli autori dei due volumi citati non avevano ancora potuto prendere visione della ricordata opera del Macintyre e di altra documentazione di fonte britannica.
(9) La maggior parte delle mine furono sganciate nei pressi dell’accesso di levante, anche se quello utilizzato all’epoca (come pure oggi) dalle unità in uscita era quello di ponente. Tuttavia, come vedremo più avanti, per maggior sicurezza nell’attesa del dragaggio degli ordigni, al termine dell’infruttuosa ricerca del nemico fu ordinato alle tre corazzate di dirigersi su Napoli.
(10) Va ricordato che, per tutta la durata della guerra, nel territorio spagnolo confinante con Gibilterra fu attiva, con successo, una fitta rete di informatori e agenti della Regia Marina la cui opera – inoltre – fu particolarmente importante per il supporto di “intelligence” alle operazioni dei mezzi d’assalto italiani contro la base britannica. Si veda, in proposito: Pitacco, G.: La “X MAS” ad Algeciras e i mezzi “R”, in “STORIA Militare” n. 31 (aprile 1996).
(11) Una volta nota l’uscita della “Forza H” da Gibilterra, Supermarina allertò i corrispondenti comandi della R.A. e – tra l’8 e il 9 febbraio – consistenti gruppi di velivoli furono utilizzati per la ricerca delle unità britanniche. La Regia Aeronautica impiegò 32 idrovolanti della ricognizione marittima: 20 Cant Z. 501 e 12 trimotori Cant Z. 506; ad essi vanno aggiunti i tre idroricognitori Ro.43 lanciati dalle unità italiane durante l’infruttuosa ricerca del nemico. La Ia Squadra aerea (Comando a Milano) Impiegò nove bombardieri Br. 20 e 2 caccia; la IIIa Squadra aerea (Roma) utilizzò 15 bombardieri Cant Z. 1007, un apparecchio dello stesso tipo attrezzato come ricognitore e sette caccia. Il comando R.A. della Sardegna impiegò 30 bombardieri S.79 ed otto ricognitori (4 Cant Z. 506 e 4 S.79); a questi aerei vanno aggiunti due ricognitori S.79 della IIa Squadra aerea (Palermo). Il X° CAT (Corpo Aereo Tedesco), di base in Sicilia con Comando a Catania, impiegò – per l’occasione – 53 bombardieri, 14 ricognitori e 18 caccia che, nel corso delle operazioni, si appoggiarono anche agli aeroporti della Sardegna.
(12) Con una certa tempestività, il Comando Marina di Genova segnalò a Supermarina l’inizio del bombardamento navale, ma l’informazione fu ricevuta a bordo del Veneto soltanto poco prima delle 10.00, quando le navi britanniche si stavano ormai allontanando dal Golfo di Genova.
(13) Sono purtroppo ben note le medesime manchevolezze che, a Punta Silo, portarono velivoli della R.A. ad attaccare unità navali nazionali, fortunatamente senza colpirle (è d’altro canto pensabile che il medesimo, scarso, risultato avrebbe potuto caratterizzare un attacco contro navi britanniche).
(14) La rotta del convoglio era nota alla commissione armistiziale italo-francese, ma – probabilmente per l’assenza di contatti diretti tra quest’ultima e Supermarina – il Comando superiore in mare non fu avvertito di questo importante elemento “perturbatore” dell’apprezzamento della situazione.
(15) Peraltro, è probabile che i 12 pezzi da 152 mm dell’armamento secondario della Malaya avrebbero avuto ben poche possibilità di essere utilizzati nel corso di un ipotetico scontro con le navi italiane.
(16) A queste vittime vanno aggiunti anche i tre caduti dell’Oriani, che – pur non affondando – ricevette alcuni colpi nella zona dell’apparato motore.
(17) Si veda, in proposito: Cernuschi, E., Mers-El-Kebir, 3 luglio 1940 (parti 1a e 2a), in “STORIA Militare” n. 80 e 81 (maggio e giugno 2000).
(18) Anche se per il “pensionamento” furono ufficialmente addotti motivi di salute, il collocamento a riposo fu forse dovuto anche ad un incidente “professionale” che, ad Aden, aveva visto l’HMS Norfolk, nave ammiraglia di Somerville, coinvolta in una collisione con una similare unità.
(19) Jachino, A.: Tramonto di una grande Marina (op. cit. in bibliografia)
Bibliografia
AA.VV., Porto e aeroporto di Genova n. 6 – giugno 1978, Genova C.A.P., 1978
AA.VV., Genova in guerra nell’ultimo conflitto mondiale, Genova, “Il Secolo XIX”, s.d.
Bragadin, M.A., Il dramma della Marina Italiana, Milano, Mondadori, 1982
Burt, R.A., British Battleships 1919-1939, Londra, Arms and Armour Press, 1993
Campbell, J., Naval Weapons of World War Two, Annapolis, U.S. Naval Institute Press, 1985
Cernuschi, E., Fuoco dal mare, supplemento alla “Rivista marittima”, maggio 2002
Clerici, C.A:, Le difese costiere italiane nelle due guerre mondiali, Parma, Albertelli Edizioni Speciali, 1996
Craighero, R., Domenica mattina ore 8.14, l’inferno arriva dal mare, in “Il Secolo XIX” del 9 febbraio 2003
Cunningham, A.B., A Sailor’s Odyssey, Londa, Hutchinson & Co., 1951
Fioravanzo, G., Le azioni navali in Mediterraneo dal 10-VI-1940 al 31-III-1941 (vol. IV della serie “La Marina Italiana nella seconda guerra mondiale), Roma, Uff. Storico della M.M., 1976
Giorgerini, G.: La guerra italiana sul mare, Milano, Mondadori, 2001
Jachino, A.: Tramonto di una grande Marina, Milano, Mondadori, 1959
Macintyre, D., Fighting Admiral, Londra, Evans Bros., 1961
Raven, A., Roberts, J., Ensign 4 – “Queen Elizabeth” class battleships, Londra. Bivouac, 1975
Raven, A., Roberts, J., Ensign 5 – “Town” class cruisers”, Londra. Bivouac, 1975
Raven, A., Roberts, J., Ensign 8 – Renown & Repulse, Londra. Bivouac, 1978
Rapallo, 28 Marzo 2014
U-455 - Ipotesi Affondamento
U-455
IPOTESI SULL’AFFONDAMENTO DEL SOMMERGIBILE TEDESCO

Sperando di fare cosa gradita, per chi della Lista non conosce la storia, o non la ricorda, faccio il punto sul relitto di Portofino che, dopo molte incertezze e discussioni, scoperto da Del Veneziano è stato riconosciuto per il sommergibile tedesco U-455. La causa della sua perdita, e dei suoi 51 uomini d’equipaggio, rimane però per molti versi misteriosa, ed è stata fonte, e lo sarà ancora, di discussioni.
L’U-455, al comando del tenente di vascello Hans-Martin Scheibe, entrò nel Mediterraneo nel mese di gennaio 1944 dopo nove missioni di guerra svolte in Atlantico, che lo avevano portato ad affondare con il siluro, il 3 maggio e l’11 giugno 1942, due navi mercantili per 13.908 tsl (le cisterne britanniche BRITISH WORKMAN e GEO H. JONES), e ad effettuare la posa di due sbarramenti minati: la prima nelle acque degli Stati Uniti; la seconda presso le coste marocchine di Casablanca, causando il 25 aprile 1943 l’affondamento del piroscafo francese ROUNNAIS di 3.777 tsl.
L’U-455 apparteneva alla 7^ Flottiglia Sommergibili tedeschi di Saint Nazaire, e arrivò a Tolone il 3 febbraio 1941, proveniente da Lorient, per poi essere ufficialmente aggregato alla 29^ Flottiglia del Mediterraneo in data 2 marzo.
Partì da Tolone – principale base della 29^ Flottiglia – il 22 febbraio per la sua decima ed ultima missione. La sua destinazione bellica comportava di posare uno sbarramento minato nelle acque dell’Algeria, per poi operare in quella zona di mare, dove l’U-455 stazionò per circa quaranta giorni, senza avere avuto possibilità di realizzare attacchi contro il numeroso naviglio alleato che transitava in quel settore focale di traffico, dove i sommergibili tedeschi della 29^ Flottiglia ottennero, tra l’aprile e i primi di maggio, i loro ultimi successi, prima di essere spazzati via dal Mediterraneo dall’organizzazione difensiva degli anglo-americani, realizzata con la tattica Swam (ricerca metodica). Seguì poi, per bombardamenti aerei statunitensi violentissimi, l’annientamento dei superstiti sommergibili nel porto di Salamina, e nei bacini di Tolone, e ciò avvenne prima che i tedeschi fossero riusciti a ultimare la costruzione dei bunker in cemento armato che avrebbero dovuto proteggerli in quel porto francese.
Uno di questi bombardamenti, con 120 quadrimotori B-17 della 12^ Air Force, si verificò l’11 marzo, quando l’U-455 si trovava in mare da diciassette giorni. L’attacco aereo causò quasi settecento morti, inclusi quattordici soldati tedeschi, colpì il Comando della 29^ Flottiglia e molte navi in porto, affondò i sommergibili U-380 e U-410 e due dragamine adibiti al pilotaggio degli U-boote, e in particolare arrecò gravissimi danni alla zona dei bacini, compromettendo il riassetto delle unità subacquee che rientravano dalle missioni belliche. Si aggiunse poi il fatto che il Comandante Marina Ovest, ammiraglio Theodor Krancke, si mostrò preoccupato per la scarsa difesa di Tolone, da parte della Luftwaffe ed anche dall’artiglieria contraerea (Flak). Fu questo il motivo per cui l’U-455 e l’U-230, rientrando dalle loro missioni di guerra, furono deviati eccezionalmente alla Spezia, che in quel periodo era un porto più tranquillo di Tolone, e possedeva un arsenale al momento forse più efficiente.
Dei due sommergibili, l’U-230 (tenente di vascello Paul Siegmann), che il 16 e il 20 febbraio aveva affondato nella zona di Anzio le navi da sbarco per carri armati LST 418 e LST 305, entrambe britanniche, arrivò alla Spezia il 24 febbraio, per poi ripartire il 6 aprile per raggiungere Tolone tre giorni più tardi.
Da informazioni chieste dal compianto Achille Rastelli in Germania, e trasmesse, tramite Manfred Krellenberg, dal Dott. Axel Miestlè, considerato uno dei maggiori esperti di sommergibili tedeschi, e da altre notizie di cui sono in possesso, risulta che il capitano di vascello Werner Hartmann, Comandante degli U-boote del Mediterraneo, alle 11.33 del 1° aprile 1044 ordinò all’U-455 di raggiungere La Spezia. Con un secondo messaggio delle ore 11.52 del medesimo giorno furono inviate al sommergibile dettagliate istruzioni per entrare in quel porto della Liguria. All’U-455 fu fissato un appuntamento a ovest del Golfo della Spezia, sul punto “C” (per Caesar”), corrispondente alla lat. 44°07’8” Nord, long. 09°28’6” Est, con una nave di scorta, che avrebbe dovuto fungere da nave pilota nell’entrata in porto del sommergibile.

Le rotte germaniche nell’Alto Tirreno al 1° febbraio 1944. Il punto “C” è a ovest di La Spezia.
Il Comandante della 29^ Flottiglia consigliò all’U 455 di raggiungere il punto “C” al tramonto, e gli chiese di segnalare con urgenza il momento in cui esso riteneva di arrivare all’appuntamento, nella zona stabilita, con la nave scorta, che avrebbe dovuto pilotarlo in porto attraverso le rotte di sicurezza che passavano tra gli sbarramenti minati difensivi e che portavano, da ponente lungo la costa, all’entrata del Golfo della Spezia. Il sommergibile fu, in effetti, avvertito delle difficoltà esistenti, durante la traversata, per mantenersi nei limiti dell’area minata, denominata Gurke. L’U-455, che lasciata la zona di Algeri si trovava a sud-ovest della Corsica, segnalò con la radio, per l’ultima volta, alle 04.42 del 2 aprile 44, informando il Comandante della 29^ Flottiglia della sua intenzione di arrivare sul punto “C” alle 19.30 del giorno 5. Non si presentò all’appuntamento, e non avendo dato sue notizie, il 6 aprile il sommergibile fu considerato perduto per causa sconosciuta.
Le informazioni dell’Ammiragliato britannico del dopoguerra, forniscono sulla perdita dell’U-455 due versione: la prima sostiene che il sommergibile sarebbe affondato in lat. 44°04’N, long. 09°51’E, poco a sud dell’Isola Del Tino, probabilmente per causa di una mina tedesca al limite settentrionale dello sbarramento Gurke, esplosa proprio mentre l’unità si apprestava a entrare nel Golfo di La Spezia; la seconda ipotesi, ribadendo quanto sostenuto dai tedeschi, afferma che la causa della perdita era sconosciuta.
Da parte nostra sappiamo oggi che rispetto al punto di affondamento ipotizzato dall’Ammiragliato britannico, il relitto dell’U-455, secondo le coordinate fornite da Massimo Bondone, si trova in realtà in lat. 44°18’ 651 Nord, long. 09°02'891 Est. Questa posizione corrisponde a circa 5 miglia da Recco, mentre finora si era detto che l’affondamento del sommergibile era avvenuta a circa 2 miglia a sud di Portofino.
Guardando la cartina delle rotte tedesche, il Punto C era quello di avvicinamento all’entrata del canale di sicurezza delle navi che percorrevano la cosiddetta “Via Aurelia”, proveniente da sud-ovest. La rotta proseguiva poi a est (“Via Valeria”) per il punto focale n. 718 (a sud di Portofino), su cui convergevano da nord altre due rotte, e che naturalmente doveva essere fortemente controllato giorno e notte, potendo infiltrarsi sommergibili nemici.
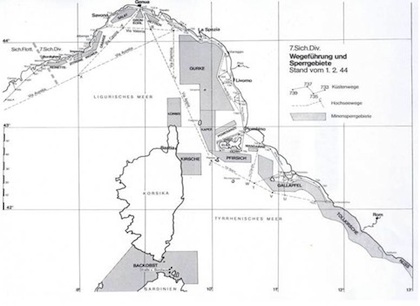
Gli sbarramenti minati tedeschi dell’Alto Tirreno al 1° febbraio 1944.
Faccio il punto delle mie riflessioni, che potranno anche non essere condivise:
1°) Non ritengo plausibile l’idea, fornita da alcuni, che il sommergibile abbia sbagliato rotta, finendo sulle mine. Anche se avesse avuto le bussole in avaria (tutte ?), e nonostante una navigazione di 45 giorni, sarebbe stato un errore inconcepibile, direi impossibile, per qualsiasi comandante esperto; per di più navigando vicino alla costa, che poteva servire per fare agevolmente il punto astronomico, anche di notte. E’ da escludere che l’U-455 fosse affondato sullo sbarramento “Gurke”, ma è possibile che sia andato a urtare su una mina vagante (strappata all’ormeggio), ma essendo pur sempre entro la rotta di sicurezza. E poiché siamo in vena d’ipotesi, non possiamo escludere si fosse verificata l’esplosione di un proprio siluro, a poppa, come successo ad altri sommergibili.
2°) Non credo assolutamente che l’U-455 navigasse in immersione, proprio perché si trovava sotto costa e tra gli sbarramenti minati amici e nemici. Nessuno lo avrebbe fatto in queste condizioni, come potrebbe dimostrare un qualsiasi sommergibilista.
3°) E’ mia opinione che l’esplosione di una mina avvenuta nella navigazione in superficie entra la rotta di sicurezza, e l’alta colonna d’acqua da essa generata, non poteva sfuggire alla vigilanza tedesca, della nave pilota e da terra, anche se vi era cattivo tempo, e temporali da accertare. L’esplosione della mina e il tuono, più o meno forte, di un fulmine avrebbero dovuto essere contemporanei Inoltre, l’affondamento repentino del sommergibile, con la poppa fortemente squarciata, doveva lasciare tracce alla superficie del mare, sotto forma di detriti, di chiazze di nafta e cadaveri.
4°) Quanto ai corpi degli uomini dell’equipaggio, che al momento del sinistro dovevano trovarsi in coperta, è possibile che la corrente possa averli trascinati lontano. Ma se un corpo si rintraccia in mare o sulla costa, e può essere anche identificato per non altro per l’uniforme, si collega sempre a qualche nave affondata. Quindi ai tedeschi, che avevano il controllo dell’Alto Tirreno e della Francia meridionale, e la benevolenza della Spagna, sarebbe stato alquanto facile appurare che si trattavi di un uomo dell’equipaggio dell’U- 455, e quindi stabilire dove presumibilmente il sommergibile si era perduto, e in quale giorno.
5°) E assolutamente impossibile che l’U-455, com’è stato ipotizzato, trovandosi in difficoltà per il mare grosso, si sia diretto sottocosta senza avvertire i Comandi della Liguria, preposti al controllo del traffico (questa è una cosa seria), che avrebbero provveduto a fornirgli tutto l’aiuto necessario per raggiungere la destinazione. Per la difesa del traffico di cabotaggio le precauzioni di vigilanza per una Marina efficiente (e la tedesca lo era) erano continue, sia di giorno che di notte, anche con il cattivo tempo, accettando il rischio di imbattersi nel contrasto aereo del nemico, che a quell’epoca (aprile 1944), con la linea del fronte a Cassino, proveniva soprattutto dagli aeroporti della 12^ Air Force statunitense in Corsica.
6°) In mancanza di una foto sulle ultime modifiche cui era stato sottoposto in torretta il sommergibile, in particolare riguardo all’incremento dell’armamento e delle numerose apparecchiature tecniche, come il radar, la visione dei filmati non mi permette dei dare un giudizio, trovandosi la torretta quasi completamente coperta di reti, soprattutto nella parte posteriore del giardino d’inverno. Si parla di una grossa mitragliera, che però, essendo nascosta dalle reti, potrebbe anche essere la semplice asta della bandiera ?

Ecco come si presentava, in missione di guerra, la torretta di un sommergibile tipo VII C, a due piattaforme. Vi sono alzati i due periscopi (oppure abbassati sulle rispettive colonnine fisse), il radiogoniometro, l’intercettatore di onde radar Naxos, la grande antenna del radar di scoperta aeronavale, le due coppie di mitragliere da 20 mm. sulla piattaforma superiore; la mitragliera da 37 mm. su impianto scudato sulla piattaforma inferiore. Sul davanti della torretta, in basso, il contenitore della bussola magnetica.
Se non sono stati asportati tutti questi strumenti tecnici e di armamento dovrebbero ancora essere presenti sul relitto dell’U-455. Ma finora nessuna, nei numerosissimi difficili filmati degli operatori ad alta profondità, è riuscito a farceli vedere, e per vedere intendo dire “chiaramente” non per quello che hanno visto i subacquei. Attendiamo speranzosi.
Ricordo che l’U-455, alla sua decima missione di guerra, stava dirigendo verso la Spezia anziché a Tolone, come inizialmente avrebbe dovuto fare, a causa di un bombardamento degli aerei statunitensi della 12^ Air Force. L’ultima sua trasmissione riporta la data del 2 aprile 1944, ed è praticamente impossibile conoscere cosa abbia fatto, prima di arrivare alla Spezia il giorno 6, in cui era atteso. Era in anticipo o in ritardo; ha sbagliato la rotta per raggiungere la nave pilota all’ingresso (badate bene all’ingresso) della rotta di sicurezza. E’ un rebus che, temo, rimarrà per sempre.
Che poi nessuno abbia udito nulla dell’esplosione della mina, che non vi fossero cadaveri almeno degli uomini in coperta, anche se rintracciabili a grande distanza, e non fossero state localizzati rottami e perdite di nafta (anche di piccola entità), che potessero far capire ai tedeschi quale era stata la fine del sommergibile, a poche miglia dalla costa ligure, non permette di fare supposizioni e ancor meno di esprimere fantasie.
Ripeto, si potrebbero fare dei calcoli approssimativi sulla rotta seguita dall’U-455, soltanto dopo aver conosciuto le esatte coordinate dell’affondamento. Ma sembra che nessuno voglia darle!
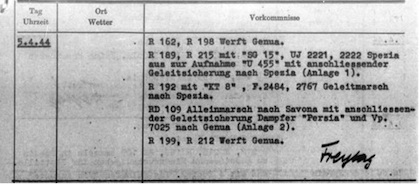

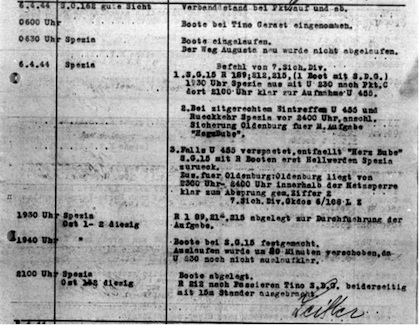
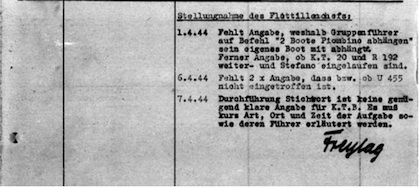
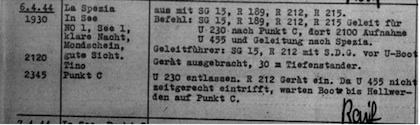
In attesa della traduzione di Francesco, ripeto quanto già segnalato e aggiungo quanto ho compreso dalla lettura dei cinque documenti postati da Milani:
Nella prima scansione e riportato che i dragamine R-189, R-215, il posamine SG-15, e le navi scorta UJ-2221, 2222 Spezia erano partite il giorno 5 aprile per raggiungere il sommergibile e condurlo alla Spezia.
Se poi si collega questa preziosissima informazione con il paragrafo successivo, costatiamo che altre tre navi, il dragamine R-19, la nave trasporto KT-8 e la motozattera F-2484, si trovavano quello stesso giorno a percorrere il medesimo tratto di mare.
Nella seconda scansione le cinque navi tedesche ricevettero l’ordine di partire da La Spezia alle ore 1900 del 5 aprile per raggiungere l’U-450 sul previsto Punto “Ceaser” (Punto C), passando a sud dell’Isola del Tino e proseguendo la loro rotta nella “Via Augusta”.
Vi sono poi altri movimenti navali a dimostrazione che nella zona vi era un gran traffico.
Nella terza scansione, il solito grande traffico nella zona tra il Punto C e la Spezia. Le cinque navi della 7^ Divisione di Sicurezza diressero sul Punto C scortando il sommergibile U-230, salpato dalla Spezia alle 19.30 per poi arrivare alle 2100 sul Punto C. Alle 23.45 l’U-230 proseguì la sua navigazione (per Tolone), mentre le cinque navi scorta restarono ad attendere fino all’alba l’U-455, che non arrivò all’appuntamento (scansioni 4 e 5).
Ribadisco che in queste condizioni come sia avvenuta la perdita dell’U- 455 a sud di Recco, senza che nessuno se ne accorgesse, appare veramente un mistero!
Se l’U-455 era in ritardo al momento dell’appuntamento, una volta entrato nella rotta di sicurezza, sarebbe stato dovere del comandante del sommergibile di informare le locali autorità della zona, senza badare al rischio di usare la radio. Che cosa gli era successo ?
Francesco MATTESINI
Rapallo, 3 Gennaio 2014
ARTIGLIO, una vita gloriosa
LA VITA GLORIOSA DELL’”ARTIGLIO”
La vicenda che rese famoso l’”Artiglio” e che rappresenta, una delle più celebri e drammatiche campagne di recuperi sottomarini, ebbe inizio il 20 maggio 1922 al largo dell’isola di Ouessant, a ovest di Brest.
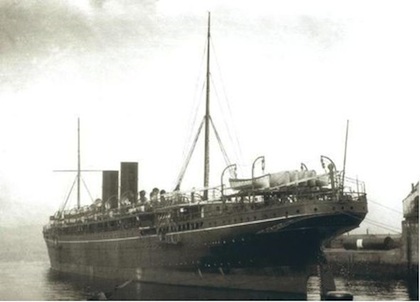
Quel giorno la nave passeggeri inglese “Egypt”, (nella foto) partita da Tilbury alle foci del Tamigi e diretta in India e in Australia, fu speronata nella nebbia dal piroscafo francese “Seine” e affondò in poco più di venti minuti.
L’“Egypt” aveva a bordo 338 persone e un autentico tesoro nascosto in una camera blindata: 1.089 barre d’oro puro, 164.979 sterline d’oro, 1.229 lingotti d’argento del peso complessivo di 43 tonnellate e migliaia di banconote indiane.
Nel naufragio perirono ottantotto persone.
La zona in cui era affondata la nave presenta fondali bassi e non si poteva escludere, in teoria, la possibilità di recupero del tesoro. La posta in gioco era molto allettante, pur essendo certamente pesanti i rischi e costosa l’impresa.
Per anni inglesi, francesi e tedeschi cercarono il relitto: le tempestose acque dei mari del nord sembrava avessero suggellato per sempre la tomba dell’“Egypt”.
Frattanto si era costituita a Genova, 11 ottobre 1926, la “SO.RI.MA.” (Società Ricuperi Marittimi) con lo scopo di effettuare in tutti i mari, ma specialmente nel golfo di Guascogna e nella Manica, rigorose e vaste ricerche di navi piene di materiali pregiati affondate a profondità accessibili, e cercare di recuperare il carico.
Le acque dove si proponeva di operare la “SO.RI.MA.” erano molto pericolose, sia per le frequenti tempeste e le forti correnti, che per la presenza, sui fondali, di relitti carichi di materiale esplosivo e ostacoli di ogni genere. Quelle acque erano state il campo di operazioni dei sommergibili tedeschi durante la prima guerra mondiale. A centinaia le navi da carico provenienti dall’America e dall’Inghilterra, destinate a rifornire di armi, munizioni e materie prime gli eserciti alleati in lotta con la Germania e l’Austria-Ungheria, erano state vittime dell’inesorabile caccia condotta dagli U-Boat. Operare in quei mari era come arare un campo minato.
Di ciò erano perfettamente consci i dirigenti della “SO.RI.MA.”, ma essi non si lasciarono impressionare, perché sapevano di poter contare su equipaggi pronti a tutto, rotti alla fatica, impavidi in faccia alla morte. E i dirigenti stessi erano pronti a condividere, come fece specialmente il presidente e amministratore delegato comm. avv. Giovanni Quaglia, la vita dei marinai.
La “SO.RI.MA.” acquistò subito alcune piccole navi di alte qualità nautiche e robustissime, e le fece attrezzare per i recuperi a grande profondità.
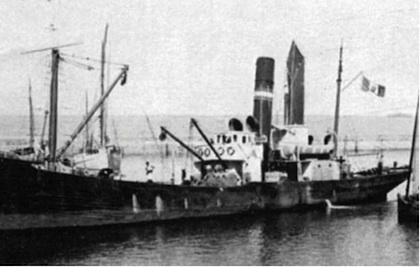
I loro nomi “Artiglio”, “Arpione”, “Raffio”, “Rampino”, rievocano tutti episodi di grande eroismo e sono entrati ormai nella letteratura delle gesta leggendarie.
La ricerca del relitto dell’“Egypt” e il recupero del suo tesoro, che era stato assicurato dai Lloyd’s di Londra per più di un milione di sterline, furono affidati appunto all’”Artiglio”. Furono accettate, senza batter ciglio, le dure condizioni imposte dai Lloyd’s di Londra: ricerca a rischio e spese della “SO.RI.MA.”, divisione a metà del tesoro recuperato.
Se si pensa che l’impresa appariva aleatoria, dati i precedenti tentativi , tutti falliti, di altre ditte specializzate, che i pericoli erano sempre in agguato, che a quei tempi i mezzi tecnici a disposizione non erano ancora abbastanza sperimentati e che ci sarebbe voluto, oltre all’abnegazione degli uomini, anche un grande dispendio di tempo e di capitali, si può facilmente comprendere quale coraggio ci sia voluto e quale fede nella riuscita, per apporre la firma a quel contratto.
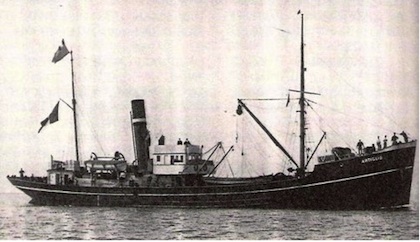
L’”Artiglio” si mise subito all’opera. La zona di mare dove era affondato l’“Egypt” fu scandagliata a palmo a palmo, i palombari s’immersero, in speciali scafandri, centinaia di volte. Dopo due anni di estenuanti ricerche, durante le quali furono localizzati altri trentotto relitti di navi, il 30 agosto 1930 finalmente fu scoperta la posizione dell’“Egypt”, a 130 metri di profondità. La nave si era appoggiata, senza rovesciarsi, su un fondo orizzontale.
Conseguita questa prima vittoria, cominciavano ora ben altre difficoltà. Mentre la “SO.RI.MA.” continuava a studiare mezzi sempre più idonei per raggiungere il tesoro e ripescarlo, l’”Artiglio” riceveva l’incarico di demolire presso la Belle Ile, nello specchio di mare fra le isole Houat e Hoedic, lo scafo del piroscafo francese “Florence”, affondato con un carico di munizioni dai tedeschi in acque molto basse (tanto che l’albero maestro era per buona parte visibile) e perciò pericolosissimo per la navigazione.
L’operazione era quasi giunta al termine, quando, il 7 dicembre 1930, l’intero carico di munizioni del “Florence” esplodeva, e l’”Artiglio” sebbene si fosse portato a rispettosa distanza, saltava in aria. Nel disastro perirono dodici marinai e sette rimasero feriti.
Tra gli scomparsi erano il comandante, cap. Giacomo Bertolotto di Camogli, e i famosi palombari viareggini Alberto Gianni, Aristide Franceschi, Alberto Bargellini.
Il colpo morale e materiale subito dalla “SO.RI.MA.” era tremendo, ma non riuscì ad abbatterne il ferreo volere. Fu acquistata subito un’altra nave (originariamente iscritta con il nome Maurétanie), già adibita alla pesca oceanica, e sulla sua prora fu scritto ancora il nome indomito di “Artiglio II”( ma tutti continuarono a chiamarla Artiglio): la sfida al destino era lanciata.
Il nuovo “Artiglio” aveva le seguenti principali caratteristiche: lunghezza m. 50,70, larghezza m. 7,64, altezza m. 4,19, stazza lorda tonn. 385.

Il suo scafo non era bello, ma teneva stupendamente il mare.
Vi fu imbarcato un equipaggio sceltissimo, agli ordini del cap. Giovanni Battista Carli e di cui facevano parte, tra gli altri, il capo macchinista Cesare Albavera e tre intrepidi palombari viareggini: Mario Raffaelli, Giovanni Lenci, Raffaello Mancini.
Il 29 maggio 1931 cominciò a operare sul relitto dell’“Egypt”. Si trattava di demolire quattro ponti d’acciaio per giungere alla cella blindata e scoperchiarla. Per fare ciò occorreva portarsi sul fondo della nave aprendo il passaggio dall’alto, per far scendere i palombari, le torrette di osservazione, gli esplosivi, le benne. Nuove attrezzature furono studiate e realizzate allo scopo. Cinquemila chilogrammi di tritolo fecero per settimane ribollire le acque e squarciarono l’“Egypt”.
La fatica fu inaudita, poiché il lavoro non si poteva svolgere come immaginavano i disegnatori delle copertine a colori dei settimanali illustrati: palombari che passeggiavano in fondo al mare, che entravano e uscivano dagli squarci dell’“Egypt”, che afferravano lingotti e sterline, che spingevano le benne con le mani per sistemarle sui carichi. I fatti erano ben diversi. Raramente i palombari, rinchiusi in pesantissimi scafandri metallici, potevano agire direttamente. Di solito gli uomini scendevano in speciali torrette di osservazione e di lì ordinavano per telefono alla nave i movimenti delle benne e di uno speciale ricuperatore, che diede risultati eccezionali.
I palombari vedevano ma non potevano agire; sull’“Artiglio” potevano agire ma non vedevano. In questo modo si lavorava.


Apparati per lavori subacquei
Migliaia di volte le benne mancarono il punto giusto, migliaia di volte i palombari dovettero ordinare spostamenti anche minimi. Spesso rimasero incagliati anche loro tra i rottami, qualche volta disperarono di poter tornare in superficie. Non si stancarono mai e vinsero.
Il 22 giugno 1931 giungevano in coperta, tra fango e rottami, le prime due sterline d’oro. Ma doveva passare ancora un anno esatto, un anno in cui spesso le operazioni furono interrotte per il maltempo, perché si cominciasse a vedere qualcosa di sostanzioso.
Finalmente, il 22 giugno 1932, ecco i primi lingotti d’oro, e da quel momento la campagna di recupero comincia a marciare a ritmo più spedito per terminare, spesso avversata dalle tempeste, nel 1934. Alla fine l’inventario del tesoro recuperato dava le seguenti cifre: 83.300 sterline d’oro, 865 barre d’oro puro, 54 quintali d’argento.
Conclusa questa favolosa avventura che fu seguita, da tutto il mondo con ansia e ammirazione (il “Times” tenne a bordo quattro anni il suo inviato speciale David Scott, che scrisse due libri andati a ruba in Inghilterra e in America), l’“Artiglio” intraprese altre numerose campagne di recupero, isolato o in collaborazione con le altre unità della “SO.RI.MA.” che per anni ebbero le loro basi a Saint Nazaire, Brest, Morlaix in Francia e a Freetown nella Sierra Leone, East London nel Sud Africa. I suoi palombari compirono altre migliaia di immersioni, le sue benne affondarono altre migliaia di volte nei fondi melmosi e tra le lamiere contorte.
Gian Paolo Olivari
Rapallo, 2 Gennaio 2014
CARLO FECIA DI COSSATO
Carlo FECIA di COSSATO

Carlo Fecia di Cossato nacque a Roma il 25 settembre 1908 da una famiglia di tradizioni militari: il bisnonno, aiutante di campo di Re Carlo Alberto, e il nonno furono decorati durante le guerre d'indipendenza; il padre invece capitano di vascello fu costretto a lasciare la marina in seguito ad un incidente in Cina in cui perse un occhio. Dopo aver ultimato gli studi al Collegio Militare di Moncalieri entrò in Accademia Navale a soli quindici anni nel 1923. Uscì nel 1928 con il grado di guardiamarina e l'anno successivo fu promosso Sottotenente di Vascello; nel 1931 fu destinato al Distaccamento Marina di Pechino. Rientrato in patria il Corso Superiore e fu promosso Tenente di Vascello; durante la guerra Etiopica fu incaricato della sistemazione difensiva del fronte a mare della zona di Massaua. Nel 1939 seguì la Scuola Comando Sommergibili, partecipando tra l'altro a due "missioni speciali" durante la guerra spagnola.
Il 10 giugno 1940 Carlo Fecia di Cossato era comandante del sommergibile Ciro Menotti, una delle unità più vecchie della nostra flotta subacquea, alle dipendenze della 34° Sq Sommergibili di base a Messina. Con questo vecchio sommergibile effettuò varie missioni infruttuose di agguato nel Mediterraneo Centrale poi viene trasferito in Atlantico come comandante in seconda del sommergibile Tazzoli, e con questo incarico partecipa ad un missione in Atlantico che termina il 13 gennaio 1941.

Le sue caratteristiche tecniche erano: costruzione a doppio scafo completo - dislocamento: 1.530 t (in superficie) - 2.032 t (in immersione) - dimensioni: 84,3 m (lungh.) - 7,71 m (largh.) – (5,14 m (pescaggio medio) - profondità di collaudo: 100 m (con coefficiente di sicurezza 3) - potenza app. motore: 4.400 HP (in sup.) - 1.800 HP (in imm.) - velocità max.: 17,1 nd (in sup.) - 7,9 nd (in imm.) - autonomia: 11.400 mg a 8 nd - 5.600 mg a 14 nd (in sup.); 7 mg a 7,9 nd - 120 mg a 3 nd (in imm.) - armamento: 8 TT.LL.SS. da 533 mm (4 a prora e 4 a poppa); 12 siluri in dotazione; 2 cannoni da 120/45 (uno a proravia e uno a poppavia della falsa torre); 4 mitragliere binate da 13.2 mm (in plancia, a poppavia); 2 lanciamine nell’intercapedine a poppa, con 14 mine (solo il TAZZOLI) - equipaggio: 7 Ufficiali, 14 S/Ufficiali, 46 Sottocapi e Comuni

La mattina del 5 aprile 1941, appena promosso Capitano di Corvetta e al comando del sommergibile Tazzoli, di Cossato parlò così al suo equipaggio: "Se qualcuno vuole sbarcare lo dica subito, io intendo partire con gente decisa a tutto. Se qualcuno non si sente venga avanti, non ha nulla da vergognarsi", nessuno si mosse e allora Fecia di Cossato li ringrazio uno ad uno. Il 7 Aprile il sommergibile salpo da Bordeaux per la prima missione in Atlantico di Cossato. Era l'inizio di una leggenda: nella prima missione vennero affondati il piroscafo inglese Aurillac (4.733 tonnellate), il mercantile norvegese Fernlane (4.310 tonnellate) e la petroliera norvegese Alfred Olsen (8.817 tonnellate). Per affondare la grossa petroliera fu necessario un inseguimento durato un intero giorno in mezzo ad una fitta banchina di nebbia e ingaggiando con essa un lungo duello di artiglieria, molto rischioso per lo stesso sommergibile. Durante il viaggio di ritorno fu infine abbattuto un aereo antisommergibile. Per questa missione Fecia di Cossato fu decorato con la Medaglia d'Argento al V.M. In una successiva missione del luglio 1941 riuscì ad affondare solamente la motocisterna Sildra (7.313 tonnellate) per poi dover rientrare, con un'elica spezzata dalle bombe di profondità, senza poter cogliere altri successi, ricevendo comunque la Medaglia di Bronzo al V.M. E qui emerge il carattere mai domo di Carletto (così era chiamato affettuosamente a bordo del sommergibile) che si rammarica di ogni occasione perduta e se la prende con il sommergibile ogni volta che non riesce a raggiungere una nave avvistata: "dopo ogni mancata occasione era intrattabile, si metteva a passeggiare nervosamente lungo tutta la coperta soffermandosi a prua con la speranza di riavvistare la nave che gli era sfuggita". In una successiva missione partecipò al recupero di 414 naufraghi dei raiders tedeschi Atlantis e Python ricevendo al termine della missione, con gli altri comandanti italiani che avevano partecipato alla missione, la croce di ferro tedesca per mano dell'Amm Dönitz. Con l'entrata in guerra dell'america i sommergibili italiani, per le loro ottime caratteristiche di autonomia furono destinati ad operare in quei mari lontani.
Cossato, salpato l'11 febbraio 1942, dopo non essere riuscito ad affondare una grossa petroliera manda a picco il piccolo piroscafo olandese Astrea (1.406 tonnellate) il 6 marzo e nella stessa notte anche la motonave norvegese Tonsbergfjord (3.156 tonnellate). L'8 è il turno del piroscafo uruguayano Montevideo (5.785 tonnellate ) dopo un inseguimento durato tutto il pomeriggio e concluso solo a notte fonda. L' 11 marzo a sole cinque miglia dall'isola di San Salvador due siluri affondano il cargo panamense Cygnet (3.628 tonnellate); in questo situazione di pericolo Carlo Fecia di Cossato emerse per controllare che tutti i naufraghi stessero bene, e poiché aveva udito il giorno prima che da una trasmissione radio americana che "nessun sommergibile italiano osava venire ad operare sulle coste statunitensi" agitò più volte il tricolore gridando in inglese ai naufraghi: "dite agli americani che siete stati affondati da un sommergibile italiano!". Il 13 marzo dopo essersi avvicinato in immersione Cossato centrò con due siluri il piroscafo inglese Daytoniam (6.434 tonnellate), che fini poi con un terzo siluro. Il 15 dopo aver immobilizzato con due siluri la petroliera inglese Athelqueen ( 8.780 tonnellate ) emerse per finirla, ma fu accolto a cannonate e fu costretto a rimmergersi: tentando di riportarsi a quota periscopica il sommergibile fu speronato dalla petroliera, nell'urto la prua si piegò rendendo inservibili i tubi di prua; allora Fecia di Cossato emerse e con un rabbioso duello di artiglieria mandò a picco la nave nemica. Nel viaggio di ritorno incontrò numerose navi, ma suo malgrado non poteva attaccarle per i danni riportati. Rientrò a Bordeaux il 31 marzo, dove lo aspettava la sua seconda Medaglia d'Argento al V.M.
Dopo che il suo secondo Gianfranco Gazzana Priaroggia, lo aveva lasciato per comandate il sommergibile Da Vinci, iniziò una gara incessante su chi tornava a casa con più navi nemiche affondate; nelle successive missioni Carlo Fecia di Cossato continuò ad affondare navi nemiche a ritmi incredibili, tanto da meritarsi l'appellativo di "Corsaro dell'Atlantico", sempre però comportandosi in maniera encomiabile tanto che in due successive missioni accolse tre naufraghi poiché il mare grosso li avrebbe messo in pericolo. In una missione dato che un suo marinaio si era gravemente ferito, lo fece sistemare nella sua cuccetta e lui fino alla fine della missione non toccò più il letto, alla domanda di un suo ufficiale: "comandante perché non dorme un pò - rispose - altrimenti non mi sveglierei più!".
In effetti le lunghe e faticose missioni avevano deperito di molto il fisico di Fecia di Cossato e quindi per motivi di salute nel febbraio del 1943 fu trasferito a comandare la 3° Sq Torpediniere a bordo della Tp Aliseo. A conferma delle qualità straordinarie di Carlo, il suo sommergibile andò perduto alla prima missione senza di lui. Fino a quel momento aveva affondato 16 navi nemiche per complessive 86.535 tsl: la sfida con il suo amico Cazzana Priaroggia, scomparso in mare con il suo sommergibile, finì in parità poiché quest'ultimo affondò solo 11 navi ma per complessive 90.601 tsl!
Promosso Capitano di Fregata, Fecia di Cossato, si meritò la Croce di Cavaliere il 19 marzo 1943 ed una Croce di Guerra nel luglio dello stesso anno. Sorpreso dall'armistizio nel porto di Bastia, e volendo ubbidire all'ordine del re di consegnare la flotta al vecchio nemico, uscì in mare la mattina successiva ma constatando l'aggressione che 2 cacciasommergibili e 7 ms. tedesche stavano portando al porto ed altre navi impossibilitate a difendersi, attacco con incredibile decisione e dopo un durissimo combattimento durato più di un'ora affondò tutte le navi tedesche, poi diresse per Malta.
Gli avvenimenti politico-militari dei mesi successivi scossero la profonda integrità militare di Fecia di Cossato, che si sentì tradito; amareggiato per le sorti dell'Italia e per la resa della Marina, che riteneva ignobile e priva di risultati, il 21 agosto scrisse una lettera di addio alla madre e il 27 agosto 1944 si suicidò. La Medaglia d'Oro al Valore Militare gli fu conferita postuma nel 1949, tutt'oggi un sommergibile della Marina Militare porta il nome di Fecia di Cossato.
Sotto il comando di FECIA di COSSATO (apr.‘41- feb.’43) il TAZZOLI compie ben sei lunghe missioni in Atlantico, spingendosi fin sotto le coste americane e affondando altre 16 navi mercantili: - P.fo AURILLAC di 4.733 t. inglese (15.4.41) - M/n FERNLANE di 4.310 t. norvegese (7.5.41) - Petr. ALFRED OLSEN di 8.817 t. norvegese (9.5.41) - Petr. SILDRA di 7.313 t. norvegese (19.8.41) - P.fo ASTREA di 1.406 t. olandese (6.3.42) - M/n TÖNSBERGFJORD di 3.156 t. norvegese (7.3.42) - P.fo MONTEVIDEO di 5.785 t. uruguaiano (9.3.42) - P.fo CYGNET di 3.628 t. panamense (11.3.42) - P.fo DAYTONIAN di 6.434 t. inglese (13.3.42) - Petr. ATHELQUEEN di 8.780 t. inglese (15.3.42) - P.fo CASTOR di 1.830 t. olandese (1.8.42) - Petr. HAVSTEN di 6.161 t. norvegese (6.8.42) - P.fo EMPIRE HAWK di 5.032 t. inglese (12.12.42) - P.fo OMBILIN di 5.658 t. olandese (12.12.42) - P.fo QUEEN CITY di 4.814 t. inglese (21.12.42) - P.fo DONA AURORA di 5.011 t. statunitense (25.12.42)
per un totale di quasi 83.000 t., un primato personale superato più tardi (per tonnellaggio, ma non per numero di navi) soltanto da quello di GAZZANA PRIAROGGIA (11 navi per oltre 90.000 t). Dal 7 al 29 dicembre ’41 partecipa, partendo da Bordeaux con altri tre battelli italiani, al salvataggio dei naufraghi (oltre 400) delle navi tedesche ATLANTIS e PYTHON, affondate sotto le Isole del Capo Verde

Un’impresa eccezionale, caso unico nella storia della marineria, di salvataggio a circa 1500 miglia di distanza; impresa che fece guadagnare a FECIA di COSSATO (e agli altri Comandanti) un’importante decorazione tedesca da parte dell’Amm. Dönitz.
Mamma carissima,
quando riceverai questa mia lettera, saranno successi dei fatti gravissimi che ti addoloreranno molto e di cui sarò il diretto responsabile. Non pensare che io abbai commesso quello che ho commesso in un momento di pazzia, senza pensare al dolore che ti procuravo. Da nove mesi ho molto pensato alla tristissima posizione morale in cui mi trovo, in seguito alla resa ignominiosa della Marina, a cui mi sono rassegnato solo perché ci è stata presentata come un ordine del Re, che ci chiedeva di fare l'enorme sacrificio del nostro onore militare per poter rimanere il baluardo della Monarchia al momento della pace. Tu conosci che cosa succede ora in Italia e capisci come siamo stati indegnamente traditi e ci troviamo ad aver commesso un gesto ignobile senza alcun risultato. Da questa triste constatazione me ne è venuta una profonda amarezza, un disgusto per chi ci circonda e, quello che più conta, un profondo disprezzo per me stesso. Da mesi, Mamma, rimugino su questi fatti e non riesco a trovare una via d'uscita, uno scopo alla mia vita.
Da mesi penso ai miei marinai del Tazzoli che sono onorevolmente in fondo al mare e penso che il mio posto sia con loro.
Spero, Mamma, che mi capirai e che anche nell'immenso dolore che ti darà la mia notizia della mia fine ingloriosa, saprai capire la nobiltà dei motivi che mi hanno guidato. Tu credi in Dio, ma se c'è un Dio non è possibile che non apprezzi i miei sentimenti che sono sempre stati puri e la mia rivolta contro la bassezza dell'ora. Per questo, Mamma, credo che ci rivedremo un giorno.
Abbraccia papà e le sorelle e a te, Mamma, tutto il mio affetto profondo e immutato. In questo momento mi sento molto vicino a tutti voi e sono sicuro che non mi condannerete.
A cura di Carlo GATTI
Bibliografia: sito della REGIA MARINA
RICORDO DI GIULIANO GOTUZZO

CARLO FECIA DI COSSATO - Medaglia d'Oro al Valor Militare
Questo foglio lo aggiungo in un secondo tempo per spiegare il perché di questa foto e di questa lettera successiva. Ho vissuto un tempo che per di più fu esaltante, ma che a me non esaltò affatto; parlo del dopo l'8 settembre. Io allora avevo 12 anni e non finirò di ringraziare il Padre Nostro per questo fatto. A chi era più grande di me e fu costretto ad una scelta tra la montagna o le rive di un lago dice oggi ed avrei voluto dire allora: "Pace fratelli, nella truce era dei lupi".
Senza un preciso motivo, ma solo per la passione che mi ha sempre animato, io avrei avuto un dilemma diverso: andare a Malta o autoaffondarmi. Ecco il perché di questa foto! Premesso che l'ordine di andare a Malta arrivò per ordine del Re.
Detto anche che allora la Marina era la Regia Marina e che quasi tutti gli ufficiali per affetto e per simpatia, per radicate tradizioni della famiglia da cui provenivano erano tutti legati o quasi alla persona del Re. Così l'8 Settembre arrivò l'ordine di cessare le attività e di rispondere agli attacchi da qualunque altra parte venissero. Carlo Fecia di Cossato era al comando dell'Aliseo nel porto di Bastia. Mosse subito la sua nave per uscire dal porto. Fu attaccato da 7 imbarcazioni che da alleate si trasformarono in nemiche. Una dopo l'altra le affondò tutte e durante il combattimento trovò il tempo di strapparsi le onorificenze tedesche che aveva sul petto e che aveva guadagnate nel periodo precedente al comando del sommergibile Tazzoli di base a Betasom. Era infatti uno degli assi della guerra in Atlantico. Nel Giugno del 44' a Taranto fu protagonista di un episodio che lo esalta ancor di più.
Lui e i suoi colleghi ufficiali che avevano per obbedienza al Re fatto un enorme sacrificio appresero con grave disappunto che alcuni ministri giunti da altre nazioni si erano rifiutati di prestare giuramento al Re. Scoppiò una quasi rivolta ed i marinai si rifiutarono di far uscire le navi e manifestarono in massa in favore di Carlo Fecia di Cossato. Il quale sbarcato, due mesi dopo, a Napoli, pose fine alla sua vita raggiungendo idealmente i suoi marinai del Tazzoli che nel frattempo era affondato in Oceano.
di Giuliano Gotuzzo
(Per gentile concessione di Nuccia Gotuzzo)
Rapallo, 2 Gennaio 2014
HMS INFLEXIBLE - Malta, 1913
HMS Inflexible
Malta, 1913
LE FOTO RACCONTANO
Le fotografie d'epoca, soprattutto quando realizzate "da lastra", beneficiano di una nitidezza, di un'incisione" e di qualità generali di livello superiore, consentendo ad un attento osservatore – nel contempo - di osservare tutta una serie di dettagli realmente interessanti se non addirittura, in non pochi casi, curiosi o inusuali.
Il Notiziario del CSTN riprende una tematica già sviluppata in passato, riprendendo a presentare in ogni fascicolo - a partire da questo numero - una fotografia ormai facente parte della storia fotografico-navale più generalmente intesa con caratteristiche di particolare livello tecnico, importanza storica e valenza documentale.

Foto n.1
HMS Inflexible, Malta, estate 1913 (Foto Studio Ellis, Malta – Coll.M.Brescia)
Iniziamo con un'immagine scattata a Malta, nell'estate estate del 1913, opera del noto studio fotografico "Ellis", attivo a La Valletta dalla fine dell'800 sino ai primi anni Trenta del secolo XX: vi è raffigurato l'incrociatore da battaglia Inflexible, nave di bandiera del 2nd Battlecruiser Squadron della Mediterranean Fleet, del quale fanno parte anche l'Invincible e l'Indomitable. Si notino l'assenza delle reti parasiluri e la banda bianca sul fumaiolo anteriore che contraddistingue l'unità nell'ambito del reparto di appartenenza; il rimorchiatore a ruote in primo piano é l'HMSCracker, mentre la "pre-dreadnought" ormeggiata di poppa all'Inflexible é, con ogni probabilità, la King Edward VII.
La fotografia è stata scattata da una posizione abbastanza inconsueta per i fotografi navali maltesi: difatti, all'epoca (e sino agli anni del secondo dopoguerra) la maggioranza delle navi militari veniva fotografata dai bastioni orientali della città della Valletta con - sullo sfondo - i sobborghi di Senglea e Vittoriosa, il "Dockyard Creek" e Fort St. Angelo.
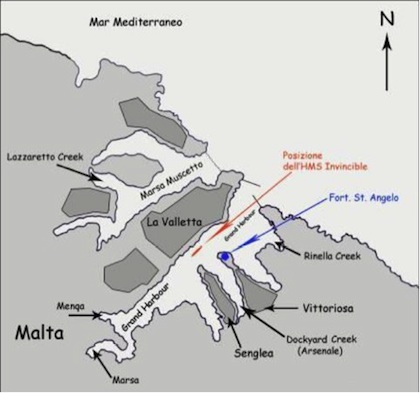
Foto n.2
Il Grand Harbour di Malta, La Valletta e il circondario con - evidenziate - la posizione dell'HMS
Inflexible (in rosso) e quella di fort. St. Angelo (in blu), da dove venne scattata la fotografia.
Al contrario questa immagine raffigura l'Invincible e le altre unità con la prora verso l'imboccatura del Grand Harbour, con i contrafforti degli "Upper Barrakka Gardens" sullo sfondo: di conseguenza, in considerazione delle posizioni relative dei vari elementi raffigurati, è stata scattata invece guardando verso ponente da una posizione sopraelevata, verosimilmente ubicata alla sommità di Fort. St. Angelo (si veda la cartina n. 2) –

Foto n.3
Il dettaglio del rimorchiatore HMS Cracker
Come evidenziavamo in precedenza, la stampa è eccezionalmente nitida per un documento fotografico risalente ad un secolo fa: ne è la prova il dettaglio del rimorchiatore HMS Cracker (foto n. 3) - utilizzato a dalla Royal Navy nel "Dockyard" (Arsenale) di Malta tra gli ultimi due decenni del secolo XIX e gli anni Trenta: in particolare evidenzia il metodo di propulsione "a pale" di questo mezzo d'uso portuale.
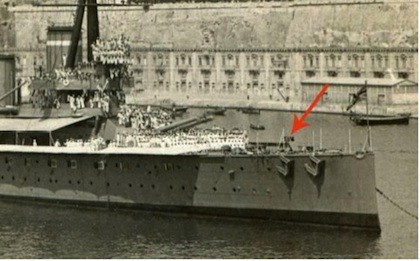
Foto n.4
Il dettaglio dell'equipaggio dell'HMS Inflexible schierato per la foto "ufficiale", con il fotografo indicato dalla freccia rossa.
Ma l'elemento più interessante è quello della foto n. 4, raffigurante il castello di prora dell'HMS Infvicible come si può notare, l'equipaggio è "in posa" sul ponte di castello, sulla torre binata prodiera da 305 mm e sui vari livelli della plancia comando mentre - indicato dalla freccia rossa - un fotografo munito di una grossa fotocamera "a treppiede" sta scattando una foto alla "ship's company" dell'unità. Come era uso all'epoca, per realizzare una foto "di gruppo" di questo genere gli ufficiali (con il comandate al centro) sono seduti nelle prime file, mentre il resto dell'equipaggio è in piedi o in altre posizioni, con alcuni marinai collocati anche a cavalcioni delle volate dei cannoni della torre di grosso calibro prodiera.
Un'immagine "del tempo che fu", dunque ma che - come tutte le fotografie navali del passato - ha il pregio di far rivivere l'atmosfera ormai trascorsa delle grandi unità corazzate armate con cannoni di grosso calibro: un aspetto della guerra sul mare definitivamente consegnato al passato ma il cui ricordo - grazie a immagini come questa che presentiamo oggi, può essere mantenuto vivo ancora ai nostri giorni.
Maurizio BRESCIA
Rapallo, 2 Gennaio 2014
GLI EROI DI ALESSANDRIA
GLI EROI DELL'IMPRESA DI ALESSANDRIA

L'attacco ad Alessandria (18 - 19 dicembre 1941)
|
« ...sei Italiani equipaggiati con materiali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l'equilibrio militare in Mediterraneo a vantaggio dell'Asse. » (Wiston Churchill) |
|
|
Luigi Durand de la Penne ed altri cinque eroi hanno affondato le navi inglesi Valiant e Queen Elizabeth. La loro impresa é passata alla storia per audacia, coraggio e grande sangue freddo. Si servirono di tre S.L.C. (siluri a lenta corsa) trasportati dal sommergibile-appoggio Scirè comandato dal Capitano di Fregata J.V. BORGHESE che fu anche l’ideatore dell’Operazione G.A.3.
CHI ERANO?

Luigi Durand de la Penne - Tenente di Vascello
Medaglia d'oro al Valor Militare
“Ufficiale coraggioso e tenace, temprato nello spirito e nel fisico da un duro e pericoloso addestramento, dopo aver mostrato, in due generosi tentativi, alto senso del dovere e di iniziativa, forzava, al comando di una spedizione di mezzi d'assalto subacquei, una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con una azione in cui concezione operativa ed esecuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sott'acqua e superando difficoltà ed ostacoli di ogni genere fino all'esaurimento di tutte le sue forze, disponeva la carica sotto una nave da battaglia nemica a bordo della quale veniva poi tratto esausto. Conscio di dover condividere l'immancabile sorte di coloro che lo tenevano prigioniero, si rifiutava di dare ogni indicazione sul pericolo imminente e serenamente attendeva la fine, deciso a non compromettere l'esito della dura missione. Rimasto miracolosamente illeso, vedeva, dalla nave ferita a morte, compiersi il destino delle altre unità attaccate dai suoi compagni. Col diritto alla riconoscenza della Patria conquistava il rispetto e la cavalleresca ammirazione degli avversari; ma non pago di ciò, una volta restituito alla Marina dopo l'armistizio, offriva nuovamente se stesso per la preparazione e l'esecuzione di altre operazioni, sublime esempio di spirito di sacrificio, di strenuo coraggio e di illuminato amor di Patria. Alessandria d'Egitto, 18 - 19 dicembre 1941.”
Nacque a Genova l'11 febbraio 1914. Dopo aver conseguito il diploma di Capitano Marittimo presso l'Istituto Nautico San Giorgio di Genova, nell'ottobre 1934 frequentò, presso l'Accademia Navale di Livorno, il Corso Ufficiali di complemento, al termine del quale, nel grado di Guardiamarina, imbarcò sul cacciatorpediniere Fulmine.Nel 1935 passò ad operare nell'ambito della 6a Squadriglia MAS di La Spezia e, trattenuto in servizio per esigenze eccezionali, connesse al conflitto italo-etiopico, nel 1938 conseguì la promozione a Sottotenente di Vascello. Nel secondo conflitto mondiale partecipò a numerose missioni con i MAS nel Mediterraneo e nell'ottobre 1940 conseguì la promozione a Tenente di Vascello. Passato ad operare con il Gruppo mezzi d'assalto, partecipò alla missione di Gibilterra (30 ottobre 1940) e all'impresa di forzamento della base inglese di Alessandria - Capogruppo dei "maiali" 221, 222 e 223 condotti rispettivamente dallo stesso Luigi Durand de la Penne, da Vincenzo Martellotta, e Antonio Marceglia, coadiuvati dai capi palombari Emilio Bianchi e Mario Marino e dal sottocapo Spartaco Schergat - che portò, all'alba del 19 dicembre 1941 all'affondamento delle navi da battaglia inglesi Valiant e Queen Elizabeth, della petroliera Sagona e al danneggiamento del cacciatorpediniere Jervis. De la Penne, dopo aver superato con notevoli difficoltà le ostruzioni del porto, da solo collocò la carica esplosiva sotto le torri di prora della Valiant e, risalito in superficie, venne scoperto e fatto prigioniero. Portato a bordo con il 2° capo Emilio Bianchi, secondo operatore del suo mezzo, fu rinchiuso in un locale adiacente al deposito munizioni e vi fu tenuto anche dopo che ebbe informato il comandante dell'unità inglese, Capitano di Vascello Morgan, dell'imminenza dello scoppio della carica, al fine di far porre in salvo l'equipaggio.Uscito indenne dall'esplosione che affondò la nave, tradotto prigioniero in India, nel febbraio 1944 rimpatriò a partecipò alla guerra di liberazione nel Gruppo Mezzi d'Assalto.Tutti gli operatori vennero poi decorati di Medaglia d'Oro al Valore Militare e promossi per merito di guerra. La consegna della decorazione a Luigi Durand de la Penne avvenne a Taranto nel marzo 1945 e fu l'occasione di uno storico episodio: fu infatti lo stesso comandante della Valiant nel 1941, Capitano di Vascello Sir Charles Morgan, divenuto ammiraglio, che decorò Luigi Durand de la Penne, su invito del luogotenente del Regno Umberto di Savoia che presiedeva la cerimonia. Promosso Capitano di Corvetta in data 31 dicembre 1941, Capitano di Fregata nel 1950 e Capitano di Vascello a scelta eccezionale nel 1954, nell'ottobre 1956 fu Addetto Navale in Brasile quindi, per mandato politico a seguito della sua elezione a Deputato al Parlamento (2a, 3a , 4a, 5a e 6a legislatura), fu collocato in aspettativa ed iscritto nel Ruolo d'Onore, dove raggiunse il grado di Ammiraglio di Squadra. L'Ammiraglio di Squadra (R.O.) Luigi Durand de la Penne morì a Genova il 17 gennaio 1992.
Altre decorazioni e riconoscimenti per merito di guerra:
• Medaglia d'Argento al Valore Militare sul Campo (Gibilterra, 1940);
• Trasferimento in s.p.e. nel grado di Tenente di Vascello (1941);
• Promozione al grado di Capitano di Corvetta (1941).
Antonio MARCEGLIA Capitano del Genio Navale

Medaglia d'oro al Valor Militare
“Ufficiale di altissimo valore, dopo aver dedicato tutte le sue forze ad un pericoloso e logorante periodo di addestramento, prendeva parte ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con un'azione in cui concezione operativa ed esecuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sott'acqua e superando difficoltà ed ostacoli di ogni genere, disponeva la carica sotto una nave da battaglia avversaria e, dopo aver distrutto l'apparecchio, prendeva terra sul suolo nemico dove veniva fatto prigioniero, non prima, però, di aver visto il pieno successo della sua azione. Luminoso esempio di cosciente eroismo e di alto spirito di sacrificio, si palesava degno in tutto delle gloriose tradizioni della Marina Italiana. Non pago di ciò, una volta restituito alla Marina dopo l'armistizio, offriva nuovamente se stesso per la preparazione e l'esecuzione di altre operazioni. Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941”
Nacque a Pirano (Pola) il 28 luglio 1915. Allievo dell'Accademia Navale nel Corpo del Genio Navale dal 1933, nel dicembre 1938 conseguì la nomina a Sottotenente del Genio Navale e, dopo la laurea ottenuta con il massimo dei voti nello stesso anno all'Università di Genova, conseguì la promozione a Tenente. Destinato prima presso il Comando Militare Marittimo Autonomo dell'Alto Adriatico, imbarcò poi su sommergibili e, alla dichiarazione di guerra dell'Italia del 10 giugno 1940, si trovava imbarcato sul sommergibile Ruggiero Settimo, con il quale partecipò a tre missioni in Mediterraneo. Nell'ottobre 1940, a domanda, passo nel Gruppo Mezzi d'Assalto e dopo un duro addestramento partecipò a due missioni contro la base navale inglese di Gibilterra (maggio e settembre 1941). Promosso Capitano G.N. nel gennaio 1941, nel dicembre dello stesso anno partecipò all'audace missione di forzamento del porto di Alessandria - condotta nella notte dal 18 al 19 dicembre, nell'incarico di 1° operatore del mezzo speciale 223 (2° operatore Palombaro Spartaco Schergat - che culminò con l'affondamento di due navi da battaglia inglesi (Valiant e Queen Elizabeth) e della petroliera Sagona e col danneggiamento del cacciatorpediniere britannico Jervis. Dopo l'azione condotta con successo contro la corazzata Queen Elizabeth, fu fatto prigioniero a condotto al campo per prigionieri di guerra n. 321, in Palestina, quindi fu trasferito in India. Rimpatriato nel febbraio 1944, partecipò alla guerra di liberazione con i Mezzi d'Assalto, compiendo una missione di guerra nell'Italia occupata dai tedeschi. Posto in congedo, a domanda, nel dicembre 1945 ed iscritto nel Ruolo del complemento con il grado di Tenente Colonnello G.N., assunse a Venezia la direzione di un cantiere navale. Il Tenente Colonnello G.N. Antonio Marceglia è morto a Venezia il 13 luglio 1992. Altre decorazioni e riconoscimenti per merito di guerra:
• Medaglia d'Argento al Valore Militare sul Campo (Gibilterra, maggio 1941);
• Croce di Guerra al Valore Militare sul Campo (Gibilterra, settembre 1941);
• Promozione a Maggiore Genio Navale (1941).
Vincenzo MARTELLOTTA Capitano delle Armi Navali

Medaglia d'oro al Valor Militare
“Ufficiale di altissimo valore, dopo aver dedicato tutte le sue forze ad un pericoloso e logorante periodo di addestramento, prendeva parte ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con un'azione in cui concezione operativa ed esecuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sott'acqua e superato difficoltà ed ostacoli di ogni genere, disponeva la carica sotto una nave avversaria e, dopo aver distrutto l'apparecchio, prendeva terra sul suolo nemico dove veniva fatto prigioniero, non prima, però, di aver visto il pieno successo della sua azione. Luminoso esempio di cosciente eroismo e di alto spirito di sacrificio, si palesava degno in tutto delle gloriose tradizioni della Marina Italiana. Non pago di ciò, una volta restituito alla Marina dopo l'armistizio, offriva nuovamente se stesso per la preparazione e l'esecuzione di altre operazioni. Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941”.
Nacque a Taranto il 1° gennaio 1913. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo Morea di Conversano (Bari) ed iscritto al 1° anno nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli, attratto dal mare, inoltrò domanda all'Accademia Navale di Livorno e nell'ottobre 1931 fu ammesso Allievo nel Corpo delle Armi Navali. Nel 1934 venne destinato all'Istituto Superiore di Guerra a Torino e, presso il Politecnico di questa città, conseguì la laurea in Ingegneria Industriale. Promosso Sottotenente A.N. nel 1935 e Tenente A.N. nel 1936, nell'ottobre 1937 e dopo aver terminato il Corso integrativo presso l'Accademia Navale, fu destinato a Massaua quale Ufficiale Dirigente delle Officine Siluri e Artiglieria e dell'Autoreparto. Rimpatriato nel 1939, svolse incarichi prima presso la Direzione Armi Subacquee a La Spezia e poi presso il Reparto Siluri, Lanciasiluri, Torpedini e Collaudo Sommergibili a Taranto. Nell'ottobre 1940, a domanda, passo negli operatori dei mezzi d'assalto ed al termine del duro corso addestrativo partecipò all'azione su Malta il 26 luglio 1941 ed a quella su Alessandria sulla notte dal 18 al 19 dicembre 1941, che culminò con l'affondamento di due corazzate e di una petroliera inglese. Coadiuvato dal 2° operatore Capo palombaro di 3a classe Mario Marino, attaccò la petroliera Sagona affondandola e danneggiando il cacciatorpediniere britannico Jervis. Tratto prigioniero dopo la vittoriosa azione, rimpatriò nel febbraio 1944 e partecipo alla guerra di liberazione nei Mezzi d'Assalto. Terminato il conflitto partecipò volontariamente alto sminamento ed alla bonifica dei porti di Genova, San Remo, Oneglia e Porto Maurizio, e, assieme al fratello Diego, Maggiore dei Bersaglieri ed esperto in chimica di guerra, alla bonifica dei porti di Brindisi, Bari, Barletta, Molfetta e Manfredonia. Nel 1947, con gli uomini del Nucleo di cui era al comando, domò un incendio sviluppatosi in un deposito di esplosivi a Bari e neutralizzo un potente aggressivo chimico fuoriuscito da un ordigno, scongiurando cosi gravissimi danni alla cittadinanza. Per questa azione, nella quale riporto ustioni da iprite tali da rendere necessario il suo ricovero in ospedale, venne decorato di Medaglia d'Argento al Valore Civile. Promosso Tenente Colonnello A.N. nel gennaio 1953, nel 1960, a domanda, venne collocato in ausiliaria nel grado di Colonnello A.N. Mori a Castelfranco Emilia (Modena) il 27 agosto 1973. Altre decorazioni e riconoscimenti per merito di guerra:
• Medaglia d'Argento al Valore Militare (Malta, luglio 1941);
• Medaglia d'Argento al Valore Civile (Porto di Bari, 1947);
• Promozione a Maggiore A.N. (1941).
Emilio BIANCHI Capo Palombaro di 3a Classe

Medaglia d'oro al Valor Militare
“Eroico combattente, fedele collaboratore del suo ufficiale, dopo averne condivisi i rischi di un tenace, pericoloso addestramento, lo seguiva nelle più ardite imprese e, animato dalla stessa ardente volontà di successo, partecipava con lui ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con un'azione in cui concezione operativa ed esecuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sott'acqua e superato difficoltà ed ostacoli di ogni genere, valido e fedele aiuto dell'ufficiale le cui forze erano esauste, veniva catturato e tratto sulla nave già inesorabilmente condannata per l'audace operazione compiuta. Noncurante della propria salvezza si rifiutava di dare ogni indicazione sul pericolo imminente, deciso a non compromettere l'esito della dura missione. Col suo eroico comportamento acquistava diritto all'ammirata riconoscenza della Patria e al rispetto dell'avversario. Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941”.
Nacque a Sondalo (Sondrio) il 22 ottobre 1912. Volontario nella Regia Marina dal marzo 1932 ed assegnato alla categoria Palombari, frequentò il Corso di specializzazione presso la Scuola C.R.E.M. del Varignano (La Spezia) ed al termine imbarcò sulla nave idrografica Ammiraglio Magnaghi, con la quale compi poi due crociere idrografiche nell'Egeo e nel Mar Rosso. Nel 1934 imbarcò sull'incrociatore Fiume, dove conseguì la promozione a Sottocapo, e nel 1936 venne destinato al 1° Gruppo Sommergibili di La Spezia. Conseguita la promozione a Sergente nel 1937, passò ad operare nella 1a Flottiglia MAS, dando inizio all'addestramento che lo doveva poi far diventare Operatore dei mezzi d'assalto subacquei. Durante il conflitto partecipò, nel grado di 2° Capo, ai due tentativi di forzamento della base inglese di Gibilterra (ottobre e novembre 1940), quindi all'audace forzamento della base di Alessandria come 2° operatore dell'LSC (maiale) n. 221 condotto dal Tenente di Vascello Luigi Durand de La Penne. Partito da bordo del sommergibile Sciré nella notte del 18 dicembre, dopo aver superato gli sbarramenti penetrò con il suo capo operatore all'interno del porto e portò il suo mezzo esplosivo sotto la chiglia della nave da battaglia inglese Valiant, che per lo scoppio, affondò all'alba del 19 dicembre. Colpito durante il tragitto da intossicazione di ossigeno, a causa del durissimo sforzo che ebbe a compiere durante le cinque ore di immersione, costretto a risalire a galla, dopo qualche tempo fu scoperto dalle sentinelle di bordo e, assieme al suo comandante, rinchiuso in un locale di bordo posto nelle immediate vicinanze della santabarbara. Salvatosi fortuitamente dopo lo scoppio della carica, che provocò l'affondamento della nave, venne condotto in un campo di concentramento e rimpatriato al termine del conflitto. Promosso per meriti di guerra Capo di 3a Classe e di 2a Classe, nel 1954, a scelta, conseguì la promozione a Capo di 1a Classe Palombaro. Nel grado di Ufficiale del C.E.M.M. prestò successivamente servizio al Centro Subacqueo del Varignano, al Nucleo Sminamento di Genova ed infine all'Accademia Navale di Livorno, terminando la carriera nel grado di Capitano di Corvetta (CS). Altri riconoscimenti per merito di guerra:
• Promozione a Capo 3a Classe (1941);
• Promozione a Capo 2a Classe (1941).
Mario MARINO Capo palombaro di 3^ classe

Medaglia d'oro al Valor Militare
“Eroico combattente, fedele collaboratore del suo Ufficiale, dopo averne condivisi i rischi di un tenace, pericoloso addestramento, lo seguiva nelle più ardite imprese e, animato dalla stessa ardente volontà di successo, partecipava con lui ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con un'azione in cui concezione operativa ed esecuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sott'acqua e superato difficoltà ed ostacoli di ogni genere, valido e fedele aiuto dell'Ufficiale; offesa a morte con ferma bravura, la nave attaccata, seguiva in prigionia la sorte del suo Capo, rifiutandosi costantemente di fornire al nemico qualsiasi indicazione. Superbo esempio di ardimento nell'azione e di eccezionali qualità morali. Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941”.
Nacque a Salerno il 27 marzo 1914. Volontario nella Regia Marina dal gennaio 1934 ed assegnato alla categoria Palombari, frequentò il corso presso la Scuola C.R.E.M. del Varignano (La Spezia) ed al termine fu destinato presso il Comando Marina di Gaeta. Imbarcò poi sul cacciatorpediniere Freccia e nel 1936 sul sommergibile H.6 sul quale frequento il 1° Corso Sommozzatori ed effettuò le prime sperimentali uscite da sommergibile immerso. A corso ultimato s'imbarcò sull'esploratore da Recco, col quale partecipò a missioni di guerra durante il conflitto italo-etiopico e nella guerra di Spagna. Nel 1938 prese successivamente imbarco sulle navi appoggio Teseo e Titano e su quest'ultima frequentò il Corso per Alti Fondali. Il 4 giugno 1940 sbarcò dal Titano a passò in forza alla 1a Flottiglia MAS quale operatore subacqueo dei mezzi d'assalto ideati dal Maggiore del Genio Navale Teseo Tesei, e partecipò a missioni di guerra con i MAS. Promosso 2° Capo Palombaro Sommozzatore, nel maggio 1941, partecipò, nella notte tra il 26 ed il 27 luglio 1941, all'impresa di forzamento della base navale inglese di Malta nell'incarico di 2° operatore del mezzo di riserva a disposizione del Capitano delle Armi Navali Vincenzo Martellotta. Sempre con Vincenzo Martellotta partecipò, col semovente 222, al forzamento della base navale inglese di Alessandria del 18 e 19 dicembre 1941, coronato dal successo con l'affondamento di due navi da battaglia e di una grossa petroliera ed il danneggiamento di un cacciatorpediniere. Tratto in prigionia dopo la riuscita missione, rimpatriò nell'ottobre 1944, partecipando poi alla guerra di liberazione nel Gruppo Mezzi d'Assalto. Promosso Capo di 1a Classe nel 1949, Sottotenente del C.E.M.M. nel 1962, ebbe il comando del Gruppo S.D.A.I. di La Spezia che mantenne fino al suo collocamento in ausiliaria, avvenuto nel grado di Capitano di Corvetta (CS) nel marzo 1977. Il Capitano di Corvetta (CS) Mario Marino è morto a Salerno l'11 maggio 1982.
Altre decorazioni a riconoscimenti per merito di guerra:
• Medaglia di Bronzo al Valore Militare (Canale di Sicilia, 1941);
Promozione a Capo Palombaro di 3a Classe.
Spartaco SCHERGAT Palombaro
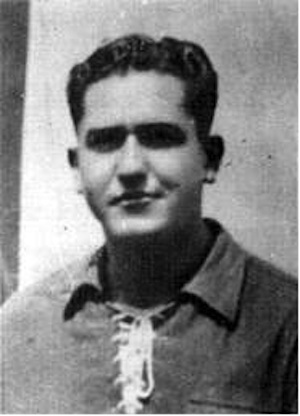
Medaglia d'oro al Valor Militare
“Eroico combattente, fedele collaboratore del suo Ufficiale dopo averne condiviso i rischi di un tenace, pericoloso addestramento, lo seguiva nelle più ardite imprese e, animato dalla stessa ardente volontà di successo, partecipava con lui ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con un'azione in cui concezione operativa ed esecuzione pratica armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sott'acqua e superato difficoltà ed ostacoli di ogni genere, valido e fedele aiuto dell'Ufficiale; offesa a morte con ferma bravura, la nave attaccata, seguiva in prigionia la sorte del suo Capo, rifiutandosi costantemente di fornire al nemico qualsiasi indicazione; superbo esempio di ardimento nell'azione e di eccezionali qualità morali. Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941”.
Nacque a Capodistria (Pola) il 12 luglio 1920. Volontario nella Regia Marina dal marzo 1940, ed assegnato alla categoria Palombari, al termine del corso sostenuto presso la Scuola C.R.E.M. di San Bartolomeo (La Spezia) e brevettato palombaro, a domanda, passo nella X Flottiglia MAS quale Operatore dei mezzi speciali d'assalto. Partecipò alle missioni di forzamento di Gibilterra del maggio e del settembre 1941 e all'impresa di Alessandria dell'alba del 19 dicembre dello stesso anno quando, 2° operatore del "maiale" condotto dal Capitano G.N. Antonio Marceglia, portò il carico di esplosivo sotto la corazzata inglese Queen Elizabeth che, per lo scoppio della carica, affondò all'alba del 19 dicembre 1941. Fatto prigioniero e condotto nel campo inglese n. 321 in Palestina, nell'ottobre 1944 rientrò in Patria partecipando alla guerra di liberazione nel Gruppo Mezzi d'Assalto. Congedato nel novembre 1945, fu iscritto nel Ruolo d'Onore nel grado di 2° Capo. Altre decorazioni e riconoscimenti per merito di guerra:
• Medaglia di Bronzo al Valore Militare (Gibilterra, 1941);
• Croce di Guerra al Valore Militare (Gibilterra, 1941);
• Croce di Guerra al Valore Militare (Mediterraneo occidentale, settembre-novembre 1941); Promozione a Sergente (1941).
L'affondamento della Valiant e della Queen Elizabeth
La più celebre delle azioni della Xª Flottiglia MAS (operazione G.A.3), l'affondamento delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elizabeth e della petroliera Sagona ormeggiate nel porto di Alessandria d'Egitto, venne effettuata il 19 dicembre 1941. Si trattò di una sorta di rivincita delle forze armate italiane per le gravi perdite navali subite nella "notte di Taranto" (ottobre 1940). È rimasta famosa come: Impresa di Alessandria.

Foto di Autore ignoto, scattata nel 1942 e ripresa dal sito regiamarina.net; la foto ritrae lo Scirè con sul ponte di coperta i contenitori per due mezzi d'assalto.
La notte del 3 dicembre il sommergibile Sciré, al comando dal Tenente di vascello Junio valerio Borghese lasciò La Spezia per la missione G.A.3. Fece scalo a Lero per imbarcare gli operatori dei mezzi d'assalto giunti in aereo dall’Italia. Il 14 dicembre il sommergibile si diresse verso la costa egiziana per l'attacco previsto nella notte del 17. A causa di una violenta mareggiata l'azione ritardò di un giorno. “Tutto il male non vien per nuocere”, recita un vecchio adagio. Infatti, la notte del 18, il mare spianò completamente, non solo, ma proprio quella notte i nostri eroi approfittarono dell'arrivo di tre cacciatorpediniere per entrare nel varco aperto nelle difese del porto. I treSCL (Siluro a lunga corsa), pilotati ciascuno da due uomini, penetrarono nella base per dirigersi verso i loro obiettivi. Capogruppo dei "maiali" 221, 222 e 223 condotti rispettivamente dallo stesso Durand de la Penne, Vincenzo Martellotta, e Antonio Marceglia, coadiuvati dai capi palombari Emilio Bianchi e Mario Marino e dal sottocapo Spartaco Schergat.
Gli incursori dovevano giungere sotto la chiglia del proprio bersaglio, piazzare la carica d'esplosivo e successivamente abbandonare la zona dirigendosi a terra e autonomamente cercare di raggiungere il sommergibile che li avrebbe attesi qualche giorno dopo al largo di Rosetta.
Siluro a lenta corsa detto comunemente “MAIALE” – (Museo Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate, Vittoriano - Roma.
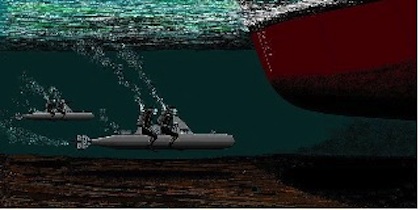

Il sommergibile Scirè, dopo una navigazione in zona minata, si portò davanti al porto di Alessandria d'Egitto «a 1,3 miglia nautiche, per 356° dal Fanale del molo di ponente del porto commerciale di Alessandria, in fondale di m.15» e da lì lasciò partire la flottiglia di maiali che attaccarono le navi inglesi ancorate nel porto. Antonio Marceglia e Spartaco Schergat affondarono la corazzata Queen Elizabeth, Vincenzo Martellotta e Mario Marino la petroliera Sagona e danneggiarono il cacciatorpediniere Jervis.

Nave da Battaglia HMS Valiant
L'equipaggio Durand de la Penne - Bianchi sul maiale nº 221 puntò verso la nave da battaglia Valiant. Perso il secondo a causa di un malore, Durand de la Penne trascinò sul fondo il proprio mezzo fino a posizionarlo sotto la carena della nave da battaglia prima di affiorare, essere catturato e portato proprio sulla corazzata. Dopo poco, gli inglesi catturarono anche Bianchi, che era risalito alla superficie e si era aggrappato ad una boa di ormeggio della corazzata, e lo rinchiusero nello stesso compartimento sotto la linea di galleggiamento nel quale avevano portato Durand de la Penne, nella speranza di convincerli a rivelare il posizionamento delle cariche.

Alle 05,30, a mezz'ora dallo scoppio, de la Penne chiamò il personale di sorveglianza per farsi condurre dall'ammiraglio Cunningham, comandante della Mediterranean Fleet, ed informarlo del rischio corso dall'equipaggio; ciò nonostante Cunningham fece riportare l'ufficiale italiano dov'era. All'ora prevista, l'esplosione squarciò la carena della corazzata provocando l'allagamento di diversi compartimenti mentre molti altri venivano invasi dal fumo, ma il compartimento che ospitava gli italiani rimase intatto e i due vennero evacuati insieme al resto dell'equipaggio. La Valiant e la Queen Elizabeth, grazie alle acque basse del porto non affondarono completamente e dopo lunghi lavori di riparazione furono recuperate e rimesse in servizio.
Martellotta e Marino, sul maiale nº 222, costretti a navigare in superficie a causa di un malore del primo, condussero il loro attacco alla petroliera Sagona. Dopo aver preso terra vennero anch'essi catturati dagli egiziani. Intorno alle sei del mattino successivo ebbero luogo le esplosioni. Quattro navi furono gravemente danneggiate nell'impresa: oltre alle tre citate anche il cacciatorpediniere HMS Jervis, ormeggiato a fianco della Sagona, fu infatti vittima delle cariche posate dagli assaltatori italiani.

Nave da battaglia QUEEN ELIZABETH
Marceglia e Schergat sul maiale nº 223, in una «missione perfetta», «da manuale» rispetto a quelle degli altri operatori, attaccarono invece la Queen Elizabeth, alla quale agganciarono la testata esplosiva del loro maiale, quindi raggiunsero terra e riuscirono ad allontanarsi da Alessandria, per essere catturati il giorno successivo, a causa dell'approssimazione con la quale il nostro servizio segreto militare, il SIM, aveva preparato la fuga: vennero date agli incursori banconote che non avevano più corso legale in Egitto e per cercare di cambiare le quali l'equipaggio perse tempo. Nonostante il tentativo degli italiani di spacciarsi per marinai francesi appartenenti all'equipaggio di una delle navi in rada, vennero riconosciuti e catturati.
Sebbene l'azione fosse stata un successo, le navi si adagiarono sul fondo, e non fu immediatamente possibile avere la certezza che non fossero in grado di riprendere il mare. Nonostante tutto, le perdite di vite umane furono molto contenute: solo 8 marinai persero la vita.
L'azione italiana costò agli inglesi, in termini di naviglio pesante messo fuori uso, come una battaglia navale perduta e fu tenuta per lungo tempo nascosta anche a causa della cattura degli equipaggi italiani che effettuarono la missione. La Valiant subì danni alla carena in un'area di 20 x 10 m a sinistra della torre A, con allagamento del magazzino munizioni A e di vari compartimenti contigui. Anche gli ingranaggi della stessa torre vennero danneggiati e il movimento meccanico impossibilitato, oltre a danni all'impianto elettrico. La nave dovette trasferirsi a Durban per le riparazioni più importanti che vennero effettuate tra il 15 aprile ed il 7 luglio 1942. Le caldaie e le turbine rimasero però intatte. La Queen Elizabeth invece fu squarciata sotto la sala caldaie B con una falla di 65 x 30 m che passava da dritta a sinistra, danneggiando l'impianto elettrico ed allagando anche i magazzini munizioni da 4,5", ma lasciando intatte le torri principali e secondarie. La nave riprese il mare solo per essere trasferita a Norfolk, in Virginia, dove rimase in riparazione per 17 mesi.
Per la prima volta dall'inizio del conflitto, la flotta italiana si trovava in netta superiorità rispetto a quella britannica, a cui non era rimasta operativa alcuna corazzata la HMS Barham era stata a sua volta affondata da un sommergibile tedesco il 25 novembre 1941). La Mediterranean Fleet alla fine del 1941 disponeva solo di quattro incrociatori leggeri e alcuni cacciatorpediniere.
L'ammiraglio Cunningham per ingannare i ricognitori italiani decise di rimanere con tutto l'equipaggio a bordo dell'ammiraglia che, fortunatamente per lui, si appoggiò sul fondale poco profondo. Per mantenere credibile l'inganno nei confronti della ricognizione aerea, sulle navi si svolgevano regolarmente le cerimonie quotidiane, come l'alzabandiera. Poiché l'affondamento avvenne in acque basse le due navi da battaglia furono recuperate negli anni successivi, ma la sconfitta rappresentò un colpo durissimo per la flotta britannica, che condizionò la strategia operativa anche ben lontano dal teatro operativo del Mediterraneo. A questo proposito, Churchill scrisse:
|
« Tutte le nostre speranze di riuscire a inviare in Estremo Oriente delle forze navali dipendevano dalla possibilità d’impegnare sin dall’inizio con successo le forze navali avversarie nel Mediterraneo »
|
Tuttavia, contrasti tra gli Stati Maggiori dell'ASSE non permisero di sfruttare questa grande occasione di conquistare il predominio aeronavale nel Mediterraneo e occupare Malta.
Durante il periodo dell'armistizio de la Penne venne decorato con la medaglia d'oro al valor militare che gli venne appuntata dalcommodoro sir Charles Morgan, ex comandante della Valiant. Stessa decorazione venne concessa agli altri cinque operatori della Xª.
Dal sito di PPORTOFINO riportiamo:
DURAND DE LA PENNE, AMMIRAGLIO SIMBOLO DI PORTOFINO Subito dopo l’ingresso dei piccolo cimitero di Portofino, posto in uno dei luoghi più belli dei mondo, si vede a sinistra un busto dell’eroe di Alessandria d’Egitto, l’ammiraglio Durand De la Penne, Medaglia d’oro al Valor Militare. E’ stato donato dai portofinesi in onore e memoria e scolpito da Lorenzo Cascio – artista presente con il suo studio in Piazzetta sulla destra, prima di salire verso la Chiesa di San Giorgio.

Visto di profilo, il busto ci dà l’esatta impressione del temperamento volitivo dell’uomo con quello sguardo deciso che ci fa ricordare la fredda risoluzione con la quale egli seppe realizzare l’affondamento, ad Alessandria d’Egitto, della corazzata inglese “Valiant”.

I suoi stessi avversari ne riconobbero appieno l’eroismo. Simbolicamente posto in un luogo dal quale si domina il mare, quel busto sta a significare l’affetto di un’intera popolazione per un uomo che ha rischiato la vita nel mare che è sempre stato l’elemento essenziale della vita portofinese. Luigi Durand De la Penne 1914 – 1992
Carlo GATTI
Rapallo, 1 Gennaio 2014