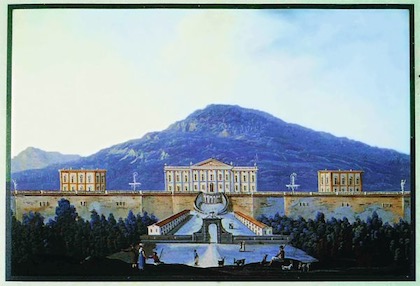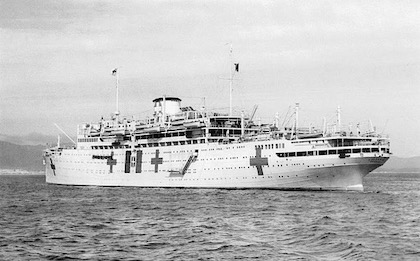I PALOMBARI - COSTA CONCORDIA
I PALOMBARI
Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.
PALOMBARI: I silenziosi protagonisti del recupero dei superstiti Caso Concordia




Vestono una tuta di gomma, calzano scarponi di piombo e portano pesi e un caratteristico elmo di rame che ha affibbiato loro il bonario nomignolo di “teste di rame”. Sono i Palombari delle Forze Specialistiche Subacque della Marina Militare. Sono loro che continuano con perseveranza ad aprire con microcariche varchi di dimensioni prestabilite nella struttura sommersa al fine di trovare superstiti e tracciare vie di fuga per il personale stesso che entra nella nave. <<Siamo giunti sul posto in 12, divisi in due squadre, il giorno dopo l’incidente con l’elicottero. Successivamente ci ha fatto d’appoggio la nave Pedretti che, imbarcando una camera iperbarica mobile e un infermiere specializzato in fisiopatologia subacquea, ha fornito a noi e agli altri soccorritori la copertura sanitaria contro i barotraumi>>, ci aggiorna il primo maresciallo palombaro Fabio Masuzzo, da oltre 15 anni nel Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.). Lui e i suoi compagni hanno effettuato immersioni sino alla profondità di 36 metri ad aria di profondità per eseguire ispezioni sotto lo scafo e valutare i danni e la stabilità dell’imbarcazione. I loro orecchi, sempre tesi a cogliere il minimo rumore proveniente dal relitto, e i loro occhi sono i più affidabili testimoni di un disastro che a detta loro, che sul posto ci sono stati, si può definire “impressionante” sia per la mole della nave e sia per il numero di passeggeri coinvolti che non ha uguali nella nostra storia civile.
In soccorso ai sommergibili
E’ infatti la prima volta che il G.O.S. è stato impegnato con un’unità passeggeri di simile portata. <<Venti anni fa è stato attivato per soccorrere il personale intrappolato nell’Espresso Trapani, il traghetto che nel 1990 affondò tra l’isola di Levanzo e lo scoglio dei Porcellini a poche miglia di distanza dal porto della città siciliana. Allora persero la vita 13 persone>>, ricorda Riccardo Fantini, capitano di Corvetta della Marina Militare Italiana. Di solito questi intrepidi subacquei si occupano di altro, in particolare del soccorso ai sommergibili sinistrati. <<Per i nostri sei sommergibili, tra cui si annoverano il Todaro e lo Scirea noti per la loro innovativa tecnica di propulsione, non c’è stato fortunatamente mai bisogno del loro intervento>>, spiega Riccardo Fantini. <<Si sono però proposti per soccorrere il sommergibile Kursk in cui morirono oltre cento uomini della Marina russa: l’Unione Sovietica all’epoca non accolse il loro intervento, come del resto quello degli altri paesi NATO>>. Con questo compito il G.O.S. fa parte di ISMERLO (International Submarine Escape and Rescue Liaison Office), un servizio internazionale che coordina tutte le marine che vi partecipano sulle stesse coordinate di fuga e di salvataggio dai sommergibili.
I mezzi speciali
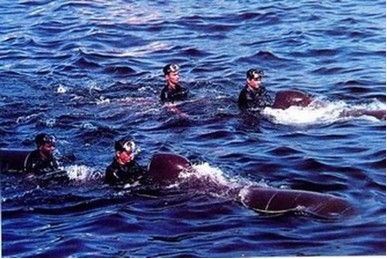
Il palombari del G.O.S, elite della nostra Marina, hanno aperto sette varchi per raggiungere parti sommerse dello scafo della Costa Concordia.
Giusto l’anno scorso il G.O.S. ha partecipato all’esercitazione Bold Monarch, tenutasi a Cartagena in Spagna, volta a migliorare la cooperazione per il recupero di vite umane dai sommergibili danneggiati. Per svolgere questa attività utilizza il mini sommergibile SRV 300, un veicolo subacqueo capace di raggiungere una profondità di 300 m e di trasferire sul sommergibile sinistrato 12 operatori a ogni viaggio, e la campana McCann, collegata con la superficie e in grado di arrivare a 120 m di profondità e di trasferire 6 persone per ogni viaggio. Molto utile nei soccorsi si è dimostrato l’A.D.S. (Atmospheric Diving Suit), una tuta in metallo collegata alla superficie da un cavo ombelicale che crea al suo interno una pressione ambientale e permette quindi agli operatori di immergersi fino a 300 m di profondità senza dover eseguire pressurizzazioni e depressurizzazioni. Grazie a essa i subacquei possono svolgere interventi in tempo reale e rimanere sottacqua il tempo che vogliono in base alla loro resistenza fisica.
Le bonifiche di ordigni
I palombari del G.O.S. sono inoltre chiamati a disinnescare piccoli e grandi ordigni esplosivi, appartenenti al II conflitto mondiale e rinvenuti a tutt’oggi nei mari, nei fiumi o nei litorali: un’attività che li impegna con più di 4.400 interventi all’anno. Chi sono dunque questi arditi operatori? <<Sono persone altamente addestrate, già in servizio presso la Marina, che hanno superato un’accurata selezione>>, spiega Riccardo Fantini. <<Prima di essere ammessi al corso che dura 10 mesi e prevede 300 immersioni tra diurne e notturne, si sottopongono a prove di idoneità fisica che valutano per esempio la capacità respiratoria, cardiaca e cerebrale. Una volta superate possono accedere alla selezione in vasca per testare la loro acquaticità>>. Il loro brevetto è davvero sudato ed ha un rateo di successo del 15 per cento circa: su 20 candidati solo 5 o 6 lo ottengono.
Manuela Campanelli
Rapallo, 28 luglio 2018
LA GARA PSEUDO SPORTIVA CHE CAMBIO' LA STORIA NAVALE
LA GARA PSEUDO SPORTIVA … CHE CAMBIO' LA STORIA NAVALE
I migliori bookmakers europei sono inglesi. Le prime scommesse e le prime agenzie sono nate nel Regno Unito. La popolazione anglosassone ha una cultura per il gioco nettamente differente dalla nostra.
Gli inglesi vivono la scommessa come un divertimento quotidiano e come un piacevole passatempo. Scommettono in tutti gli aspetti finanziari, economici, politici, NAVALI, sociali, musicali e sportivi. E’ possibile giocare con l’exchange online, puntare sul colore del cappellino della Regina o scommettere sulla vittoria del Liverpool nella Premier League.
Tempo fa scrissi:
I CLIPPERS – LE FERRARI DELL’800 - LA GRANDE CORSA DEL TE’ del 1866
Di cui riprendo un passo:
Nella “Londra Vittoriana”, con il consumo del tè, ci fu un vero cambiamento di costume nazionale, in pratica s’instaurò una moda che ebbe molte ripercussioni persino nei trasporti marittimi. L’annuale arrivo del primo carico di tè primaverile cinese, considerato il migliore (una pianta dava tre raccolti), veniva pagato 10 scellini ogni 50 piedi cubici, e 100 sterline di premio erano destinate al Capitano del clipper che arrivava per primo sui mercati. Questo tangibile riconoscimento diede il via ad una vera e propria “corsa del tè” che coinvolse navi e capitani famosi, in primo luogo il “Cutty Sark” che, ironia della sorte, non riusciva ad imporsi sul diretto concorrente “Thermopylae”, malgrado la sua meritatissima fama. Molte furono le coppie rivali di clippers che divisero l’opinione pubblica mondiale in vere e proprie tifoserie di scommettitori e appassionati che investivano somme ingenti sulle vittorie di questi “levrieri d’altura”. Qui si aprirebbe un capitolo lunghissimo e affascinante, purtroppo, per ragioni di spazio, non possiamo che fare riferimento soltanto a quella che fu la gara più spettacolare che sublimò le grandi corse dei clippers.
Dopo questa premessa che fa da sfondo “all’atmosfera inglese” di metà ‘800, vi racconto oggi un’altra “leggendaria sfida”, con contorno di scommesse a livelli stratosferici, che pose fine ad un’accanita discussione tecnica che aveva diviso l’opinione pubblica (marittima) inglese in due fazioni: quella rivoluzionaria a favore dell’elica come propulsore navale, e quella favorevole al sistema a pale che aveva, da par suo, molti sostenitori nel settore dei trasporti fluviali e lacustri.
Entrando nello specifico della questione, dobbiamo anche aggiungere che nel corso della prima metà del 1800 vi furono i più radicali cambiamenti nelle costruzioni navali, dal legno al metallo, dalle vele al vapore e, ultima e non meno importante, dalla ruota a pale all'elica.
In questo clima “rivoluzionario” che toccò l’Inghilterra dei Trasporti Marittimi, dobbiamo ricordare che nella “Perfida Albione” * che possedeva la più grande flotta, sia mercantile che militare, si svilupparono accese discussioni e lotte accanite, negli ambienti marittimi, tra i sostenitori dell'una e dell'altra soluzione, ed ognuna esaltava i pregi e i difetti dei due sistemi.
Per superare il problema e mettere la parola fine a tutte le teorie esistenti, gli Inglesi si affidarono, con molto senso pratico, ai risultati di due gare dal sapore molto sportivo: una di velocità ed una di potenza tra due navi identiche ma con le propulsioni in voga in quel momento.
Ora capite che il riferimento alle gare tra i CLIPPERS e al rituale delle scommesse non era casuale…
Ogni discussione su questo tema ebbe fine nel marzo del 1845, in stile tipico anglosassone, quando due fregate da 880 tonnellate, praticamente identiche, la Rattler e l'Alecto, accettarono di sfidarsi in mare aperto.
Le due navi furono entrambe dotate di una macchina da 220 hp, con la differenza che quella della Rattler azionava un'elica mentre quella dell'Alecto una coppia di ruote a pale.

Arrivò il giorno della sentenza PRATICA con le due navi che si sfidarono davanti al mondo!
Il confronto consisteva in due prove: di velocità la prima, e di potenza la seconda.
- Per la gara di velocità, su un percorso di 100 miglia, la Rattler vinse con un distacco di diverse miglia.
- Per la gara di potenza, fu deciso di prendere in prestito dalle famose Università britanniche il termine sportivo: TIRO ALLA FUNE.
Le due navi furono unite poppa a poppa con un grosso cavo e furono spinte in direzioni opposte con le macchine a tutta forza, in una sorta di tiro alla fune…;
dopo alcuni minuti la Rattler trascinava la Alecto fino a raggiungere la velocità di 2,7 nodi.
Fu la dimostrazione “pratica” e definitiva della superiorità dell'elica sulla ruota a pale.
Naturalmente in quell’ultima occasione si registrarono impennate altissime nel BETTING (scommesse) su tutti i territori della Gran Bretagna comprese le colonie di quel tempo.
Un po’ di Storia
La propulsione a vite (elica) aveva alcuni evidenti vantaggi potenziali per le navi da guerra rispetto alla propulsione a pale. In primo luogo, le ruote a pale erano esposte al fuoco nemico in combattimento, mentre un'elica e i suoi macchinari erano nascosti in sicurezza ben al di sotto del ponte. In secondo luogo, lo spazio occupato dalle ruote a pale limitava il numero di armi che una nave da guerra poteva portare, riducendo così la sua bordata. Questi potenziali vantaggi erano ben compresi dall’ammiragliato britannico, ma non era convinto che l'elica fosse un sistema di propulsione efficace. Fu solo nel 1840, quando la prima nave a vapore a propulsione ad elica al mondo, la SS Archimedes, completò con successo una serie di prove contro le più veloci imbarcazioni con ruote a pale, che la Marina decise di condurre ulteriori prove della tecnologia. Per questo scopo, la Marina costruì la HMS Rattler.
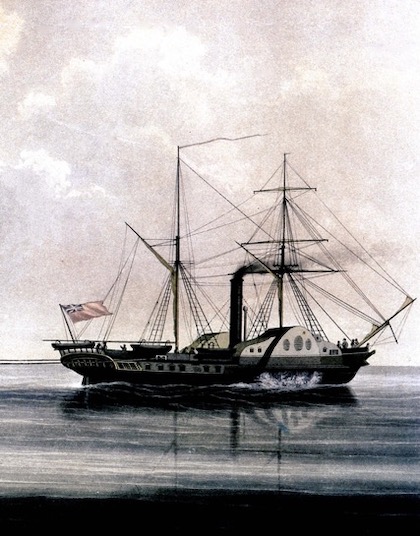
ALECTO - la sconfitta
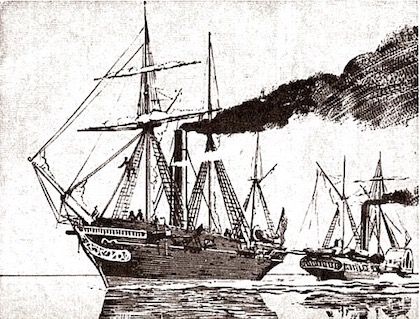
L'HMS Rattler, (nella foto) La vincitrice del confronto
Era uno sloop in legno della Royal Navy dotato di 9 cannoni, fu la prima nave da guerra britannica ad adottare un’elica a vite azionata da un motore a vapore.
L'HMS Rattler fu varata il 13 aprile 1843 al Sheerness Dockyard e trainato nel cantiere di Maudslay per l'installazione dei suoi macchinari. Ricevette un motore a vapore verticale a quattro cilindri ad espansione singola con doppio cilindro, della potenza di 200 nhp e sviluppa 326 chilowatt (437 ihp). Un gran numero di eliche furono testate durante questo periodo su HMS Rattler per trovare il progetto di elica più efficace.
Fu ramata al Woolwich Dockyard e vennero fatta diverse prove nel corso dei due anni successivi, il suo primo giorno in mare fu il 30 ottobre 1843. L'HMS Rattler fu impegnato contro diverse imbarcazioni dotate di ruote a pale dal 1843 al 1845. Queste prove estese dimostrarono in modo conclusivo che l'elica a vite era superiore alla ruota a pale come sistema di propulsione
Il suo armamento consisteva in un singolo cannone da 20 cm e otto cannoni da 32 lb posti sulle fiancate. Fu commissionata a Woolwich il 30 gennaio 1845 e fu comandata per la prima volta dal comandante Henry Smith.
* Nota
La perfida Albione - Non fu Mussolini a inventare l’espressione “Perfida Albione” per definire spregiativamente l’Inghilterra. Le ricostruzioni storiche hanno trovato associazioni tra l’aggettivo e il nome usato dai greci per definire la Gran Bretagna già nel tredicesimo secolo. Ma la sua canonizzazione viene attribuita al Marchese Agostino di Ximenes, un francese di origine spagnola, autore alla fine del Settecento di un verso che diceva
“Attacchiamo la perfida Albione nelle sue acque”.
Da quei tempi rivoluzionari mal giudicati in Inghilterra, i francesi presero a usare l’espressione spesso in ogni occasione di tensione tra i due paesi. Ma quando – nel XX secolo – i rapporti tra i paesi migliorarono con le alleanze militari nelle due guerre, il disprezzo per l’Inghilterra fu raccolto dai regimi fascisti e in special modo in Italia da Mussolini il quale parlò di “Perfida Albione” attaccando l’adesione britannica alle sanzioni anti-italiane dopo l’invasione dell’Abissinia. E proseguì a usare l’espressione successivamente.
Dopo la fine del fascismo, le due parole sono rimaste in uso di solito ironico o hanno trovato altre vite soprattutto in campo calcistico (ma anche in Argentina per la guerra delle Falkland): Dick Cheney le usò per esprimere il disappunto degli Stati Uniti nei confronti di un incontro tra il ministro britannico David Miliband e il presidente siriano Assad.
Il disprezzo per la Gran Bretagna è rimasto però parte di un vecchio pezzo della cultura reazionaria italiana, e del comune sentire di una piccola parte ignorante degli italiani (nuove destre hanno invece sviluppato attrazioni e interessi per quel paese). È diverso dal disprezzo per la Francia, spesso condiviso dalle stesse teste microscioviniste: non è frutto di una competizione spesso perdente, ma di un complesso di inferiorità (Mussolini stesso si riferiva alle pretese inglesi di mantenere il proprio impero negandolo all’Italia).
Gli ex marittimi, ma anche i cultori della storia navale moderna, conoscono le tipologie di propulsori in uso nella nostra marina; tutto o quasi tutto sull’ELICA, ma c’è il glorioso settore dei Modellisti Navali che sul sistema di propulsione a pale ne conosce sia l’applicazione tecnica che la sua storia. Ecco cosa scrivono gli Amici dei MITI DEL MARE
Breve storia della ruota a pale
Sembra che già gli antichi romani, e successivamente i cinesi, abbiamo fatto dei tentativi con delle ruote a pale mosse da schiavi, ma alla fine convennero sulla migliore efficacia del remo. Lo stesso Leonardo Da Vinci ipotizzò un battello con ruote a pedali (Fig. 1). Fu solo verso la fine del XVIII Secolo, quando si rese disponibile un sistema di propulsione a vapore abbastanza efficiente, che furono compiuti i primi tentativi di propulsione navale con l’impiego di ruote a pale. Il primo risultato soddisfacente fu ottenuto dal battello di 17 metri Charlotte Dundas che, con una macchina a vapore da 12 HP e una sola ruota a poppa, riuscì a rimorchiare delle chiatte lungo un canale americano.
I primi successi commerciali furono conseguiti dai battelli di Fulton, il Clermont ed il Phoenix, mossi entrambi da due ruote laterali, che effettuarono anch’essi servizio negli Stati Uniti.
Anche in Europa cominciò a diffondersi questo sistema di propulsione ma i battelli erano sempre di dimensioni ridotte e destinati a navigazioni fluviali o costiere. Solo nel 1819 la nave americana Savannah, comunque dotata di un’attrezzatura velica completa, attraversò l’Atlantico usando la macchina a vapore solo per alcune ore. Negli anni successivi furono costruite navi più grandi e veloci in grado di effettuare lunghi viaggi. Ma le ruote a pale erano pesanti, ingombranti e vulnerabili. Furono quindi soppiantate dall’elica, anche se la cosa non fu priva di contrasti.
Qualche nota tecnica
Le prime ruote erano a pale fisse. Successivamente, per migliorarne il rendimento, furono costruite ruote a pale oscillanti in grado di orientarsi grazie ad un sistema eccentrico. Ma queste erano più pesanti e costose e quindi non sempre preferite. Le ruote venivano raramente sistemate a poppa dove risentivano del beccheggio. Quelle sistemate ai lati della nave erano disturbate dal rollio e, sulle navi da carico, risentivano delle variazioni di immersione. Comunque le ruote laterali furono sempre preferite per le navi d’altura. La figura 2 mostra una ruota a pale con cerchio di protezione esterno.

ALCUNI LINK PRODOTTI DAI NOSTRI SOCI
LA PROPULSIONE AZIPOD - di Giuseppe SORIO
=53:maritthttps://www.marenostrumrapallo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=437:azipod&catidimo&Itemid=160
QUANTO E’ SLEGATA L’ANCORA DALL’ELICA E DAL TIMONE - di John GATTI
L'ABC DELLE MANOVRE PARTE DALLE ELICHE – di John GATTI
UNA MANOVRA CON L’USO DELL’ANCORA – di John GATTI
Carlo GATTI
Rapallo, 6 Gennaio 2021
FORTE CASTELLACCIO - GENOVA-Parte Seconda
I FORTI DI GENOVA
PARTE SECONDA
IL FORTE CASTELLACCIO
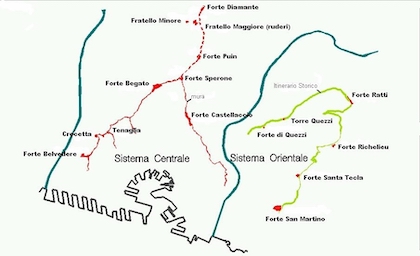
La caserma sulla Val Bisagno, vista dall’esterno delle mura
E’ stato la sede di due ENTI molto importanti per il
MONDO DELLE NAVI E DEI MARITTIMI fino agli ANNI ’50-’60

La torre vista da Nord
GENOVA RADIO E L’ISTITUO IDROGRAFICO DELLA MARINA
GENOVA RADIO
Genova-Radio (Icb), nel cuore del quartiere di Quarto, proprio davanti alla storica Via Romana della Castagna, è una ex stazione radiofonica fondata nel 1952 e all’epoca usata per comunicazioni in ambito marittimo.
Composta da due diverse stazioni: quella ricevente nel quartiere levantino, l’altra dislocata a pochi chilometri, sul Monte Righi – i suoi trasmettitori si trovano oggi all’interno dell’antico forte denominato “Il Castelaccio” (sembrerebbe che lo stesso Guglielmo Marconi abbia definito questo luogo “una delle migliori postazioni d’Italia per le radiotrasmissioni”). Entrambe le stazioni, ricevente e trasmittente, erano impiegate per adempiere a diverse funzioni: trasmissione di messaggi in codice Morse tra nave e radio; invio di telegrammi, ad esempio ai parenti, durante la permanenza in mare lontano da casa; uso del sistema telex per la trasmissione di dati commerciali; invio di chiamate di soccorso 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
I due tralicci di oltre 60 metri che ancora svettano nel bel mezzo dell’antico abitato di Quarto e la passione di alcuni “agguerriti” amatori, tengono in vita la memoria di questa eccellenza genovese e di un mestiere, quello del radiotelegrafista, ormai scomparso.
La radiotelegrafia a GENOVA

Forte Castellaccio e Torre Specola

Il complesso visto dal parco del Peralto


Mentre le prime operazioni erano svolte grazie allo sfruttamento di onde corte, a varie frequenze, la chiamata di soccorso sfruttava le onde medie a 500 kHz: usata per circa 90 anni nell’ambito del Servizio Radio Mobile Marittimo per la sicurezza in mare, tutte le stazioni radio che utilizzavano la radiotelegrafia in onda media avevano l’obbligo di assicurare l’ascolto continuo su questa frequenza, con un operatore preposto o tramite un ricevitore, in modo da ricevere in ogni momento SOS e messaggi di “urgenza”, per salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare. Solo nel 1999, la 500 kHz è stata rimpiazzata da sistemi digitali satellitari. Era possibile anche sfruttare queste tecnologie per permettere a chi si trovava in mare di utilizzare un sistema radiotelefonico e fare telefonate a casa anche se, molto dispendiose in termini di consumi di corrente e di tempi di organizzazione, questo tipo di chiamate non potevano svolgersi troppo di frequente.
Gli operatori, radiotelegrafisti capaci e ben preparati, derivavano la loro conoscenza da precedenti impieghi a bordo di navi e imbarcazioni: perlopiù facevano parte di una categoria di Ufficiali della Marina Mercantile, esistente all’epoca in cui ancora le comunicazioni avvenivano per via telegrafica, ed erano chiamati “marconisti”, nome coniato in memoria dello stesso Guglielmo Marconi, padre delle radiocomunicazioni. Tutti quelli che aspiravano ad un impiego nelle radiocomunicazioni su navi mercantili o aeromobili civili dovevano conseguire un apposito brevetto, un certificato per radiotelegrafisti rilasciato dal Ministero delle Poste. Un mestiere affascinante e motivato da grande passione personale, che oggi è scomparso, dovendo soccombere ai progressi della tecnologia. Le apparecchiature utilizzate da Genova-Radio erano degne di nota e tutte di qualità: dapprima, i trasmettitori Collins BC-312 e BC-3124, poi gli italiani Allocchio-Bacchini OC-11.
Oggi Genova-Radio ha quindi perso la maggior parte delle funzioni di un tempo e, costretta a soccombere di fronte alle nuove tecnologie, resta perlopiù inutilizzata. Visto l’interesse riscontrato, l’ipotesi di creare un museo delle radiocomunicazioni in questi luoghi, con le apparecchiature di una volta, non sembra fuori luogo: un’opportunità di rilancio e promozione di un mestiere scomparso? Perché no…
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

IIM - Istituto Idrografico della Marina - Italia
Passo dell'Osservatorio 4, 16134 Genova ITALY
Tel : +39 010 24431 (centralino) - Fax : +39 010 261400

Sede dell’Istituto Idrografico della Marina
Storia. L'istituto fu fondato con regio decreto il 26 dicembre 1872 e alla sua guida fu chiamato il capitano di fregata, matematico e idrografo Giovan Battista Magnaghi, con il compito di eseguire il rilievo idrografico dei mari italiani e di produrre la documentazione nautica nazionale.
FORTE CASTELLACCIO
Il Forte Castellaccio al Righi, sulle prime alture di Genova, come si presentava nei primi anni del '900.
A sinistra si nota ancora la costruzione che ospitava il Corpo di Guardia della Porta Chiappe, mentre la restante porzione ospitava un piccolo ristorante.
Venne successivamente demolita per allargare la strada di accesso.
La casamatta di sinistra alloggiava il cannone di mezzogiorno che, sino all'inizio della seconda guerra mondiale sparava un colpo ogni mezzogiorno in punto che serviva come segnale orario per la sincronizzazione dei cronometri di bordo delle navi.

Facciata della Torre Specola ottocentesca compresa all'interno del forte Castellaccio, caratteristica per l'uso del mattone rosso come materiale da costruzione. Fino alla vigilia della seconda guerra mondiale, ogni giorno dalla torre veniva sparato un colpo di cannone alle 12 in punto. Oggi è sede dell'osservatorio meteorologico dell'Istituto idrografico della Marina militare.
Dietro vi è la Torre Specola, costruita a pianta ottagonale in mattoni rossi dal 1817 al 1825 dall'architetto militare Giulio D'Andreis.
Venne edificata sulla sommità di una roccia adiacente al Forte chiamata Quadrato delle forche in quanto era il luogo, ben visibile da tutta la città, dove dal Cinquecento fino a tutto il Settecento i criminali condannati a morte venivano impiccati.
Costruita inizialmente come opera autonoma con proprie mura, venne chiamata Forte Specola. Disponeva di otto piazzole armate di cannone, una per lato, dotata di apposita finestra di ventilazione e scappamento dei fumi di sparo.
Pochi anni dopo, tra il 1830 ed il 1836, furono costruite le nuove caserme del Forte Castellaccio e le due fortificazioni vennero circondate da un unico bastione, accessibile con un ponte levatoio.
Per la sua posizione panoramica, la località è meta di genovesi e turisti.
IL CANNONE DI MEZZOGIORNO

Lo storico genovese Mauro Salucci ricorda così quel rito cittadino:
Ci parla della Vecchia Genova l'usanza di fare sparare il cannone dalle alture del Righi, tutti i giorni a mezzogiorno. Quel botto univa dall'alto tutta la città, dai camalli del porto che cessavano il lavoro alle mogli che attendevano a casa e capivano che era l'ora di buttare la pasta nella pentola con l'acqua che bolliva. Chi poteva tornava a casa, chi era troppo lontano si rifugiava in una delle tante e mitiche trattorie del porto o dell'angiporto, come quella stranota de "Il Toro" della Coscia di Sampierdarena, dove ogni tanto capitava anche D'Annunzio a pranzo. A Pasqua il botto accompagnava le campane slegate che suonavano per la città, il mattino del Sabato Santo, quando al conclamare di campane e botto di cannone ci si lavavano gli occhi alle fontane, all'acqua benedetta chi poteva. Oggi, nella vastità del territorio della "Grande Genova" e del suo rumore forse un botto simile non verrebbe neppure percepito.
UN PO’ DI STORIA
Stato:……………….. Regno di Sardegna, Ducato di Genova
Tipo: …………………… Forte
Costruzione:……....... 1818-1836
Materiale:…………….. Il forte in pietra, la Torre Specola in mattoni
Condizione attuale… Parzialmente utilizzato da enti pubblici e da privati
Utilizzatore………….. Regno di Sardegna
Funzione strategica. Caposaldo integrato nel sistema difensivo
Termine funzione…. Post Seconda guerra mondiale
Forte Castellaccio è un'opera fortificata compresa nelle “MURA NUOVE” a difesa della città, costruita lungo il ramo della cinta difensiva che dal FORTE SPERONE scendeva lungo il crinale della Val Bisagno.
Il complesso del Forte Castellaccio comprende in un unico recinto bastionato due caserme e la Torre Specola. Fa parte del complesso anche la cosiddetta "Tagliata Nord", un ulteriore sistema difensivo del forte, costruito nel 1840 in direzione del Forte Sperone. Questa struttura era collegata al forte con una breve galleria, oggi murata; nei locali dell'annesso corpo di guardia è oggi ospitato un piccolo ristorante.
Il complesso verso la fine dell’Ottocento ospitava una guarnigione di 600 soldati, ai quali se ne potevano aggiungere altri 1000, alloggiati “paglia a terra”, in caso di necessità. L'imponente a dotazione d’artiglieria comprendeva 22 cannoni di varie dimensioni, cinque mortai e numerosi pezzi di dimensioni minori.
Le quattro facce sul lato esposto verso la città presentano ognuna due feritoie laterali e sono coronate da caditoie. L'interno è su due piani fuori terra, più un sotterraneo con cisterna.
La torre poteva ospitare una guarnigione di 60 soldati, ai quali se ne potevano aggiungere altri 120, alloggiati “paglia a terra”, in caso di necessità.
Sul tetto è presente un locale sopraelevato, costruito intorno al 1911 dall’Istituto Idrografico della Marina, che fino agli anni sessanta del Novecento ospitò un Osservatori Meteorologico. Utilizzata come deposito ed archivio dallo stesso Istituto Idrografico.
Oggi la Torre è abbandonata. Fra il 1875 e il 1940, da una casamatta collocata sulle mura esterne, a mezzogiorno esatto veniva sparato un colpo di cannone, con funzione di segnale orario per la sincronizzazione dei cronometri di bordo delle navi; questo sparo era comunemente chiamato “il cannone di mezzogiorno”. Sospesa allo scoppio della seconda guerra mondiale, questa tradizione non fu più ripresa.
Si hanno le prime notizie certe di strutture di difesa in questo sito dal 1319, quando vi fu costruito dai Guelfi un castello con “mura e fossi”, raffigurato in illustrazioni quattrocentesche come un recinto di mura che racchiude due torri quadrate. Fu ricostruito una prima volta nel 1530, questa volta come un unico massiccio torrione, che con la costruzione della Mura Nuove, nel 1633, fu integrato nelle stesse ed utilizzato come caserma e deposito di polveri da sparo. Una nuova ricostruzione avvenne nel secolo successivo: nelle illustrazioni dell'epoca appare come formato da due caserme parallele allineate lungo il recinto di una grossa polveriera. All'interno della fortezza a quell'epoca esistevano ancora pochi ruderi dell'antico castello, completamente scomparsi nel rifacimento ottocentesco.
Verso la fine del Settecento numerosi rapporti conservati negli archivi della Repubblica di Genova evidenziano la necessità di onerosi lavori di manutenzione, tra i quali il rifacimento del tetto della caserma, ormai fatiscente.

La caserma principale vista dal cortile interno
Dopo l'annessione della ex Repubblica Ligure napoleonica al Regno di Sardegna, il forte subì una radicale trasformazione tanto da rendere la zona su cui sorgeva una sorta di cittadella fortificata, idonea sia per una difesa delle mura da attacchi esterni sia per controbattere a possibili insurrezioni da parte della popolazione locale.
Le vecchie strutture furono completamente demolite nel 1818 e il forte fu ricostruito in accordo ai nuovi criteri dell'arte militare. A lavori in corso, il progetto fu modificato intorno al 1827: le murature già realizzate e non più previste dal nuovo progetto non furono tuttavia abbattute, ma riutilizzate come terrapieno a difesa della nuova caserma, e sono tuttora visibili. La nuova caserma, costruita intorno al 1830, è divisa in due sezioni: un lungo edificio a due piani che si affaccia sulla via Peralto, dove erano collocati anche magazzini e locali di servizio, tra i quali due grandi forni, ed un altro affacciato sulla Val Bisagno, adibito esclusivamente a camerate. Quest'ultima aveva il tetto a falde, del quale restano solo i pilastri di sostegno.

La caserma sulla Val Bisagno, vista dall'esterno delle mura
Così intorno alla metà dell'Ottocento descrive il Castellaccio lo storico Giuseppe Banchero:
|
«Questo era dapprima un gran torrione edificatovi dal genovese governo per difesa della città e delle valli, essendo situato sulla cresta dei monti che dividono questa vallata del Bisagno al lato orientale della città. Ne fu ampliata la fabbrica circa il 1818; in seguito fu arricchito di altre opere che lo rendono assai più importante, tanto più per la dominazione che ha sulla città e perché protegge la superior parte della vallata detta del Lagazzo, dove sono situate le fabbriche di polveri ed i magazzini di deposito delle medesime.» |
Durante i moti del 1849, i rivoltosi riuscirono a impossessarsi del forte, da dove spararono colpi di cannone contro i soldati regi. Al volgere degli avvenimenti in favore di questi, che nel frattempo avevano rioccupato la città, gli insorti abbandonarono il forte, che il 10 aprile fu ripreso in consegna dalle autorità militari.
Storia recente
Verso la fine dell'Ottocento il duplice scopo di difesa della città da attacchi esterni o di sedare possibili rivolte popolari era venuto meno. Durante la Prima guerra mondiale nel forte furono reclusi dei prigionieri di guerra austriaci.
Nel 1924 nel forte esisteva già una prima stazione radio, chiamata ITALO RADIO (nominativo morse ICB), che nel 1929 fu assorbita dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni con il nome GENOVA RADIO, nominativo tuttora esistente. Già nel 1924 il personale civile addetto alla radio era alloggiato nei locali del forte.
Durante la Seconda guerra mondiale, il 1º febbraio 1945, nel fossato della cosiddetta "Tagliata sud", le Brigate Nere fucilarono sei partigiani; i condannati, già da tempo rinchiusi nel carcere di Marassi, furono prelevati all'alba e condotti al Forte Castellaccio dove ebbe luogo l'esecuzione; la località fu scelta perché all'epoca interdetta ai civili. Il fatto è ricordato da una targa commemorativa nel luogo dell'eccidio. Un'altra targa ricorda altri due partigiani fucilati dai nazifascisti all'interno del forte, sempre nei primi mesi del 1945.
Alcuni locali del forte sono oggi utilizzati come magazzino dall'Istituto Idrografico e altri, da qualche anno, sono affittati ad alcuni privati. La caserma affacciata sulla Val Bisagno versa in stato di completo abbandono, come abbandonata è anche torre Specola.
Il complesso non è liberamente accessibile.
Come arrivare
Il forte è raggiungibile in auto dal centro di Genova seguendo le indicazioni per il Righi e poi, superata la stazione a monte della funicolare proseguendo su via del Peralto, l'antica strada militare, oggi asfaltata; dalla strada una breve diramazione, oggi in cattive condizioni, porta all'ingresso principale del complesso, superato il quale una rampa conduce direttamente alla Torre Specola e quindi, con una conversione a "U", al cortile interno dov'è l'ingresso della caserma, distante circa 250 m dalla torre.
In alternativa è possibile raggiungere il Righi con la funicolare che parte da Largo Zecca, risalendo poi a piedi lungo le mura per qualche centinaio di metri.
Carlo GATTI
Rapallo, 17 dicembre 2020
CENNI STORICI SUI FORTI GENOVESI
FORTI GENOVESI
CENNI STORICI
PARTE PRIMA
La Genova turistica é tutta da scoprire perché i genovesi amano tenere i loro SEGRETI nell’anonimato. Questa peculiarità tutta ligure, ci porta spesso a fare tappa lungo i suoi itinerari nascosti, poco reclamizzati e quindi sconosciuti, uno dei quali ci porta oggi a visitare i 16 FORTI che le fanno da cornice.
GENOVA è stata, da sempre, epicentro della vita politica e culturale del Mediterraneo per la sua posizione strategica. Per difendere questa posizione Genova si è lungamente dotata di mura, torri e castelli. Della cerchia più interna (e più antica) rimangono pochi tratti di mura, alcune porte e alcune torri medievali. Delle "nuova mura" costruite tra il 1700 e il 1800, invece, rimangono notevolissime testimonianze cancellate dall'espansione della città solo nella parte a mare (in particolare con l'abbattimento del promontorio tra la città e Sampierdarena). In questo percorso, che lambisce e protegge la città, si trovano forti, mura, torri, polveriere ancora in buone condizioni e in un contesto naturale bellissimo e quasi incontaminato per una città così stretta tra il mare ed i monti come è Genova.
ELENCO DEI FORTI: Forte Begato; Forte Belvedere; Forte Castellaccio; Forte Crocetta; Forte Diamante; Forte Fratello Minore; Forte Puin; Forte Quezzi; Forte Ratti; Forte Richelieu; Forte San Giuliano; Forte San Martino; Forte Santa Tecla; Forte Sperone; Forte Tenaglia.
QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO AGLI AVVENIMENTI STORICI TRATTATI
L’assedio di Genova (1747) è un episodio della Guerra di Successione austriaca ed ebbe luogo quando l’esercito austriaco, al comando del conte di Schulenberg, provò a conquistare, senza successo, la capitale della Repubblica di Genova. Gli austriaci avevano preso e successivamente perso Genova l’anno precedente, e fecero della conquista della città ligure il loro principale obiettivo militare durante il 1747 prima di prendere in considerazione altre campagne militari contro il regno di Napoli e l’invasione della Francia.
Le forze di Schulenberg raggiunsero la periferia della città in aprile, ma rendendosi conto di non avere forze a sufficienza per lanciare un’offensiva, dovettero attendere fino a giugno l’arrivo di dodici battaglioni di fanteria dei loro alleati del Regno di Sardegna. Questo ritardo permise agli spagnoli e ai francesi di mandare altre truppe in città al comando del duca di Boufflers per rafforzare la guarnigione.
L’avvicinarsi delle forze franco-spagnole al comando del maresciallo Belle-Isle indusse i sardi a ritirarsi, e Schulenberg abbandonò l’assedio accusando gli alleati.
Il fallimento dell’assedio portò a reciproche recriminazioni tra austriaci e piemontesi, ed entrambi andarono a lamentarsi con i loro alleati britannici per il presunto tradimento l’uno dell’altro.
L’Assedio di Genova (1800) svoltosi fra il 6 aprile e il 4 giugno 1800, ha visto contrapporsi la Prima e la Seconda Repubblica Francese contro la Seconda Coalizione per la difesa della città ligure.
La seconda coalizione antifrancese (1799-1802) fu l’alleanza tra numerose potenze europee costituita per strappare alla Francia rivoluzionaria le sue conquiste sul continente e schiacciare la Rivoluzione restaurando l’antico regime.

In Italia, dopo la lunga serie di sconfitte subita dai francesi nell’estate del 1799, gli Austriaci ripararono dietro l’Appenino ligure e il Piemonte. Il Primo Console Napoleone Bonaparte affidò il comando delle forze (circa 40.000 soldati) al generale Massena.
Il 5 aprile Melas attaccò i francesi, questi ultimi respinsero gli austriaci senza troppe difficoltà, ma il secondo attacco rivelò che il primo si era trattato solo di un diversivo, poiché questa volta attaccarono 60.000 uomini divisi in 4 colonne verso Savona per frammentare il già debole fronte francese, mentre l’ala sinistra austriaca occupò Recco e respinse il settore destro fino a Nervi, a Nord Federico di Hohenzollern conquistò il Passo di Cadibona. In 3 giorni la manovra venne completata spezzando in due l’armata d’Italia.
Massena, rendendosi conto di essere stato tagliato fuori e circondato dal nemico, il 10 aprile si asserragliò con i suoi uomini dentro Genova e attese; siccome per mare era impossibile ritirarsi, poiché la Gran Bretagna con una squadra navale bloccò il porto già diverso tempo prima, impedendo quindi ogni tipo di approvvigionamento alla città;
In particolare fu proprio la difficoltà di reperire cibo a mettere in ginocchio il capoluogo ligure.
La città, come già detto, soffriva da diverso tempo a causa dello scarso approvvigionamento di cibo, attenuato in parte dai pochi velieri che riuscirono a entrare in porto prima del blocco navale britannico, dimostrandosi così provvidenziali.
Tuttavia la fame nella città era dilagante, siccome oltre agli 85 mila genovesi si aggiunsero altri 35 mila profughi delle zone vicine, da sommare ai 15 mila soldati di Massena, e gli scarsi approvvigionamenti portati dalle imbarcazioni che fortunosamente riuscirono a entrare nel porto prima del blocco navale. Si ricorda che numerosi Leudi rivieraschi e da Rapallo in particolare, portarono nottetempo provviste alimentari ai genovesi affamati letteralmente sfidando il blocco navale inglese.
Già prima dell’asserragliamento di Massena in città (10 aprile), la squadra navale inglese, guidata dall’ammiraglio Keith, bombardò con i vascelli Cormoran e Camaleon Genova.
La città venne accerchiata anche da terra dalle forze austriache, che per oltre due mesi non fecero passare nessun tipo di approvvigionamento o di informazione in città, fattore che influenzò fortemente le decisioni di Massena.
A questo punto al generale nizzardo non rimase altra scelta che resistere il più possibile nella speranza che l’Armata di Riserva possa giungere in suo soccorso.
A minare il suo tentativo, però, oltre al nemico si aggiunsero anche la carestia e una violenta epidemia.
Organizzò delle cucine all’aperto per chi non aveva mezzi per cucinare dedite alla distribuzione di zuppe vegetali e con dei “buoni” assegnava nominalmente i più bisognosi alle famiglie benestanti affinché gli fornissero l’aiuto necessario per sopravvivere.
Le trattative e la resa
Il 2 giugno, termine di scadenza dato da Napoleone a Massena per l’arrivo delle sue truppe in supporto, quest’ultimo non vedendo cambiamenti si decise a trattare i termini della resa, non sapendo che però Bonaparte aveva già minacciato gli austriaci al punto da far ordinare al generale Ott di sollevare l’assedio, che tuttavia proseguì in seguito alle richieste di quest’ultimo di prolungare la data di ritirata.
Pose però come condizione di non far apparire in nessun punto del trattato la parola capitolazione, minacciando di concludere immediatamente i negoziati in caso contrario.
Inaspettatamente però i nemici si dimostrarono incredibilmente accondiscendenti e disposti ad accettare i termini posti dallo sconfitto, anche perché si era resa necessaria una celere conclusione delle trattative pervia dell’avvicinamento delle truppe del Primo Console.
Il 5 giugno subito dopo l’uscita delle truppe francesi dalla città gli imperiali austriaci vi entrarono sfilando per le vie genovesi.
MAPPE DEI FORTI GENOVESI


LE SENTINELLE DELLA SUPERBA
I forti ottocenteschi sono uno dei simboli della città di Genova. Eppure le loro massicce moli di pietra, alla sommità dei colli erbosi dell’entroterra, sembrano “un altro mondo” rispetto a quello mediterraneo della vicina riviera, che si abbraccia con un unico colpo d’occhio, o a quello metropolitano delle strade e delle case, che ribolle fino alle pendici delle alture…
Questo itinerario inizia e termina nel centro città, fra treni, traffico e musei, ma per gran parte del suo percorso attraversa un ambiente naturale e culturale che è altrettanto genovese del centro storico, delle Strade Nuove Patrimonio dell’Umanità UNESCO e dei grattacieli in vetro e cemento, ma è profondamente diverso nell’aspetto e nella sostanza, talmente diverso che chi non lo conosce fatica a immaginare che possa esistere a così breve distanza – meglio: in così intima unione – con una città di quasi 600.000 abitanti, storicamente ed economicamente legata al mare.
***
FORTE SPERONE


Rappresenta il punto chiave delle fortificazioni genovesi ottocentesche ed è situato proprio al vertice delle "Mura Nuove" del 1630. Questa costruzione fu probabilmente inglobata nelle Mura Nuove all'epoca della loro costruzione (1629-1633).
Forte Sperone ha una struttura complessa, su tre distinti livelli ad altitudini diverse. Il primo livello, quello in cui si apre l'ingresso principale, ospita magazzini, locali di servizio e cisterne; al secondo livello vi erano gli uffici e le camere per ufficiali e graduati, al terzo gli alloggiamenti per i soldati. La struttura ospitava una guarnigione di circa 300 soldati, che potevano arrivare a 900 in caso di necessità. L'importanza del forte era testimoniata dalla consistenza dei suoi pezzi d'artiglieria: 18 cannoni di varie dimensioni, nove obici e numerosi pezzi di dimensioni minori.
In epoca napoleonica fu progettata una cortina muraria di "chiusura" verso la città, per la difesa del forte da eventuali sommosse popolari. Questa cortina, nella quale fu inserito il monumentale portale d'ingresso, fu costruita dal Genio Militare Sardo dopo il 1815.
Il portale d'ingresso, sovrastato da uno stemma sabaudo in marmo, è dotato di ponte levatoio, ancora presente con il suo meccanismo di sollevamento.
Durante i moti del 1849 fu occupato per breve tempo dai rivoltosi, i quali tuttavia lo abbandonarono alla spicciolata vedendo gli eventi volgere in favore dell'esercito regio.
Storia recente
Dopo la dismissione delle fortificazioni genovesi, decisa nel 1914 durante la Prima guerra mondiale, nel forte furono ospitati prigionieri di guerra croati e serbi. Dal 1958 al 1981 fu utilizzato come caserma della Guardia di Finanza, e successivamente preso in consegna dal Comune di Genova, che vi ha organizzato manifestazioni culturali nel periodo estivo.
***
FORTE CASTELLACCIO

La cinta del forte comprende anche l’ottocentesca Torre della Specola (1817/20) - caratterizzata dalla forma poligonale e dal ricorso all’uso...
Ci occuperemo di questo FORTE nella SECONDA PARTE di questa ricerca che sarà dedicata al rapporto tra il CASTELLACCIO ed alcuni importanti Enti Marittimi.
***
FORTE BEGATO


Forte Begato è un'opera fortificata compresa nelle “MURA NUOVE” a difesa della città di Genova, costruita su un vasto pianoro lungo il ramo della cinta difensiva che dal Forte Sperone scendeva lungo il crinale della Val Polcevera.
Il possente complesso del forte, munito di bastioni angolari e cortile centrale é sostenuto da un ampio terrapieno.
Nel 1818 il governo sabaudo su questo sito fece costruire la caserma, i cui lavori di costruzione si protrassero fino al 1830. Tra il 1832 e il 1836 fu completato il recinto bastionato che si affaccia sull'attuale strada, isolando il complesso dalla città.
Durante i moti del 1849 il forte fu occupato dai rivoltosi, che da lì potevano controllare la Val Polcevera attraversata dalla strada di accesso a Genova dei soldati regi. Dal forte i rivoltosi bombardarono i soldati regi che avevano rioccupato la collina di San Benigno e il Forte Tenaglia.
Nei giorni successivi, vedendo gli eventi volgere in favore dell'esercito regio, i rivoltosi abbandonarono il forte, che le autorità militari, prendendolo in consegna dopo la resa del 10 aprile, trovarono vuoto.
Storia recente
Durante la Prima guerra mondiale nel forte furono rinchiusi i prigionieri di guerra austriaci impiegati nelle opere di rimboschimento del monte Peralto.
Durante la Seconda guerra mondiale vi furono approntate delle postazioni contraeree. Nel 1941 un bombardamento aereo inglese distrusse completamente uno dei quattro bastioni. Dopo l’8 settembre 1943 il forte fu occupato dalle truppe tedesche, che lo tennero fino alla fine del conflitto.
Il forte è chiuso al pubblico, e nonostante il suo interesse storico e architettonico, e la costosa opera di restauro, il forte é lasciato a sé stesso. Il giorno 8 ottobre 2015, il Forte è ufficialmente passato di proprietà, dal Demanio Pubblico al Comune di Genova.
***
FORTE TENAGLIA (forse Tenaglie)

Forte Tenaglia (208 s.l.m.) è un'opera fortificata risalente al 1633, originariamente inserita nell'andamento delle “Mura Nuove” a difesa della città, sulle alture i Sampierdarena in un crinale dominante sulla Val Polcevera. Deve il suo nome alla particolare conformazione architettonica che assomiglia ad una tenaglia, opera che in architettura militare viene detta “opera a corno”.
Il possente complesso del forte, munito di bastioni angolari e cortile centrale, sostenuto da un ampio terrapieno, fu edificato tra il 1818 e il 1831.
Nel 1747 durante l'assedio austriaco, la linea occidentale delle mura fu rinforzata secondo i dettami dell'ingegnere spagnolo J. Sicre, per poi essere quasi abbandonato fino al 1797 anno di una rivolta antifrancese, in cui nel forte si asserragliarono l'11 luglio, alcuni insorti, sconfitti dalle truppe del generale Dupont. Nel 1914 l'intero sistema difensivo genovese, ritenuto ormai inadeguato, venne abbandonato, passando dal Demanio Pubblico Militare al Demanio Patrimoniale dello Stato. Nel 1917 vi vennero rinchiusi prigionieri di guerra dell'esercito austro-ungarico. Tuttavia all'inizio del Secondo conflitto mondiale l'esercito modificò le vecchie postazioni sull'opera, edificando quattro piazzole per pezzi di contraerea da 88/56, oggi ancora visibili, nei pressi delle quali furono realizzati piccole strutture per il servizio della guarnigione. Dopo l'armistizio dell’8 settembre 1943, il forte passò nelle mani della Wehrmacht, e fu danneggiato da un bombardamento alleato, effettuato per indurre la guarnigione alla resa, che diroccò in parte sulla cortina meridionale.
***
TORRE SAN BERNARDINO

Torre San Bernardino (205 m. s.l.m.) situata sulle alture di Staglieno, è una delle torri ottocentesche costruite a difesa del nucleo della città di Genova, la sua costruzione risale intorno al 1832; terminata cinque anni dopo, fu prevalentemente utilizzata come postazione avanzata della vicina porta San Bernardino. Costruita tra il 1820 e il 1825, questa torre in laterizio presenta notevoli affinità con le altre torri di Genova, quali Torre Quezzi e Torre Monteratti, contraddistinta però da una struttura più snella. A metà Ottocento, la torre era utilizzata come "Caserma, Corpo di Guardia e deposito polveri" fino al 1914, quando viene utilizzata tra vari passaggi e concessioni, per diversi scopi, tra cui abitazione civile.
Nel 1934 Torre San Bernardino passa di proprietà del Comune, e attualmente risulta in stato di abbandono.
La torre è strutturata su tre piani, di cui uno interrato adibito a magazzino con una cisterna per l'acqua. Al piano terra sono presenti 3 cannoniere e numerose feritoie, come al primo piano, dove inoltre la cannoniera presenta ancora l'originale inferriata in ferro ancora funzionante.
All'interno della torre sono ancora presenti gli anelli per l'imbrigliamento dei cannoni, la comunicazione ai vari livelli è assicurata da una ripida scala che porta fino al terrazzo del tetto, in cui si nota la lieve pendenza per il reflusso delle acque che incanalate in un canale portava l'acqua nella cisterna sotterranea. Le artiglierie presenti nella torre comprendeva un cannone da 9 pollici BR (Ret), oltre alle varie armi da fuoco portatili.
***
PUIN

È uno dei forti meglio conservati tra tutti quelli che componevano il sistema difensivo ottocentesco della città di Genova.
Il Forte Puìn è il primo dei forti fuori le Mura che si incontrano dirigendosi verso nord, dopo essersi lasciati alle spalle Forte Sperone, che in passato rappresentava il limite nord della cinta muraria a protezione della città di Genova. A nord del monte Peralto, proseguendo lungo la dorsale che divide la val Bisagno e la val Polcevera sono presenti alcune fortificazioni isolate che traggono origine dalle fortificazioni campali allestite nel 1747, per fronteggiare le truppe austriache durante la Guerra di successione austriaca, nei punti in cui erano posizionate delle ridotte.
La realizzazione di Forte Puin fu ideata nel 1815 dagli ingegneri del Corpo Reale del Genio Sardo, con lo scopo di riempire il vuoto nel crinale tra lo Sperone e il Forte Diamante. I lavori iniziarono nel 1815, con la costruzione della torre centrale, mentre tre anni dopo fu iniziata la cinta di protezione attorno completata nel 1828. I lavori terminarono nel 1830, ed intorno a metà Ottocento l'opera disponeva di due cannoni campali da 8 cm, due obici lunghi, due petrieri e quattro cannoncini. La torre, a pianta rettangolare, poteva ospitare una guarnigione fissa di 28 soldati, a cui in caso di necessità se ne potevano aggiungere 45 da sistemare "paglia a terra".
Il forte venne poi abbandonato nell'ultimo decennio dell'Ottocento, e "radiato" dalle liste militari del 1908.
Oggi il forte dopo gli interventi degli anni '60 e dopo piccoli interventi da parte del Comune di Genova, è in buone condizioni, ma al momento non è visitabile.
***
FRATELLO MINORE

Forte Fratello Minore è un'opera fortificata che si trova sulle alture di Bolzaneto, in Val Polcevera. Il forte sorge sulla vetta del Monte Spino (622 m s.l.m), una delle due collinette che formano la cima del monte popolarmente chiamato “Due Fratelli”, in posizione dominante.
Il Forte Fratello Minore è costituito da una torre quadrata inserita all'interno di un recinto bastionato, originariamente accessibile mediante un ponte levatoio, oggi non più esistente.
La struttura ospitava una guarnigione di 12 soldati, che potevano arrivare a 40 in caso di necessità.
La dotazione d’artiglieria comprendeva tre cannoni da 12 GRC Ret puntati verso la Val Polcevera (dei quali sono ancora visibili i resti delle piazzole), ed un altro più piccolo rivolto verso il Fratello Maggiore. Il magazzino a polvere poteva contenere 1.200 kg di esplosivo.
I rilievi noti come “Due Fratelli” rivestirono un importante ruolo strategico già durante l'assedio del 1747, Queste postazioni erano protette da una linea trincerata, dalla quale si diramavano altre trincee di sbarramento (delle quali restano ancora oggi tracce visibili), per contrastare eventuali sortite delle truppe austriache.
Durante l'assedio del 1800 la zona fu nuovamente teatro di violenti combattimenti tra Francesi e Austriaci, culminati con la battaglia del 30 aprile, quando le truppe francesi del generale Nicolas Soult conquistarono definitivamente queste postazioni; in questi combattimenti rimase ferito Ugo Foscolo, che si era arruolato nella Guardia Nazionale Francese. Il forte Fratello Minore fu costruito a partire dal 1816 e inizialmente, come il Fratello Maggiore e il Puin, era costituito da una semplice torre quadrata. Solo nel 1830 fu decisa l'aggiunta del recinto bastionato.
Alla fine dell’800 il forte, ritenuto non più strategico dalle autorità militari, fu abbandonato, per essere poi utilizzato, durante la Seconda guerra mondiale come alloggio del responsabile della postazione contraerea posizionata sui ruderi del Fratello Maggiore.
Attualmente abbandonato, è liberamente accessibile ma in condizioni di degrado.
***
FORTE DIAMANTE

Forte Diamante (667 mt. s.l.m.), posizionato sulle alture tra la Val Polcevera e la Val Bisagno, prende il nome dal monte su cui è stato eretto tra il 1756 ed il 1758 a presidio della posizione dominante terminale della dorsale che si sviluppa a nord dello Sperone. La sua funzione era, insieme ai forti Fratello Maggiore, Fratello Minore e Puin, quella di proteggere lo Sperone (una dei tre settori vulnerabili delle Mura Nuove) come parte di un sistema di difesa avanzata a catena, secondo la logica del campo trincerato
Nella primavera del 1800 il forte, difeso dai francesi della 41ª Demi-Brigade del comandante di Compagnia Bertrand, fu al centro di un violento combattimento quando gli austriaci, guidati dal conte di Hohenzollern, vi avevano posto un feroce assedio; il 30 aprile gli austriaci, con un attacco fulmineo, conquistarono le allora semplici "ridotte" dei "Due Fratelli" e il conte di Hohenzollern intimò la resa al Bertrand con le seguenti parole:
|
«Vi intimo, Comandante, di rendere all'istante il vostro Forte, altrimenti tutto è pronto ed io vi prendo d'assalto e vi passo a fil di spada. Potete ancora ottenere una capitolazione onorevole. Davanti a Diamante alle 4 di sera. Conte di Hohenzollern.» |
La risposta determinata di Bertrand non si fece attendere:
|
«Signor Generale, l'onore, che è il pregio più caro per i veri soldati, proibisce imperiosamente alla brava guarnigione che io comando, di rendere il Forte di cui mi è stato affidato il comando, perché possa acconsentire alla resa per una semplice intimidazione, e mi sta troppo a cuore Signor generale, di meritare la Vostra stima per dichiararvi cha la sola forma e l'impossibilità di difendermi più a lungo, potranno determinarmi a capitolare. Bertrand. » |
Il presidio francese del Diamante (circa 250 soldati) non si arrese e grazie all'intervento del generale Nicolas Jean de Dieu Soult, secondo del generale in capo la piazza di Genova (il futuro maresciallo André Massena) partito dal forte Sperone con due colonne di fanteria di linea, gli austriaci furono ricacciati alle posizioni di partenza.
L'ultimo fatto di rilevanza si ebbe nel 1857, quando un gruppo di rivoltosi mazziniani tentò di occupare il forte dopo aver assassinato un sergente, ma l'azione non durò a lungo e il fallimento dei moti che contemporaneamente dovevano aver luogo in città, portò alla fine dell'azione sul Diamante.
La fortificazione fu abbandonata definitivamente dal demanio militare nel 1914 e mai più utilizzata. All'interno del forte, si trovano la caserma a tre piani, utilizzati come cappella, magazzino e camerate per la guarnigione che poteva variare da 40 a 100 uomini. Cinque grandi obici posizionati verso nord, e due cannoncini a difesa dell'ingresso.

***
FORTE CROCETTA

Costruito nel periodo napoleonico su di un’area a 157 metri di altitudine, che aveva in precedenza ospitato anche un monastero.
Il forte si trova poco a monte di Belvedere, sulle alture di Sampiedarena. È situato presso il borgo della Crocetta, sull'area già occupata dal seicentesco convento degli Agostiniani e dall'annessa chiesa del Santissimo Crocifisso.
Impulso alla fortificazione del sito, si ebbe nel 1747 durante l'assedio austriaco di Genova. Solo dopo la caduta dell’Impero Napoleonico, gli inglesi che per un breve periodo occuparono la città, piazzarono sull'altura dei pezzi d’artiglieria rivolte verso la foce del torrente Polcevera. Nel 1849 durante i moti popolari, la fortificazione fu adibita a carcere per i rivoltosi catturati dai soldati del generale La Marmora, in seguito liberati, ma non prima di aver subito il terrore dell'estrema condanna.
Dismesso dal demanio militare nel 1914 e sgombrato dei pezzi d'artiglieria inviati al fronte, a varie riprese fu abitato fino al 1961, e fu anche usato come rifugio per sfollati durante il Secondo conflitto mondiale.
***
FORTE BELVEDERE

114 metri di altitudine, in una zona già precedentemente fortificata presso il Santuario del Belvedere. Importanza strategica, questo sito, la dimostrò anche nell'assedio del 1747, dove la sistemazione di due ridotte con pezzi d'artiglieria, bastarono a resistere all'urto dell'attacco austriaco. Attacco che l'ingegner de Sicre contrastò con uno sbarramento d'artiglieria fuoco contro fuoco con quello della batteria di Coronata, piazzata sul versante opposto della val Polcevera, tenuta dagli austro-piemontesi.
La posizione fortificata del Belvedere dimostrò la sua utilità il 22 aprile 1800, quando due battaglioni francesi mossero per attaccare la colonna austriaca del Reggimento "Nadascki", le cui avanguardie si erano spinte fino a raggiungere il ponte levatorio della Lanterna.
Nel 1815 dopo la caduta dell’Impero Napoleonico, e l'annessione della Liguria al Regno Sabaudo, iniziarono i lavori per la sua realizzazione. L'opera è stata completata intorno al 1827.
Nel 1914, in seguito alla dichiarazione di Genova "città aperta", le strutture militari furono dismesse e i pezzi d'artiglieria inviati al fronte. Durante il Ventennio Fascista, i locali della Batteria Belvedere Superiore furono utilizzati come "camere di punizione", come testimoniano le scritte e i disegni dei prigionieri. Durante la Seconda guerra mondiale, il forte fu armato nuovamente, con quattro cannoni contraerei da 76/,45 poi nel 1943 il complesso fu occupato dai tedeschi che lo tennero fino alla conclusione del conflitto.
***
FORTE RICHELIEU

Il Forte, che sorge sul colle dei Camaldoli a 415 metri di altitudine.
Nel 1747 è affidato all'ingegnere dell'esercito di Spagna J.Sicre. Il 16 novembre dello stesso anno i lavori iniziarono, e per decreto il ridotto fu al Maresciallo Armand du Plessis de Richelieu e assunse il nome di "Forte Richelieu". Il sito, che rivelò la sua importanza strategica durante l'assedio austriaco del 1747, fu quindi dotato di una fortificazione bastionata a pianta rettangolare in cui collocare delle artiglierie.
Nel 1809, in pieno dominio francese, il complesso subì l'ampliamento del perimetro in larghezza, con la ricostruzione delle cortine laterali, il rialzo di tutta la cinta bastionata e l'ampliamento del bastione di ponente con la ricostruzione della cortina di collegamento con l'altro bastione.
A metà Ottocento il forte fu armato con sette cannoni da 16 centimetri, un cannone "campale" da 8, cinque obici lunghi ed otto cannoncini, e poteva ospitare circa ottanta soldati.
Nel 1849 durante i fervori dei moti rivoluzionari, il forte era occupato da 16 militi della Guardia Nazionale che presidiarono da soli la fortezza;
Storia recente
Nei primi del Novecento l'opera fu presidiata da un distaccamento di fanteria, e durante la Grande Guerra utilizzata, analogamente ai forti vicini, come carcere per i prigionieri di guerra austriaci.
Dal 1959 l'accesso è precluso al pubblico in quanto fu installato al suo interno un ripetitore RAI -tutt'oggi ancora presente ed operativo.
***
FORTE SANTA TECLA
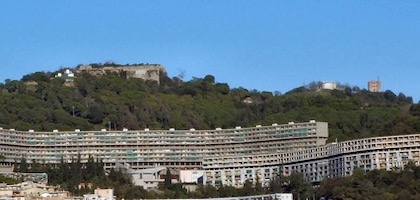
I forti si trovano alle spalle dell’ospedale di San Martino
Costruito nel XVIII secolo a 180 metri sul livello del mare, nel luogo dove sorgeva l’oratorio di Santa Tecla, da cui prende il nome.
Nello spiano dove oggi sorge il Forte, esisteva una chiesetta omonima risalente all'XI secolo e nell'anno 1339 appartenente al Doge di Genova Simon Boccanegra. La costruzione del Forte vero e proprio fu pianificata nell'ambito della più vasta opera di fortificazione della città in opposizione agli assedi austriaci. Così nel 1747 il De Sicre riferiva:
|
«"L'opera che si propone è un quadrato di trenta "toises" di poligono interno, difeso da due fronti di opera a corno che sarà dalla parte verso i Camaldoli [...]; quest'opera secondo i miei calcoli che ho già presentato alla Ec. Giunta, potrà costare cento quattordicimila lire in moneta di Genova, con poca differenza".» |
Durante il 1800, il Forte era uno dei contrafforti a difesa del settore orientale della città, perché utile alla difesa del perimetro di Albaro, del quartiere di San Martino, della Madonna del Monte e perché ben collegato al Forte Richelieu.
Nel 1849 durante i moti popolari il Forte fu occupato, come il vicino Forte Richelieu, da insorti e senza colpo ferire fu riconquistata dalle Regie truppe in pochi giorni, come tra l'altro avvenne per Forte Richelieu.
La fortificazione fu poi utilizzata occasionalmente da reparti militari fino alla prima metà del Novecento, durante la Grande Guerra, i locali del Forte furono adibiti a carceri per prigionieri austriaci.
***
FORTE QUEZZI

Edificato nel XVIII secolo, a 289 metri sul livello del mare, restaurato nel XIX secolo, danneggiato durante la seconda guerra mondiale, è abbandonato.
Forte Quezzi (285 m.s.l.m.) è un forte che domina parte della val Bisagno e quella di Quezzi. È prossimo ad un altro forte Monteratti.
L'ideazione di un forte sulle alture orientali del Bisagno avvenne intorno al 1747, quando la città di Genova l'anno prima fu minacciata dall'avanzata dell'esercito austro-piemontese arrivato ad assediare le alture del vicino monte Ratti, sopra l'abitato di Quezzi.
Dopo l'annessione di Genova al Regno di Sardegna nel 1814, l'obiettivo era quello di impedire al nemico di inoltrarsi nella valle del Bisagno, per questo scopo.
Una relazione militare del 1830 analizzò la condizione del Forte, che venne considerato di scarsa importanza, in quanto in "cattivo stato", e in quanto "la sua posizione non pare essere di grande utilità nella difesa; converrà lasciarlo cadere, e perciò non si faranno più riparazioni."
Storia recente
Durante la Seconda guerra mondiale il primo piano fu demolito per far posto ad alcune postazioni di artiglieria contraerea, armate con sei cannoni da 76/45; che insieme ad altre postazioni lungo il crinale sul versante dell'abitato di Quezzi erano parte della difesa contraerea della città.
Al termine del conflitto il forte fu completamente abbandonato, e depredato di ogni cosa, oggi è un cumulo di rovine lasciate a sé stesso, con mura crollate, rimaste riconoscibili solo quelle perimetrali, e fa da ricovero per greggi.
***
FORTE RATTI o MONTERATTI

Il Forte Monteratti o Forte Ratti (560 metri sul livello del mare) è una caserma militare di Genova edificata tra il 1831 ed il 1842 dal Governo Sabaudo per difendere, per l'appunto, il rilievo "Monte Ratti", posto alle spalle dei quartieri genovesi di Marassi e Bavari, da eventuali assedi del nemico che avrebbe potuto, da lì, dirigersi indisturbato verso gli allora piccoli borghi di Sturla, Albaro, e San Martino (oggi quartieri di Genova), da cui puntare verso il capoluogo.
Nel giugno del 1747 Genova fu assediata dagli austriaci, che conquistarono e occuparono il Monte Ratti nonostante la rapida costruzione di ridotte e accampamenti a difesa del rilievo. Riconquistata la posizione dai genovesi il mese successivo, per sollecitazioni del Duca di Bissj e poi del Duca di Richelieu, fu approvata la delibera per la costruzione di opere campali sul monte Ratti, affidata all'impresario De Ferrari.
Monte Ratti fu al centro di un altro assedio nel 1800, sempre da parte dell'esercito austriaco, che conquistò facilmente la ridotta, poi riconquistata il 30 aprile dello stesso anno dai francesi (che allora estendevano il loro dominio anche sulla città di Genova), che costrinsero alla resa un battaglione di 450 austriaci.
Nel 1819, dopo l'annessione della Liguria al Regno Sabaudo, fu decisa, per la difesa del monte, la costruzione di due torri difensive a pianta circolare; entrambe non furono terminate, anche se i loro resti sono ancora ben visibili.
Tra il 1831 e il 1842 vennero gettate le basi per la costruzione di una snella caserma che si estendesse per quasi tutti i 250 m di lunghezza dello spiano sovrastante l'abitato di Quezzi. Fu realizzato quindi il Forte Monteratti, che nella sua costruzione inglobò la preesistente torre, divenuta parte integrante della struttura difensiva. La facciata del forte è diretta verso la città mentre sul retro erano collocate le artiglierie puntate verso la val Bisagno.
Storia recente
Durante la Grande Guerra il Forte fu usato come prigione per i coatti austriaci. Durante il Secondo conflitto mondiale questa postazione contraerea fu utilizzata prima dal Regio Esercito e, dopo l’8 settembre 1943 da reparti della Wehrmacht.
FONTI:
I FORTI DI GENOVA - Aldo Carmine - Sagep Editrice
I QUARTIERI DI GENOVA ANTICA - Giulio Miscosi - Tolozzi Editore
STORIA DLLA REPUBBLICA LIGURE - Antonino Ronco - Sagep Editrice
STORIA D'ITALIA DAL RISORGIMENTO AI NOSTRI GIORNI - Sergio Romano -Longanesi
Ricerca a cura di:
Carlo GATTI
Rapallo, 10 Dicembre 2020
SPEZIA - “LA PORTA DI SION” UNA STORIA CHE NON TUTTI CONOSCONO
OGNI ANNO SPEZIA RICORDA
“LA PORTA DI SION”
UNA STORIA CHE NON TUTTI CONOSCONO

Pagina dimenticata quella dell'Operazione Exodus che ci fornisce l’idea di una città che ha fatto dell'accoglienza e della solidarietà la propria carta di identità. Spezia, infatti, è conosciuta come "porta di Sion".
Alla fine della seconda guerra mondiale il golfo spezzino divenne la base di partenza degli scampati ai lager nazisti, che ora guardavano al mare con la speranza di lasciarsi alle spalle le guerre e gli orrori nazisti dei lager.
Nel porto di Spezia erano pronte a partire due imbarcazioni, la FEDE di Savona e il motoveliero FENICE, che avrebbero condotto 1014 profughi ebrei nella loro "terra promessa": Israele. Tutto era pronto, ma alcune navi inglesi bloccarono l'uscita dal porto alle due imbarcazioni venendo a creare così una situazione di crisi internazionale. I profughi a bordo della nave dichiararono lo sciopero della fame e riuscirono così ad attirare l'attenzione delle maggiori autorità inglesi (autorizzate a controllare l'afflusso in Palestina) che cedettero alle volontà dei profughi.

SPEZIA
Monumento commemorativo
Dalla Porta di Sion alla Terra Promessa
Un cuore spezzato e le onde del mare che lo raccolgono
Il 17 giugno 2019, su questo Molo Pagliari, nel punto in cui all’epoca c’era la “Porta di Sion”, é stato inaugurato il monumento alla memoria:
SULLE ALI DELLA LIBERTA’
alla presenza di una delegazione di Israele e dalla vice ambasciatrice in Italia, a ricordo delle vicende del 1946.
Presenti il rabbino capo di Genova Giuseppe Momigliano e i discendenti dei protagonisti di quell'evento, i nipoti di Yehuda Arazi e Ada Sereni, alla cui memoria è stata dedicata la piazza all'inizio del molo. All’inizio dell’anno in corso 2020, il percorso della memoria é visitabile da tutti. Un messaggio che il Comune di Spezia lancia alle generazioni future.
Il monumento commemorativo, insieme a un percorso espositivo su molo Pagliari, in forma di simbolo rappresenta quella che probabilmente è la vicenda storica più importante della città di Spezia e che nel 2006 le è valsa la medaglia d’oro al valore civile.
Perché Spezia - Porta di Sion?
- Perché da qui, dopo la Seconda guerra mondiale, partirono navi cariche di ebrei che cercavano una vita migliore nel futuro Stato d’Israele.
- Per la grande solidarietà che gli abitanti di una Spezia devastata dalle bombe seppero dimostrare nei confronti di migliaia e migliaia di ebrei sopravvissuti all'Olocausto.

LO STORICO MOLO PAGLIARI
Nel 1946, da questo molo salparono la Fede e la Fenice e, nel 1947, salpò la storica nave Exodus.

La FENICE ribattezzata ELIAHU GOLOMB

La FEDE
I loro corpi avevano conosciuto la persecuzione nazista, lo sterminio, la Shoá, l’inferno dei lager, ma ora, come ci mostra la foto, questi reduci guardano al mare con la speranza di lasciarsi alle spalle l’Europa degli orrori e di raggiungere la “Terra promessa”.

La nave EXODUS 1947
IL PREMIO EXODUS 2019
“L'importanza che la città della Spezia riserva ogni anno al premio Exodus – dichiara Marina Piperno – rivela la sensibilità e la volontà di tenere viva la storia e la memoria degli eventi che hanno fatto della città e dei suoi cittadini un importante luogo di riferimento per tutto Il mondo ebraico e per coloro che hanno a cuore la storia del nostro Paese”.
Lia Levi scrittrice e giornalista, è stata insignita del “Premio Exodus 2019” con la seguente motivazione: “In riconoscimento del profuso impegno nell’attività di testimonianza della Shoah e nella promozione della conoscenza della cultura e religione ebraica in Italia e in Europa”.
Marina Piperno è stata insignita della “menzione speciale Exodus 2019” con la seguente motivazione: “In riconoscimento della sua attività di ricerca attraverso l’arte cinematografica e documentaria delle diaspore delle famiglie ebraiche italiane nel Novecento”.
Levi ha accolto con gioia la notizia del riconoscimento: “A volte capita che ti passi per la testa
l’idea che bisognerebbe inventare delle nuove parole per esprimere nella loro complessità certe specifiche sensazioni e pensieri che ti si stanno muovendo da dentro. Ecco, ci troviamo oggi proprio davanti a uno di questi casi – dichiara Lia Levi - La notizia che il Comitato Scientifico di una città come la gloriosa La Spezia (medaglia d’oro al merito per la tangibile solidarietà offerta agli ebrei sopravvissuti allo Sterminio) mi ha scelta come destinataria del premio Exodus mi è stata fonte di profonda emozione. Quelle “nuove parole” che mi piacerebbe usare per esprimerla al meglio, si sa, non esistono. Vi prego perciò di accettare quelle che accompagnano tutti i giorni mettendoci voi, attraverso le misteriose vie dello spirito, quella carica di reminiscenze, entusiasmo e commozione che spero di essere riuscita a trasmettere. Un grande rabbino ha detto che l’ebraismo, con la sua scontentezza sacra non pretende certo di cambiare il mondo ma solo di “aggiustarlo”. E questa mi sembra essere anche la forza portante della gente della Spezia e di tanti altri che riescono ad operare per render migliore il nostro pianeta”.


Pagliari e Fossamastra al centro di un percorso del ricordo degli eventi del 1946 che legano per sempre Spezia e Israele
UN PO’ DI STORIA
Il Mediterraneo, negli del primo dopoguerra, é attraversato da un popolo in fuga, reduce dalla sua più grande tragedia e disposto a tutto pur di ritornare alla terra lasciata 2000 anni prima. Dalle nostre coste salparono in massa per raggiungere clandestinamente la Palestina, o come preferivano chiamarla, Eretz Israel, la terra di Israele.
Il nostro Paese, pur devastato dalla guerra, offrì loro rifugio e li aiutò a partire dai suoi porti, sicuramenti gli italiani di allora sentivano il peso di scelte sbagliate: come l’infamia delle leggi razziali di pochi anni prima, e sentivano il dovere di farsi perdonare.
IL PROBLEMA: la Gran Bretagna, potenza occupante, sia in Italia che in Palestina, si oppose con tutte le forze a questo esodo di massa per non contrariare gli arabi in rivolta che temevano di diventare minoranza in quel paese.
Il Mossad le Aliyah Bet (organizzazione segreta, progenitore del famoso servizio di intelligence israeliano) fu incaricato da Ben Gurion di portare in Eretz Israel il maggior numero di ebrei della diaspora e spingere la comunità internazionale ad approvare la nascita dello stato di Israele.
Due capi di grande intelligenza e audacia entrarono in scena: Yehuda Arazi e Ada Sereni. Lui, soprannominato “il re degli stratagemmi”, ricercato dagli inglesi che avevano messo una taglia sulla sua testa per aver rubato armi in quantità dai depositi britannici per conto dell’Haganà.
Lei, alto borghese romana d’origine, espatriata negli anni 20 in Palestina, dove aveva fondato insieme al marito Enzo, un eroe del sionismo, il kibbutz Givaat Brenner, e ora pronta ad usare tutte le sue conoscenze italiane per aiutare la causa. Abbiamo incontrato, esperti e testimoni diretti e indiretti, come i discendenti di Yheuda Arazi, e Ada Sereni; e ripercorso i luoghi di questa vicenda, un giallo politico intricato e appassionante, ma anche una toccante storia umana di cui ora vi proponiamo uno stralcio.
Il Comandante Yehuda Arazi, conosciuto con diversi pseudonimi e costretto a celarsi sotto false spoglie, racconta la nipote, guidava l’Istituto per l’emigrazione illegale sorto nel 1938. Il caso internazionale del maggio 1946, il cui epicentro fu proprio il porto della Spezia, vide le imbarcazioni Fede e Fenice preparate a trasportare 1.014 profughi.
La Gran Bretagna, forza occupatrice, regolamentava l’afflusso controllato dei sopravvissuti in Palestina, indicato in 75.000 ebrei da rimpatriare in cinque anni. Ma tale numero si rivelò decisamente insufficiente: l’Europa rifiutava gli ebrei di ritorno dai campi di sterminio, già vittime di un forte senso di straniamento, e ciò aumentò il desiderio della comunità internazionale di ritornare verso la propria terra promessa. Arazi radunò così il flusso migratorio verso i porti italiani, in particolare in quello spezzino, presso il quale la comunità ebraica, ferma sulle banchine per settimane, ricevette, dopo un primo sospettoso approccio, forte solidarietà dagli spezzini.
Il governo britannico continuava a fermare la missione clandestina di Arazi, e le imbarcazioni non potevano partire. Gli spezzini, intanto, continuavano a portare cibo e conforto alla gente ammassata sulla banchina, piena di speranza e al contempo esasperata.
Fu proprio il sostegno della gente locale, la resistenza dei profughi marcata con un lungo sciopero della fame, l’attenzione dei media internazionali e la visita di Harold Lasky, presidente dell’esecutivo del Partito Laburista britannico, che portarono in ultimo le autorità londinesi a decidere di far salpare le due imbarcazioni dal Molo Pirelli, a Pagliari, alle ore 10 dell’8 maggio 1946.
In particolare fu con Harold Lasky, che sollevò la necessità di non affamare uomini, donne e bambini che già avevano patito sofferenze indicibili, che Arazi intavolò un’appassionata trattativa per raggiungere l’obiettivo.
La prima nave di profughi, il Dallin (già Sirius) partì da Monopoli il 21 agosto 1945 con soli 35 immigrati a bordo.

La questione dell’immigrazione ebraica scoppiò come caso internazionale nel maggio 1946: l’epicentro della crisi divenne il porto della Spezia dove erano in allestimento due imbarcazione, la Fede di Savona e il motoveliero Fenice, pronte a trasbordare 1.014 profughi. Come in parte abbiamo già visto, oltre a Yehuda Arazi, detto dottor Paz, l’operazione La Spezia fu preparata da Ada Sereni e Raffaele Cantoni, responsabile della comunità ebraica italiana.
Così nella notte tra il 7 e l’8 maggio 1947 la nave Trade Winds/Tikva, allestita in Portogallo, imbarcò 1.414 profughi a Porto Venere. Nelle stesse ore era giunta nelle acque Golfo della Spezia, proveniente da Marsiglia, la nave President Warfield, un goffo e pesante battello. La nave venne ristrutturata nel cantiere dell’Olivo a Porto Venere per la più grande impresa biblica dell’emigrazione ebraica: trasportare 4.515 profughi stivati su quattro piani di cuccette dall’altra parte del Mediterraneo.
Ma soprattutto quell’operazione godette dell’aiuto di tutta la città della Spezia, già stremata dalla guerra e distrutta dai bombardamenti. Proprio il sostegno della gente, la resistenza dei profughi, l’intervento dei giornalisti di tutto il mondo e la visita a bordo di Harold Lasky, presidente dell’esecutivo del Partito laburista britannico, costrinsero le autorità londinesi – le cui navi bloccavano l’uscita dal porto della Spezia - a togliere il blocco alle due imbarcazioni che salparono dal Molo Pirelli a Pagliari alle ore 10 dell’8 maggio 1946.

LA NAVE EXODUS
A narrarci le peripezie dei profughi dello sterminio ebreo ci ha pensato nel 1958 Leon Uris con il celebre romanzo EXODUS, tema ripreso nel libro Il comandante dell’Exodus di Yoram Kaniuk, incentrato sulla figura di Yossi Harel, classe 1919, il marittimo che cercò di portare a Haifa ottomila occhi che avevano visto l’inconcepibile… tanti bambini e orfani, volti dal sorriso indecifrabile.
A EXODUS fu dedicato anche un bellissimo film del 1960 di Otto Preminger interpretato da Paul Newman, Peter Lawford e Eva Marie Saint.

Paul Newman nel film di Otto Preminger "Exodus" del 1960
La Exodus mosse da Porto Venere ai primi di luglio del ’47, sostò a Port-de-Bouc….
Purtroppo in quel celebre film s’ignora totalmente il vergognoso cambiamento di rotta della nave EXODUS dopo la sosta nel porto francese Port-de-Bouc, nel Golfo del Leone, in cui i profughi rifiutarono lo sbarco e gli inglesi li riportarono in Germania ad Amburgo; li fecero sbarcare con la forza e l’inviarono nel campo di Poppendorf, un ex lager trasformato in campo di prigionia per gli ebrei!
Il nome Exodus da allora significò il desiderio di giustizia per l’immigrazione ebraica. Ma solo con la fine del mandato britannico i profughi sarebbero potuti tornare in Palestina.
L’imbarcazione divenne un simbolo, prese il nome di Exodus, raggiunse le coste della Palestina, venne attaccata dagli Inglesi e avviò la nascita dello stato di Israele con tutte le conseguenze che sappiamo.

I passeggeri sulla nave nell'attesa della partenza
La Fede, la Fenice e la Exodus si mossero tutte dal Golfo di Spezia, una dicitura che non compare nelle carte geografiche israeliana. La Spezia in Israele è infatti indicata col nome di:
«Schàar Zion», Porta di Sion.
Nel nome di Exodus la città di Spezia porta nel Mediterraneo l’idea della pace, della convivenza per il dialogo tra i popoli, e opera tramite il Comitato Euro Mediterraneo Cultura dei Mari, presieduto dal Sindaco della Spezia, Ogni anno La Spezia ospita in Premio Exodus dedicato all’interculturalità.

La nave EXODUS impiegata nelle scene del film era ben diversa da quella reale rappresentata qui sotto.
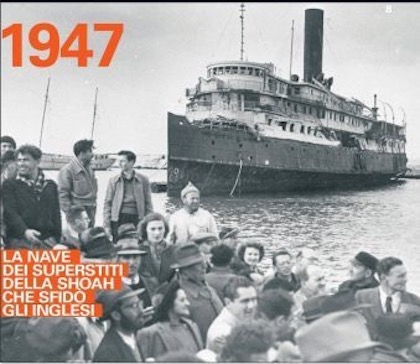
La nave dei superstiti della Shoah che sfidò gli inglesi
Il nome della nave lo conoscono tutti, grazie al kolossal hollywoodiano, tratto dal romanzo di Leon Uris, diretto nel 1960 da Otto Preminger, con Paul Newman e Eve-Marie Saint: Exodus.
Il film, come il romanzo non si riferiva solo alla vicenda reale della nave piena di profughi ebrei abbordata nel 1947 dalla marina inglese, ma all’intera nascita dello Stato d’Israele. Pur se molto romanzata, la storia della nave piena di sopravvissuti dei campi di sterminio e diretta in Palestina si basava comunque su un episodio reale, che destò immenso scalpore ovunque nel ‘47 ed ebbe certamente un peso nella decisione di far nascere Israele.
Milioni di ebrei scampati alla Shoah vivevano nei campi profughi allestiti in Germania e Austria. L’Inghilterra, che manteneva dal 1919 il Mandato sulla Palestina, aveva limitato il numero di profughi ebrei accettabile a 75mila in cinque anni. La maggior parte degli ebrei che dai campi profughi arrivavano in Palestina dovevano quindi passare per i canali dell’immigrazione clandestina. Più precisamente dovevano passare per Shàar Zion, ‘la porta di Sion’ che era e tuttora è chiamata La Spezia. Le navi clandestine partivano da qui. O almeno ci provavano. Nel maggio 1946 due imbarcazioni stracariche di profughi, la Fede di Savona e il motoveliero Fenice furono bloccate nel porto dalle navi inglesi. I 1014 passeggeri stipati si trovarono in condizioni terribili mentre il braccio di ferro proseguiva. A sbloccare la situazione fu soprattutto la solidarietà dell’intera popolazione, seguita dall’arrivo di nugoli di giornalisti da tutto il mondo e infine del presidente dell’Esecutivo dei Laburisti Harold Lasky, che si recò di persona a portare la solidarietà del partito ai profughi. Gli inglesi alla fine cedettero e le due navi salparono l’8 maggio del 1946.
Esattamente un anno dopo salpò da Portovenere un’altra nave, la Trade Winds, ribattezzata Tikva, con 1414 profughi a bordo. Poco prima nel Golfo un’altra nave, destinata a una sorte molto più drammatica e ancora più clamorosa di quella delle navi bloccate l’anno precedente
La President Warfield era una grossa nave costruita nel 1927 nel Delaware. Per anni aveva scorrazzato turisti su e giù per il fiume Potomac, poi, nel 1942 era passata all’esercito, che la aveva usata per lo sbarco in Normandia, il 6 giugno del 1944. Due anni dopo fu comprata dall’Haganah, l’organizzazione ebraica che in quel momento si occupava di trasferire illegalmente ebrei, molti dei quali sopravvissuti ai lager, in Palestina.
Anche la President Warfield, dopo essere stata fornita di mezzi adeguati a respingere un eventuale arrembaggio inglese, inclusi tubi in grado di spargere vapore e olio bollente, partì da Baltimora diretta a Portovenere il 25 febbraio del 1947. Nel frattempo era stata ribattezzata EXODUS 1947.
SEGUE UN APPROFONDIMENTO
ECCO LA VERA STORIA DELLA NAVE EXODUS:
Nei cantieri Olivo di Portovenere l’Exodus subì un refitting in modo da poter ospitare un numero enorme di profughi, quasi 5 mila, molti più di quanti non avessero viaggiato con i carichi precedenti, per lo più partiti a loro volta da Portovenere. Dal porto ligure la nave si diresse verso Sète, sulla costa meridionale della Francia, dove il 10 luglio 1947, 170 camion trasportarono 4500 profughi ebrei, nella grande maggioranza sopravvissuti ai campi di concentramento, tra cui 950 bambini. Nella notte tra il 10 e l’11 luglio la nave, con bandiera dell’Honduras, lasciò la costa francese, ufficialmente diretta in Colombia, ma la mèta era in realtà il porto di Haifa.
E’ improbabile che l’Haganah sperasse davvero di sfuggire al controllo degli inglesi con una nave di quelle dimensioni e con un carico così folto. Molto più probabilmente l’intenzione era sin dall’inizio quella di creare un caso clamoroso. La marina inglese, in effetti, seguì con un cacciatorpediniere e alcune navi da guerra l’Exodus sin dall’uscita del porto di Sète. Le navi britanniche affiancarono quella dei profughi fino al limite delle acque internazionali, mentre di fronte al porto di Haifa veniva schierata una vera flotta: 45 navi da guerra. Il 18 luglio, arrivati a 40 km dalla costa, le navi inglesi speronarono l’Exodus poi, dopo aver sparato una quantità esorbitante di lacrimogeni, la abbordarono. Negli scontri con i passeggeri ci furono tre morti e decine di feriti.
L’Exodus fu scortata sino ad Haifa. Di qui i profughi furono imbarcati su tre navi che dovevano riportarli in Francia, a Port-de-Bouc, 40 km da Marsiglia. Ci arrivarono il 2 agosto, ma i profughi rifiutarono di scendere dalle navi. La Francia scelse di non intervenire per sbarcarli con la forza.
Lo stallo si prolungò per tre settimane, con le tre navi ferme di fronte al porto francese. Il Comitato speciale dell’Onu per la Palestina si riunì d’urgenza. L’attenzione di tutto il mondo concentrata sulle migliaia di sopravvissuti che rifiutavano di lasciare le navi. Il danno d’immagine per l’Inghilterra fu immenso anche perché l’odissea dei profughi dell’Exodus ricordava sin troppo da vicino quel che era successo una decina d’anni prima, quando il mondo intero aveva chiuso le frontiere agli ebrei che cercavano di lasciare un’Europa già minacciata dall’ombra nazista.
La sola alternativa, per il Regno Unito, era deviare la nave verso la parte della Germania occupata dall’esercito inglese ma era comprensibilmente una scelta che il governo di sua maestà esitava a fare. Riportare i sopravvissuti dei lager in quella stessa Germania che ce li aveva rinchiusi, ridotti pelle e ossa dal lungo assedio prima sulla Exodus e poi sulle navi che li avevano riportati in Europa significava rendere ancora più micidiale il colpo inflitto all’immagine dell’Inghilterra.
Alla fine tuttavia gli inglesi si rassegnarono. Le navi furono indirizzate nel porto di Amburgo, i passeggeri furono fatti scendere con la forza e smistati in due campi di internamento. Moltissimi scapparono di nuovo. Alcuni raggiunsero la Palestina. Molti però furono catturati di nuovo e rinchiusi nel campo di Famagosta, a Cipro, fino al voto dell’Onu che decretò l’esistenza dello Stato d’Israele.
Il viaggio dell’Exodus è rimasto un capitolo essenziale nella storia della nascita di Israele. Ma quella nave abbordata, sballottata da una costa all’altra, da un porto all’altro, carica di bambini, donne e uomini che venivano dalla più mostruosa persecuzione della storia, ma a cui lo stesso non veniva permesso di trovare riparo, diventò il simbolo dei profughi di tutto il mondo.
Nella RICERCA dello storico Achille Rastelli dedicata all’esodo degli Ebrei dall’Italia, pubblicato sul sito di Mare Nostrum, vengono menzionati (in grassetto) due navi: AVVENIRE e CICCILLO che furono costruite nel CANTIERE NAVALE GOTTUZZO di Chiavari. Il nostro socio Comandante Ernani Andreatta, discendente del ramo Gottuzzo, mi ha fatto pervenire la foto del prezioso dipinto del bravo pittore Amedeo Devoto il quale riassume, amplia e storicizza la vita di queste due imbarcazioni che parteciparono al trasferiento, non privo di pericoli, di tanti profughi dai lager nazisti alla Terra Promessa.
Con un semplice clic su Vista-Ingrandisci potete gustare i passaggi cronologici di queste navi divenute, loro malgrado, famose.
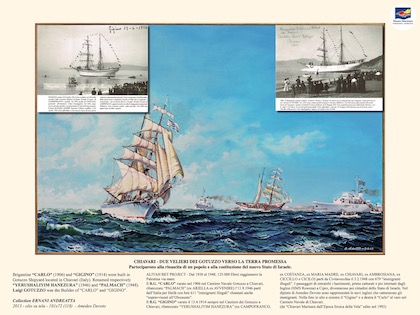
Carlo GATTI
Rapallo, 8 Novembre 2020
ESODO EBREI-IL CONTRIBUTO ITAIANO alle navi dell'Aliyah Beth 1945-1948
ESODO EBREI
Il Contributo italiano alle navi dell'Aliyah Beth 1945-1948
di Achille Rastelli
· Gennaio 4, 2015
Presentato al Convegno AIDMEN tenuto a Roma il 17 novembre 2007 presso la Confraternita di San Giovanni Battista de’ Genovesi.
Dallo stesso convegno vedere anche La Scuola nautica del Bethar di Enrico Ciancarini.
Sostenuti dal sogno del Movimento sionista del focolare ebraico e spinti dalle paure degli anni Trenta diventate poi la realtà della Shoah, circa 125.000 ebrei affrontarono il pericoloso viaggio per mare nel periodo 1934-1948 nonostante i numerosi ostacoli posti dalla dura opposizione del Governo britannico.
All’inizio gruppi sionisti organizzarono e addestrarono dei giovani nei paesi europei e iniziarono a farli arrivare in Palestina, fra questi gruppi c’era già il Mossad e il Bethar. Il mandato inglese su quel territorio era stato assegnato in seguito alla Grande Guerra a cui era seguita la dichiarazione Balfour che aveva promesso una casa nazionale agli ebrei. La popolazione ebrea era dell’11% nel 1922 ed era salita al 30% nel 1937. Iniziarono le ostilità da parte degli arabi e che portarono a migliaia di morti. Per tentare di calmare la situazione gli inglesi introdussero delle limitazioni all'immigrazione ebraica mettendo nel 1939 il tetto di 75.000 immigrati per i successivi cinque anni.

L’EMANUEL con la bandiera ufficiosa ebraica
Lo scoppio della guerra e l’espansione sempre più grande della Germania nazista spinsero alla creazione di una massa di gente sempre più grande che cercava di scappare ad una morte quasi certa, ma erano pochi i paesi che volevano, o potevano accogliere un numero sempre maggiore di fuggiaschi perseguitati.
L’Agenzia ebraica per la Palestina nell’immediato dopoguerra diede vita ad un movimento per portare la gente in quel territorio; si alleò quindi al Mossad e diede vita all’operazione chiamata Aliyah Bet. Ci furono numerosi problemi, come la difficoltà di trovare le navi che erano a rischio confisca, le assurde leggi messe in atto in alcuni paesi per impedirne il viaggio, i rischi della navigazione, armatori disonesti e i tentativi inglesi di bloccare il traffico.
Fra tutti questi problemi c’è da rilevare la grande presenza di navi d’origine italiana coinvolte in questo traffico che ebbe un andamento alterno.
La prima fase, come detto, avvenne fra il 1934 e la primavera 1945, quando si sviluppò sempre di più l’antisemitismo nazista che invase quasi subito l’Austria e una parte della Cecoslovacchia provocando un’ondata di profughi e continuò per tutta la guerra con tentativi più o meno riusciti con la partenza da nazioni alleate della Germania, ma che consentivano un’emigrazione forzata dalle circostanze. Dalla fine degli anni Trenta e per gli anni di guerra il traffico si svolse con navi che partivano dai porti della Jugoslavia, della Romania e della Bulgaria fra difficoltà d’ogni genere fra cui anche il rinvio ai porti di partenza da parte degli inglesi.
Già nel 1934 una nave l’Emanuel, uno schooner a tre alberi, aveva innalzato una bandiera che faceva riferimento all’ebraismo con il sigillo di Salomone (o stella di Davide) al centro.

Il piroscafo STRUMA a Istanbul
Avvennero anche delle tragedie come quella dello Struma: partito da Costanza l’11 dicembre 1942 con 767 passeggeri, fu bloccato a Istanbul per due mesi dietro pressioni degli inglesi con la scusa che non era adatto alla navigazione.
Dopo lunghe discussioni la nave fu rimorchiata in Mar Nero per farla tornare a Costanza fra le urla di disperazione dei passeggeri, ma fu silurata dal sommergibile sovietico SC 213 comandato dal tenente di vascello Denezhko e si salvò solo una persona. Per inciso, su questa nave fu fatta da parte di un gruppo di sommozzatori inglesi una immersione commemorativa nel 2000.
Subito dopo la fine della guerra la pressione degli ebrei sopravvissuti alla Shoah era diventata molto forte, alimentata anche dal fatto che in Polonia, come a Kielce, avvenivano ancora dei pogrom con numerose vittime e nessuno voleva tornare in territori dove aveva subito tremende sofferenze.
Le prime partenze clandestine avvennero dall’Italia, un po’ per la sua posizione geografica, ma anche perché la principale centrale per l’immigrazione clandestina era il nostro Paese, grazie all’attivismo del capo del Mossad in Italia, Yehuda Arazi, e di Ada Sereni.
Alcune navi erano già partite dall’Italia: la Dalin era partita da Bari il 21 agosto 1945 con 35 persone a bordo, ma non si conosce l’origine di questa unità. Italiano erano invece il Nettuno (poi Natan) che effettuò due viaggi da Bari, in agosto 1945 con 73 persone e in settembre con 79.
Pure italiani erano il Gabriella, partito nel settembre 1945 dal Pireo con 40 persone e il Pietro, con due viaggi da Taranto nel settembre e nell’ottobre 1945
con 168 e 174 persone.

L’AMORTA come HANNA SHENESH
La prima unità di una certa importanza fu l’Amorta (poi Hannah Shenesh) partita da Vado il 14 dicembre 1945 con 252 passeggeri. La nave finì incagliata a Naharyia e tutti raggiunsero terra mediante delle corde.

L’HANNAH SHENESH in servizio nella Marina Israeliana
Fu poi la volta del motopeschereccio Rondine, ribattezzato Enzo Sereni: nel gennaio 1946 partì da Vado con 908 emigranti a bordo e arrivò il 17 di quel mese ad Haifa, catturato però da una nave inglese.
La successiva unità italiana fu il piroscafo Fede, ribattezzato Dov Hos, che doveva partire nell’aprile 1946 da La Spezia con 1014 passeggeri, ma fu bloccato dalle autorità italiane sollecitate dal governo inglese. Arazi approfittò dell’occasione per organizzare uno sciopero della fame che fu sospeso quando il segretario del partito laburista inglese Harold Laski salì a bordo per avviare un negoziato. Nel frattempo gli italiani accordarono la partenza purché una parte dei passeggeri passasse su un’altra nave, il motopeschereccio Fenice che adesso si chiamava Eliahu Golomb. Entrambe le unità poterono arrivare legalmente a Haifa.

Il RONDINE come ENZO SERENI
Il 30 luglio 1946 partì da un posto imprecisato dell’Italia il piropeschereccio Maria Serra (poi Katriel Yaffe) con 604 persone e il 3 agosto partiva sempre dall’Italia il Giuseppe Bertolli (poi Twenty Three) con 790 emigranti. Il primo fu catturato dagli inglesi e il secondo dovette accettare la cattura dopo una dura resistenza.
Nel frattempo erano partite dall’Italia altre 5 navi (una da Vado), ma non di bandiera italiana.
Il 23 agosto 1946 effettuava un secondo viaggio il Fede, questa volta con il nome di Arba Hacheruyot con 1.024 passeggeri. La nave fu catturata dopo una dura resistenza nel corso della quale alcuni immigrati annegarono.

Il FENICE come ELIAHU GOLOMB
L’11 settembre 1946 partiva dall’Italia l’Ariella, ribattezzato Palmach con 611 persone e il 9 ottobre 1946 partiva con 611 imbarcati per un secondo viaggio il Fenice, questa volta con il nome di Bracha Fuld con 806 persone. Entrambe le unità furono catturate e sul Palmach ci fu anche un morto.
Fino al marzo 1947 non partirono altre navi di origine italiana mentre altre navi di origine diversa partirono da Taranto e Metaponto. Il 18 gennaio 1947 partiva da Sète l’italiano Merica (ora Lanegev) con 647 passeggeri. Fu catturato dopo una dura resistenza che provocò morti e feriti.

Il GALATA come SHEAR YISHUV
Il 4 marzo 1947 da Metaponto si dirigeva verso la Terra Promessa il Susanna (poi Shabtai Lozinsky) con 823 passeggeri e il 7 aprile 1947 partiva dall’Italia il Galata (Shear Yashuv) con altri 768. Il primo arrivò inosservato sulla costa presso Gaza, il secondo fu catturato dagli inglesi mentre era molto sbandato. Il 15 maggio 1947 partiva da Bari il motoveliero Orietta (poi Mordei Hagetaoth) con ben 1.457 persone, ma fu catturato dagli inglesi. Il luglio 1947 vide l’avventura del President Warfield, più noto come Exodus 1947 con 4.554 passeggeri, ma nello stesso mese partivano le navi italiane Bruna (Haleli Gesher Aziv) con 685 persone e il Luciano (Shivat Zion) con 411 persone, entrambi catturati senza resistenza.

L’EXODUS 1947
Per quanto riguarda l’Exodus 1947 c’è da ricordare un avvenimento drammatico: tutti gli emigranti catturati furono deportati su tre navi dagli inglesi ad Amburgo, creando uno scandalo internazionale. Era inconcepibile che chi era sfuggito alla Shoah venisse portato nel paese che ne era stato responsabile. Gli ebrei furono poi portati in campi situati nella zona statunitense dove ebbero un documento di priorità per l’emigrazione.
In novembre 1947 partivano lo Albertina ora Alyah (forse era già il Pietro) con 182 persone e il Raffaelluccio poi Kadima con altre 794. Il primo fu trovato dagli inglesi abbandonato sulla spiaggia di Naharyia, il secondo fu catturato.
Nel dicembre 1947 partiva da Civitavecchia il Maria Cristina, ora Lo Tafchidinu, e dalla Corsica il Giovanni Maria ora 29 November con 680, entrambe catturate senza resistenza.
L’inizio dell’anno vide un altro grande avvenimento: due grandi navi, Pan York e Pan Crescent, stavano arrivando da Burgas in Bulgaria con più di 15.000 emigranti, ma il Mossad accettò di dirottarle direttamente a Cipro dove i passeggeri furono internati.
Nel 1948 arrivarono quasi soltanto navi italiane partite da porti italiani: Archimede poi Ha’umot Ham’uchadim arriva il 1° gennaio 1948 con 537 emigranti.
Silvia Starita poi Giborei Etzion arriva il 31 gennaio 1948 con 280 emigranti.
Ciccillo poi Yerusheliam Hanetzura arriva il 12 febbraio 1948 con 670 emigranti.
Sette Fratelli poi Lekomemyut arriva il 20 febbraio 1948 con 699 emigranti.
Esmeralda poi Yechiam arriva il 28 marzo 1948 con 769 emigranti.
Vivara poi Tirat Zvi arriva il 12 aprile 1948 con 798 emigranti.
Michela poi Mishmar Haemek arriva il 24 aprile 1948 con 782 emigranti.
Borba poi Lanitzachon arriva il 16 maggio 1948 con 189 emigranti.
Cristina Tuglia poi Medinat Yisroel arriva il 17 maggio 1948 con 243 emigranti.
L’ultima unità italiana è il Fabio (Krav Emek Ayalon) arrivato il 29 maggio 1948 con 706 emigranti.
Quasi tutte queste unità furono catturate meno le ultime tre che arrivarono dopo la nascita dello Stato d’Israele, avvenuta il 14 maggio 1948.
In conclusione su 69 partenze 37 avvennero dall’Italia, 18 dalla Francia, 3 dalla Grecia, 3 dalla Jugoslavia, 4 dalla Bulgaria, altre sconosciute. Ada Sereni ne conta 40, forse perché considera partite dall’Italia anche Exodus 1947 e le due Pan Crescent e Pan York che furono modificate in Italia.
Su 69 viaggi, poi, 33 avvennero su navi di origine italiana.
Per quanto riguarda il numero dei trasportati, furono 72.845 gli ebrei che viaggiarono nel programma aliyah Bet, 33.302 quelli partiti dall’Italia e 23.246 quelli partiti su navi italiane.
Una storia particolare è quella del Ben Hecht (ex PY 31 Uss Cythera) che nel 1957 fu comprato dai Fratelli Capano per la Navigazione Libera del Golfo e viaggiò per 40 anni fino al 1998 nel golfo di Napoli con il nome di Santa Maria del Mare.
Un’altra storia particolare è quella del piroscafo greco Haghia Zoni che fu utilizzato nell’aprile 1939 dal questore di Fiume Giovanni Palatucci per far fuggire 800 ebrei: si trattava dell’ex Taranto, costruito nel 1899 dal Cantiere Orlando di Livorno.
Per tornare alla predominanza dell’Italia, questa è dovuta, secondo me, a un fattore oggettivo e uno soggettivo: il primo è dovuto al fatto che l’Italia era “il ponte di lancio” migliore per il Medio Oriente: la Grecia era afflitta da una dura guerra civile, la Jugoslavia era una dittatura con molti problemi interni ed era difficile muovere nel suo territorio grandi masse di profughi.
Bisogna tenere presente che il problema logistico era notevole, considerando che siamo nel primo dopoguerra: bisognava muovere senza dare nell’occhio gruppi di 600/800 persone, provvedere agli alloggi, ai viaggi, ai rifornimenti e all’assistenza igienico-sanitaria. L’unica alternativa valida era la Francia, ma il viaggio dalla Provenza era molto più lungo. Il fattore soggettivo era la maggiore facilità di muoversi in Italia dove, pur con le difficoltà del dopoguerra, si poteva contare su assistenze continue e su appoggi più o meno taciti delle popolazioni locali; c’è da considerare anche l’attivismo delle comunità ebraiche italiane che agevolarono i viaggi.
Anche per quanto riguarda l’acquisto di navi, anche questo doveva esser facile, così come trovare i cantieri dove effettuare le necessarie modifiche alle strutture per ospitare i passeggeri: si trattava quasi sempre di piccole navi da carico o motopescherecci, tutti non attrezzati per trasportare persone.
Per quanto riguarda i cantieri di provenienza delle unità, si nota una prevalenza dei canteri liguri o toscani: per i primi si ricordano l’Albertina che era del cantiere Sangermani di Riva Trigoso, il Rondine di Galleani e Osterle di Arenzano, il Fede di Serra Cervo di San Bartolomeo, il Merica di Briasco di Sestri Ponente, l’Avvenire e il Ciccillo di Gotuzzo di Chiavari, il Luciano di Calamaro di Savona. Per i cantieri toscani si notano il Silvia Starita della Cooperativa mastri d’ascia e calafati di Viareggio, il Bruna e il Susanna di Benetti di Viareggio, il Sette Fratelli di Gamba di Viareggio, il Giuseppe Bertolli di Picchiotti di Viareggio. Ricordiamo ancora il Raffaelluccia del Cantiere Navale Peloritano di Messina, il Maria Cristina di Tortorella di Salerno, il San Michele di Starita di Piana di Sorrento, il Vivara di Mazzella di Torre del Greco, l’Orietta dei CNR di Ancona e infine l’Esmeralda di Schiavon di San Pietro in Volta. E’ ovvio che il Mossad non li comprava dai cantieri ma dagli armatori, in ogni modo le unità italiane davano una garanzia di qualità pur essendo economiche. Nessuna naufragò, grazie anche all’abilità degli equipaggi, italiani volenterosi ed ebrei che avevano frequentato scuole nautiche come quella di Civitavecchia o erano dei reduci di guerra delle marine alleate.
Per quanto riguarda gli armatori che hanno venduto le navi, per alcune di esse non sono riuscito a risalire ai proprietari perché si trattava di unità costruite durante la guerra e nel primo dopoguerra, una ricerca ancora da completare. Per altre ho trovato armatori di tutta l’Italia: Liburnum di Livorno (Fenice), Mario Bianchi di Genova (Giovanni Maria), Mario Starita di Napoli (Raffaelluccio e Silvia Starita), Tito Neri di Livorno (Luciano), Ernesto Leva di Riva Trigoso (Merica), Onofrio Giacomino di Torre del Greco (Orietta), Tomei di Viareggio (Giuseppe Bertolli), Adragna di Trapani (Ariella) e altri ancora.

Il LINO affondato a Bari
Una breve osservazione riguarda il contributo italiano alla nascita della Marina israeliana. Subito dopo la proclamazione della nascita dello Stato d’Israele le nazioni arabe che lo circondavano gli mossero guerra e i soldati di questa nuova nazione si trovarono nella necessità di costruirsi anche una marina, con mezzi molto spesso improvvisati. Fra le armi di risulta che riuscirono a procurarsi cannoni italiani di vecchio tipo da 76 mm, 102 mm e 120 mm. Soprattutto però riuscirono ad ottenere dei barchini esplosivi del tipo MTM con i quali ottennero i primi successi navali. Ora sia i cannoni sia i barchini, anche se fuori servizio, erano gestiti dalla Marina Militare italiana per cui è molto probabile che sia stata una fornitura riservata alla nuova nazione.

La corvetta MISGAV con cannoni di origine italiana
Dall’Italia partivano però anche forniture di armi per i paesi arabi e Bari era un po’ il centro principale di questo traffico che venne contrastato dal Mossad. Dapprima affondarono nel porto pugliese il trasporto Lino che aveva a bordo 8.000 fucili e 10 milioni di colpi, provenienti dalla Cecoslovacchia e diretti all’Egitto. Le armi furono recuperate e imbarcate sul trasporto Argiro che però fu catturato dagli israeliani con tutto il carico il 24 aprile 1948.
Un'ultima considerazione: questa che ho narrata è una storia di navi, ma non basta: manca la storia degli uomini, sapere come viaggiavano, chi li ha aiutati, sotto quale bandiera navigavano, questa è una storia ancora tutta da scrivere: io non la conosco, se qualcuno la conosce la narri, è un contributo per la storia.
In conclusione questo lavoro, sulla quale ha lavorato molto lo storico navale statunitense Paul Silverstone e dalla quale sono partito per evidenziare il contributo italiano, racconta di una delle numerose migrazioni che sono avvenute nel corso dei secoli nel Mediterraneo e che hanno contribuito, pur fra guerre, massacri e odi di tutti i tipi, a creare una cultura comune di questo mare, grazie anche all’Italia, ponte fra tutte le terre.
Rapallo, 1 Novembre 2020
A cura di Mare Nostrum Rapallo
I CANTIERI NAVALI DI RECCO
CANTIERI NAVALI
RECCO

PRIMA PARTE
La recente pubblicazione del libro: RECCO UN PAESE NEL CUORE di Vittorio Massone, ha aperto uno squarcio di luce sulla storia di questa cittadina che pare abbia dimenticato il suo passato ottocentesco come, purtroppo, é accaduto a molte altre cittadine del comprensorio rivierasco che si sono convertite al turismo all’inizio del ‘900.
Ma chi, meglio del Comandante chiavarese Ernani Andreatta, può introdurci in questo capitolo di storia locale, ma anche nazionale, visto il gran numero di velieri costruiti sul bagnasciuga di questo superbo quanto incantevole pezzo di terra?
Porgiamo quindi la parola all’autorevole “Nanni” pubblicando una sua lettera da cui emerge persino la parentela “cantieristica navale” tra Chiavari e Recco!
Chiavari 12 Ottobre 2020
OGGETTO: Volume su “RECCO UN PAESE NEL CUORE” di Vittorio Massone
Egr. Sig. Vittorio Massone Autore del Volume “RECCO UN PAESE NEL CUORE”
Spett.le Ass. Culturale L’ARDICIOCCA
Spett.le Sig. Sindaco di Recco GIAN LUCA BUCCILLI
Gent.mi Signori
Ho avuto in omaggio dalla Gentile Signora Carla BOZZO il libro in oggetto. Ne ho molto apprezzato il contenuto e anche le inedite foto del “passato” compresa l’ultima sul tragico scenario della distruzione totale di Recco.
Personalmente sono molto affezionato a Recco dato che sono strettamente imparentato con i Gotuzzo, (mia madre Adele) il cui mio bisnonno Francesco detto “Mastro Checco” era appunto nato a Recco nel 1808.
Oltre che aver fondato il Museo Marinaro di Chiavari tutt’ora esposto alla Scuola Telecomunicazione Forze Armate di Chiavari (zona Militare) mi sono anche dedicato nel passato alla “grande” storia marinara dei paesi limitrofi tra cui anche Recco. Non solo, i vari costruttori navali di Chiavari e cioè GOTUZZO, TAPPANI e BERALDO erano tutti imparentati tra di loro ma erano tutti originari di Recco. Ho conosciuto personalmente il Sindaco MATTEO BERALDO (per noi Mattelin”) che per molto tempo abitò anche a Chiavari ed era, insieme ai Tappani, mio cugino da parte di Madre.
Negli anni intorno al 1990 feci scrupolose e dettagliate ricerche sui libri RINA (Registro Navale Italiano) di allora per trovare eventuali “bastimenti” cioè grandi velieri da due a tre alberi costruiti e varati appunto a Recco. Ne trovai circa sessanta come potete constatare a pag. 12 di questo allegato. Ma sono certo che furono molti di più o, come afferma il “Gio Bono Ferrari almeno 200”! Purtroppo i libri RINA iniziano dal 1860 in poi e per gli altri prima del 1860 bisognerebbe ricercare negli archivi delle Capitanerie, cosa che non ho mai fatto.
Ogni volta che si parla di Recco, giustamente riconvertita, dopo la ricostruzione, alla più moderna “focaccia” che gli ha dato negli ultimi decenni “fama e ricchezza” per modo di dire, siamo tutti d’accordo, ma qualche anziano “storico” come me non può fare a meno di ricordare qualcosa di diverso nel suo passato. Ben lungi da ogni benché minima polemica.
Ho cercato di sintetizzarlo al massimo e spero avrete la pazienza di leggerne qualche riga.
Tutto ciò per far capire quanto fosse importante Recco sia prima dei tragici bombardamenti che della gustosissima e ineguagliabile “focaccia al formaggio”.
Con i miei migliori saluti
Ernani Andreatta
Email: andreattaernani@libero.it cell. 335 392 601
Allegati Pag. 11 – I Cantieri Navali di Recco ed il suo indotto.
LINK
MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA - CHIAVARI
SECONDA PARTE
I CANTIERI NAVALI DI RECCO ED
IL SUO INDOTTO
di Ernani Andreatta
Dal libro di Gio Bono Ferrari
Capitani di Mare e Bastimenti di Liguria del Secolo XIX
Edito nel 1939
Gio Bono Ferrari, dedica ben 50 pagine alla storia marinara di Recco. Sono pagine fitte di nomi di navi, di armatori, di costruttori navali, di capitani e marinai, di viaggi, di naufragi ecc. Questo dà un’idea di quanto importante e quanta storia di mare e di fatica c’è in questa cittadina rivierasca che senza fare classifiche di merito o di numero di velieri occupa un posto importante nella storia accanto a Camogli o a Chiavari e a tutte le altre cittadine liguri che per secoli avevano nel mare e nei commerci l’unica risorsa che era una delle poche vie di uscita dalla grama e povera vita del tempo. Non solo, tutti conoscono Camogli che giustamente ha un posto veramente grande nella storia legata al mare ma, se pensiamo che Camogli, per questioni di spiaggia non aveva cantieri navali, mentre Chiavari e Recco hanno costruito navi per secoli. E non erano da meno in armamenti in generale, questo deve farci riflettere e dare a tutte le nostre cittadine il posto che meritano senza campanilismi o piccole gelosie. Ora Recco, è diventato il paese della “focaccia” per autonomasia, ma un tempo la sua struttura commerciale e sociale era ben diversa.
IL CANTIERE NAVALE DI RECCO NEL 1857
La spiaggia prima del mare è pochissima.
Sulla sinistra si nota il ponte della ferrovia in costruzione.
Il primo treno vi passò nel 1860. Nel cantiere navale è in costruzione il “RE GALANTUOMO” un Brigantino a palo di proprietà dei Gotuzzo, uno degli ultimi che Luigi Gotuzzo costruì prima del passaggio del Cantiere a Paolo Rolla nel 1863.

Il CANTIERE NAVALE DI RECCO nel 1865
notare le due navi in costruzione sulla sinistra e la pochissima spiaggia a disposizione prima del mare.

Già nel 1600 e 1700, a Recco, esistevano una miriade di attività navali. Non possiamo andare troppo indietro e dobbiamo riferire la nostra conversazione solo ai tempi più recenti.
Un esempio, dal 1840 sino al 1876, a Recco vi costruirono velieri i Gotuzzo, i Rolla e i Saccomanno tanto per citarne alcuni.
Secondo i registri RINA consultati, Luigi Gotuzzo (parente dell’omonimo che costruì a Chiavari) vi costruì 16 velieri dal 1840 al 1863. Il Rolla ne costruì 25 dal 1863 al 1875. Il Rolla assieme al Saccomanno ne costruì 3 e altri anonimi circa una dozzina. Ma siamo consapevoli delle nostre manchevolezze nel riportare quanti altri costruttori prima di questi tre nominati si cimentarono nell’arte della costruzione navale a Recco. Ed infatti Gio Bono Frrari nel suo irripetibile volume riporta: Se si facesse il calcolo dei grandi bastimenti costruiti a Recco si sorpasserebbero di certo i 200.
A RECCO, AL TEMPO DELLA VELA, ESISTEVA ANCHE UN INDOTTO IMPORTANTISSIMO.
• Oltre ad essere rinomata per le sue campane e i suoi orologi da torre, oltre che avere tra i suoi figli un Nicolosio da Recco, scopritore delle Isole Canarie e un “ferreo” ammiraglio come Biagio Assereto che aveva saputo vincere ben due re alla battaglia di Ponza, Recco era famosa per i suoi “bozzellai”. La grande fabbrica di questo prodotto del quale tutte le navi che si varavano in riviera avevano bisogno, era nei capaci fondaci del convento di San Nicolò. I “canapini” così chiamati, erano i portatori della canapa per fare i cordami. La buona canapa arrivava anche dall’Emilia e veniva portata con una lunga teoria di muli, una vera e propria carovana che faceva l’antica strada di Brignole, Priosa, Favale di Malvaro, Tribogna, la Spinaiola, Testana e Recco. Un grande fabbro, il “Gillio”, “capace di fare dalle “teste di morto” ai grossi Paranchi “ arrivò ad avere ben 22 operai ai suoi ordini. Poi c’erano i “Ciavairi” o chiodatori, i forgiatori dei perni di rame che in genere provenivano tutti da Masone, lavoro delicatissimo. E non ultimi i Mastri Scultori perché Recco aveva anche la specialità delle belle polene, vere statue, artisticamente scolpite che si mettevano sotto il bompresso. Fino al 1865 c’era l’usanza che quando un barco era pronto sotto il nome del barco si incideva un rudimentale castello. Era una bella affermazione di campanile. Poi l’usanza sparì.
CURIOSITA’
• Al tempo dell’epoca eroica della vela (1700-1800) un buon Maestro d’Ascia guadagnava Lire 6 al giorno, cifra favolosa, se si pensa che gli uomini che lavoravano a incatramare o “impeciare” i cavi guadagnavano soltanto due “mutte” al giorno, ossia 80 centesimi.
• Ogni barco voleva la sua campana di bordo bella e ornata. Così a Recco nacquero anche le fonderie dei Picasso. Gli armatori vi si recavano personalmente per ordinare le campane. Se erano “Michelini” facevano incidere sulla campana l’effige di San Michele che trafigge Lucifero. Se “Madonnini” il bassorilievo della Madonna del Suffragio. Se erano di Camogli usavano il medaglione della Madonna del Boschetto, San Prospero o San Fortunato come effige. Un Capitano di Camogli che aveva la moglie di nome Maria vi fece incidere “Aspettami Marinin”, un altro “Salvami dai pirati o divo Prospero”.
Oltre 250 velieri varati a Chiavari
Una piccola premessa era necessaria
ma rivolgiamoci ora al vero tema della nostra conversazione:
oltre 250 velieri oceanici varati a Chiavari tra il 1830 e il 1930 i cui costruttori, tutti nati a Recco, emigrarono a Chiavari per costruire le loro navi. Cerchiamo di capirne
i motivi dopo aver conosciuto i personaggi.
I Gotusso comunque , poi registrati come Gotuzzo, nascono come armatori di barchi a Portofino e poi, si spostano a Recco con Luigi e a Chiavari con Francesco (detto Mastro Checco) per diventare costruttori navali nei primi anni del 1800.

Francesco Gotuzzo detto Mastro Checco nato a Recco nel 1808.
Svolse tutta la sua attività di costruttore navale a Chiavari dove vi morì nel 1865.
Quando morì aveva ben 9 velieri in costruzione tra “Ciassa di Barchi” (Piazza Gagliardo) e il Cantiere Navale degli Scogli attualmente denominato:
“LUNGOMARE DEI GOTUZZO COSTRUTTORI NAVALI”
Il suo testamento, che era anche un accordo commerciale, venne firmato dalla vedova, Vittoria Gagliardo (1820-1888), dal figlio Luigi Gotuzzo, da Matteo Tappani, e dagli armatori Erasmo, Sebastiano e Francesco Raffo. Alla sua morte, nel 1865 come detto, erano in costruzione nel cantiere degli Scogli ben 9 velieri: BP VENEZIA (già ultimato e varato), BP PETRONILLA, BP FENICE, NG VIRGINIA, BP ERASMO, BP APENNINO, BP SOLLECITO, BP ANTONIETTA COSTA, BP GIABATTISTA D’ASTE. Tutti grandi velieri a tre alberi come Brigantini a palo e un Nave Goletta il VIRGINIA.
Lasciò scritto che i due quinti dei costi e ricavi sarebbero andati a Matteo Tappani per la sua opera prestata nella costruzione, che aveva anche sposato la figlia di Francesco, Giulia Gotuzzo, mentre i tre quinti andavano al figlio Luigi Gotuzzo con la raccomandazione di “andare d’accordo almeno per 6 anni”.
In pratica Matteo Tappani imparò l’arte di costruttore dal suocero, Francesco Gotuzzo, detto “Mastro Checco”.

Matteo Tappani, “U sciu Mattè”, nato a Recco nel 1833.
Svolse tutta la sua attività di costruttore navale a Chiavari dove vi morì nel 1924. Assieme al figlio Francesco fu uno dei fondatori del Cantiere Navale di Riva Trigoso.
I Fratelli Beraldo, tutti Capitani di mare, erano tre:
Giuseppe, 1853-1939, Enrico, 1858-1925 ed
Erasmo, 1863-1946, tutti originari di Recco, per un certo periodo abbastanza lungo operarono e abitarono a Chiavari. Non siamo in possesso di loro fotografie.
Ma possiamo constatarne la loro importanza dai Capitoli 6 e 7 del Volume “CHIAVARI MARINARA DALL’EPOCA EOICA DELLA VELA . STORIA DEL RIONE SCOGLI” Seconda Edizione del 1997.

Nella foto il B.G. Maddalena Beraldo costruito a Chiavari e varato nel 1920
Era stato costruito proprio nella zona denominata ora Via dei Velieri nella quale furono costruiti e varati molti velieri di vari costruttori come i Briasco, i Brigneti, i Piceni Gessaga, i Copello e gli stessi Beraldo.
I costruttori navali GOTUZZO, TAPPANI e BERALDO erano tutti imparentati, vediamo come:
• FRANCESCO GOTUZZO detto Mastro Checco, (1808-1865) coniugato con Vittoria Gagliardo ebbe 9 figli: 5 maschi e 4 femmine.
• La terza figlia, GIULIA GOTUZZO (nata 1844) sposò MATTEO TAPPANI (1833-1924) ed ebbero 4 figli: FRANCESCO, costruttore navale divenne poi Podestà di Chiavari dal 1932 al 1942.
• La seconda figlia di Matteo Tappani, TERESA, sposò appunto ENRICO BERALDO (1858-1925).
• Il quarto maschio di Francesco Gotuzzo, LUIGI (1846-1919) continuò a condurre il cantiere navale di Chiavari lasciando poi, alla sua morte, la direzione al figlio EUGENIO detto Mario.
• Nota: Il Luigi Gotuzzo nato nel 1786, che costruì a Recco prima del Rolla, era figlio di Francesco (nato 1759) e Pellegrina Massone mentre Francesco Gotuzzo detto “Mastro Checco” nato nel 1808 era figlio di Francesco e della seconda moglie, Maria Geronima Avegno, quindi fratellastro di Luigi.
ATTIVITA’ COSTRUTTORI NAVALI
SVOLTA A CHIAVARI DA OGNUNO:
Gotuzzo Francesco e figlio Luigi e figlio Eugenio
Oltre 105 velieri costruiti
Tappani Matteo e figlio Francesco
Oltre 55 Velieri
Beraldo e altri (Briasco, Brigneti, Piceni Gessaga,
Copello) oltre 30 velieri
DOMANDA?
PERCHE’ I GOTUZZO, I TAPPANI E I BERALDO E ALTRI, DI CHIARA ORIGINE “RECCHELINA”, VENNERO TUTTI A COSTRUIRE LE LORO NAVI A CHIAVARI?
Come abbiamo visto nelle precedenti panoramiche di Recco dovevano trovare una alternativa alla concessione demaniale data l’esposizione evidente alle mareggiate quando lo scafo era in costruzione. Pur tuttavia, a Recco nonostante gli spazi limitati, in certi anni come nel 1865 si ebbero 4 vari e addirittura nel 1875, (un anno prima della chiusura del cantiere) 6 vari nello stesso anno. Crediamo che il record spetti a Francesco Gotuzzo.
Quando morì a Chiavari nel 1865, aveva ben 9 scafi in costruzione come dedotto dal suo testamento e dalle divisioni che poi vennero fatte tra Matteo Tappani (che aveva dato assistenza nelle costruzioni) e Luigi Gotuzzo figlio di Francesco. Solo con questi dati possiamo farci un’idea di quanto fosse attiva la cantieristica nelle nostre riviere dato che Chiavari o Recco non erano certamente casi isolati.
Il veliero, a Chiavari, quando i Tappani e i Gotuzzo vi si recarono, poteva essere costruito tranquillamente al riparo delle mareggiate e tutti sappiamo quanto fosse agevole dato la grande quantità di legno da tagliare o lavorato che giaceva sotto la nave.
3) La spiaggia di Chiavari, specialmente ai primi anni del 1800 era lunga e ininterrotta, con una dolce pendenza verso il mare che consentiva allo scafo, nel momento del varo, di scivolare lentamente senza accelerare la corsa, verso l’acqua.
4) Non appena il veliero toccava l’acqua, inoltre, poteva contare su di una notevole profondità che le assicurava un immediato galleggiamento senza insabbiarsi.

Chiavari - Casa Gotuzzo - Piazza Gagliardo
MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA CHIAVARI
GLI ATTREZZI DEL MAESTRO D'ASCIA
Ogni attrezzo corrisponde ad un antenato, che qui continua idealmente a vivere ... queste asce sono intrise del suo sudore, del suo sangue, del suo pensiero ... Ecco spiegata la sacralità del luogo! Gli odori forti della resina, della stoppa e della pece stanno ai vecchi cantieri come l'odore d’incenso sta alle chiese, come il mosto sta alle cantine.
Nel lavoro del maestro d’ascia tutto é cadenzato da segreti e gelosia di mestiere! Dal fabbricare i propri utensili per entrare in qualsiasi “recanto” della barca in costruzione, alla scelta dei manici di legno (pero, melo, limone), alle misure (peso, lunghezza, larghezza) che devono essere armoniche con la sua stazza e con lunghezza del suo braccio. Ogni colpo d’ascia emana una nota musicale che racconta la storia di quel legno (vecchiaia, stagionatura, duttilità, qualità, prontezza d’impiego). L’ascia é affilata come il rasoio da barba. Nel tempo diventa l’estensione dell’arto del suo maestro di cui assume la stessa personalità. E’ solo paragonabile allo scalpello dello scultore, al pennello di un pittore. Se l’occhio ti tradisce e sbagli il “tocco”, devi ripartire daccapo.


GLI ATTREZZI DEL CALAFATO

La MARMOTTA DEL CALAFATO


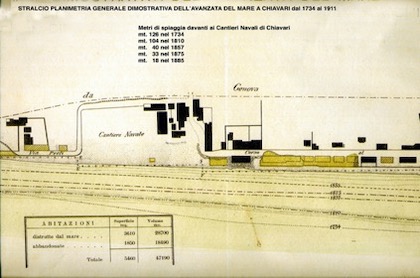
VEDUTA DI CHIAVARI NEL 1888

VEDUTA DI CHIAVARI NEL 1912

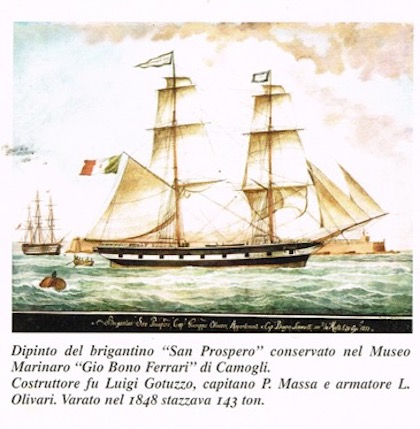


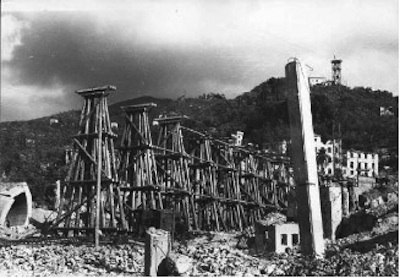

TERZA PARTE
RICERCHE E STUDI DELLA PROF.SSA
LUCIANA GATTI
Prof.ssa Luciana Gatti e Prof. Carlo Maccagni – Università di Genova- In attesa di intervenire con la loro relazione.
Il Comandante Ernani Andreatta é da tempo in contatto con la Prof.ssa Luciana Gatti dalla quale ha ottenuto la ricerca (PDF) così intitolata:
ATTI DELLA SOCIETA’ LIGURE DI STORIA PATRIA – Nuova Serie – Vol. XLVIII (CXXII) FSC. II
Cliccando sul titolo sopra si aprie una finestra sulla quale si preme “Salva” per scaricare il pdf di cui al titolo.
LUCIANA GATTI
(é solo un caso di omonimia…)
“Un raggio di convenienza” –
Navi mercantili, costruttori e proprietari in Liguria nella prima metà dell’Ottocento
Si tratta di un corposo STUDIO di 495 pagine del quale segnalo agli appassionati le pagine relative ai “bastimenti” costruiti a Recco, essendo questo l’argomento di cui ci occupiamo oggi.
La ricerca, come vedrete, riguarda tutta la cantieristica ligure di quel periodo che inizia al Capitolo: 2. Cantieri e costruttori
Pag. 93-94-95-106
A pag.123-124 Appendice 1 – Le navi costruite (1826-30 e 1838-52)
Gli elenchi seguenti segnalano, per gli anni e le direzioni documentate, le singole costruzioni raggruppate per tipi, con l’indicazione di nome, portata, costruttore, proprietario e cantiere.
Ripeto: segnalo soltanto le pagine dove compaiono i Cantieri di Recco.
Pag. 123-124-125-126-127-128-129-131-132-133-135-136-140-141-142-147-150-152-154-155-157-161-162-163-164-166-168-170-173-174-
A pag. 365 Appendice 3 – Repertorio di Costruttori
A pag. 427-438-439-440-450-452-453-454-455-456
Più di tante informazioni sulla carriera della Prof.ssa Luciana Gatti, studiosa e ricercatrice di Storia del Mondo Marittimo Ligure, preferiamo segnalare 10 tra i suoi più importanti lavori di ricerca a cui gli appassionati e followers della nostra Associazione MARE NOSTRUM RAPALLO possano attingere per migliorare la conoscenza delle proprie radici marinare.
Gatti, Luciana
Navi e cantieri della Repubblica di Genova, sec. 16.-18. / Luciana Gatti
Genova : Brigati, 1999]
Gatti, Luciana
Il baro del tempo / Luciana Gatti
Legnago : Edizioni Grafiche Stella, 1999
Gatti, Luciana
Sulle maestranze dei cantieri genovesi in età moderna / Luciana Gatti
Fa parte di: Navalia : archeologia e storia
Gatti, Luciana
I mestieri a Genova tra medioevo ed età moderna Luciana Gatti
Spoleto : Centro italiano di studi sull'alto medioevo, [s.d.]
Gatti, Luciana
Genova : s.n!, 1990-...
Gatti, Luciana
Artigiani delle pelli e dei cuoi / Luciana Gatti
Genova : [s.n.], 1986
Gatti, Luciana
Le navi di Angelo M. Ratti, imprenditore genovese del 18. secolo / Luciana Gatti
Genova : s. n.!, 2001 (Genova : G. Brigati)
Gatti, Luciana
5 : Artigiani delle pelli e dei cuoi / Luciana Gatti
Genova : s. n.!, 1986 (Genova : Prima cooperativa grafica genovese, 1987)
Fa parte di: Maestri e garzoni nella societa genovese fra 15. e 16. secolo
Gatti, Luciana
Genova : [s.n.], 1990
Gatti, Luciana
Le navi di Angelo M. Ratti, imprenditore genovese del 18. secolo / Luciana Gatti
Genova : [s.n.], 2001 (Genova : Brigati Glauco)
Ernani ANDREATTA
A cura di Carlo GATTI
Rapallo, 20 Ottobre 2020
LA REGGIA DI PORTICI - REAL ACCADEMIA DI MARINA
LA REGGIA DI PORTICI
L'Italia vanta un inestimabile patrimonio artistico, forse il più vasto d'Europa. Dal nord al sud, sono tante le dimore reali che raccontano la storia del nostro paese per cui vale la pena ricordare che da noi si conta il maggior numero di siti UNESCO al mondo: ben 54 censiti nel 2019 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Si tratta di luoghi con un enorme valore storico, archeologico e culturale, un immenso patrimonio che attrae ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo.
Le regge in particolare ci fanno immaginare balli di corte, complotti militari, amori clandestini. Quanti segreti si nascondono tra i corridoi intricati come labirinti, tra le fronde dei giardini e nelle grandi stanze dai soffitti a volta? Nessuno può saperlo.
Oggi ci occupiamo della La Reggia di Portici e della
REAL ACCADEMIA DI MARINA
La stupenda Reggia Borbonica, come mostra la carta sotto, é vicinissima a Napoli. La sua costruzione diede vita al cosiddetto Miglio d’oro: una linea disegnata da stupende ville nobiliari lungo la costa da Portici ad Ercolano.

La Reggia di Portici, costruita a partire dal 1738 per volere del re di Napoli, Carlo III di Borbone e della regina, Amalia di Sassonia, é considerata tra gli esempi più significativi di residenza estiva della Casa reale borbonica e della sua corte.
Situata alle pendici del Vesuvio - tra il bosco superiore (dedicato alla caccia) e quello a valle (di natura ornamentale e prospicente il mare) – fa parte della tradizione dell’aristocrazia napoletana di costruire ville periferiche ai piedi del vulcano.
“Ci penserà Iddio, Maria Immacolata e San Gennaro!”
Con questa espressione il sovrano rispondeva a chiunque gli facesse osservare la pericolosità del luogo.
I lavori di costruzione iniziati da Giovanni Antonio Medrano, furono condotti dal 1741 secondo il progetto di Antonio Canevari e conclusi dai celebri Luigi Vanvitelli e Ferdinando Fuga.
Le preziose decorazioni degli interni furono affidate a Giuseppe Canart, Giuseppe Bonito e Vincenzo Re al quale vanno attribuite: le decorazioni architettoniche dello scalone a doppia rampa e le finiture delle sale delle Guardie e del Trono.
Attraversato l’atrio si accede alla parte inferiore del palazzo caratterizzata dalla grande facciata verso il mare e un’ampia terrazza da cui si dipartono due rampe a tenaglia che conducono al parco curato da Francesco Geri.
Tutta la zona, intensamente abitata in epoca storica e conservata dall’eruzione del 79 d.C., si dimostrò ricca di reperti eccezionali che furono valorizzati e sistemati, in fasi successive, nelle stanze della Reggia fin all’allestimento del Herculanense Museum divenuto ben presto una delle mete preferite all’interno del Grand Tour; oggi il materiale è custodito presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Segnaliamo ancora: gli affreschi di Crescenzo Gamba nelle volte (Allegoria della Verità e Aurora); il Gabinetto in stile Luigi XV; il Gabinetto cinese con pavimento musivo - proveniente da Ercolano - e la Sala Cinese, oggi Aula Magna. Attestazione greche e romane arricchiscono logge, viali, giardini, il Chiosco del Re Carlo, l’Orto fitopatologico e gli altri ambiti. Si fa menzione, inoltre, del “recinto del gioco del pallone” realizzato sotto Ferdinando IV.
Diventata, sul finire del XIX secolo (1872), sito per la Reale Scuola Superiore di Agricoltura e sede di un Orto Botanico nel “giardino soprano della Reggia”, dal 1935 ospita la Facoltà di Agraria della Università di Napoli Federico II.
Possiamo chiudere questo capitolo con un’anonima dichiarazione che ci sembra appropriata: “nel corso del tempo il complesso della Reggia di Portici divenne “luogo di memorie d’arte, di memorie storico-scientifiche e paesaggistiche ed è ancora oggi luogo di contrasti in cui vivono l’anima archeologica e l’anima scientifica”.


Carlo III di Borbone
Si dice che tre sia il numero perfetto, che Carlo III di Borbone fece suo ordinando di costruire, oltre al Palazzo di Capodimonte e la Reggia di Caserta, anche il Palazzo Reale di Portici.
Una delle tesi sulla storia del palazzo vuole che il sovrano abbia scelto la costiera vesuviana dopo essere stato invitato, dal principe di Elboeuf Emanuele Maurizio di Lorena, a trascorrere una giornata nel suo palazzo di Portici, da qui partì l’entusiastica idea di commissionare la costruzione di una Reggia nel 1738.
Un’altra tesi ci racconta che nel 1737 Re Carlo III di Borbone scoprì la zona grazie ad una tempesta che costrinse la sua nave a entrare in fretta nel porto del Granatello a Portici. Il posto piacque molto sia alla Regina Maria Amalia che al Re che decise di farvi costruire una delle sue residenze che divenne poi Reggia ufficiale.
I lavori iniziarono nel 1738, e il Re Carlo acquistò poco dopo anche vaste aree verdi circostanti per realizzare un grande parco ed inglobò nella nuova costruzione anche le ville preesistenti del conte di Palena e del principe di Santobuono espandendosi così verso il mare e acquistando boschi e terreni di altri nobili. I lavori terminarono nel 1742, ma la Reggia non fu sufficiente ad ospitare tutta la corte, e così molti nobili fecero costruire stupende ville nei dintorni, creando una zona bellissima che prese il nome “il miglio d’oro” che abbiamo già citato dando così vita alle Ville Vesuviane.

Palazzo Reale di Portici in un dipinto del XVIII secolo

La reggia presenta una ampia e maestosa facciata terrazzata e munita di balaustre. L'edificio ha una pianta quadrangolare e, l'atrio attraverso cui vi si accedeva da una cancellata in ferro prima e successivamente, grazie alla cosiddetta strada delle Calabrie (oggi via Università) che andava a tagliare in due il parco, è sostenuto da nove volte a pilastri.
Il cortile del palazzo, che in pratica è simile ad un vero e proprio piazzale, presenta sul lato sinistro la caserma delle Guardie Reali e la cappella Palatina (1749), mentre un maestoso scalone (1741) conduce dal vestibolo al primo piano, dove si trova l'appartamento di Carolina Bonaparte.
Le già accennate opere di scavo portarono alla luce numerose opere d’arte di valore, tra cui un tempio con 24 colonne di marmo, che furono sistemate temporaneamente nel Museo di Portici, annesso alla Accademia Ercolanese, dove vengono depositati i reperti provenienti dagli scavi archeologici di Ercolano.
Tra monarchia e rivoluzione: una storia tumultuosa
Durante la rivoluzione napoletana del 1799, combattuta dai rivoltosi per rovesciare la monarchia borbonica ed instaurare la Repubblica partenopea, la Reggia fu abbandonata e spogliata di numerose opere d’arte a causa della fuga a Palermo della corte reale, che portò con sé 60 casse piene di reperti. Nel 1806, quando divenne re di Napoli Giuseppe Bonaparte, le antichità rimaste a Portici furono trasferite al Museo di Napoli, dove furono sistemate, dopo il ritorno dei Borbone, anche le opere trasferite precedentemente nella capitale siciliana. Il Museo di Portici trovò così la sua fine, anche se il trasferimento degli affreschi venne concluso solo nel 1827.
Sotto Ferdinando II di Borbone, la reggia acquistò un collegamento diretto con Napoli, grazie alla più antica linea ferroviaria italiana (inaugurata nel 1839), ed ospitò anche il pontefice Pio IX, per divenire progressivamente un sito sempre meno frequentato.
Il bosco e i giardini all’inglese
Di particolare rilievo è il bosco, disegnato con ampi viali contornati di giardini all’inglese che fanno da sfondo ad opere d’arte tra cui vanno segnalate: la Fontana delle sirene, il Chiosco di re Carlo, la Fontana dei cigni e persino un anfiteatro.
All’interno del parco fu anche allestito uno zoo con specie di animali esotici che il sovrano Ferdinando IV volle acquistare all’estero.
Oggi la reggia ospita la sede della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed alcuni musei.


Pensato come dimora estiva del Corte, il Palazzo divenne col tempo residenza reale e sede del Museo Ercolanense, voluto da Re Carlo per raccogliere gli oggetti trovati nello stesso periodo ad Ercolano, Pompei e Stabia.

Lo scalone
Le collezioni archeologiche andarono poi a Napoli
Nei primi anni dell’Ottocento le collezioni archeologiche furono trasferite a Napoli e costituirono il nucleo dell’attuale Museo Archeologico Nazionale.
In seguito, durante il Decennio francese (1806–1815), la Reggia fu trasformata da Gioacchino Murat che fece cambiare tutto il mobilio secondo il gusto dell’Impero francese.

Con il ritorno dei Borbone la Reggia fu al centro dell’attenzione reale in particolare quando il 3 ottobre 1839 fu inaugurata la linea ferroviaria, la prima in Europa, che collegava Napoli alla Reggia.

La scala affrescata dell'ala a mare della Reggia di Portici

All’interno del Palazzo Reale si accede al primo piano con un magnifico scalone lungo il quale sono state sistemate le statue trovate ad Ercolano e che fu decorato nei soffitti dallo scenografo del San Carlo. Bellissime le Sale delle Guardie e quella del Trono, stupendo anche il parco, con un giardino all’inglese degradante verso il mare con lunghi viali.

Gli interni del Palazzo
Dal 1872 la Reggia ospitò una Scuola di Agraria che poi si è trasformata, negli anni 30 del ‘900, in facoltà di Scienze Agrarie dell’Università Federico II di Napoli.

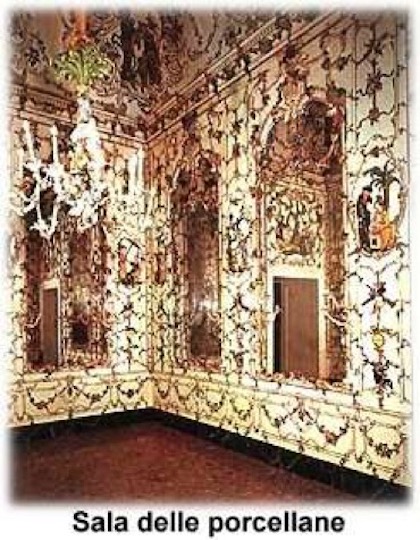
Oggi la Reggia ospita anche l’Orto Botanico di Portici e L’Herculanense Museum che è l’anima archeologica del polo museale del Sito Reale di Portici e vari Musei delle Scienze Agrarie.
L’orto botanico di Portici
Della Reggia è parte integrante anche l’Orto botanico di Portici che occupa parte del parco della Reggia. Ancora oggi sono visibili le opere architettoniche realizzate nel Settecento: cassoni per le piante, muri di cinta, busti marmorei e fontane, aiuole specializzate, vasche con piante acquatiche e la Serra Pedicino.

Ripartita secondo un ordine sistematico, l’esposizione botanica è organizzata per distribuzione geografica e relative tipologie ambientali: vi si allevano conifere nordiche, flora del Mediterraneo, magnolie e piante provenienti dal Centro e Sud America, Australia, Sudafrica e di origine euroasiatica.
C’è anche un giardino storico e, all’ombra dei lecci, c’è il giardino delle felci che è uno degli angoli più suggestivi dell’Orto. Vi si coltivano oltre 400 specie provenienti dai deserti africani e americani. Al verde del giardino storico, si contrappone la natura quasi selvaggia del bosco circostante. L’Orto botanico e il bosco sono luoghi molto belli che meritano di essere visitatati.
ALTRE MERAVIGLIE DI PORTICI
I lavori, realizzati con fondi europei e diretti dall’architetto Ciro La Greca, proseguirono tra mille problemi, ma anche tante soddisfazioni, non solo per la meraviglia della capriata palladiana, ma come la scoperta sotto strati e strati d’intonaco – rimosso con un bisturi da restauro – del graffito di un vascello inglese, forse un omaggio alla forte presenza dei figli d’Albione nel Regno, e del disegno di un pentagramma con alcune note – tracciato con la “sanguigna”, una matita rossa in uso fino al 1806 – che all’epoca suscitarono grande interesse tra gli esperti.
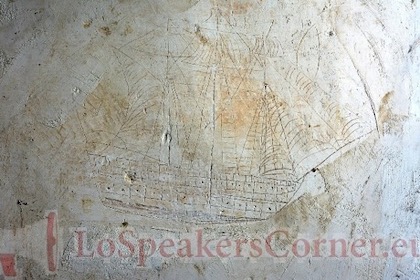
Riportiamo la consulenza sul vascello inglese che è stata gentilmente fornita dall’ingegnere navale Lucio Militano, autore, tra l’altro, di libri molto ben documentati sulla Marineria Borbonica: «Il disegno è molto schematico e fatto, probabilmente, non da uomo di mare per certi errori sulla struttura degli alberi e la forma dello scafo. Armata a “nave” con tre alberi a vele quadre, tre vele di prua (fiocchi) e vela di poppa. La vela di poppa (randa di mezzana) fa pensare ad un armamento velico tipico della seconda metà del XVIII secolo in poi; sullo scafo si vedono i portelli dei cannoni, ve ne sono 32 evidenti nei due ponti inferiori e dovrebbero essercene altri 5/6 sul ponte di coperta, per un totale (stimato) di 80 cannoni. In tal caso sarebbe un vascello di terzo rango secondo la terminologia in uso preso la Royal Navy (secoli XVIII, XIX). La nave potrebbe essere la rappresentazione di una della flotta di Nelson al tempo di Ferdinando IV (ma anche successivo). Era un tipo di nave molto diffuso nella Royal Navy, infatti nel 1805 su 175 navi, 147 erano di terzo rango. Per la cronaca il vascello Monarca della Marina Duosiciliana (costruito a Castellammare di Stabia) e trasformato in nave a propulsione meccanica ad elica nel 1854, apparteneva a questa classificazione (detta anche a due ponti). Potrebbe essere stata una nave di questo tipo.»
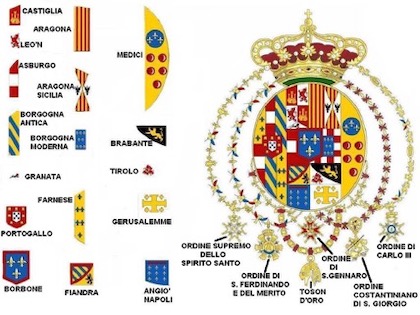
REAL ACCADEMIA DI MARINA
La Real accademia di marina di Napoli, fondata il 4 dicembre 1735 da Carlo III di Borbone sotto il nome di Academia de los Guardia Estendardes de las Galeras, è stato l'istituto di formazione degli ufficiali dell’Armata di mare del Regno di Napoli e quindi delle Due Sicilie. Dal 1861 al 1878 formò gli allievi ufficiali della Regia Marina Italiana. È la più antica accademia navale d'Italia, nonché progenitrice, insieme alla sua omologa di Genova, dell’Accademia Navale di Livorno.
Al fine di aumentare il numero degli aspiranti, gli anni di corso furono ridotti da quattro a tre, ed il ventaglio d'età fu ampliato fino a comprendere allievi dagli 11 ai 16 anni.
Da un punto di vista dei programmi di insegnamento, l'istituto era egualmente provvisto di elementi teorici e pratici. Oltre alla storia, alla geografia, alla lingua inglese e francese, alla matematica, alla trigonometria piana e sferica, alla fisica sperimentale ed allo studio dei trattati pratici per la costruzione dei vascelli; gli allievi facevano pratica due volte a settimana di armi bianche e da fuoco, artiglierie comprese, e si esercitavano in mare a tenere l'ordine di battaglia.

Sir John Acton
Il sistema di addestramento sul modello spagnolo rimase in vigore fino all'avvento, in qualità di ministro, dell'ammiraglio inglese John Acton, il quale impresse un notevole impulso allo sviluppo della flotta militare.
Come detto in precedenza, l'intendimento originario era quello di allocare i cadetti in un apposito edificio alla Darsena di Napoli. Permanendo tuttavia ancora negli anni Settanta del XVIII secolo l'indisponibilità di tale edificio, fu deciso il trasferimento dell'Accademia a Portici.
Il trasferimento a Portici (1780-1793)
La scelta di trasferire a Portici l'Accademia non fu casuale, in quanto la cittadina vesuviana diventava, da marzo ad ottobre, il centro della vita di corte.
La scelta dell'edificio da destinare all'Accademia di Marina cadde sull'antico convento dei Gesuiti, il quale, alla cacciata dell'ordine dal Regno, avvenuta mediante la prammatica del 31 ottobre 1767, era stato acquisito ai beni della corona. L'antico monastero, similmente a quanto avvenuto per quello che avrebbe ospitato la Reale Accademia della Nunziatella di Napoli, era già stato destinato ad usi militari. Esso ospitava infatti i cadetti del Battaglione Real Ferdinando, corpo di Casa Reale del quale lo stesso re Ferdinando IV di Borbone aveva il grado di colonnello.
L'edificio aveva subìto, rispetto alle origini, numerosi miglioramenti tra cui quelli operati da Carlo Vanvitelli nel 1771, i quali avevano lo scopo di rendere confortevole l'alloggiamento dei cadetti, in quanto i Gesuiti avevano lasciato i luoghi in condizioni pietose. I lavori, iniziati nell'autunno di quello stesso anno, procedettero rapidamente, tanto da potersi considerare ultimati il 27 marzo 1777. Al completamento dei lavori, i cadetti del Battaglione Real Ferdinando vi ebbero accesso, seguendo durante l'anno la corte negli spostamenti tra Napoli e Portici.
All'inizio del giugno 1779, in funzione della determinazione di portare a Portici l'Accademia di Marina, vi fu inviato l'ingegnere delle opere idrauliche della Marina Giuseppe Bompiede, con l'incarico di studiare la situazione e disegnare i piani di un ampliamento. Il progetto risultante vide la realizzazione di un nuovo braccio dell'edificio. I lavori, affidati al Tenente di Vascello, ingegnere idraulico, Salvatore Carrabba, iniziarono alla fine dell'estate del 1779; e furono completati in una prima tranche entro il febbraio 1780. Il completamento della prima fase consentì il trasferimento a Portici di un Comandante, due subalterni, e venti guardiamarina, uno per stanza. Il proseguimento dei lavori consentì il trasferimento dell'intero corpo docente, degli ufficiali, del personale di servizio e di tutti i 40 guardiamarina nell'edificio entro l'estate del 1780.
Il trasferimento nella nuova sede, e la sua prossimità al porto del Granatello, consentiva l'agevole addestramento dei cadetti in mare, il quale veniva effettuato a bordo di una galeotta ivi ancorata. La pratica di artiglieria veniva invece effettuata presso il Fortino del Granatello, antica costruzione sorta intorno ad una precedente torre di avvistamento costruita ai tempi del viceré di Napoli Pedro Alvarez de Toledo y Zúñiga.
L'Accademia fu oggetto di frequenti visite da parte di Ferdinando IV, il quale fin da giovanissimo coltivò un forte interesse per i giochi di guerra. Nelle acque antistanti il Granatello, infatti, e nel bosco che circondava la locale Reggia, si svolgevano spesso simulazioni di combattimenti, cui il re partecipava di persona. All'Accademia passarono inoltre numerosi personaggi di rilievo del tempo, tra cui, il 17 febbraio 1784, il re di Svezia Gustavo III, che ne rimase molto favorevolmente impressionato.

Francesco Caracciolo
La sede di Portici dell'Accademia, che in questo periodo ospitò come allievo il futuro ammiraglio Francesco Caracciolo, fu abbandonata alla fine del 1793, quando l'istituto fu trasferito in un edificio della capitale.
l secondo periodo napoletano (1793-1805)
La sede di Pizzofalcone
Il periodo palermitano (1805-1816)
Il terzo periodo napoletano (1816-18619
Il monastero dei SS. Severino e Sossio (1816-1835)
La sede di Santa Lucia (1843-1878)
Nel regno d'Italia (1861-1878)
A seguito dell’Unità d’Italia e dell'istituzione nel 1861 della Regia Marina proseguì nella formazione degli allievi ufficiali di marina fino al 1868, quando la Reale Accademia di marina fu unificata con la "Regia scuola di marina" di Genova, già della Marina del Regno di Sardegna per creare un unico istituto, con decreto del 20 settembre 1868: la Regia scuola di marineria. L’allora Ministro della Marina, ammiraglio Augusto Riboty, unificò le due scuole in un unico Istituto, e le suddivise in due Comandi, detti Divisioni. Da quel momento gli allievi seguirono i primi due anni di corso presso la sede di Napoli e gli ultimi due a Genova.
Nel 1878, con la trasformazione della Scuola in Accademia Navale con legge presentata dall'allora ministro della Marina, l'ammiraglio Benedetto Brin, furono soppresse le sedi di Napoli e Genova, e fu indicata come sede unica Livorno.
CONCLUSIONE
– Come abbiamo visto in questo panorama di valori storici ed artistici inestimabili, PORTICI fa parte di quella storia, arte, cultura, paesaggi, ma anche tradizione, folklore, miti, leggende che hanno fatto grande l’Italia nel mondo. Una miscela di risorse che devono essere conosciute da tutti e tradursi in ricchezza per l’umanità.
Ci ha provato in Parlamento il senatore Sergio Puglia che ha ottenuto l’approvazione dell’ordine del giorno votante la valorizzazione del Real Sito di Portici. Il Governo “opererà nelle opportune sedi al fine di ottenere, da parte dell’Unesco, il riconoscimento del valore universale e l’inserimento dello stesso nella lista dei patrimoni dell’Umanità”.
Carlo GATTI
Rapallo, 14 Settembre 2020
L'MPRESA SEMPRE ATTUALE DI UN CAPITANO CAMOGLIESE
L'IMPRESA SEMPRE ATTUALE DI UN CAPITANO CAMOGLIESE

Molto si dice sui brigantini e l'epoca eroica della vela. Qualcuno evidenzia negativamente la vetustà dell'argomento, cioè afferma che tale periodo appartiene ormai a storie desuete, fuori dai nostri tempi.
Eppure, il nostro Civico Museo Marinaro "G.B. Ferrari" conserva molte testimonianze di quell'epoca che non sono avvolte da antiquate ragnatele del passato, ma "au contraire" - come in ogni museo - si rigenerano, soprattutto per la fruizione delle generazioni future.
Un esempio remoto, e al tempo stesso attuale, è il dipinto raffigurante la nave a vela Trojan, che fu gestita dai fratelli Mortola, ramo "Liggia". Il veliero balzò alle vette della notorietà quando il suo capitano, Filippo Avegno di Camogli, la condusse come prima nave in assoluto nel porto di Gulfport, nello stato del Mississippi, Stati Uniti.
A quel tempo, la struttura portuale era stata appena inaugurata e gli americani erano perciò impazienti di iniziare il loro business del traffico di legname. Tale notizia è riferita dall'insigne custode della cultura marinara camogliese, Giò Bono Ferrari. Ferrari omette però il periodo storico di riferimento di quell'impresa ma, d'altro canto, spiega esaustivamente che il capitano Avegno non solo "inaugurò" il porto statunitense, ma anzi contribuì ad effettuare degli approfonditi sondaggi nei tortuosi fondali di quell'accesso. Fatto sta, che altre navi, dapprima riluttanti ad entrare in porto, si convinsero della sicurezza di quell'approdo: per Avegno fu perciò un tripudio di premi e riconoscimenti.
Bene, si dirà, abbiamo letto il testo di Ferrari; cosa c'è di nuovo?
Ecco, qui si richiama il concetto di rigenerazione e riferimento alle generazioni future.
Tempo fa, la Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli fu contattata dalla Società Storica di Gulfport. Come è noto, gli americani sono attentissimi al loro passato, per cui chiesero se avevamo disponibile un'immagine ben definita della nave Trojan, la quale costituisce ovviamente una pietra miliare nella storia di quel porto. I Capitani di Camogli inviarono immediatamente la foto del dipinto presente in Museo e, in Mississippi, di conseguenza, i nostri interlocutori furono euforici di quella trasmissione.

Il dipinto del Trojan presente al Museo Marinaro di Camogli
Quando la comunicazione con gli amici americani fu stabilita, iniziò un fitto scambio di informazioni sulla nave, dei suoi armatori, delle immagini. Anche noi fummo arricchiti di testimonianze: per esempio, le foto del 24 gennaio 1902 (data effettiva - finalmente nota - dell'inaugurazione del porto di Gulfport), che mostrano la "nostra" nave ormeggiata e imbandierata!

Il Trojan ormeggiato a Gulfport: è il 24 gennaio 1902
Ma la collaborazione non termina qui: all’inaugurazione della nuova sede della Società Storica di Gulfport – prevista per il 2020 – verrà esposto un modello del veliero lungo un metro e mezzo, attualmente in costruzione presso il laboratorio di un professionista. E aggiungiamo la più grande soddisfazione: il logo della Società statunitense, che è un’immagine stilizzata del Trojan, farà per sempre una splendida pubblicità alla professionalità e intraprendenza camogliese.
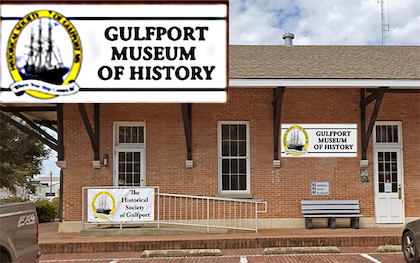
La prossima sede della Società Storica di Gulfport. Il logo dell'ente raffigura il
veliero camogliese Trojan (vedi immagine sopra)
Come si vede, le gesta degli artefici della navigazione a vela camogliese sopravvivono nel tempo; anzi, c'è da aspettarsi che altri legami riaffiorino dagli anfratti più inaspettati e che - certamente - ci riempiono d'orgoglio.
BRUNO MALATESTA
10/2019
LE NAVI OSPEDALE ITALIANE
LE NAVI OSPEDALE ITALIANE
LE ORIGINI …
La Fondazione del “Comitato Milanese della Associazione Medica Italiana per il soccorso ai malati e ai feriti in guerra”
Al dott. Cesare Castiglioni si deve la costituzione del “Comitato Milanese della Associazione Medica Italiana per il soccorso ai malati e ai feriti in guerra” di cui ne divenne il Presidente il 15 giugno 1864.
Il suo intento fu quello di creare un'Associazione per fornire aiuti medici ai militari feriti (in accordo con le numerose associazioni sorte in Europa grazie all'opera di Henry Dunant).
Tale comitato, presupposto per l'istituzione della Croce Rossa Italiana, andò ad occupare il settimo posto in ordine di fondazione fra le società nazionali, quinto per adesione alla Convenzione di Ginevra.
Nell'agosto 1864 il dott. Castiglioni venne chiamato a Ginevra per esporre quanto fatto a Milano, partecipando quindi alla stessa conferenza dalla quale nacque la Convenzione di Ginevra del 1864, dove si proclamò:
“DOVERSI NON CONSIDERARE NEMICO IL NEMICO FERITO E BISOGNOSO DI ASSISTENZA” – Assumendo quindi il principio d’uguaglianza di alleati e nemici davanti alla necessità di assistenza.
D'intesa con il Comitato Internazionale della CROCE ROSSA di Ginevra fu poi stabilito che la bandiera della Croce Rossa potesse essere usata solo in caso di guerra. L'Associazione fu approvata dal Ministero dell’Interno e della guerra, e il 1º giugno 1866 il Ministero della guerra disciplinò l'organizzazione, ponendo regole militari ai componenti delle squadriglie; il personale superiore doveva perciò indossare una divisa formata da: un berretto di panno verde scuro con la legenda "soccorso ai feriti" ricamata in oro; una cravatta nera; una giacchetta alla cacciatora di panno verde scuro e pantaloni di panno grigio, come usava la Guardia Nazionale.
Il 22 giugno 1866 l'Italia dichiarò guerra all’Austria e dieci giorni dopo partirono le prime squadriglie di volontari, che soccorsero i combattenti in Trentino e i feriti dell'Armata di Mare. Il comitato milanese trovò inoltre appoggio e aiuto nella Francia e nella Svizzera per la sua opera di soccorso: per la prima volta le nazioni non belligeranti si adoperarono apertamente per soccorrere le avversità di Paesi limitrofi in guerra. L'Italia nel panorama internazionale fece inoltre da tramite ai soccorsi destinati ai feriti nella Guerra franco-prussiana del 1870-71.
IN MARE CI SI MOSSE DUE SECOLI PRIMA
Le prime navi ospedale, dette "pulmonare", vennero approntate nel XVII secolo utilizzando vecchie galee in disarmo, non più in grado di navigare. La pulmonara restava fissamente attraccata nel porti, funzionando come INFERMERIA per i marinai in attesa della pratica, ai quali era vietato lo sbarco sulla terraferma.
L'8 dicembre 1798, non ritenuta più idonea al servizio come nave da guerra, la britannica HMS VICTORY fu convertita in nave ospedale per curare prigionieri francesi e spagnoli feriti di guerra.
L'ispettore Luigi Verde fu il primo capo del Corpo sanitario della regia Marina a dare vita nel 1866 alla prima nave ospedale italiana: la WASHINGTON.
Luigi Verde morì poco dopo nell'affondamento del RE D’ITALIA durante la Battaglia di Lissa.
Il concetto moderno di nave ospedale protetta e denunciata presso apposite istituzioni internazionali doveva sorgere solo con la CONVENZIONE DELL’AJA DEL 1907.
CONVENZIONE DELL’AJA
Le navi ospedali vennero definite nel 1907 dalla Convenzione dell’Aia. In particolare l'articolo 4 definiva le limitazioni affinché una nave potesse essere considerata "nave ospedale".
La nave ospedale spagnola Esperanza del Mar, impiegata come supporto ai pescherecci al largo delle Canarie
· La nave deve avere segni di riconoscimento e illuminazione che la classifichino come tale.
· La nave dovrà fornire assistenza medica a feriti di tutte le nazionalità.
· La nave non dovrà essere impiegata per alcun scopo militare.
· La nave non dovrà interferire né ostacolare le navi militari.
· Le forze belligeranti, come designate dalla convenzione dell'Aia, potranno ispezionare le navi ospedale per verificare eventuale violazioni dei punti precedenti.
In caso di violazione di una delle precedenti limitazioni la nave dovrà essere considerata come unità combattente e potrà essere legittimamente colpita e affondata. Comunque, l'aprire deliberatamente il fuoco o affondare una nave ospedale in rispetto alla convenzione dell'Aia, è da considerarsi crimine di guerra.
Seconda guerra mondiale
Nel corso della Seconda guerra mondiale la Regia Marina armò decine di navi ospedale, spesso mercantili o piroscafi trasformati, ma anche navi soccorso e navi ambulanza, che facevano in maggioranza la spola tra l'Italia e il Nord Africa.
Molte furono affondate dagli alleati:
Giuseppe Orlando, San Giusto, Città di Trapani, Arno, Po e Virgilio.
Complessivamente delle 18 unità ne furono affondate 12. L'Italia denunciò inutilmente gli affondamenti alle autorità di Ginevra.
Navi bianche
Le navi ospedale, dal colore con cui vengono tinteggiate, prendono il nome di navi bianche. Per antonomasia vennero chiamate navi bianche quelle impiegate nel 1942 (sotto l'egida della Croce Rossa) per rimpatriare 50.000 civili italiani, rimasti in Etiopia dopo la conquista inglese.
Navi ospedale italiane:
· Washington (1854 - 1904)
· Albaro (1890)
· Brasile (1905)
· Clodia (1905)
· Menfi (1911)
· Cordova (1906 - 1918)
· Ferdinando Palasciano (1899 - 1923)
· Italia (1905 - 1943)
· Marechiaro (1911-1916)
· Re d'Italia (1907 - 1929)
· Regina d'Italia (1907 - 1928)
· R 1 (1911)
· Santa Lucia (1912)
· Gargano
· Aquileia (1914 - 1943)
· Arno (1912 - 1942)
· California (1920 - 1941)
· Città di Trapani (1929 - 1942)
· Gradisca (1913 - 1950)
· Po (1911 - 1941)
· Principessa Giovanna (1923 - 1953)
· Ramb IV (1937 - 1941)
· Sicilia (1924 - 1943)
· Tevere (1912 - 1941)
· Toscana (1923-1961)
· Virgilio (1928-1944)
Navi soccorso italiane:
· Capri (1930 - 1943)
· Epomeo (1930 - 1943)
· Laurana (1940 - 1944)
· Meta (1930 - 1944)
LE NAVI BIANCHE CON LA CROCE ROSSA
Non vi fu molto rispetto da parte del nemico per le "navi bianche italiane", come venivano chiamate le navi ospedale, nella seconda guerra mondiale.
- Nave Ospedale: WASHINGTON
https://it.wikipedia.org/wiki/Washington_(pirotrasporto)

- Nave Ospedale: ITALIA
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_(nave_ospedale)

- Nave Ospedale: FERDINANDO PALASCIANO
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_Palasciano_(nave_ospedale)

- Nave Ospedale: REGINA D’ITALIA
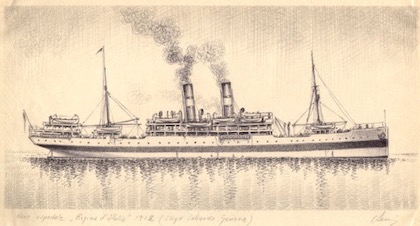
- Nave Ospedale: PO
- https://it.wikipedia.org/wiki/Po_(nave_ospedale)
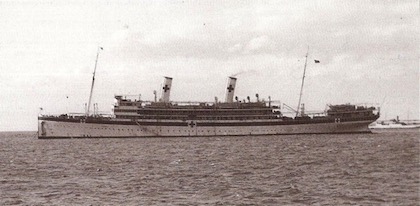
- Nave Ospedale: CALIFORNIA
https://it.wikipedia.org/wiki/California_(nave_ospedale)

- Nave Ospedale: ARNO
https://it.wikipedia.org/wiki/Arno_(nave_ospedale)

- Nave Ospedale: SICILIA
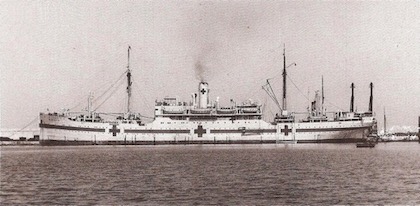
- Nave Ospedale: CITTA’ DI TRAPANI
https://it.wikipedia.org/wiki/Città_di_Trapani_(nave)

"Tevere ", "Orlando", " San Giusto " ……perdute per bombe di aeroplani o per urto contro mine.
- Nave Ospedale: TEVERE
https://it.wikipedia.org/wiki/Tevere_(nave_ospedale)
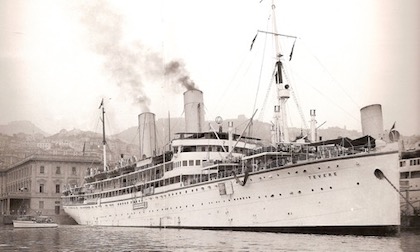

Affondamento della nave TEVERE
- Nave Ospedale: ORLANDO
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Orlando_(nave_soccorso)

- Nave Ospedale: SAN GIUSTO
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giusto_(nave_soccorso)
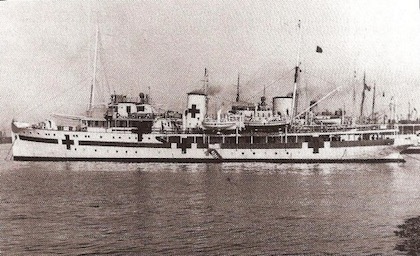
" California ", "Arno", " Sicilia ", " Città di Trapani ", …….affondate per siluramento.
- Nave Ospedale: VIRGILIO (Mitragliata)
https://it.wikipedia.org/wiki/Virgilio_(nave_ospedale)

- Nave Ospedale: TOSCANA (Mitragliata)
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana_(transatlantico)#/media/File:Toscanapiroscafo.jpg

- Nave Ospedale: AQUILEIA (Mitragliata)
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquileia_(nave_ospedale)
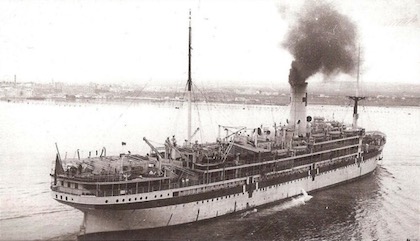
- Nave Ospedale (soccorso): CAPRI (Attaccata e mitragliata)
https://it.wikipedia.org/wiki/Capri_(nave_soccorso)

- Nave Ospedale: PRINCIPESSA GIOVANNA (Mitragliata)
https://it.wikipedia.org/wiki/Principessa_Giovanna_(nave_ospedale)

Violazione deliberata delle convenzioni internazionali? In parte, forse: ma gli inglesi rispondevano che spesso le nostre navi ospedale, invece dei feriti, caricavano truppe e munizioni per i fronti, per farli arrivare a destinazione sotto la copertura del la Croce Rossa. La verità è ancora da decifrare. Le navi ospedale erano mercantili requisiti e conservavano il proprio equipaggio, al quale si aggiungevano (dopo la trasformazione ospedaliera) i medici, gli infermieri e le crocerossine, agli ordini di un colonnello medico di Marina, il quale affiancava il comandante della unità. Molti piroscafi, divenuti nave ospedale al tempo della campagna d'Etiopia, erano stati successivamente riconvertiti al primitivo impiego.
Solo il "California" e l' "Aquileia", tra essi, erano stati conservati nei ruoli e tenuti in posizione di riserva fino al maggio 1940, quando erano stati rimessi entrambi in funzione. La prima missione del "California" era stata assai penosa. Aveva rimpatriato da Bengasi, oltre al previsto carico di ammalati e feriti, nel luglio 1940, anche i feriti dell'incrociatore "Giovanni dalle Bande Nere", superstite del combattimento di Capo Spada, che aveva visto l'affondamento dei gemello "Colleoni".
La "Po" fu una delle prime unità trasformate in nave ospedale allo scoppio della guerra. Era stato un piroscafo di 7.289 tonnellate, costruito nel 1911 e appartenente al Lloyd Triestino. Ebbe breve vita: entrato in servizio nel luglio 1940, il 14 marzo 1941 fu colato a picco da un attacco notturno di aerosiluranti, mentre si trovava nella rada di Valona per imbarcare feriti provenienti dal fronte greco. A bordo si trovava come crocerossina Edda Ciano, che si salvò.
L' "Aquileia" era stata costruita nel 1914. Si trattava di un vecchio trabiccolo, ancora dotato di caldaie con forni alimentati a carbone, per cui frequentemente era soggetta ad avarie di macchina, pertanto doveva procedere a velocità ridottissima, oppure era costretta a lunghi periodi di inattività in cantiere, per riparazioni. Con tutto ciò riusci a navigare fino all'armistizio. Il 15 settembre 1943, dopo essere stata catturata dai tedeschi, fu affondata a Marsiglia.
Per tornare alla "California", essa fu colpita a poppa da un siluro d'un aerosilurante inglese la notte del 10 agosto 1941, verso le 23, durante un attacco alla rada di Siracusa, dove la nave era all'ancora. A mezzogiorno dell'11, la "California", parzialmente affondata, giaceva su un fondale con l'acqua fin quasi alla coperta. Fu deciso che l'equipaggio e il personale medico l'abbandonassero, nella speranza di poterla recuperare in seguito. Essendosi ciò rivelato impossibile, venne demolita sul posto, dopo che il materiale di bordo era stato portato a terra. Non si può far colpa agli inglesi della sua perdita: infatti, forse per evitare il riconoscimento del porto da parte dei ricognitori nemici, il "California" aveva quella sera tutte le luci di bordo spente, mentre la convenzione di Ginevra faceva obbligo alle navi ospedale di mantenerle sempre accese. Non venne quindi individuata e questo fatto segnò il suo destino. Era stata una delle nostre "navi bianche" più efficienti, con una trentina di missioni al suo attivo, effettuate specialmente nel Mediterraneo orientale.
- Nave Ospedale: GRADISCA
https://it.wikipedia.org/wiki/Gradisca_(nave_ospedale)
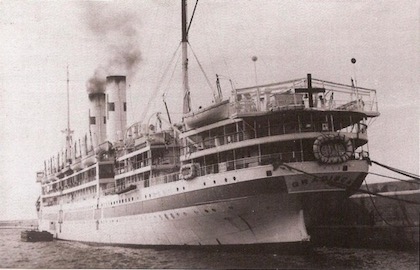
Segnalata l'opera della "Gradisca", (un ex piroscafo fabbricato in Olanda), alla battaglia di Capo Matapan, conclusasi in modo funesto per la nostra flotta, con la più grave sconfitta navale subita dall'Italia nel corso dell'intera guerra. La battaglia avvenne, come é noto, nella notte del 29 marzo 1941. Furono colati a picco tre nostri incrociatori, il "Fiume", lo " Zara " e il " Pola ". Le perdite risultarono ingenti.
Furono gli stessi inglesi a segnalare a Supermarina il punto esatto dove era avvenuto lo scontro, perché si potessero soccorrere quei naufraghi che essi non erano in grado di fermarsi a raccogliere, trovandosi sotto la minaccia di bombardamento da parte di aerei tedeschi: come fu scritto, "un gesto cavalleresco che dimostrò una volta di più lo spirito di solidarietà che da sempre accomuna i marinai di tutte le nazionalità”.
Nonostante lo stato di profonda prostrazione in cui erano caduti i nostri comandi a causa della disfatta, e lo stato d'animo ben comprensibile che ne era seguito, vi fu una tempestività ammirevole nell'eseguire l'ordine di soccorso suggeritoci dagli stessi inglesi. La "Gradisca" venne dunque dirottata sul posto e recuperò quanti più naufraghi le riuscì di imbarcare, pochi, purtroppo, rispetto agli oltre tremila marinai che perirono in quella drammatica notte. Dopo l'otto settembre la "Gradisca" fu catturata dai tedeschi a Patrasso, in Grecia.
- Nave Ospedale: RAMB IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramb_IV

Quanto alla "Ramb IV", (nella foto sopra), la bananiera trasformata in nave ospedale per l'AOI (Africa Orientale Italiana) di base a Massaua, essa fu catturata dagli inglesi nel 1940 quando presero la città. Successivamente venne affondata nel Mediterraneo.
Benemerita fu anche l'azione della "Toscana" sopravvissuta ai mitragliamenti di cui era stata fatta oggetto. Anch'essa era stata un piroscafo passeggeri del Lloyd Triestino, trasformata all'inizio del 1941 ed entrata in servizio sul finire dal 1942. Nonostante quindi questa sua data di ingresso in ruolo piuttosto tardiva, la "Toscana" fu una delle più attive unità ospedaliere italiane e portò a termine ben 54 missioni, trasportando 4720 feriti e naufraghi, e 28.684 ammalati.
Complessivamente le 19 navi ospedale della nostra Marina effettuarono durante il secondo conflitto mondiale oltre 700 missioni per trasporto feriti e ammalati e soccorso naufraghi, con una percorrenza totale di oltre 310.000 miglia. Importanti furono in modo particolare le tre missioni con cui si ricondussero in patria altre trentamila civili italiani dall'ex impero, ossia dall'Africa orientale ormai caduta in mano degli inglesi. Esse si svolsero rispettivamente dal marzo al giugno 1942, dal settembre 1942 al gennaio 1943, dal maggio all'agosto 1943. Vi furono impiegati, sotto le insegne della Croce Rossa.
LE GRANDI NAVI BIANCHE DELL’ESODO D’AFRICA
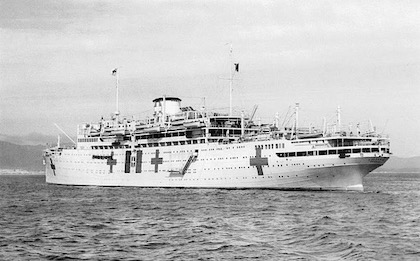
- LA M/N VULCANIA, gemella della SATURNIA, in missione di rimpatrio dei Civili dalla AOI nel 1942
http://transatlanticera.blogspot.com/2013/03/i-transatlantici-saturnia-e-vulcania.html
Furono circa 28 mila i nostri connazionali che in tre viaggi diversi tra il 1942 e il 1943 lasciarono Etiopia, Eritrea e Somalia per rimpatriare. Le motonavi Saturnia e Vulcania e i transatlantici Caio Duilio e Giulio Cesare, definite per l’occasione «navi bianche» perché decorate con i colori della Croce Rossa e allestite come grandi dormitori — con ospedali per far fronte a serie emergenze sanitarie — furono il teatro di una delle missioni più interessanti di cui finora si è parlato molto poco.

La DUILIO, gemella della GIULIO CESARE, con la livrea di Nave ospedale
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_(transatlantico_1920)
I grandi piroscafi "Saturnia" e "Vulcania", seguiti ad otto giorni di distanza dal "Cesare" e dal "Duilio". La rotta era la seguente: Trieste, Genova, Gibilterra, Canarie, Isole dei Capo Verde, Capo di Buona Speranza, Port Elizabeth, Canale di Mozambico, Oceano Indiano, Berbera, Massaua. Ogni viaggio equivaleva, in miglia, al giro del mondo.
22
Anche la nave passeggeri VIRGILIO (gemella dell’ORAZIO) operò come nave ospedale in Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Virgilio_(nave_ospedale)
CARLO GATTI
Rapallo, 24 Agosto 2020